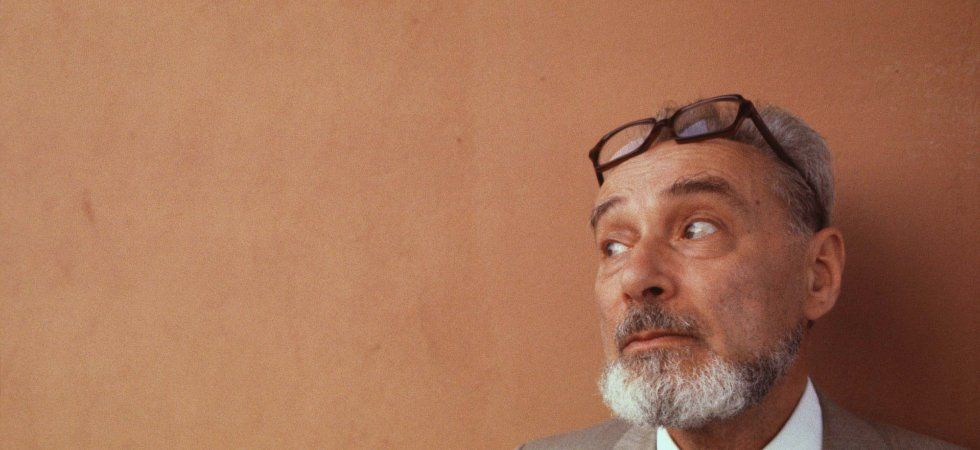Tra gli ortodossi d’Israele che ora dettano legge. E il Mossad li vuole 007
Di Davide Lerner 21 luglio 2019
Cappotto nero, rigidi rituali, sussidi: presto saranno il 30% della popolazione. Sempre più decisivi in politica, invisi ai laici: così cambiano il volto del Paese.
BNEI BRAK (Israele). «Tel Aviv è a dieci minuti da qui
ma non ci metto piede, per carità, là le donne vanno in giro mezze nude. Chi si
espone a quel mondo lì poi torna in yeshivà e non capisce più niente degli
studi religiosi» dice Elad Kuper, ultraortodosso israeliano di 27 anni,
passeggiando nell’enclave haredi di Bnei Brak.
Kuper abita con la moglie e i suoi primi tre figli (la media per gli
ultraortodossi è di circa sette) in una stanza e mezza affittata in uno stabile
sgangherato e circondato di spazzatura, vicino alla sovraffollata arteria di
“Rabbi Akiva”. Vive del sussidio della yeshivà, la scuola religiosa, che
ammonta a 2.000 shekel al mese (490 euro), in buona parte prelevati
direttamente dalle casse dello stato. Studia di notte – «solo col buio si
raggiunge la massima concentrazione secondo l’importante rabbino Shimon Bar
Yochai» – e durante il giorno aiuta un vecchio per raggranellare qualche altro
shekel.
Ma nella comunità ultraortodossa sono piuttosto le mogli che, non “obbligate” a
studiare le scritture ininterrottamente, sono autorizzate a fare qualche
lavoro: in molte, come la ventiquattrenne Avigail, moglie di Kuper, fanno le
maestre a scuola o negli asili part-time. Agli sforzi del governo per cerare di
spingere più ultraortodossi a integrarsi nella società “mondana” si è di
recente aggiunto niente meno che il Mossad, l’agenzia di intelligence
israeliana.
«Abbiamo cominciato ad assumere personale ultraortodosso dopo lunghi percorsi
propedeutici specializzati», ha detto il direttore del Mossad Yossi Cohen
all’inizio del mese, citando una collaborazione con la Ong Pardes che si pone
l’obiettivo di conciliare la vita religiosa degli haredim con quella lavorativa,
finanche nel settore della difesa.
Kuper è un caso particolare nella comunità ultraortodossa: è un hoser
leteshuva’ (colui che ritorna alla chiamata), cioè ha vissuto da laico fino a
circa vent’anni, compreso il servizio militare, prima di scegliere il lungo
cappotto nero e il cappello a larghe tese dei religiosi.
Ma per i suoi figli la strada è segnata. Kuper scandisce: «Dai 3 ai 13 anni
talmud torah, poi yeshivà fino al matrimonio, che verrà organizzato da un
“shachdan” o agente matrimoniale e approvato dai genitori, poi continueranno a
studiare al kollel, la scuola religiosa per uomini sposati. Qui le vite sono
semplici, è tutto pre-ordinato: non bisogna mai prendere decisioni», dice.
«Ovviamente useranno cellulari kasher, che possono fare solo telefonate. E
quando a 18 anni arriverà lo “zav rishon”, la chiamata dall’esercito, ci faremo
dare un certificato d’esenzione dalla yeshivà», spiega.
Proprio sul risentimento verso i super-religiosi, visti come parassiti che
eludono il servizio militare e vivono di sussidi statali da molti israeliani,
si sono incagliati i negoziati per formare il quinto governo del primo ministro
Benjamin Netanyahu. Ed è probabile che la stessa impasse si riproponga
dopo le nuove elezioni del prossimo settembre: Avigdor Lieberman,
che ha impugnato la causa dei laici, ha già detto che non farà sconti per
andare in coalizione coi religiosi. E, secondo recenti sondaggi della
televisione israeliana, senza Lieberman Netanyahu, ancora una volta, non sarà
in grado di formare un governo.
Secondo l’Ocse, entro pochi decenni la componente haredi della società
israeliana (attualmente circa un milione) potrebbe raggiungere il 30 per cento
della popolazione, con gravi conseguenze su economia e politica del Paese. «È
fondamentale che vengano rivisti i curriculum delle scuole haredi inserendo
materie più classiche, dalla matematica alle scienze all’inglese, se si vuole
favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro», ha detto Peter Jarrett
dell’Ocse al giornale economico israeliano The Marker. «È una battaglia
contro il tempo», ha aggiunto.
C’è anche chi, come il noto scrittore israeliano Yuval Noah Harari, autore del
bestseller “Sapiens,” interpreta la questione degli ultra-ortodossi in chiave
positiva. In un mondo in cui l’automazione rendesse i mestieri dell’uomo sempre
meno utili, teorizza nel suo ultimo libro “21 lezioni per il XXI secolo”
(Bompiani editore), le persone godranno di un reddito di cittadinanza e
dovranno realizzarsi facendo a meno del lavoro. Ecco allora che gli
ultraortodossi, secondo diverse ricerche appagati da una vita fatta di soli
rituali, sarebbero un’avanguardia da imitare invece che una zavorra di cui
disfarsi, relegandola al passato remoto. Ma, per ora, la preoccupazione
principale in Israele rimane quella di come favorire una loro integrazione alla
luce del crescente peso demografico ed elettorale.
Al contrario della minoranza araba, anch’essa poco emancipata nella società
israeliana, le autorità religiose haredi mandano i propri discepoli a votare
come soldati. «Sappiamo che avere peso politico conta parecchio, anche se la
nostra società vive separata», spiega Kuper.
Per misurare il peso politico degli ultraortodossi basta prendere in mano le
prime pagine goliardicamente distopiche dei giornali “haredi” all’alba
dell’ultima consultazione elettorale: “Matrimoni civili in arrivo,” “Trasporti
pubblici di Shabbat (sabato) nella maggior parte delle città del Paese,” e
ancora “Coscrizione obbligatoria per tutti”. Nessuno di questi scenari, con 16
deputati ultra-ortodossi alla Knesset, si possono realizzare.