
Blog
- Home
- Blog

“Salām/Shalom. Due padri” Reading teatrale
“Salām/Shalom. Due padri”, lettura scenica di Massimo Somaglino e Alessandro Lussiana, tratta Apeirogon di Colum McCann (Feltrinelli, 2022), vincitore del Premio Terzani 2022. Ispirata a una storia vera, la lettura scenica “Salām/Shalom. Due padri” è contemporaneamente una straziante denuncia e un flebile sogno. Merito anche della drammaturgia e della recitazione dei due attori, Massimo Somaglino e Alessandro Lussiana. La figlia di Rami è stata uccisa da un attentatore palestinese, la bambina di Bassam da un soldato israeliano: quel lutto che prima li divideva, ora, grazie al dialogo, li accomuna. Provano a capirsi in un’area del mondo così complessa da assomigliare a un apeirogon, la figura geometrica con un numero infinito di angoli che dà il titolo al libro.
Appuntamento mercoledì 9 ottobre, ore 21.00, al Memoriale.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, richiesta la prenotazione alla mail eventi@memorialeshoah.it.

The Unpunished: How Extremists Took Over Israel
By Ronen Bergman and Mark Mazzetti New York Times
- May 16, 2024
This story is told in three parts. The first documents the unequal system of justice that grew around Jewish settlements in Gaza and the West Bank. The second shows how extremists targeted not only Palestinians but also Israeli officials trying to make peace. The third explores how this movement gained control of the state itself. Taken together, they tell the story of how a radical ideology moved from the fringes to the heart of Israeli political power.
PART I.
IMPUNITY
By the end of October, it was clear that no one was going to help the villagers of Khirbet Zanuta. A tiny Palestinian community, some 150 people perched on a windswept hill in the West Bank near Hebron, it had long faced threats from the Jewish settlers who had steadily encircled it. But occasional harassment and vandalism, in the days after the Oct. 7 Hamas attack, escalated into beatings and murder threats. The villagers made appeal after appeal to the Israeli police and to the ever-present Israeli military, but their calls for protection went largely unheeded, and the attacks continued with no consequences. So one day the villagers packed what they could, loaded their families into trucks and disappeared.
Who bulldozed the village after that is a matter of dispute. The Israeli Army says it was the settlers; a senior Israeli police officer says it was the army. Either way, soon after the villagers left, little remained of Khirbet Zanuta besides the ruins of a clinic and an elementary school. One wall of the clinic, leaning sideways, bore a sign saying that it had been funded by an agency of the European Union providing “humanitarian support for Palestinians at risk of forcible transfer in the West Bank.” Near the school, someone had planted the flag of Israel as another kind of announcement: This is Jewish land now.
Such violence over the decades in places like Khirbet Zanuta is well documented. But protecting the people who carry out that violence is the dark secret of Israeli justice. The long arc of harassment, assault and murder of Palestinians by Jewish settlers is twinned with a shadow history, one of silence, avoidance and abetment by Israeli officials. For many of those officials, it is Palestinian terrorism that most threatens Israel. But in interviews with more than 100 people —current and former officers of the Israeli military, the National Israeli Police and the Shin Bet domestic security service; high-ranking Israeli political officials, including four former prime ministers; Palestinian leaders and activists; Israeli human rights lawyers; American officials charged with supporting the Israeli-Palestinian partnership — we found a different and perhaps even more destabilizing threat. A long history of crime without punishment, many of those officials now say, threatens not only Palestinians living in the occupied territories but also the State of Israel itself.
Many of the people we interviewed, some speaking anonymously, some speaking publicly for the first time, offered an account not only of Jewish violence against Palestinians dating back decades but also of an Israeli state that has systematically and increasingly ignored that violence. It is an account of a sometimes criminal nationalistic movement that has been allowed to operate with impunity and gradually move from the fringes to the mainstream of Israeli society. It is an account of how voices within the government that objected to the condoning of settler violence were silenced and discredited. And it is a blunt account, told for the first time by Israeli officials themselves, of how the occupation came to threaten the integrity of their country’s democracy.
How we reported this article:
The reporters spent years interviewing more than 100 former and current Israeli governmento fficials — including four former prime ministers — scoured secret government documents, and reported from Jerusalem, Tel Aviv, the West Bank and Washington. Natan Odenheimer, who contributed reporting from Israel and the West Bank, also obtained documents about how ultranationalist crimes went unpunished.
The interviews, along with classified documents written in recent months, reveal a government atwar with itself.
One document describes a meeting in March, when Maj. Gen. Yehuda Fox, the head of Israel’s Central Command, responsible for the West Bank, gave a withering account of the efforts by Bezalel Smotrich — an ultraright leader and the official in Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government with oversight over the West Bank — to undermine law enforcement in the occupied territory. Since Smotrich took office, Fox wrote, the effort to clamp down on illegal settlement construction has dwindled “to the point where it has disappeared.” Moreover, Fox said, Smotrich and his allies were thwarting the very measures to enforce the law that the government had promised Israeli courts it would take.
This is a story, pieced together and told in full for the first time, that leads to the heart of Israel. But it begins in the West Bank, in places like Khirbet Zanuta. From within the village’s empty ruins, there is a clear view across the valley to a tiny Jewish outpost called Meitarim Farm. Built in 2021, the farm has become a base of operations for settler attacks led by Yinon Levi, the farm’s owner. Like so many of the Israeli outposts that have been set up throughout the West Bank in recent years, Meitarim Farm is illegal. It is illegal under international law, which most experts say doesn’t recognize Israeli settlements in occupied land. It is illegal under Israeli law, like most settlements built since the 1990s.
Few efforts are made to stop the building of these outposts or the violence emanating from them. Indeed, one of Levi’s day jobs was running an earthworks company, and he has worked with the Israel Defense Forces to bulldoze at least one Palestinian village in the West Bank. As for the victims of that violence, they face a confounding and defeating system when trying to get relief. Villagers seeking help from the police typically have to file a report in person at an Israeli police station, which in the West Bank are almost exclusively located inside the settlements themselves. After getting through security and to the station, they sometimes wait for hours for an Arabic translator, only to be told they don’t have the right paperwork or sufficient evidence to submit areport. As one senior Israeli military official told us, the police “exhaust Palestinians so they won’t file complaints.”
And yet in November, with no protection from the police or the military, the former residents of Khirbet Zanuta and five nearby villages chose to test whether justice was still possible by appealing directly to Israel’s Supreme Court. In a petition, lawyers for the villagers, from Haqel, an Israeli human rights organization, argued that days after the Oct. 7 Hamas attack, a raiding party that included settlers and Israeli soldiers assaulted village residents, threatened murder and destroyed property throughout the village. They stated that the raid was part of “a mass transfer of ancient Palestinian communities,” one in which settlers working hand in hand with soldiers are taking advantage of the current war in Gaza to achieve the longer-standing goal of “cleansing” parts of theWest Bank, aided by the “sweeping and unprecedented disregard” of the state and its “de facto consent to the massive acts of deportation.”
The Supreme Court agreed to hear the case, and the relief the villagers are seeking — that the law be enforced — might seem modest. But our reporting reveals the degree to which decades of history are stacked against them: After 50 years of crime without punishment, in many ways the violent settlers and the state have become one.

Separate and Unequal
The devastating Hamas attacks in Israel on Oct. 7, the ongoing crisis of Israeli hostages and the grinding Israeli invasion and bombardment of the Gaza Strip that followed may have refocused the world’s attention on Israel’s ongoing inability to address the question of Palestinian autonomy. But it is in the West Bank where the corrosive long-term effects of the occupation on Israeli law and democracy are most apparent.
A sample of three dozen cases in the months since Oct. 7 shows the startling degree to which the legal system has decayed. In all the cases, involving misdeeds as diverse as stealing livestock andassault and arson, not a single suspect was charged with a crime; in one case, a settler shot a Palestinian in the stomach while an Israel Defense Forces soldier looked on, yet the police questioned the shooter for only 20 minutes, and never as a criminal suspect, according to an internal Israeli military memo. During our review of the cases, we listened to recordings of Israeli human rights activists calling the police to report various crimes against Palestinians. In some of the recordings, the police refused to come to the scene, claiming they didn’t know where the villages were; in one case, they mocked the activists as “anarchists.” A spokesman for the Israeli National Police declined to respond to repeated queries about our findings.
The violence and impunity that these cases demonstrate existed long before Oct. 7. In nearly every month
before October, the rate of violent incidents was higher than during the same month in the previous year. And Yesh Din, an Israeli human rights group, looking at more than 1,600 cases of settler violence in the West Bank between 2005 and 2023, found that just 3 percent ended in a conviction. Ami Ayalon, the head of Shin Bet from 1996 to 2000 — speaking out now because of his concern about Israel’s systemic failure to enforce the law — says this singular lack of consequences reflects the indifference of the Israeli leadership going back years. “The cabinet, the prime minister,” he says, “they signal to the Shin Bet that if a Jew is killed, that’s terrible. If an Arabis killed, that’s not good, but it’s not the end of the world.”
Ayalon’s assessment was echoed by many other officials we interviewed. Mark Schwartz, a retired American three-star general, was the top military official working at the United States Embassy in Jerusalem from 2019 to 2021, overseeing international support efforts for the partnership between Israel and the Palestinian Authority. “There’s no accountability,” he says now of the long history of settler crimes and heavy-handed Israeli operations in the West Bank. “These things eat away at trust and ultimately the stability and security of Israel and the Palestinian territories. It’s undeniable.”
How did a young nation turn so quickly on its own democratic ideals, and at what price? Any meaningful answer to these questions has to take into account how a half-century of lawless behavior that went largely unpunished propelled a radical form of ultranationalism to the center of Israeli politics. This is the history that is told here in three parts. In Part I, we describe the origins of a religious movement that established Jewish settlements in the newly won territories of Gaza and the West Bank during the 1970s. In Part II, we recount how the most extreme elements of the settler movement began targeting not only Palestinians but also Israeli leaders who tried to make peace with them. And in Part III, we show how the most established members of Israel’s ultraright, unpunished for their crimes, gained political power in Israel, even as a more radical generation of settlers vowed to eliminate the Israeli state altogether.
Many Israelis who moved to the West Bank did so for reasons other than ideology, and among the settlers, there is a large majority who aren’t involved in violence or other illegal acts against Palestinians. And many within the Israeli government fought to expand the rule of law into the territories, with some success. But they also faced harsh pushback, with sometimes grave personal consequences. Prime Minister Yitzhak Rabin’s efforts in the 1990s, on the heels of the First Intifada, to make peace with Yasir Arafat, chairman of the Palestine Liberation Organization, gave rise to a new generation of Jewish terrorists, and they ultimately cost him his life.
The disagreement over how to handle the occupied territories and their residents has bred a complex and sometimes opaque system of law enforcement. At its heart are two separate and unequal systems of justice: one for Jews and another for Palestinians.
The West Bank is under the command of the I.D.F., which means that Palestinians are subject to a military law that gives the I.D.F. and the Shin Bet considerable authority. They can hold suspects for extended periods without trial or access to either a lawyer or the evidence against them. They can wiretap, conduct secret surveillance, hack into databases and gather intelligence on any Arab livingin the occupied territory with few restrictions. Palestinians are subject to military — not civilian —courts, which are far more punitive when it comes to accusations of terrorism and less transparent to outside scrutiny. (In a statement, the I.D.F. said, “The use of administrative detention measures is only carried out in situations where the security authorities have reliable and credible information indicating a real danger posed by the detainee to the region’s security, and in the absence of other alternatives to remove the risk.” It declined to respond to multiple specific queries, in some cases saying “the events are too old to address.”)
According to a senior Israeli defense official, since Oct. 7, some 7,000 settler reservists were called back by the I.D.F., put in uniform, armed and ordered to protect the settlements. They were given specific orders: Do not leave the settlements, do not cover your faces, do not initiate unauthorized roadblocks. But in reality many of them have left the settlements in uniform, wearing masks, setting up roadblocks and harassing Palestinians.
All West Bank settlers are in theory subject to the same military law that applies to Palestinian residents. But in practice, they are treated according to the civil law of the State of Israel, which formally applies only to territory within the state’s borders. This means that Shin Bet might probe two similar acts of terrorism in the West Bank — one committed by Jewish settlers and one committed by Palestinians — and use wholly different investigative tools.
In this system, even the question of what behavior is being investigated as an act of terror is different for Jews and Arabs. For a Palestinian, the simple admission of identifying with Hamas counts as an act of terrorism that permits Israeli authorities to use severe interrogation methods and long detention. Moreover, most acts of violence by Arabs against Jews are categorized as a “terror”attack — giving Shin Bet and other services license to use the harshest methods at their disposal.
The job of investigating Jewish terrorism falls to a division of Shin Bet called the Department for Counter intelligence and Prevention of Subversion in the Jewish Sector, known more commonly as the Jewish Department. It is dwarfed both in size and prestige by Shin Bet’s Arab Department, the division charged mostly with combating Palestinian terrorism. And in the event, most incidents of settler violence — torching vehicles, cutting down olive groves — fall under the jurisdiction of the police, who tend to ignore them. When the Jewish Department investigates more serious terrorist threats, it is often stymied from the outset, and even its successes have sometimes been undermined by judges and politicians sympathetic to the settler cause. This system, with its gap sand obstructions, allowed the founders of groups advocating extreme violence during the 1970sand 1980s to act without consequences, and today it has built a protective cocoon around their ideological descendants.
Some of these people now run Israel. In 2022, just 18 months after losing the prime ministership, Benjamin Netanyahu regained power by forming an alliance with ultraright leaders of both the Religious Zionism Party and the Jewish Power party. It was an act of political desperation on Netanyahu’s part, and it ushered into power some truly radical figures, people — like Smotrich and Itamar Ben-Gvir — who had spent decades pledging to wrest the West Bank and Gaza from Arab hands. Just two months earlier, according to news reports at the time, Netanyahu refused to share a stage with Ben-Gvir, who had been convicted multiple times for supporting terrorist organizations and, in front of television cameras in 1995, vaguely threatened the life of Rabin, who was murdered weeks later by an Israeli student named Yigal Amir.
Now Ben-Gvir was Israel’s national security minister and Smotrich was Israel’s finance minister,charged additionally with overseeing much of the Israeli government’s activities in the West Bank. In December 2022, a day before the new government was sworn in, Netanyahu issued a list of goal sand priorities for his new cabinet, including a clear statement that the nationalistic ideology of his new allies was now the government’s guiding star. “The Jewish people,” it said, “have an exclusive and inalienable right to all parts of the land of Israel.”
Two months after that, two Israeli settlers were murdered in an attack by Hamas gunmen near Huwara, a village in the West Bank. The widespread calls for revenge, common after Palestinian terror attacks, were now coming from within Netanyahu’s new government. Smotrich declared that “the village of Huwara needs to be wiped out.” And, he added, “I think the State of Israel needs to do it.”

Birth of a Movement
With its overwhelming victory in the Arab- Israeli War of 1967, Israel more than doubled the amount of land it controlled, seizing new territory in the West Bank, the Gaza Strip, the Sinai Peninsula, the Golan Heights and East Jerusalem. Now it faced a choice: Would the new land become part of Israel or be bargained away as part of a future Palestinian state? To a cadre of young Israelis imbued with messianic zeal, the answer was obvious. The acquisition of the territories animated a religious political movement — Gush Emunim, or “Bloc of the Faithful” — that was determined to settle the newly conquered lands.
Gush Emunim followers believed that the coming of the messiah would be hastened if, rather than studying holy books from morning to night, Jews settled the newly occupied territories. This was the land of “Greater Israel,” they believed, and there was a pioneer spirit among the early settlers. They saw themselves as direct descendants of the earliest Zionists, who built farms and kibbutzim near Palestinian villages during the first part of the 20th century, when the land was under British control. But while the Zionism of the earlier period was largely secular and socialist, the new settlers believed they were advancing God’s agenda.
The legality of that agenda was an open question. The Geneva Conventions, to which Israel was a signatory, forbade occupying powers to deport or transfer “parts of its own civilian population into the territory it occupies.” But the status of the territory was, in the view of many within and outsidet he Israeli government, more complex. The settlers sought to create what some of them called “facts on the ground.” This put them into conflict with both the Palestinians and, at least putatively, the Israeli authorities responsible for preventing the spread of illegal settlements.

Whether or not the government would prove flexible on these matters became clear in April 1975 at Ein Yabrud, an abandoned Jordanian military base near Ofra, in the West Bank. A group of workers had been making the short commute from Israel most days for months to work on rebuilding the base, and one evening they decided to stay. They were aiming to establish a Jewish foothold in Judea and Samaria, the Israeli designation for the territories that make up the West Bank, and they had found a back door that required only the slightest push. Their leader met that same night with Shimon Peres, then Israel’s defense minister, who told the I.D.F. to stand down. Peres would treat the nascent settlement not as a community but as a “work camp” — and the I.D.F. would do nothing to hinder their work.
Peres’s maneuver was partly a sign of the weakness of Israel’s ruling Labor party, which had dominated Israeli politics since the country’s founding. The residual trauma of the Yom Kippur War in 1973 — when Israel was caught completely by surprise by Egyptian and Syrian forces before eventually beating back the invading armies — had shaken citizens’ belief in their leaders, and movements like Gush Emunim, directly challenging the authority of the Israeli state, had gained momentum amid Labor’s decline. This, in turn, energized Israel’s political right.
By the late 1970s, the settlers, bolstered in part by growing political support, were expanding in number. Carmi Gillon, who joined Shin Bet in 1972 and rose by the mid-1990s to become its director, recalls the evolving internal debates. Whose responsibility was it to deal with settlers? Should Israel’s vaunted domestic security service enforce the law in the face of clearly illegal acts of settlement? “When we realized that Gush Emunim had the backing of so many politicians, we knew we shouldn’t touch them,” he said in his first interview for this article in 2016.
One leader of the ultraright movement would prove hard to ignore, however. Meir Kahane, an ultraright rabbi from Flatbush, Brooklyn, had founded the militant Jewish Defense League in 1968 in New York. He made no secret of his belief that violence was sometimes necessary to fulfill his dream of Greater Israel, and he even spoke of plans to buy .22 caliber rifles for Jews to defendt hemselves. “Our campaign motto will be, ‘Every Jew a .22,’” he declared. In 1971, he received a suspended sentence on bomb-making charges, and at the age of 39 he moved to Israel to start a new life. From a hotel on Zion Square in Jerusalem, he started a school and a political party, what would become Kach, and drew followers with his fiery rhetoric.

Kahane said he wanted to rewrite the stereotype of Jews as victims, and he argued, in often vivid terms, that Zionism and democracy are in fundamental tension. “Zionism came into being to create a Jewish state,” Kahane said in an interview with The Times in 1985, five years before he was assassinated by a gunman in New York. “Zionism declares that there is going to be a Jewish state with a majority of Jews, come what may. Democracy says, ‘No, if the Arabs arethe majority then they have the right to decide their own fate.’ So Zionism and democracy are atodds. I say clearly that I stand with Zionism.”
A Buried Report
In 1977, the Likud party led a coalition that, for the first time in Israeli history, secured a right-wing majority in the country’s Parliament, the Knesset. The party was headed by Menachem Begin, a veteran of the Irgun, a paramilitary organization that carried out attacks against Arabs and British authorities in Mandatory Palestine, the British colonial entity that preceded the creation of Israel. Likud — Hebrew for “the alliance” — was itself an amalgam of several political parties. Kach itself was still on the outside and would always remain so. But its radical ideas and ambitions were moving closer to the mainstream.
Likud’s victory came 10 years after the war that brought Israel vast amounts of new land, but the issue of what to do with the occupied territories had yet to be resolved. As the new prime minister, Begin knew that addressing that question would mean addressing the settlements. Could there be a legal basis for taking the land? Something that would allow the settlements to expand with the full support of the state?

It was Plia Albeck, then a largely unknown bureaucrat in the Israeli Justice Ministry, who found Begin’s answer. Searching through the regulations of the Ottoman Empire, which ruled Palestine inthe years preceding the British Mandate, she lit upon the Ottoman Land Code of 1858, a major effort at land reform. Among other provisions, the law enabled the sultan to seize any land that had not been cultivated by its owners for a number of years and that was not “within shouting distance”of the last house in the village. It did little to address the provisions of the Geneva Convention, but it was, for her department, precedent enough. Soon Albeck was riding in an army helicopter, mapping the West Bank and identifying plots of land that might meet the criteria of the Ottoman law. The Israeli state had replaced the sultan, but the effect was the same. Albeck’s creative legal interpretation led to the creation of more than 100 new Jewish settlements, which she referred to as “my children.”
At the same time, Begin was quietly brokering a peace deal with President Anwar Sadat of Egypt in the United States at Camp David. The pact they eventually negotiated gave the Sinai Peninsula back to Egypt and promised greater autonomy to Palestinians in the occupied territories in return for normalized relations with Israel. It would eventually win the two leaders a joint Nobel Peace Prize. But Gush Emunim and other right-wing groups saw the accords as a shocking reversal. From this well of anger sprang a new campaign of intimidation. Rabbi Moshe Levinger, one of the leaders of Gush Emunim and the founder of the settlement in the heart of Hebron, declared the movement’s purposes on Israeli television. The Arabs, he said, “must not be allowed to raise their heads.”
Leading this effort would be a militarized offshoot of Gush Emunim called the Jewish Underground. The first taste of what was to come arrived on June 2, 1980. Car bombs exploded as part of a complex assassination plot against prominent Palestinian political figures in the West Bank. The attack blew the legs off Bassam Shaka, the mayor of Nablus; Karim Khalaf, the mayor of Ramallah,was forced to have his foot amputated. Kahane, who in the days before the attack said at a news conference that the Israeli government should form a “Jewish terrorist group” that would “throw bombs and grenades to kill Arabs,” applauded the attacks, as did Rabbi Haim Druckman, a leader of Gush Emunim then serving in the Knesset, and many others within and outside the movement. Brig. Gen. Binyamin Ben-Eliezer, then the top I.D.F. commander in the West Bank, noting the injuries suffered by the Palestinian mayors under his watch, said simply, “It’s a shame they didn’t hit them a bit higher.” An investigation began, but it would be years before it achieved any results. Ben-Eliezer went on to become a leader of the Labor party and defense minister
The threat that the unchecked attacks posed to the institutions and guardrails of Jewish democracy wasn’t lost on some members of the Israeli elite. As the violence spread, a group of professors at Tel Aviv University and Hebrew University in Jerusalem sent a letter to Yitzhak Zamir, Israel’s attorney general. They were concerned, they wrote, that illegal “private policing activity” against the Palestinians living in the occupied territories presented a “threat to the rule of law in the country.”The professors saw possible collusion between the settlers and the authorities. “There is a suspicion that similar crimes are not being handled in the same manner and some criminals are receiving preferential treatment over others,” the signatories to the letter said. “This suspicion requires fundamental examination.”
The letter shook Zamir, who knew some of the professors well. He was also well aware that evidence of selective law enforcement — one law for the Palestinians and another for the settlers— would rebut the Israeli government’s claim that the law was enforced equally and could become both a domestic scandal and an international one. Zamir asked Judith Karp, then Israel’s deputy attorney general for special duties, to lead a committee looking into the issue. Karp was responsible for handling the most delicate issues facing the Justice Ministry, but this would require even greater discretion than usual.
As her team investigated, Karp says, “it very quickly became clear to me that what was described in the letter was nothing compared to the actual reality on the ground.” She and her investigative committee found case after case of trespassing, extortion, assault and murder, even as the military authorities and the police did nothing or performed notional investigations that went nowhere. “The police and the I.D.F. in both action and inaction were really cooperating with the settler vandals, ”Karp says. “They operated as if they had no interest in investigating when there were complaints,and generally did everything they could to deter the Palestinians from even submitting them.”
In May 1982, Karp and her committee submitted a 33-page report, determining that dozens of offenses were investigated insufficiently. The committee also noted that, in their research, the police had provided them with information that was incomplete, contradictory and in part false. They concluded that nearly half the investigations opened against settlers were closed without the police conducting even a rudimentary investigation. In the few cases in which they did investigate, the committee found “profound flaws.” In some cases, the police witnessed the crimes and did nothing. In others, soldiers were willing to testify against the settlers, but their testimonies and other evidence were buried.
It soon became clear to Karp that the government was going to bury the report. “We were very naïve,” she now recalls. Zamir had been assured, she says, that the cabinet would discuss the grave findings and had in fact demanded total confidentiality. The minister of the interior at the time, Yosef Burg, invited Karp to his home for what she recalls him describing as “a personal conversation.” Burg, a leader of the pro-settler National Religious Party, had by then served as a government minister in one office or another for more than 30 years. Karp assumed he wanted to learn more about her work, which could in theory have important repercussions for the religious right. “But, to my astonishment,” she says, “he simply began to scold me in harsh language about what we were doing. I understood that he wanted us to drop it.”
Karp announced she was quitting the investigative committee. “The situation we discovered was one of complete helplessness,” she says. When the existence of the report (but not its contents) leaked to the public, Burg denied having ever seen such an investigation. When the full contents of the report were finally made public in 1984, a spokesman for the Justice Ministry said only that the committee had been dissolved and that the ministry was no longer monitoring the problem.
PART II.
WARNINGS
“You have to understand why all this is important now,” Ami Ayalon said, leaning in for emphasis.The sun shining into the backyard of the former Shin Bet director was gleaming off his bald scalp,illuminating a face that looked as if it were sculpted by a dull kitchen knife. “We are not discussing Jewish terrorism. We are discussing the failure of Israel.”
Ayalon was protective of his former service, insisting that Shin Bet, despite some failures, usually has the intelligence and resources to deter and prosecute right-wing terrorism in Israel. And, he said, they usually have the will. “The question is why they are not doing anything about it,” he said.“And the answer is very simple. They cannot confront our courts. And the legal community finds it almost impossible to face the political community, which is supported by the street. So everything starts with the street.”
By the early 1980s, the settler movement had begun to gain some traction within the Knesset, but it remained far from the mainstream. When Kahane himself was elected to the Knesset in 1984, the members of the other parties, including Likud, would turn and leave the room when he stood up to deliver speeches. One issue was that the continual expansion of the settlements was becoming an irritant in U.S.-Israel relations. During a 1982 trip by Begin to Washington, the prime minister had a closed-door meeting with the Senate Committee on Foreign Relations to discuss Israel’s invasion of Lebanon that year, an effort to force out the P.L.O. that had been heavy with civilian casualties. According to The Times’s coverage of the session, Senator Joseph R. Biden Jr. of Delaware, then in his second term, had an angry exchange with Begin about the West Bank, telling him that Israel was losing support in this country because of the settlements policy.
But Israeli officials came to understand that the Americans were generally content to vent their anger about the issue without taking more forceful action — like restricting military aid to Israel, which was then, as now, central to the country’s security arrangements. After the Jewish Underground plotters of the bombings targeting the West Bank mayors and other attacks were finally brought to trial in 1984, they were found guilty and given sentences ranging from a few months to life in prison. The plotters showed little remorse, though, and a public campaign swelled to have them pardoned. Foreign Minister Yitzhak Shamir also made the case for pardoning them, saying they were “excellent, good people who have erred in their path and actions.” Clemency, Shamir suggested, would prevent a recurrence of Jewish terrorism.
In the end, President Chaim Herzog, against the recommendations of Shin Bet and the Justice Ministry, signed an extraordinary series of pardons and commutations for the plotters. They were released and greeted as heroes by the settler community, and some rose to prominent positions in government and the Israeli media. One of them, Uzi Sharbav, now a leader in the settlement movement, was a speaker at a recent conference promoting the return of settlers to Gaza.
In fact, nearly all the Jews involved in terror attacks against Arabs over the past decades have received substantial reductions in prison time. Gillon, the head of the Jewish Department when some of these people were arrested, recalls the “profound sense of injustice” that he felt when they were released. But even more important, he says, was “the question of what message the pardons convey to the public and to anyone who ever thinks about carrying out acts of terror against Arabs.”
Operational Failures
In 1987, a series of conflicts in Gaza led to a sustained Palestinian uprising throughout the occupied territories and Israel. The First Intifada, as it became known, was driven by anger over the occupation, which was then entering its third decade. It would simmer for the next six years, as Palestinians attacked Israelis with stones and Molotov cocktails and launched a series of strikes and boycotts. Israel deployed thousands of soldiers to quell the uprising.
In the occupied territories, reprisal attacks between settlers and Palestinians were an increasing problem. The Gush Emunim movement had spread and fractured into different groups, making it difficult for Shin Bet to embed enough informants with the settlers. But the service had one key informant — a man given the code name Shaul. He was a trusted figure among the settlers and rose to become a close assistant to Rabbi Moshe Levinger, the Gush Emunim leader who founded the settlement in Hebron.
Levinger had been questioned many times under suspicion of having a role in multiple violent attacks, but Shaul told Shin Bet operatives that they were seeing only a fraction of the whole picture. He told them about raids past and planned; about the settlers tearing through Arab villages vandalizing homes, burning dozens of cars. The operatives ordered him to participate in these raids to strengthen his cover. One newspaper photographer in Hebron in 1985 captured Shaul smashing the wall of an Arab marketplace with a sledge hammer. As was standard policy, Shin Bet had ordered him to participate in any activity that didn’t involve harm to human life, but figuring out which of the activities wouldn’t cross that line became increasingly difficult. “The majority of the activists were lunatics, riffraff, and it was very difficult to be sure they wouldn’t hurt people and would harm only property,” Shaul said. (Shaul, whose true identity remains secret, provided these quotes in a 2015 interview with Bergman for the Israeli Hebrew-language paper Yedioth Ahronoth. Some of his account is published here for the first time.)
In September 1988, Rabbi Levinger, Shaul’s patron, was driving through Hebron when, he later said in court, Palestinians began throwing stones at his car and surrounding him. Levinger flashed a pistol and began firing wildly at nearby shops. Investigators said he killed a 42-year-old shopkeeper,Khayed Salah, who had been closing the steel shutter of his shoe store, and injured a second man. Levinger claimed self-defense, but he was hardly remorseful. “I know that I am innocent,” he said at the trial, “and that I didn’t have the honor of killing the Arab.”
Prosecutors cut a deal with Levinger. He was convicted of criminally negligent homicide, sentenced to five months in prison and released after only three.
Shin Bet faced the classic intelligence agency’s dilemma: how and when to let its informants participate in the very violent acts the service was supposed to be stopping. There was some logicin Shin Bet’s approach with Shaul, but it certainly didn’t help deter acts of terror in the West Bank,especially with little police presence in the occupied territories and a powerful interest group ensuring that whoever was charged for the violence was released with a light sentence.
Over his many years as a Shin Bet mole, Shaul said, he saw numerous intelligence and operational failures by the agency. One of the worst, he said, was the December 1993 murder of three Palestinians in an act of vengeance after the murder of a settler leader and his son. Driving home from a day of work in Israel, the three Palestinians, who had no connection to the deaths of the settlers, were pulled from their car and killed near the West Bank town Tarqumiyah.
Shaul recalled how one settler activist proudly told him that he and two friends committed the murders. He contacted his Shin Bet handlers to tell them what he had heard. “And suddenly I saw they were losing interest,” Shaul said. It was only later that he learned why: Two of the shooters were Shin Bet informants. The service didn’t want to blow their cover, or worse, to suffer the scandal that two of its operatives were involved in a murder and a cover-up.
In a statement, Shin Bet said that Shaul’s version of events is “rife with incorrect details” but refused to specify which details were incorrect. Neither the state prosecutor nor the attorney general responded to requests for comment, which included Shaul’s full version of events and additional evidence gathered over the years.
Shaul said he also gave numerous reports to his handlers about the activities of yet another Brooklyn-born follower of Meir Kahane and the Jewish Defense League: Dr. Baruch Goldstein. He earned his medical degree at Albert Einstein College of Medicine in the Bronx and in 1983 immigrated to Israel, where he worked first as a physician in the I.D.F., then as an emergency doctor at Kiryat Arba, a settlement near Hebron.
In the years that passed, he gained the attention of Shin Bet with his eliminationist views, calling Arabs “latter-day Nazis” and making a point to visit the Jewish terrorist Ami Popper in prison, wherehe was serving a sentence for the 1990 murder of seven Palestinians in the Tel Aviv suburb Rishon Le Zion. Shaul said he regarded Goldstein at the time as a “charismatic and highly dangerous figure” and repeatedly urged the Shin Bet to monitor him. “They told me it was none of my business,” he said.
‘Clean Hands’
On Feb. 24, 1994, Goldstein abruptly fired his personal driver. According to Shaul, Goldstein told the driver that he knew he was a Shin Bet informer. Terrified at having been found out, the driver fled the West Bank immediately. Now Goldstein was moving unobserved.
That evening marked the beginning of Purim, the festive commemoration of the victory of the Jews over Haman the Agagite, a court official in the Persian Empire and the nemesis of the Jews in the Old Testament’s Book of Esther. Right-wing Israelis have often drawn parallels between Haman and Arabs — enemies who seek the annihilation of Jews. Goldstein woke early the next day and put on his I.D.F. uniform, and at 5:20 a.m. he entered the Cave of the Patriarchs, an ancient complex in Hebron that serves as a place of worship for both Jews and Muslims. Goldstein carried with him his I.D.F.-issued Galil rifle. It was also the Muslim holy month of Ramadan, and on that morning hundreds of Muslims crowded the hall in prayer. Goldstein faced the worshipers and beganshooting , firing 108 rounds before he was dragged down and beaten to death. The massacre killed 29 Muslim worshipers and injured more than 100.
The killings shocked Israel, and the government responded with a crackdown on extremism. Kachand Kahane Chai, the two political organizations most closely affiliated with the Kahanist movement, were outlawed and labeled terrorist groups, as was any other party that called for “the establishment of a theocracy in the biblical Land of Israel and the violent expulsion of Arabs from that land.” Rabin, in an address to the Knesset, spoke directly to the followers of Goldstein and Kahane, who he said were the product of a malicious foreign influence on Israel. “You are not part of the community of Israel,” he said. “You are not partners in the Zionist enterprise. You are a foreign implant. You are an errant weed. Sensible Judaism spits you out. You placed yourself outside the wall of Jewish law.”
Following the massacre, a state commission of inquiry was appointed, headed by Judge Meir Shamgar, the president of the Supreme Court. The commission’s report, made public in June 1994, strongly criticized the security arrangements at the Cave of the Patriarchs and examined law-enforcement practices regarding settlers and the extreme right in general. A secret appendix to the report, containing material deemed too sensitive for public consumption, included a December 1992 letter from the Israeli commissioner of police, essentially admitting that the police could not enforce the law. “The situation in the districts is extremely bleak,” he wrote, using the administrative nomenclature for the occupied territories. “The ability of the police to function is far from there quired minimum. This is as a result of the lack of essential resources.”
In its conclusions, the commission, tracing the lines of the previous decade’s Karp report, confirmed claims that human rights organizations had made for years but that had been ignored by the Israeli establishment. The commission found that Israeli law enforcement was “ineffective in handling complaints,” that it delayed the filing of indictments and that restraining orders against “chronic” criminals among the “hard core” of the settlers were rarely issued.
The I.D.F. refused to allow Goldstein to be buried in the Jewish cemetery in Hebron. He was buried instead in the Kiryat Arba settlement, in a park named for Meir Kahane, and his grave site has become an enduring place of pilgrimage for Jews who wanted to celebrate, as his epitaph reads,the “saint” who died for Israel with “clean hands and a pure heart.”
A Curse of Death
One ultranationalist settler who went regularly to Goldstein’s grave was a teenage radical named Itamar Ben-Gvir, who would sometimes gather other followers there on Purim to celebrate the slain killer. Purim revelers often dress in costume, and on one such occasion, caught on video, Ben-Gvir even wore a Goldstein costume, complete with a fake beard and a stethoscope. By then, Ben-Gvir had already come to the attention of the Jewish Department, and investigators interrogated hims everal times. The military declined to enlist him into the service expected of most Israeli citizens.
After the massacre at the Cave of the Patriarchs, a new generation of Kahanists directed their anger squarely at Rabin for his signing of the Oslo agreement and for depriving them, in their view, of their birth right. “From my standpoint, Goldstein’s action was a wake-up call,” says Hezi Kalo, along time senior Shin Bet official who oversaw the division that included the Jewish Department at that time. “I realized that this was going to be a very big story, that the diplomatic moves by the Rabin government would simply not pass by without the shedding of blood.”
The government of Israel was finally paying attention to the threat, and parts of the government acted to deal with it. Shin Bet increased the size of the Jewish Department, and it began to issue a new kind of warning: Jewish terrorists no longer threatened only Arabs. They threatened Jews.
The warnings noted that rabbis in West Bank settlements, along with some politicians on the right, were now openly advocating violence against Israeli public officials, especially Rabin. Extremist rabbis issued rulings of Jewish law against Rabin — imposing a curse of death, a Pulsa Dinura , and providing justification for killing him, a din rodef.
Carmi Gillon by then had moved on from running the Jewish Department and now had the top job at Shin Bet. “Discussing and acknowledging such halakhic laws was tant amount to a license to kill ,”he says now, looking back. He was particularly concerned about Benjamin Netanyahu and Ariel Sharon, who were stoking the fury of the right-wing rabbis and settler leaders in their battles with Rabin.
Shin Bet wanted to prosecute rabbis who approved the religiously motivated death sentences against Rabin, but the state attorney’s office refused. “They didn’t give enough importance back then to the link between incitement and legitimacy for terrorism,” says one former prosecutor who worked in the state attorney’s office in the mid-1990s.
Shin Bet issued warning after warning in 1995. “This was no longer a matter of mere incitement, but rather concrete information on the intention to kill top political figures, including Rabin,” Kalo now recalls. In October of that year, Ben-Gvir spoke to Israeli television cameras holding up a Cadillachood ornament, which he boasted he had broken off the prime minister’s official car during chaotic anti-Oslo demonstrations in front of the Knesset. “We got to his car,” he said, “and we’ll get to him,too.” The following month, Rabin was dead.
Conspiracies
Yigal Amir, the man who shot and killed Rabin in Tel Aviv after a rally in support of the Oslo Accords on Nov. 4, 1995, was not unknown to the Jewish Department. A 25-year-old studying law, computer science and the Torah at Bar-Ilan University near Tel Aviv, he had been radicalized by Rabin’s efforts to make peace with Palestinian leaders and had connections to Avishai Raviv, the leader of Eyal, a new far-right group loosely affiliated with the Kach movement. In fact, Raviv was a Shin Bet informant, code-named Champagne. He had heard Amir talking about the justice of the din rodef judgments, but he did not identify him to his handlers as an immediate danger. “No one took Yigal seriously,” he said later in a court proceeding. “It’s common in our circles to talk about attacking public figures.”
Lior Akerman was the first Shin Bet investigator to interrogate Amir at the detention center where he was being held after the assassination. There was of course no question about his guilt. But there was the broader question of conspiracy. Did Amir have accomplices? Did they have further plans? Akerman now recalls asking Amir how he could reconcile his belief in God with his decision to murder the prime minister of Israel. Amir, he says, told him that rabbis had justified harming the prime minister in order to protect Israel.
Amir was smug, Akerman recalls, and he did not respond directly to the question of accomplices.“‘Listen,” he said, according to Akerman, “I succeeded. I was able to do something that many people wanted but no one dared to do. I fired a gun that many Jews held, but I squeezed the trigger because no one else had the courage to do it.”
The Shin Bet investigators demanded to know the identities of the rabbis. Amir was coy at first, but eventually the interrogators drew enough out of him to identify at least two of them. Kalo, the head of the division that oversaw the Jewish Department, went to the attorney general to argue that the rabbis should be detained immediately and prosecuted for incitement to murder. But the attorney general disagreed, saying the rabbis’ encouragement was protected speech and couldn’t be directly linked to the murder. No rabbis were arrested.
Days later, however, the police brought Raviv — the Shin Bet operative known as Champagne —into custody in a Tel Aviv Magistrate Court, on charges that he had conspired to kill Rabin, but he was released shortly after. Raviv’s role as an informant later came to light, and in 1999, he was arrested for his failure to act on previous knowledge of the assassination. He was acquitted on all charges, but he has since become a fixture of extremist conspiracy theories that pose his failure toring the alarm as evidence that the murder of the prime minister was due not to the violent rhetoric of the settler right, or the death sentences from the rabbis, or the incitement by the leaders of the opposition, but to the all-too-successful efforts of a Shin Bet agent provocateur. A more complicatedand insidious conspiracy theory, but no less false, was that it was Shin Bet itself that assassinated Rabin or allowed the assassination to happen. Gillon, the head of the service at the time, resigned, and ongoing inquiries, charges andcountercharges would continue for years. Until Oct. 7, 2023, the killing of the prime minister was considered the greatest failure in the history of Shin Bet. Kalo tried to sum up what went wrong with Israeli security. “The only answer my friends and I could give for the failure was complacency,” he wrote in his 2021 memoir. “They simply couldn’t believe that such a thing could happen, definitely not at the hands of another Jew.”
The Sasson Report
In 2001, as the Second Intifada unleashed a wave of Palestinian suicide bombings against Israeli civilians, Ariel Sharon took office as prime minister. The struggling peace process had come to a complete halt amid the violence, and Sharon’s rise at first appeared to mark another victory for thesettlers. But in 2003, in one of the more surprising reversals in Israeli political history, Sharon announced what he called Israel’s “disengagement” from Gaza, with a plan to remove settlers —forcibly if necessary — over the next two years.
The motivations were complex and the subject of considerable debate. For Sharon, at least, it appeared to be a tactical move. “The significance of the disengagement plan is the freezing of the peace process,” his senior adviser Dov Weisglass told Haaretz at the time. “And when you freeze that process, you prevent the establishment of a Palestinian state.” But Sharon was also facing considerable pressure from President George W. Bush to do something about the ever-expanding illegal settlements in the West Bank, which were a growing impediment to any regional security deals. In July 2004, he asked Talia Sasson, who had recently retired as the head of the special tasks division in the state attorney’s office, to draw up a legal opinion on the subject of“unauthorized outposts” in the West Bank. His instructions were clear: Investigate which Israeli government agencies and authorities were secretly involved in building the outposts. “Sharon never interfered in my work, and neither was he surprised by the conclusions,” Sasson said in an interview two decades later. “After all, he knew better than anyone what the situation was on the ground, and he was expecting only grave conclusions.”
It was a simple enough question: Just how had it happened that hundreds of outposts had been built in the decade since Yitzhak Rabin ordered a halt in most new settlements? But Sasson’s effort to find an answer was met with delays, avoidance and outright lies. Her final report used careful but pointed language: “Not everyone I turned to agreed to talk with me. One claimed he was too busy to meet, while another came to the meeting but refused to meaningfully engage with most of my questions.”
Sasson found that between January 2000 and June 2003, a division of Israel’s Construction and Housing Ministry issued 77 contracts for the establishment of 33 sites in the West Bank, all of which were illegal. In some cases, the ministry even paid for the paving of roads and the construction of buildings at settlements for which the Defense Ministry had issued demolition orders.
Several government ministries concealed the fact that funds were being diverted to the West Bank, reporting them under budgetary clauses such as “miscellaneous general development.” Just as in the case of the Karp Report two decades earlier, Sasson and her Justice Ministry colleagues discovered that the West Bank was being administered under completely separate laws, and those laws, she says, “appeared to me utterly insane.”
Sasson’s report took special note of Avi Maoz, who ran the Construction and Housing Ministry during most of this period. A political activist who early in his career spoke openly of pushing all Arabs out of the West Bank, Maoz helped found a settlement south of Jerusalem during the 1990s and began building a professional alliance with Benjamin Netanyahu, who was then the Israeli ambassador to the United Nations and would soon go on to his first term as prime minister. Years later, Maoz would be instrumental in ensuring Netanyahu’s political survival.
“The picture that emerges in the eye of the beholder is severe,” Sasson wrote in her report. “Instead of the government of Israel deciding on the establishment of settlements in the territories of Judea and Samaria, its place has been taken, from the mid-1990s and onward, by others.” The settlers she wrote, were “the moving force,” but they could not have succeeded without the assistance of“various ministers of construction and housing in the relevant periods, some of them with a blind eye, and some of them with support and encouragement.”
This clandestine network was operating, Sasson wrote, “with massive funding from the State of Israel, without appropriate public transparency, without obligatory criteria. The erection of the unauthorized outposts is being done with violation of the proper procedures and general administrative rules, and in particular, flagrant and ongoing violation of the law.” These violations, Sasson warned, were coming from the government: “It was state and public agencies that broke the law, the rules, the procedures that the state itself had determined.” It was a conflict, she argued, that effectively neutered Israel’s internal checks and balances and posed a grave threat to the nation’s integrity. “The law-enforcement agencies are unable to act against government departments that are themselves breaking the law.”
But, in an echo of Judith Karp’s secret report decades earlier, the Sasson Report, made publicly available in March 2005, had almost no impact. Because she had a mandate directly from the prime minister, Sasson could have believed that her investigation might lead to the dismantling of theillegal outposts that had metastasized throughout the Palestinian territories. But even Sharon, withhis high office, found himself powerless against the machine now in place to protect and expand the settlements in the West Bank — the very machine he had helped to build.
All of this was against the backdrop of the Gaza pullout. Sharon, who began overseeing the removal of settlements from Gaza in August 2005, was the third Israeli prime minister to threaten the settler dream of a Greater Israel, and the effort drew bitter opposition not only from the settlers but also from a growing part of the political establishment. Netanyahu, who had served his first termas prime minister from 1996 to 1999, and who previously voted in favor of a pullout, resigned his position as finance minister in Sharon’s cabinet in protest — and in anticipation of another run for the top job.
The settlers themselves took more active measures. In 2005, the Jewish Department of Shin Bet received intelligence about a plot to slow the Israeli withdrawal from Gaza by using 700 liters of gasoline to blow up vehicles on a major highway. Acting on the tip, officers arrested six men in central Israel. One of them was Bezalel Smotrich, the future minister overseeing civilian affairs in the West Bank.
Smotrich, then 25, was detained and questioned for weeks. Yitzhak Ilan, one of the Shin Bet officers present at the interrogation, says he remained “silent as a fish” throughout — “like an experienced criminal.” He was released without charges, Ilan says, in part because Shin Bet knew putting him on trial might expose the service’s agents inside Jewish extremist groups, and in part because they believed Smotrich was likely to receive little punishment in any case. Shin Bet was very comfortable with the courts when we fought Palestinian terrorism and we got the heavy punishments we wanted, he says. With the Jewish terrorists it was exactly the opposite.
When Netanyahu made his triumphant return as prime minister in 2009, he set out to undermineTalia Sasson’s report, which he and his allies saw as an obstacle to accelerating the settlement campaign. He appointed his own investigative committee, led by Judge Edmond Levy of the Supreme Court, who was known to support the settler cause. But the Levy report, completed in 2012, did not undermine the findings in the Sasson Report — in some ways, it reinforced them. Senior Israeli officials, the committee found, were fully aware of what was happening in the territories, and they were simply denying it for the sake of political expediency. The behavior, they wrote, was not befitting of “a country that has proclaimed the rule of law as a goal.” Netanyahu moved on.
PART III.
A NEW GENERATION
The ascent of a far-right prime minister did little to prevent the virulent, anti-government strain inside the settler movement from spreading. A new generation of Kahanists was taking an even more radical turn, not only against Israeli politicians who might oppose or insufficiently abet them butagainst the very notion of a democratic Israeli state. A group calling itself Hilltop Youth advocated for the total destruction of the Zionist state. Meir Ettinger, named for his grand father Meir Kahane, was one of the Hilltop Youth leaders, and he made his grandfather’s views seem moderate.
Their objective was to tear down Israel’s institutions and to establish “Jewish rule”: anointing a king, building a temple in place of the Jerusalem mosques sacred to Muslims worldwide, imposing a religious regime on all Jews. Ehud Olmert, who served as Israeli prime minister from 2006 to 2009, said in an interview that Hilltop Youth “genuinely, deeply, emotionally believe that this is the right thing to do for Israel. This is a salvation. This is the guarantee for Israel’s future.”
A former member of Hilltop Youth, who has asked to remain anonymous because she fears speaking out could endanger her, recalls how she and her friends used an illegal outpost on a hilltop in the West Bank as a base to lob stones at Palestinian cars. “The Palestinians would call the police, and we would know that we have at least 30 minutes before they arrive, if they arrive. And ift hey do arrive, they won’t arrest anyone. We did this tens of times.” The West Bank police, she says, couldn’t have been less interested in investigating the violence. “When I was young, I thought that I was outsmarting the police because I was clever. Later, I found out that they are either not trying or very stupid.”
The former Hilltop Youth member says she began pulling away from the group as their tactics became more extreme and once Ettinger began speaking openly about murdering Palestinians. She offered to become a police informant, and during a meeting with police intelligence officers in 2015, she described the group’s plans to commit murder — and to harm any Jews that stood in their way. By her account, she told the police about efforts to scout the homes of Palestinians before settling on a target. The police could have begun an investigation, she says, but they weren’t even curious enough to ask her the names of the people plotting the attack.
In 2013, Ettinger and other members of Hilltop Youth formed a secret cell calling itself the Revolt,designed to instigate an insurrection against a government that “prevents us from building the temple, which blocks our way to true and complete redemption.”
During a search of one of the group’s safe houses, Shin Bet investigators discovered the Revolt’s founding documents. “The State of Israel has no right to exist, and therefore we are not bound bythe rules of the game,” one declared. The documents called for an end to the State of Israel andmade it clear that in the new state that would rise in its place, there would be absolutely no room fornon-Jews and for Arabs in particular: “If those non-Jews don’t leave, it will be permissible to killthem, without distinguishing between women, men and children.”
This wasn’t just idle talk. Ettinger and his comrades organized a plan that included timetables andsteps to be taken at each stage. One member even composed a training manual with instructionson how to form terror cells and burn down houses. “In order to prevent the residents fromescaping,” the manual advised, “you can leave burning tires in the entrance to the house.”
The Revolt carried out an early attack in February 2014, firebombing an uninhabited home in asmall Arab village in the West Bank called Silwad, and followed with more arson attacks, theuprooting of olive groves and the destruction of Palestinian granaries. Members of the grouptorched mosques, monasteries and churches, including the Church of the Multiplication of theLoaves and Fishes on the banks of the Sea of Galilee. A police officer spotted Ettinger himselfattacking a herd of sheep belonging to an Arab shepherd. He stoned a sheep and then slaughteredit in front of the shepherd, the officer later testified. “It was shocking,” he said. “There was a sort ofinsanity in it.”
Shin Bet defined the Revolt as an organization that aimed “to undermine the stability of the State ofIsrael through terror and violence, including bodily harm and bloodshed,” according to an internalShin Bet memo, and sought to place several of its members, including Ettinger, underadministrative detention — a measure applied frequently against Arabs.
The state attorney, however, did not approve the request. The U.N. Office for the Coordination ofHumanitarian Affairs (OCHA) documented 323 incidents of violence by settlers against Palestiniansin 2014; Palestinians were injured in 107 of these incidents. By the following year, the Revoltescalated the violence by openly advocating the murder of Arabs.
The Shin Bet and the police identified one of the prominent members of the Revolt, Amiram Ben-Uliel, making him a target of surveillance. But the service failed to prevent the wave of violence thathe unleashed. On the night of July 31, 2015, Ben-Uliel set out on a killing spree in a central WestBank village called Duma. Ben-Uliel prepared a bag with two bottles of incendiary liquid, rags, alighter, a box of matches, gloves and black spray paint. According to the indictment against him,Ben-Uliel sought a home with clear signs of life to ensure that the house he torched was notabandoned. He eventually found the home of Reham and Sa’ad Dawabsheh, a young mother andfather. He opened a window and threw a Molotov cocktail into the home. He fled, and in the blazethat followed, the parents suffered injuries that eventually killed them. Their older son, Ahmad,survived the attack, but their 18-month-old toddler, Ali, was burned to death.
It was always clear, says Akerman, the former Shin Bet official, “that those wild groups would movefrom bullying Arabs to damaging property and trees and eventually would murder people.” He is stillfurious about how the service has handled Jewish terrorism. “Shin Bet knows how to deal with suchgroups, using emergency orders, administrative detention and special methods in interrogation untilthey break,” he says. But although it was perfectly willing to apply those methods to investigatingArab terrorism, the service was more restrained when it came to Jews. “It allowed them to incite,and then they moved on to the next stage and began to torch mosques and churches. Stillundeterred, they entered Duma and burned a family.”
Shin Bet at first claimed to have difficulty locating the killers, even though they were all supposed to be under constant surveillance. When Ben-Uliel and other perpetrators were finally arrested, right-wing politicians gave fiery speeches against Shin Bet and met with the families of the perpetratorsto show their support. Ben-Uliel was sentenced to life in prison, and Ettinger was finally put inadministrative detention, but a fracture was spreading. In December 2015, Hilltop Youth memberscirculated a video clip showing members of the Revolt ecstatically dancing with rifles and pistols,
belting out songs of hatred for Arabs, with one of them stabbing and burning a photograph of themurdered toddler, Ali Dawabsheh. Netanyahu, for his part, denounced the video, which, he said,exposed “the real face of a group that poses danger to Israeli society and security.”
American Friends
The expansion of the settlements had long been an irritant in Israel’s relationship with the UnitedStates, with American officials spending years dutifully warning Netanyahu both in public and inprivate meetings about his support for the enterprise. But the election of Donald Trump in 2016ended all that. His new administration’s Israel policy was led mostly by his son-in-law, JaredKushner, who had a long personal relationship with Netanyahu, a friend of his father’s who hadstayed at their family home in New Jersey. Trump, in a broader regional agenda that lined upperfectly with Netanyahu’s own plans, also hoped to scuttle the nuclear deal with Iran that BarackObama had negotiated and broker diplomatic pacts between Israel and Arab nations that left thematter of a Palestinian state unresolved and off the table.
If there were any questions about the new administration’s position on settlements, they wereanswered once Trump picked his ambassador to Israel. His choice, David Friedman, was abankruptcy lawyer who for years had helped run an American nonprofit that raised millions ofdollars for Beit El, one of the early Gush Emunim settlements in the West Bank and the place whereBezalel Smotrich was raised and educated. The organization, which was also supported by theTrump family, had helped fund schools and other institutions inside Beit El. On the heels of theTrump transition, Friedman referred to Israel’s “alleged occupation” of Palestinian territories andbroke with longstanding U.S. policy by saying “the settlements are part of Israel.”
This didn’t make Friedman a particularly friendly recipient of the warnings regularly delivered by Lt.Gen. Mark Schwartz, the three-star general who in 2019 arrived at the embassy in Jerusalem tocoordinate security between the Israeli government and the Palestinian Authority. A career GreenBeret who had combat deployments in Afghanistan and Iraq and served as deputy commander ofthe Joint Special Operations Command, the military task force with authority over U.S.counterterrorism special missions units, Schwartz wasn’t short on Middle East experience.
But he was immediately shocked by the landscape of the West Bank: settlers acting with impunity, apolice force that was essentially nonexistent outside the settlements and the Israeli Army fanningthe tensions with its own operations. Schwartz recalls how angry he was about what he called thearmy’s “collective punishment” tactics, including the razing of Palestinian homes, which he viewedas gratuitous and counterproductive. “I said, ‘Guys, this isn’t how professional militaries act.’” AsSchwartz saw it, the West Bank was in some ways the American South of the 1960s. But at anymoment the situation could become even more volatile, resulting in the next intifada.
Schwartz is diplomatic when recalling his interactions with Friedman, his former boss. He was a“good listener,” Schwartz says, but when he raised concerns about the settlements, Friedmanwould often deflect by noting “the lack of appreciation by the Palestinian people about what theAmericans are doing for them.” Schwartz also discussed his concerns about settler violence directlywith Shin Bet and I.D.F. officials, he says, but as far as he could tell, Friedman didn’t follow up withthe political leadership. “I never got the sense he went to Netanyahu to discuss it.”
Friedman sees things differently. “I think I had a far broader perspective on acts of violence in Judeaand Samaria” than Schwartz, he says now. “And it was clear that the violence coming fromPalestinians against Israelis overwhelmingly was more prevalent.” He says he “wasn’t concerned
about ‘appreciation’ from the Palestinians; I was concerned by their leadership’s embrace of terrorand unwillingness to control violence.” He declined to discuss any conversations he had with Israeliofficials.
Weeks after Trump lost the 2020 election, Secretary of State Mike Pompeo traveled to Israel for atrip that delivered a number of gifts to Netanyahu and the settler cause. He announced newguidelines requiring that goods imported to the United States from parts of the West Bank belabeled “Made in Israel.” And he flew by helicopter to Psagot, a winery in the West Bank, makinghim the first American secretary of state to visit a settlement. One of the winery’s largeshareholders, the Florida-based Falic family, have donated millions to various projects in thesettlements.
During his lunchtime visit, Pompeo paused to write a note in the winery’s guest book. “May I not bethe last secretary of state to visit this beautiful land,” he wrote.
A Settler Coalition
Benjamin Netanyahu’s determination to become prime minister for an unprecedented sixth termcame with a price: an alliance with a movement that he once shunned, but that had been broughtinto the political mainstream by Israel’s steady drift to the right. Netanyahu, who is now on trial forbribery and other corruption charges, repeatedly failed in his attempts to form a coalition after mostof the parties announced that they were no longer willing to join him. He personally involved himselfin negotiations to ally Itamar Ben-Gvir’s Jewish Power party and Bezalel Smotrich’s ReligiousZionism Party, making them kingmakers for anyone trying to form a coalition government. InNovember 2022, the bet paid off: With the now-critical support of the extreme right, Netanyahureturned to office.
The two men ushered into power by this arrangement were some of the most extreme figures everto hold such high positions in an Israeli cabinet. Shin Bet had monitored Ben-Gvir in the years afterYitzhak Rabin’s murder, and he was arrested on multiple charges including inciting racism andsupporting a terrorist organization. He won acquittals or dismissals in some of the cases, but hewas also convicted several times and served time in prison. During the Second Intifada, he ledprotests calling for extreme measures against Arabs and harassed Israeli politicians he believedwere insufficiently hawkish.
Then Ben-Gvir made a radical change: He went to law school. He also took a job as an aide toMichael Ben-Ari, a Knesset member from the National Union party, which had picked up manyfollowers of the Kach movement. In 2011, after considerable legal wrangling around his criminalrecord, he was admitted to the bar. He changed his hairstyle and clothing to appear moremainstream and began working from the inside, once saying he represented the “soldiers andcivilians who find themselves in legal entanglements due to the security situation in Israel.”Netanyahu made him minister of national security, with authority over the police.
Smotrich also moved into public life after his 2005 arrest by Shin Bet for plotting road blockages tohalt the Israeli withdrawal from Gaza. He made Shin Bet’s Jewish Department a frequent target ofcriticism, complaining that it was wasting time and money investigating crimes carried out by Jews,when the real terrorists were Palestinians. His ultraright allies sometimes referred to the JewishDepartment as Hamakhlaka Hayehudit — the Hebrew phrase for the Gestapo unit that executed Hitler’s Final Solution.
In 2015, while campaigning for a seat in the Knesset, Smotrich said that “every shekel invested inthis department is one less shekel invested in real terrorism and saving lives.” Seven years later,Netanyahu made him both minister of finance and a minister in the Ministry of Defense, in charge ofoverseeing civilian affairs in the West Bank, and he has steadily pushed to seize authority over theterritory from the military. As part of the coalition deal with Netanyahu, Smotrich now has theauthority to appoint one of the senior administrative figures in the West Bank, who helps overseethe building of roads and the enforcement of construction laws. The 2022 election also brought AviMaoz to the Knesset — the former housing-ministry official whom Talia Sasson once marked as ahidden hand of Israeli government support for illegal settlements. Since then, Maoz had joined thefar-right Noam party, using it as a platform to advance racist and homophobic policies. And henever forgot, or forgave, Sasson. On “International Anti-Corruption Day” in 2022, Maoz took to thelectern of the Knesset and denounced Sasson’s report of nearly two decades earlier, saying it waswritten “with a hatred of the settlements and a desire to harm them.” This, he said, was “publiccorruption of the highest order, for which people like Talia Sasson should be prosecuted.”
Days after assuming his own new position, Ben-Gvir ordered the police to remove Palestinian flagsfrom public spaces in Israel, saying they “incite and encourage terrorism.” Smotrich, for his part,ordered drastic cuts in payments to the Palestinian Authority — a move that led the Shin Bet andthe I.D.F. intelligence division to raise concerns that the cuts would interfere with the PalestinianAuthority’s own efforts to police and prevent Palestinian terrorism.
Weeks after the new cabinet was sworn in, the Judea and Samaria division of the I.D.F. distributedan instructional video to the soldiers of a ground unit about to be deployed in the West Bank. Titled“Operational Challenge: The Farms,” the video depicts settlers as peaceful farmers living pastorallives, feeding goats and herding sheep and cows, in dangerous circumstances. The illegal outpostsmultiplying around the West Bank are “small and isolated places of settlement, each with a handfulof residents, a few of them — or none at all — bearing arms, the means of defense meager ornonexistent.”
It is the settlers, according to the video, who are under constant threat of attack, whether it be“penetration of the farm by a terrorist, an attack against a shepherd in the pastures, arson” or“destruction of property” — threats from which the soldiers of the I.D.F. must protect them. Thecommander of each army company guarding each farm must, the video says, “link up with theperson in charge of security and to maintain communications”; soldiers and officers are encouragedto cultivate a close and intimate relationship with the settlers. “The informal,” viewers are told, “ismuch more important than the formal.”
The video addresses many matters of security, but it never addresses the question of law. When weasked the commander of the division that produced the video, Brig. Gen. Avi Bluth, why the I.D.F.was promoting the military support of settlements that are illegal under Israeli law, he directlyasserted that the farms were indeed legal and offered to arrange for us to tour some of them. Later,a spokesman for the army apologized for the general’s remarks, acknowledged that the farms wereillegal and announced that the I.D.F. would no longer be promoting the video. This May, Bluth wasnonetheless subsequently promoted to head Israel’s Central Command, responsible for all Israelitroops in central Israel and the West Bank.
In August, Bluth will replace Maj. Gen. Yehuda Fox, who during his final months in charge of theWest Bank has seen a near-total breakdown of law enforcement in his area of command. In lateOctober, Fox wrote a letter to his boss, the chief of Israel’s military staff, saying that the surge ofJewish terrorism carried out in revenge for the Oct. 7 attacks “could set the West Bank on fire.” TheI.D.F. is the highest security authority in the West Bank, but the military’s top commander put the
blame squarely on the police — who ultimately answer to Ben-Gvir. Fox said he had established aspecial task force to deal with Jewish terrorism, but investigating and arresting the perpetrators is“entirely in the hands of the Israeli police.”
And, he wrote, they aren’t doing their jobs.
‘Only One Way Forward’
When the day came early this January for the Supreme Court to hear the case brought by thepeople of Khirbet Zanuta, the displaced villagers arrived an hour late. They had received entrypermits from the District Coordination Office to attend the hearing but were delayed by securityforces before reaching the checkpoint separating Israel from the West Bank. Their lawyer, QuamarMishirqi-Assad, noting that their struggle to attend their own hearing spoke to the essence of theirpetition, insisted that the hearing couldn’t proceed without them. The judges agreed to wait.
The villagers finally were led into the courtroom, and Mishirqi-Assad began presenting the case.The proceedings were in Hebrew, so most of the villagers were unable to follow the arguments thatdescribed the daily terrors inflicted by settlers and the glaring absence of any law-enforcementefforts to stop them.
The lawyers representing the military and the police denied the claims of abuse and failure toenforce the law. When a judge asked what operational steps would be in place if villagers wanted toreturn, one of the lawyers for the state said they could already — there was no order preventingthem from doing so.
The next to speak was Col. Roi Zweig-Lavi, the Central Command’s Operations Directorate officer.He said that many of these incidents involved false claims. In fact, he said, some of the villagershad probably destroyed their own homes, because of an “internal issue.” Now they were blamingthe settlers to escape the consequences of their own actions.
Colonel Zweig-Lavi’s own views about the settlements, and his role in protecting them, were wellknown. In a 2022 speech, he told a group of yeshiva students in the West Bank that “the army andthe settlements are one and the same.”
In early May, the court ordered the state to explain why the police failed to stop the attacks anddeclared that the villagers have a right to return to their homes. The court also ordered the state toprovide details for how they would ensure the safe return of the villagers. It is now the state’s turn todecide how it will comply. Or if it will comply.
By the time the Supreme Court issued its rulings, the United States had finally taken action todirectly pressure the Netanyahu government about the violent settlers. On Feb. 1, the White Houseissued an executive order imposing sanctions on four settlers for “engaging in terrorist activity,”among other things, in the West Bank. One of the four was Yinon Levi, the owner of Meitarim Farmnear Hebron and the man American and Israeli officials believe orchestrated the campaign ofviolence and intimidation against the villagers of Khirbet Zanuta. The British government issued itsown sanctions shortly after, saying in a statement that Israel’s government had created “anenvironment of near-total impunity for settler extremists in the West Bank”
The White House’s move against individual settlers, a first by an American administration, was metwith a combination of anger and ridicule by ministers in Netanyahu’s government. Smotrich calledthe Biden administration’s allegations against Levi and others “utterly specious” and said he wouldwork with Israeli banks to resist complying with the sanctions. One message that circulated in anopen Hilltop Youth WhatsApp channel said that Levi and his family would not be abandoned. “Thepeople of Israel are mobilizing for them,” it said.
American officials bristle when confronted with the question of whether the government’s actionsare just token measures taken by an embattled American president hemorrhaging support at homefor his Israel policy. They won’t end the violence, they say, but they are a signal to the Netanyahugovernment about the position of the United States: that the West Bank could boil over, and it couldsoon be the latest front of an expanding regional Middle East war since Oct. 7.
But war might just be the goal. Ehud Olmert, the former Israeli prime minister, said he believes thatmany members of the ultraright in Israel “want war.” They “want intifada,” he says, “because it is theultimate proof that there is no way of making peace with the Palestinians and there is only one way forward — to destroy them.”

ASSEMBLEA NAZIONALE
Causa sciopero dei treni e dunque necessità di assicurare un buon collegamento streaming, è stato necessario modificare il luogo dell’Assemblea Nazionale.
L’Assemblea Nazionale si terrà regolarmente agli stessi orari e con gli stessi programmi ma presso:
il Centro Internazionale di Brera
Via Formentini, 10 Milano
Trovate qui il programma completo.
Vi ricordiamo che per partecipare è necessario registrarsi, qui trovate il link per la registrazione:
Vi aspettiamo numerosi.

Radio Popolare intervista Luciano Belli Paci
Trovate qui l’intervista di Radio Popolare a Luciano Belli Paci di oggi 23 Marzo 2024
Buon ascolto

SINISTRA PER ISRAELE, DAL 7 OTTOBRE ALLA PACE, la presentazione a Milano del Manifesto
Claudio Scaccianoce , Gli Stati Generali
22 Marzo 2024
Si è tenuta a Milano nella serata di giovedì 21 marzo la presentazione del manifesto nazionale “Dal 7 ottobre alla pace”, documento programmatico di “Sinistra per Israele”.
L’evento è stato ospitato nei locali milanesi del Circolo Caldara di via De Amicis, ambito protetto da un nutrito schieramento di forze dell’ordine pronte a tutelare i partecipanti da eventuali contestazioni che in qualche modo erano state annunciate nel corso della giornata.
Per prima cosa cerchiamo di capire cosa sia “Sinistra per Israele”.
Leggiamo nel sito internet dell’associazione: “Sinistra per Israele raccoglie il testimone dal gruppo omonimo costituitosi all’indomani della guerra dei sei giorni, si propone due obiettivi: sviluppare la conoscenza delle posizioni della sinistra israeliana e la solidarietà nei confronti del “campo della pace” in Israele, contrastare i pregiudizi antiisraeliani, antisionisti e talora perfino antisemiti nella sinistra italiana”.
Nel novembre 2005 Sinistra per Israele fissa undici principi che ne definiscono il campo d’azione in modo molto netto e chiaro, una sorta di statuto e di road map. (http://www.sinistraperisraele.com/chi-siamo/#)
Primi firmatari Giorgio Napolitano, Giuliano Amato, Piero Fassino, Sandra Bonsanti, Enrico Boselli, Peppino Caldarola, Furio Colombo, Umberto Eco, Emanuele Fiano, Gad Lerner, Adriano Sofri, Walter Veltroni, Gustavo Zagrebelsky, Giorgina Arian Levi, Luciano Belli Paci, Felice Carlo Besostri, David Bidussa, Daniele Bonifati, Ugo Caffaz, Marco Campione, Massimo Chierici, Gabriele Eschenazi, Claudia Fellus, Giuseppe Franchetti, Giorgio Gomel, Paola Jarach Bedarida, Victor Magiar, Francesco Mariotti, Enrico Modigliani, Fabio Nicolucci, Francesca Romani, Bruno Segre.
Rileggere oggi i punti programmatici del 2005 aiuta molto la corretta comprensione del Manifesto nazionale “dal 7 ottobre alla pace” presentato in questo marzo 2024.
In questi momenti, traumatici e divisivi, fare sintesi espone al rischio di non sottolineare adeguatamente qualche passaggio. Quando ogni parola pesa è preferibile proporre i documenti nella loro interezza, limitando il lavoro di sintesi giornalistica alle opinioni e alle dichiarazioni dei singoli partecipanti.

Il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre scorso e le drammatiche conseguenze dell’operazione militare sulla popolazione palestinese hanno determinato una spirale che va immediatamente interrotta attraverso un accordo di cessate il fuoco che consenta la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e l’inoltro alla popolazione civile di Gaza, in condizioni di sicurezza, degli aiuti umanitari.
È la drammaticità degli eventi a imporre l’urgenza di una risposta razionale, progressista, tesa ad affermare il principio di una pace possibile, indispensabile per tutti i popoli della regione. La risposta che auspichiamo poggia su due ineludibili presupposti.
Il primo riguarda il giudizio sulla strage del 7 ottobre, che non viene dal nulla ma che, al contrario, si inscrive nella strategia di Hamas che, sin dal suo statuto fondativo, rifiuta ogni forma di compromesso e ogni prospettiva di pace, perseguendo la cancellazione dello Stato di Israele e predicando l’uccisione degli ebrei. Hamas tuttavia non rappresenta tutto il popolo palestinese. A maggior ragione la ricerca di una soluzione di pace va perseguita con determinazione.
Per rimettere in moto il percorso di pace — è il secondo presupposto — occorrono leadership credibili. Innanzitutto, è necessario che una rinnovata leadership palestinese dell’ANP — unico interlocutore per la pace oggi internazionalmente riconosciuto — superi le ambiguità che hanno concorso al fallimento degli accordi di Oslo. Così come sono essenziali un atteggiamento cooperativo del mondo arabo, sulla scorta degli Accordi di Abramo, e un impegno attivo dell’intera comunità internazionale, superando troppe inerzie. Allo stesso tempo, è necessaria una nuova leadership israeliana che creda nella convivenza di due Stati per i due Popoli. Le politiche perseguite dal governo Netanyahu, la prosecuzione dell’occupazione della Cisgiordania, l’espansione degli insediamenti di coloni e il pervicace rifiuto della nascita dello Stato palestinese sono incompatibili con soluzioni di pace.
Anche per queste ragioni di stringente attualità, Sinistra per Israele — che fin dalla sua fondazione si è battuta per una soluzione di convivenza e di pace — ribadisce oggi i seguenti principi e obiettivi, rivolgendosi a tutti coloro che in questi mesi terribili condividono la nostra medesima urgenza.
— Riaffermiamo come irrinunciabile il diritto di Israele a esistere, riconosciuto dai suoi vicini, e a vivere in sicurezza nei propri confini. Si tratta di un diritto non scontato, ma anzi minacciato quotidianamente da organizzazioni terroristiche e forze politiche radicali in ogni parte del mondo, manovrate soprattutto dal regime iraniano. Il diritto di Israele a esistere è tutt’uno con il diritto del popolo palestinese a un proprio Stato indipendente a fianco di Israele, come stabilito dalle Nazioni Unite e dagli accordi di Oslo e Washington del 1993. Proprio perché su quella terra vivono due diritti ugualmente legittimi, l’obiettivo di «due popoli due Stati», il mutuo riconoscimento di due ragioni, è ancora e sempre il nostro orizzonte e la soluzione da perseguire.
— Le radici di Israele affondano in una storia che i progressisti europei devono sapere riconoscere e valorizzare. Il sionismo è stato il legittimo movimento di liberazione nazionale e sociale del popolo ebraico e in esso sono vissuti e tuttora vivono i valori di uguaglianza, giustizia, liberazione umana della sinistra democratica e del progressismo. Vivono, come nella straordinaria esperienza dei kibbutz, il progetto e il sogno di una società più giusta, di donne e uomini liberi ed eguali. Soltanto la conoscenza delle radici di Israele può arginare i pregiudizi anti-sionisti e anti-israeliani che albergano nella società italiana, anche a sinistra e nel campo progressista, e che si manifestano attraverso forme antiche e nuove di delegittimazione, di ostilità, quando non di aperto antisemitismo.
— Come per tutte le democrazie, il giudizio sullo Stato di Israele non deve coincidere con quello sul suo governo in carica. Israele è fin dalla sua nascita una democrazia fondata su valori liberali e progressisti, in una regione fortemente segnata da regimi autocratici. Anche le continue e straordinarie mobilitazioni della società israeliana testimoniano una robusta e radicata cultura democratica e la possibilità concreta di restituire a Israele una politica aperta a un vero processo di pace. Il più drastico giudizio sulle politiche di Netanyahu non può in alcun modo tradursi nella negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, né tantomeno nella colpevolizzazione degli ebrei che vivono in ogni parte del mondo.
Questo è il nostro impegno per la pace, oggi e sempre, per due Stati per i due popoli.

L’evento è stato presieduto da Luciano Belli Paci che ha ringraziato per la partecipazione il pubblico intervenuto, numeroso forse oltre ogni aspettativa, che ha gremito la sala conferenze di via De Amicis, così come gli organizzatori e le forze dell’ordine “presenti qui con noi perché viviamo tempi molto difficili”.
Prima a prendere la parola l’on. Lia Quartapelle (componente della III commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati).

“Parto da una frase che ho sentito ripetere molte volte in queste giornate, dal 7 di ottobre a oggi. Immagino che l’abbiate sentita in tanti anche voi e che forse l’abbiate anche pronunciata. —Non vedo altra alternativa, non vedo come potremmo fare altrimenti—
Questa è una frase che mi è stata detta da diversi amici israeliani e da rappresentanti delle istituzioni, ma che ho sentito pronunciare anche nel dibattito pubblico da parte dei sostenitori della causa palestinese. Anch’io, come penso molti di voi qui questa sera, davanti a questa tragedia della guerra tra Israele e Hamas, che è una parte di una tragedia più ampia, la guerra israelo-palestinese, sono arrivata a chiedermi se è vero che non esiste un’altra alternativa, sono arrivata a chiedermi se vedremo mai la fine di questa storia nel corso della nostra vita. Se siamo qui questa sera, tutti insieme, è perché noi speriamo e vogliamo che ci sia un’alternativa.
“Sinistra per Israele” è un’associazione politica, è un percorso politico, perché l’alternativa al terrorismo di Hamas si fa con la politica. L’alternativa alla guerra infinita di Netanyahu con il suo carico di morte e di distruzione, con la mancata sicurezza e normalità per Israele si deve raggiungere attraverso la politica.
Riconoscere che nel Medio Oriente ci sono due ragioni che devono convivere vuole dire proporre un’alternativa. Per Israele deve esistere un’alternativa perchè non è possibile che continui a vivere un’esistenza perennemente minacciata e messa in discussione dai propri vicini. Altrettanto vale per i palestinesi, anche per loro deve esserci un’alternativa al terrorismo di Hamas.
In questi giorni, in queste settimane, da quando abbiamo lanciato questo appello, in tanti ci hanno chiesto perché “Sinistra per Israele”. Lo diceva prima Luciano Belli Paci, questo nome sembra una provocazione, è stato vissuto da alcuni come una provocazione. C’è una minoranza che ritiene (lo sentiamo ripetere anche dai contestatori che sono in strada) che l’accostamento delle parole sinistra e Israele sia una blasfemia. Noi nasciamo anche per contrastare l’ignoranza che c’è dietro questa idea. Perché Israele è nato dalla sinistra, è nato dalla sinistra russa, dalla sinistra ucraina e dalla sinistra europea.
“Sinistra per Israele” perché noi non vogliamo che in Italia succeda come in Francia, dove gli ebrei sono minacciati e portati a fuggire. Quello che abbiamo visto all’Università di Torino in questi ultimi giorni è un segnale molto profondo e molto preoccupante.
Israele è una storia di valori della sinistra, una storia di resistenza, di condivisione, di socialismo, di emancipazione, di patriottismo. Sinistra e Israele stanno insieme perché chi ha provato a dare sicurezza a Israele è stata la sinistra, è stato Rabin, quello straordinario premier che ha pagato con la vita la sua volontà di pace e di sicurezza per il suo Paese. “Sinistra per Israele” non è solo radici, non è solo tradizione nobile, è anche il presente e speriamo il futuro.
In Israele prima del 7 di ottobre ci sono state 29 settimane di manifestazioni per la democrazia, una cosa che non si era mai vista prima, qualcosa che ha scaldato davvero il cuore in una fase in cui le democrazie in tutto il mondo vivono una crisi molto profonda. “Sinistra per Israele” infine è perché chi mette in pericolo Israele in questo momento (al di là di Hamas) è Netanyahu, un uomo che ha isolato Israele come mai prima per garantirsi la sopravvivenza politica, pronto a continuare il disastro strategico che purtroppo stiamo vivendo.
Noi continueremo in questo percorso che è un percorso di dialogo tra la sinistra italiana e la sinistra israeliana, è un percorso di dialogo sulla democrazia, è un percorso che speriamo diventi anche un dialogo di pace con gli stessi palestinesi. Speriamo che voi vogliate essere con noi anche nelle prossime tappe perché c’è bisogno di “Sinistra per Israele”.
La serata è proseguita con un saluto di Roberto Cenati, per tredici anni Presidente dell’ANPI milanese (Associazione nazionale partigiani d’Italia) recentemente dimessosi dicendosi in dissenso con alcune parole d’ordine espresse in diverse manifestazioni dell’associazione sul tema del conflitto israelo-palestinese e in particolare modo sull’uso del termine “genocidio”.

“Condivido pienamente il documento illustrato da Lia Quartapelle nella sua introduzione. Il 2 marzo ho rassegnato le dimissioni da Presidente dell’Ambito Provinciale di Milano ANPI e da Presidente del Comitato Permanente Antifascista, che è l’organismo che promuove le celebrazioni del 25 aprile ogni anno oltre a promuovere il Giorno della Memoria. È stata per me una decisione molto sofferta maturata in disaccordo con la linea tracciata dall’ANPI nazionale che ha inserito nelle sue parole d’ordine e nei suoi slogan “impedire il genocidio”.
Genocidio è un termine che deve essere usato con estrema attenzione, con estrema cura, perché io sono convinto che, nonostante di quello che sta succedendo, a Gaza non si sta verificando il genocidio di un popolo…
Io credo che la parola genocidio sia profondamente sbagliata in questa situazione pur grave che c’è nella striscia di Gaza… il termine ha un significato ben preciso, vuol dire “sterminio programmato scientifico di un intero popolo, dalla prima all’ultima persona”, come è stata la Shoah. Non è questo l’obiettivo che ci stanno proponendo le forze israeliane, ma quello di eliminare Hamas, non certo di sterminare un popolo…”
E’ quindi seguito l’intervento del Segretario di “Sinistra per Israele”, Emanuele Fiano che ha proposto un lungo e articolato intervento caratterizzato anche da una attenta ricostruzione storica delle relazioni tra israeliani e palestinesi.

“… La storia che sta dietro i drammatici giorni che vive il Medio Oriente è un susseguirsi di molti, moltissimi, troppi decenni di guerre, di armistizi, di accordi, di tragedie, di stragi, di attentati, di ecatombe… Niente di ciò che è avvenuto prima di noi, prima di questa sera, è slegato da ciò che accade ogni giorno sotto i nostri occhi.
… Nessuno di noi potrà mai dimenticare le immagini che ha visto, se le avete viste, del massacro sadico e disumano del 7 ottobre nel sud Israele. Nessuno di noi potrà dimenticare le immagini e i filmati delle violenze sessuali, dello strazio dei corpi, delle mutilazioni. Delle case bruciate con dentro le persone, delle grida “all’ebreo, all’ebreo”, dei civili che entrano in territorio israeliano al seguito dei terroristi armati di Hamas e che anch’essi come loro compiono violenza. Nessuno di noi può far finta di non sapere come quegli attimi e quelle violenze hanno acceso nella percezione di Israele e degli ebrei nel mondo una lampadina che rischiarava il ricordo dei tempi terribili del secolo scorso.
…Nessuno di noi può dimenticare le immagini e le sofferenze che si riferiscono oggi alla popolazione civile di Gaza. Pur conoscendo e sapendo della responsabilità di Hamas, dell’uso dei civili come scudo, delle infrastrutture militari di Hamas, delle loro rampe di lancio, dei magazzini delle loro armi, dei rifugi dei loro capi mescolati o costruiti dentro o sotto le infrastrutture civili, sanitarie e religiose, va detto tutto questo, non possiamo essere ciechi di fronte alla violenza tremenda, ai lutti spaventosi, alla sofferenza per fame e privazioni che soffre da molti mesi la popolazione civile di Gaza.
Di fronte a tutto questo, “Sinistra per Israele” lo ha scritto nel manifesto, noi chiediamo un cessate il fuoco che permetta la liberazione degli ostaggi israeliani, questo tassello dimenticato di questi orrori, che possa permettere ogni aiuto possibile, umanitario alla popolazione.
… Quello che oggi appare lontanissimo, e cioè la convivenza nella pace tra due Stati per i due popoli, rimane per noi l’unico obiettivo possibile. Esso necessita di un cambio politico del governo dello Stato di Israele, che ovviamente ha sfidato la volontà democratica dei suoi cittadini, ed anche un cambio di forza, di atteggiamento e di coerenza da parte dell’autorità nazionale palestinese e di un cambio di atteggiamento dei paesi arabi moderati, che pure avevano iniziato un percorso, oltre a un cambio di ruolo delle Nazioni Unite che non hanno in questo momento un atteggiamento equilibrato su questo conflitto.
… Noi continueremo a considerare come primario l’obiettivo di una pace tra i due popoli in due Stati. Rimane a tutt’oggi un obiettivo che pare a ognuno di noi difficilissimo, se non irrinunciabile, ma rimane lo stesso.
E’ stato quindi il momento del collegamento con Israele e con Manuela Dviri, nota giornalista e scrittrice italiana naturalizzata israeliana, che da moltissimi anni risiede in Israele.
In un dialogo a distanza con Lia Quartapelle Manuela ha ripercorso i momenti immediatamente successivi alle stragi del 7 ottobre.

“Il 7 di ottobre è arrivato per Israele e noi in qualche modo siamo ancora fermi a quel 7 ottobre. Forse per la prima volta abbiamo sentito in modo così forte il pericolo esistenziale di Israele, cioè il pericolo che Israele potesse non esistere più perché quello che abbiamo visto quel giorno, e ci abbiamo messo parecchi giorni a vederlo, a capirlo, era un odio che non immaginavamo che esistesse.
Io vivo in Israele ormai da più di 50 anni, le guerre le ho viste come le hanno viste e superate le persone della mia età, ma questa volta è stata una cosa completamente diversa. Abbiamo provato una grande paura e anche una specie di vergogna. Com’è possibile che non ci fosse nessuno che ci potesse salvare, che potesse salvare le persone che erano lì di fronte alla striscia di Gaza? Dov’era l’esercito? …Sono stati dei giorni terribili che nessuno di noi ha ancora dimenticato.
… Credi ancora nella pace? Diceva il vecchio Simon Peres che il pessimista e l’ottimista moriranno lo stesso giorno, ma l’ottimista avrà vissuto meglio. L’ottimismo è quello a cui dobbiamo credere, dobbiamo crederci anche se sembra veramente difficile”.
Al termine di un saluto dell’on. Ivan Scalfarono di Italia Viva e del console onorario di Israele in Italia Marco Carrai, le conclusioni sono state esposte dall’on. Piero Fassino.

“ Siamo tante e tanti questa sera. Questo dimostra che “Sinistra per Israele” risponde a un’esigenza, l’esigenza di far sentire la voce di quanti a sinistra credono in noi. “Sinistra per Israele”, come è stato ricordato bene da Lia e da Lele, ha una storia lunga, e saluto anche io Franchetti che ebbe l’intuizione di dare vita a questa associazione tantissimi anni fa.
Questa sigla oggi appare a chi non conosce la storia, a chi non sa, quasi una forma di provocazione. E allora bisogna dire subito una cosa chiara. “Sinistra per Israele” non significa sinistra per Netanyahu. È un punto chiaro per noi, forse non è chiaro invece per chi ci guarda, per coloro che ci guardano e pensano che avere nella nostra sigla la Stella di Davide significa che noi siamo – acriticamente – a sostegno di qualsiasi cosa Israele faccia o dica. Bene, non è così.
…Io penso che noi siamo di fronte a una situazione che ha conosciuto un arretramento drammatico, perché siamo tornati a prima di Madrid. Abbiamo invece il dovere di fare una battaglia perché non si smarrisca l’unica strada possibile. Quello che è successo ha scavato un solco profondo di rancore, di odio, di desiderio di vendetta, di sfiducia che sarà difficile da colmare.
Dovremo farlo, ma bisogna sapere che sarà molto complicato. Però non c’è un’altra strada. L’unica strada possibile è quella di riconoscere che ci sono due ragioni da far convivere e che quindi la coesistenza dei due stati è l’unica strada che può dare quella stabilità e quella pace che fino ad oggi non c’è.
…Io credo che noi dobbiamo dire con grande chiarezza, perché è coerente con tutto quello che abbiamo detto sinora, che se si vuole fare la pace abbiamo bisogno di una nuova leadership israeliana di pace. Ma dire questo ed essere molto severi con Netanyahu non può significare il negare il diritto di Israele di esistere.
… Dobbiamo combattere contro chi ha queste idee, anche per contrastare il paradosso secondo cui adesso il difensore migliore di Israele è la destra, la destra che è erede di quelli che li hanno mandati nelle camere a gas. Per carità, va bene tutto. Se la destra italiana ed europea ha cambiato posizione e oggi riconosce il valore israeliano siamo felici, ma non è che resettiamo la memoria.
… Nel nostro paese noi abbiamo bisogno di mettere in campo un’iniziativa politica, come stiamo facendo, che deve avere un’attenzione culturale, pedagogica, formativa, perché tutto quello che abbiamo detto questa sera contrasti con quel patrimonio purtroppo largamente diffuso, non dico comune, di pregiudizi manichei, stereotipi, di rappresentazioni di comodo che naturalmente vengono legittimate dal dramma che si è consumato a Gaza. Ma è esattamente questo ciò che noi dobbiamo sconfiggere e non accettare e quindi fare in modo che a Gaza ci si fermi. E a partire dal cessate il fuoco si imbocchi in una strada diversa, una strada che può consentire un’evoluzione politica in Israele.
NdR: I passi “virgolettati” riportati in questo articolo sono la fedele trascrizione di dichiarazioni raccolte tramite registrazione vocale. Ovviamente si tratta di stralci di esposizioni molto più estese che sarebbe stato impossibile trascrivere nella loro completezza per motivi di spazio redazionale.
Coloro che avessero il desiderio di ascoltare in versione integrale il convegno di “Sinistra per Israele” possono farlo attivando questo link: https://www.radioradicale.it/scheda/723918/presentazione-del-manifesto-nazionale-dal-7-ottobre-alla-pace
Saranno condotti alla benemerita pagina di Radio Radicale che ha curato la registrazione integrale della serata.


Presentato a Roma il Manifesto Nazionale “Dal 7 Ottobre alla Pace” di Sinistra per Israele
Massimiliano Boni da riflessimenorah.com
Si è svolto ieri pomeriggio a Roma, presso il palazzo della Provincia, il lancio pubblico del manifesto di Sinistra per Israele “dal 7 ottobre alla pace”. L’appuntamento, organizzato dalla sezione romana di Sinistra per Israele, ha visto la partecipazione di oltre 120 persone venute ad ascoltare gli interventi di alcuni degli oltre 1200 aderenti al manifesto.
Moderati da Victor Magiar, Flavia Di Castro e Aurelio Mancuso, e dopo una breve introduzione di Massimiliano Boni, il primo intervento è stato di Silvia Berti, storica, che ha evidenziato il grande dolore provato in questi tempi in cui Israele, colpito dal terrorismo di Hamas, subisce anche l’offensiva ideologica di chi sovverte il significato delle parole, utilizzando ad esempio il termine sionista come un’offesa, cancellando così una lunga tradizione che vede il sionismo nato all’interno del pensiero socialista, e che si esprime purtroppo soprattutto nelle università.

Berti, dopo aver ricordato le varie posizioni espresse sul conflitto negli Stati Uniti, ha concluso il suo intervento spiegando che la sua convinta adesione al manifesto è mossa anche dalla necessità di promuovere una nuova leadership politica in Medio Oriente, ma soprattutto dal dovere morale di ciascuno di impegnarsi perché venga impedito un nuovo tentativo di sterminio degli ebrei, dopo quello della Shoah.
Anselmo Calò, imprenditore e già vice presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, ha provato a spiegare il sentimento provato oggi dagli israeliani, smarriti dopo il 7 ottobre, anche perché alle loro spalle non è presente la lunga storia di persecuzioni e pogrom come quella conosciuta dagli ebrei europei. È per questo che dopo l’attacco di Hamas gli israeliani vivono ancora una situazione di incertezza e di timore per la stessa sussistenza dello Stato ebraico, oltre che per la loro personale incolumità.

Calò ha ricordato inoltre che sono oltre 150.000 i cittadini israeliani che ancora non possono fare il ritorno nelle loro case e che se tale situazione di incertezza e di timore non verrà eliminata non sarà possibile neppure percorrere la strada per la pace. Strada, ha concluso, sbarrata anche dall’attuale governo Netanyahu, influenzato e guidato dall’ala più estremista, ispirata a un messianismo fanatico che, scontrandosi con quello islamico, impedisce ogni soluzione politica.
Valentina Caracciolo, assessore Pd al secondo municipio di Roma, ha spiegato come abbia aderito fin dall’inizio al manifesto, nel quale si riconosce in pieno, specialmente nell’obiettivo di riavviare un percorso che porti alla formazione di due Stati per due popoli, il che significa che innanzitutto occorre il pieno riconoscimento dello Stato ebraico e del suo diritto a vivere in sicurezza.

Ha poi evidenziato come si stia ormai facendo un uso virale e superficiale di parole come genocidio o un uso dispregiativo della parola sionista. Anche durante la celebrazione dello scorso 8 marzo è stato evidente il tentativo di molte organizzazioni femministe di passare sotto silenzio la violenza ripetuta e terribile subita dalle donne israeliane. Sinistra per Israele deve porsi dunque anche l’obiettivo di portare le istanze del manifesto all’interno del Partito democratico, dove purtroppo a volte si rischia che passino letture superficiali e sbagliate; nonché sostenere, in Israele, tutti i cittadini che da oltre un anno si battono per il cambio di governo.
Valeria Fedeli, già vice presidente Pd del Senato, ha evidenziato che il manifesto di Sinistra per Israele ha soprattutto tre pregi: la chiarezza con cui sottolinea l’obiettivo di due popoli per due Stati; l’efficace ricostruzione storica del percorso intrapreso, che già prima degli accordi di Oslo ha sempre sostenuto le ragioni dei due popoli; e infine la sottolineatura delle radici comuni fra la sinistra e il sionismo.

Ha poi evidenziato con preoccupazione la violenza registrata negli ultimi giorni, con gli attacchi sulla stampa a Liliana Segre, e quelli fisici che hanno impedito a Maurizio Molinari e David Parenzo di parlare in due atenei italiani.
Si pone dunque la necessità, innanzitutto per la nostra Repubblica, di intervenire nei programmi scolastici, ha concluso Fedeli, facendo in modo, ad esempio, che nelle scuole si arrivi a studiare anche il ’900, per comprendere la storia degli ebrei e del nostro passato.
Claudia Mancina, filosofa, ha evidenziato il pericolo che il radicalismo ideologico si diffonda negli atenei italiani, così come sta prendendo piede negli Stati Uniti. A questa forma di antisemitismo sembra saldarsi anche una matrice antioccidentale, che fa di Israele l’avamposto dell’occidente in Medio Oriente.

Quanto all’obiettivo politico del manifesto, la nascita di due Stati per due popoli, ha rimarcato come seppure si riuscirà a sradicare il terrorismo di Hamas da Gaza, occorrerà poi riuscire a sradicare anche l’ideologia antioccidentale dai giovani palestinesi.
Gennaro Migliore, parlamentare di Italia Viva, ha sottolineato come Sinistra per Israele debba sapersi porre senza timore l’obiettivo di fare del manifesto una piattaforma di azione politica. Ha ricordato come nella sua storia politica è stato sempre presente, fin dall’inizio, l’importanza della tutela di Israele.

Quanto alla situazione attuale, ha evidenziato i collegamenti di Hamas con l’Iran, gli Houti e altre organizzazioni terroristiche e che la sua gestione del territorio a Gaza è simile a quella delle organizzazioni mafiose. Si è detto pertanto favorevole all’inasprimento delle sanzioni contro l’Iran e al tempo stesso ha affermato quanto sia importante, anche a sinistra, riconoscere l’importanza degli accordi di Abramo. Ha infine espresso un giudizio severo sul governo Netanyahu e, guardando alla politica italiana, ha sollevato dubbi circa la possibilità che si possa creare un’alleanza a sinistra fra partiti che non condividono le linee generali di politica estera.
Andrea Romano, docente universitario e già parlamentare Pd, ha evidenziato come il manifesto esprima in maniera razionale un progetto politico progressista e che la sua utilità stia anche nel mettere in guardia dal rischio presente di antisemitismo a sinistra, un rischio che si riconosce ad esempio in posizioni antioccidentali. Al contrario, la realtà di Israele dimostra che nel paese esiste una componente robusta contraria a Netanyahu e che essa va sostenuta contro il governo attuale animato da ideologie razziste. Ha ricordato poi come L’Europa di oggi non debba dimenticare di essere stata costruita sulle macerie della seconda guerra mondiale e in particolare della Shoah.

Sostenere Israele oggi, ha spiegato, significa anche evidenziare come l’identità ebraica non vada legata, come spesso tendono a pensare i detrattori di Israele, a un’immagine esclusivamente vittimistica. Ha concluso spiegando che il manifesto di Sinistra per Israele diventi uno strumento di azione politica all’interno della sinistra italiana.

Ha chiuso i lavori Piero Fassino, che ha evidenziato come la riunione rappresenti essa stessa un atto politico, capace di imporsi a quelle frange estremiste che fino all’ultimo hanno tentato di impedirla. A tal proposito ha condannato fermamente la decisione del Senato accademico dell’università statale di Torino di ritirarsi dal bando di concorso indetto dal ministro dal ministero degli esteri e della cooperazione con le università israeliane. Ha poi ripercorso la nascita e gli obiettivi di Sinistra per Israele, sorta già dopo la Guerra dei sei giorni, per dare uno strumento a chi riteneva necessario difendere Israele nella sinistra italiana. Ricordato che il sionismo di Theodor Herzl nasce all’interno dei movimenti socialisti di fine 800, e che il rapporto fra gli ebrei e la sinistra è lungo e non privo di contraddizioni (come dimostrano le persecuzioni staliniste degli anni 50), ha sottolineato come Israele oggi sia una realtà democratica costruita sul modello occidentale e che Sinistra per Israele da sempre si batte perché si riconosca a due popoli di avere ciascuno il diritto ad uno Stato e a vivere in sicurezza, il che significa innanzitutto osteggiare qualsiasi forma di criminalizzazione dello Stato ebraico. Ha poi sottolineato come la guerra a Gaza, che certo può essere criticata in alcuni suoi aspetti e nelle sue modalità di conduzione, non può tuttavia essere in alcun modo paragonata all’attacco di Hamas del 7 ottobre, perché ciò equivarrebbe a mettere sullo stesso piano il bombardamento di Dresda con lo sterminio realizzata da Auschwitz o, detto altrimenti, equivarrebbe a mettere sullo stesso piano aggressore e aggredito. Ciò naturalmente non deve far dimenticare le enormi responsabilità di Netanyahu, che del resto nascono da lontano, cioè fin dall’assassinio di Rabin, e che passano per la colonizzazione della Cisgiordania o la pretesa di fare di Gerusalemme l’unica capitale dello Stato ebraico. In altre parole, ha spiegato Fassino, Netanyahu si oppone a qualsiasi prospettiva di pace, motivo per cui Sinistra per Israele deve sostenere un ricambio di leadership non solo in campo palestinese ma anche in Israele. Venendo alla situazione attuale, Fassino ha ritenuto che il cessate il fuoco debba essere condizionato alla liberazione degli ostaggi, la restituzione dei corpi, e a portare aiuto al popolo palestinese. Ha messo in guardia in inoltre dal rischio che le varie organizzazioni estremiste operanti in Medio Oriente, come il Fronte per la liberazione della Palestina, gli Houti e l’Iran si saldino in un movimento ostile non solo Israele ma all’intero Occidente. Ha evidenziato che nonostante l’aumento delle difficoltà a seguito del 7 ottobre, l’unica soluzione resta quella dei due Stati, soluzione che però oggi è più difficile, in quanto la pace può nascere solo da dove c’è fiducia, la fiducia che oggi manca. Infine, per quel che riguarda l’Europa, ha sottolineato come oggi Israele non guardi al continente europeo con fiducia, perché troppe volte gli Stati europei hanno dimostrato di non essere imparziali. Ritiene invece che sia necessaria per l’Europa non essere equidistante da Israele e dai palestinesi, ma praticare “un’equivicinanza”. In conclusione, ha auspicato che con la presentazione odierna del manifesto si avvii un’azione politica, culturale, pedagogica e formativa all’interno della sinistra e che Sinistra per Israele possa operare nel campo della sinistra con successo.

Presentazione del Manifesto Nazionale Dal 7 Ottobre alla Pace
21 Marzo 2024 ore 21
Circolo Caldara , via De Amicis 17 , Milano

Dal 7 ottobre alla pace Manifesto promosso da Sinistra per Israele
Il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre scorso e le drammatiche conseguenze dell’operazione militare sulla popolazione palestinese hanno determinato una spirale che va immediatamente interrotta attraverso un accordo di cessate il fuoco che consenta la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e l’inoltro alla popolazione civile di Gaza, in condizioni di sicurezza, degli aiuti umanitari.
È la drammaticità degli eventi a imporre l’urgenza di una risposta razionale, progressista, tesa ad affermare il principio di una pace possibile, indispensabile per tutti i popoli della regione. La risposta che auspichiamo poggia su due ineludibili presupposti.
Il primo riguarda il giudizio sulla strage del 7 ottobre, che non viene dal nulla ma che, al contrario, si inscrive nella strategia di Hamas che, sin dal suo statuto fondativo, rifiuta ogni forma di compromesso e ogni prospettiva di pace, perseguendo la cancellazione dello Stato di Israele e predicando l’uccisione degli ebrei. Hamas tuttavia non rappresenta tutto il popolo palestinese. A maggior ragione la ricerca di una soluzione di pace va perseguita con determinazione.
Per rimettere in moto il percorso di pace — è il secondo presupposto — occorrono leadership credibili. Innanzitutto, è necessario che una rinnovata leadership palestinese dell’ANP — unico interlocutore per la pace oggi internazionalmente riconosciuto — superi le ambiguità che hanno concorso al fallimento degli accordi di Oslo. Così come sono essenziali un atteggiamento cooperativo del mondo arabo, sulla scorta degli Accordi di Abramo, e un impegno attivo dell’intera comunità internazionale, superando troppe inerzie. Allo stesso tempo, è necessaria una nuova leadership israeliana che creda nella
convivenza di due Stati per i due Popoli. Le politiche perseguite dal governo Netanyahu, la prosecuzione dell’occupazione della Cisgiordania, l’espansione degli insediamenti di coloni e il pervicace rifiuto della nascita dello Stato palestinese sono incompatibili con soluzioni di pace.
Anche per queste ragioni di stringente attualità, Sinistra per Israele — che fin dalla sua fondazione si è battuta per una soluzione di convivenza e di pace — ribadisce oggi i seguenti principi e obiettivi, rivolgendosi a tutti coloro che in questi mesi terribili condividono la nostra medesima urgenza.
- Riaffermiamo come irrinunciabile il diritto di Israele a esistere, riconosciuto dai suoi vicini, e a vivere in sicurezza nei propri confini. Si tratta di un diritto non scontato, ma anzi minacciato quotidianamente da organizzazioni terroristiche e forze politiche radicali in ogni parte del mondo, manovrate soprattutto dal regime iraniano. Il diritto di Israele a esistere è tutt’uno con ildiritto del popolo palestinese a un proprio Stato indipendente a fianco diIsraele, come stabilito dalle Nazioni Unite e dagli accordi di Oslo e Washingtondel 1993. Proprio perché su quella terra vivono due diritti ugualmente legittimi,l’obiettivo di «due popoli due Stati», il mutuo riconoscimento di due ragioni, è ancora e sempre il nostro orizzonte e la soluzione da perseguire.
2. Le radici di Israele affondano in una storia che i progressisti europei devono sapere riconoscere e valorizzare. Il sionismo è stato il legittimo movimento di liberazione nazionale e sociale del popolo ebraico e in esso sono vissuti e tuttora vivono i valori di uguaglianza, giustizia, liberazione umana della sinistra democratica e del progressismo. Vivono, come nella straordinaria esperienza dei kibbutz, il progetto e il sogno di una società più giusta, di donne e uomini liberi ed eguali. Soltanto la conoscenza delle radici di Israele può arginare i pregiudizi anti-sionisti e anti-israeliani che albergano nella società italiana, anche a sinistra e nel campo progressista, e che si manifestano attraverso forme antiche e nuove di delegittimazione, di ostilità, quando non di aperto antisemitismo.
3. Come per tutte le democrazie, il giudizio sullo Stato di Israele non deve coincidere con quello sul suo governo in carica. Israele è fin dalla sua nascita una democrazia fondata su valori liberali e progressisti, in una regione fortemente segnata da regimi autocratici. Anche le continue e straordinarie mobilitazioni della società israeliana testimoniano una robusta e radicata cultura democratica e la possibilità concreta di restituire a Israele una politica aperta a un vero processo di pace. Il più drastico giudizio sulle politiche di Netanyahu non può in alcun modo tradursi nella negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, né tantomeno nella colpevolizzazione degli ebrei che vivono in ogni parte del mondo.
Questo è il nostro impegno per la pace, oggi e sempre, per due Stati per i due popoli.
Per aderire cliccate qui
Primi firmatari
Mario Ajello, Giorgio Albertini, Luca Alessandrini, Alessandro Alfieri, Giuliano Amato, Aldo Amoretti, Federigo Argentieri, Alessio Aringoli, Ernesto Assante, Corrado Augias, Ludina Barzini, Franco Bassanini, Luciano Belli Paci, Marco Bentivogli, Silvia Berti, Enzo Bianco, Massimiliano Boni, Daniele Bonifati, Anna Borletti, Enrico Boselli, Gianclaudio Bressa, Virginio Brivio, Ugo Caffaz, Riccardo Calimani, Anselmo Calò, Donatella Capirchio, Pierluigi Castagnetti, Fiorella Castelnuovo, Francesco Cataluccio, Alberto Cavaglion, Stefano Ceccanti, Luca Cefisi, Carlo Cerami, Franca Chiaromonte, Vannino Chiti, Francesco Clementi, Furio
Colombo, Paola Concia, Silvia Costa, Silvia Cuttin, Erica D’Adda, Cesare Damiano, Alessandro De Angelis, Andrea De Benedetti, Edmondo de Donato, Ariel Dello Strologo, Angelo Di Capua, Flavia Di Castro, Beppe Di Chio, Piero Fassino, Valeria Fedeli, Emanuele Fiano, Massimo Finzi, Giovanni Maria Flick, Anna Foa, Stefano Folli, Emilio Gabaglio, Paolo Giaretta, Siegmund Ginzberg, Silvia Godelli, Giorgio Gomel, Anna Grattarola Romano, Andrea Graziosi, Luca Jahier, Stefano Jesurum, Roberto Jona, Fiorella Kostoris, Marco Krivacek, Guido Laj, Linda Lanzillotta, Bruna Laudi (e il Gruppo di Studi Ebraici di Torino), Fabio Levi, Sara Levi , Fernando Liuzzi, Elena Loewenthal, Alessandra Longo, Andrea Lorusso Caputi, Luigi Maccotta, Victor Magiar, Simona Malpezzi, Claudia Mancina, Aurelio Mancuso, Enzo Maraio, Alessandro Maran, Marina Marini, Giacomo Marramao, Claudio Martelli, Virginio Merola, Gennaro Migliore, Adriano Musi, Daniele Nahum, Tommaso Nannicini, Sandro Nannini, Giulio Napolitano, Dario Nardella, Riccardo Nencini, Fabio
Nicolucci, Gabriele Nissim, Simone Oggionni, Alberto Pagani, Emmanuele Pavolini, Pina Picerno, Marco Pierini, Anna Piperno, Lia Quartapelle, Fausto Raciti, Mario Raffaelli, Umberto Ranieri, Mario Ricciardi, Christian Rocca, Mario Rodriguez, Andrea Romano, Fabrizio Rondolino, Lina Salmon, Mario Salmon, Michele Salvati, Ivan Scalfarotto, Gadi Schoenheit, Renata Segre, Daniela Tagliafico, Alessandra Tarquini, Irene Tinagli, Claudio Vercelli, Francesco Verducci, Walter Verini, Marco Vigevani, Luciano Violante, Tobia Zevi.
Roma, 6 marzo 2024
Hanno inoltre aderito
Paola Abbina; Daniela Abram; Massimo Salvatore Accolla; Elena Aga Rossi; Deborah Aghib; Roberta Agretti; Simone Aiolfi; Francesca Ajmar; Francesca Alatri; Clara Elena Albani; Ettore Albano; Roberto Albano; Sofia Albano; Claudio Alberti; Elena Alberti; Susanna Aldini; Paola Alicata; Gabriella Alù; Elena Alvino; Maurizio Amadori; Cesare Amati; Luca Amato Lazzaroni; Guido Ambroso; Fabrizio Amerelli; Giangiacomo Amoretti; Franco Angelico; Massimo Ankor; Rosella Annibali; Rapisardo Antinucci; Enrica Antonini; Rosa Antonucci; Paolo Anziani; Fabio Apicella; Gregorio Apicella; Simone Aprea; Pietro Aragona; Marilena Arancio; Annalena Aranguren; Gloria Arbib; Adriana Argentini; Francesco Argenton; Marco Armano Elio; Antonio Armellini; Giuliano Arnaldi; Giorgio Arras; Angiolina Arru; Carla Artefice; Manuela Ascoli; Maurizio Ascoli; Ornella Ascoli; Marco Ascoli Marchetti; Emilio Astesani; Roberto Attias; Daniela Atzeni; Paola Aurucci; Nicola Avigni; Alessandra Babighian; Alberto Bader; Carlo Baffert; Enrico Baglioni; Soimona Bagnato; Paolo Bagnoli; Fulvio Baldin; Cinzia Ballesio; Renzo Bandinelli; Dionisio Franco Barattini; Luciana Barbarano; Filippo Barberis; Lucia Barberis; Pietro Barbetta; Paola Barbetti-bohm; Laura Barbieri; Nora Barbieri; Zanobi Barducci; Umberto Barlassina; Andrea Baroncelli; Franco Baroni; Rosauro Baroni; Pietro Barrera; Susanna Barta; Elena Lea Bartolini; Riccardo Bartolini; Sandro Bartolomeo; Cesare Bassani; Giorgina Bassetti; Alessandro Basso; Gianni Battimelli; Giovanni Battistini; Luisa Battuello; Giuseppe Bayma; Mario Beghelli; Attilio Beghin; Jacky Behar; Filippo Bellandi; Anna Belli; Paolo Belli; Francesco Belluscio; Carlo Beltramino; Nino Bemporad; Luigina Benci; Folco Giovanni Bencini; Giovanna Benini; Pierpaolo Benini; Roberto Benini; Vittorio Hajime Beonio Brocchieri; Marina Berlinghieri; Paolo Bernacchioni; Giovanna Bernardelli; Carlo Bersani; Ugo Berti Arnoaldi; Daniele Bertino; Nicola Bertoglio; Barbara Bertola; Niccolò Bertorelle Mazzilli; Maria Cristina Betteghella; Fiorenza Bevilacqua; Donata Bianchi; Elisa Bianchi; Carlo Bianco; Paola Biasci; Vittoria Bigi; Paolo Birolini; Augusto Bisegna; Claudio Bises; Angela Bizzarro; Umberto Blasimme; Eva Boccara; Silvia Boccara; Giorgio Boccolari; Angelo Bolaffi; Riccardo Bonacina; Patrizia Bonanni; Luca Lorenzo Bonatti; Barbara Bonci; Athos Boncompagni; Mauro Bondi; Francesco Bonincontro; Fabrizio Bonino; Enrico Bono; Mino Bonomelli; Matteo Andrea Bonomo; Enrico Borg; Valeria Borgese; Aldo Borghesi; Stella Regina Borghi; Paola Borghini; Paolo Borrello; Paolo Borroni; Gianluca Bortoletto; Giorgio Bottiglioni; Eva Bovolenta; Bruno Maria Bracci; Claudio Bragaglia; Daniela Bragazzi; Francesca Brandes; Paolo Brandi; Marco Brando; Carla Brandolini; Giovanni Brauzzi; Gianmarco Brenelli; Alexandre Brentel; Giorgio Brera; Paola Bressan; Mercedes Bresso; Cecilia Brighi; Cristina Brioschi; Mario Brociner; Simona Brugnoni; Daniela Bruno; Danilo Bruno; Gabriella Brusa-zappellini; Edmondo Bruti Liberati; Daniel Buaron; Filippo Bucarelli; Marco Bucciarelli; Rosa Buono; Gian Domenico Burbassi; Anna Buscemi; Federico Buscemi; Giovanni Buscemi; Pietro Bussolati; Anastazja Buttitta; Annamaria Cabitza; Giovanni Cacciano; Franco Cacciatori; Alberto Cadeddu; Eva Caianiello; Eduardo Caiazzo; Patrizia Calcaterra; Paolo Calì; Carolina Calicchio; Avner Calò; Angelica Edna Calò; Giovanni Caloggero; Mirella Camarca; Arianna Camellini; Mattia Camellini; Adriana Camerini; Davide Camisa; Stefano Camisasso; Lia Cammeo; Marco Camorali; Fiore Camorino; Alessandra Campagnano; Massimo Campanino; Marco Campione; Salvatore Campo; Niccolò Camponi; Donata Campra; Marina Canale; Fredy Cancino; Mario Canfora; Rocco Antonio Cangelosi; Antonella Canova; Giorgina Cantele; Giovanna Cantore; Giovanni Canzio; Teodoro Capannelli; Leonardo Capannoli; Carlo Capelli; Marco Capoduro; Elizabeth Cappa; Francesco Capretti; Bruno Capurro; Antonio Caputo; Valentina Caracciolo; Daniela Carbone; Luciana Carbone; Maria Fabiola Cardia; Egidio Cardini; Pietro Carideo; Grazia Carifi; Corrado Carletti; Silvano Carli; Laura Carlotta Gottlob; Paola Carlucci; Monica Carollo; Antonio Carones; Lorena Carpi; Silvia Carrara; Luigi Carrera; Giuseppe Caruso; Sonia Caruso; Vincenzo Caruso; Antonietta Casalanguida; Manuela Casale; Elsa Casanova; Bruna Dora Cases; Marco Casonato; Sergio Casprini; Gim Cassano; Giacomina Cassina; Maria Antonietta Cassini; Carlo Castellani; Sergio Castelletti; Susanna Castelletti; Silvano Castelli; Carlo Catelani; Ines Catellani; Andrea Catena; Fania Cavaliere; Gina Cavalieri; Paola Cavallari; Marco Cavallarin; Emma Cavallucci; Adriana Cavarero; Carla Cavazzi; Wanda Cavecchia; Ludovico Cazzola Hofmann; Bruno Ceccarelli; Francesca Ceccherini Silberstein; Franca Cecchinato; Alberto Celli; Giovanni Matteo Centore; Renzo Ceola; Gabriella Ceracchi Fornaro; Alessandro Cerrato; Vincenzo Cerulli Irelli; Jose Alberto Ceruttt; Gianni Cervetti; Valeria Cervetti; Letizia Cesarini Sforza; Manrico Cesaro; Anna Cesselon; Mino Chamla; Maria Teresa Chialant; Marco Michele Chiauzza; Franca Chizzoli; Alessandro Ciancio; Massimo Cingolani; Gianuario Cioffi; Claudio Cippitelli; Maria Vittoria Cirillo; Stefano Cirillo; Graziella Cirri; Roberto Citterio; Luisa Cittone; Remo Cittone; Fulvio Chaim Ciucci; Carmela Ciulla; Luca Clara; Marcello Clarich; Listello Claudia; Giorgio Cocchi; Donato Cocuzzo; Giancarla Codrignani; Miriam Coen; Monica Coen; Olga Coen; Sabrina Coen; Maria Cogliati; Maurice Albert Cohen; Miriam Cola; Rita Colantonio; Antonio Michele Colantuono; Federica Colarieti; Chiara Maria Colombari; Mario Colombini; Ambrogio Colombo; Claudia Colombo; Marco Colombo; Ennio Coltorti; Michaela Colucci; Maria Grazia Comini; Fabrizio Comolli; Marian Comotti; Michele Concato; Davide Concilio; Claudia Conforti; Sandra Consarelli; Sergio Consigli; Pietro Contegiacomo; Aurora Contu; Daniele Coppin; Nadia Coppola; Andrea Cora; Maurizio Coradini; Luigi Corbani; Alberto Corcos; Patrizia Cordone; Riccardo Corona; Francesca Corradi; Lucia Corso; Gennaro Cortese; Franco Corti; Domenico Cortinovis; Luigi Corvaglia; Francesco Cosentino; Antonino Costantino; Umberto Costi; Luciano Cosuccia; Iolanda Covre; Rosanna Credendino; Giovanni Crema; Filippo Crescentinu; Edoardo Crisafulli; Alberto Cucco; Alberto Cuevas; Mattia Cugini; Gianni Cuperlo; Laura Curatolo; Massimo Cuzzolaro; Roberto D’incau; Giordano D’urbino; Daniele Dal Mas; Camillo Dal Verme; Franco D’alfonso; Massimo Dalla Torre; Antonio D’Andria; Moreno D’angelo; Ardemagni Daniele; Veronika Daprà; Elena Davoli; Stefano De Anseris; Davide De Bella; Alfredo De Bellis; Arnaldo Angelo De Benedetti; Giorgio De Benedetti; Ludovica De Benedetti; Luca De Benedictis; Rosa Maria De Benedictis; Alberto De Bernardi; Candida De Bernardinis; Maura De Bernart; Maurizio Giovanni De Bonis; Sandra De Castro; Maria Elisabetta De Gaudentis; Francesco De Giacomi; Celso De Lauro; Cristiano De Lorenzo; Diana De Marchi; Danilo De Masi; Angelo De Maso; Marie-françoise De Mendonça Faria Soares; Marinella De Nigris; Andrea De Pasquale; Daniele De Paz; Andrea De Petris; Paolo De Petris; Rosanna De Ponti; Roberta De Sanctis; Michele De Seneen; Michele De Simone; Enrico Deaglio; Samuele Marco Degradi; Gino Deho’; Vittoria Dehò; Fabienne Dejean Schwalbe; Alessandra Del Boca; Mauro Del Bue; Marco Del Ciello; Matteo Del Corno; Maddalena Del Gatto; Marina Del Monte; Ludovica Del Roscio; Pasquale Del Vecchio; Gadiel Dell’ariccia; Manlio Dell’ariccia; Micol Dell’ariccia; Fabio Della Pergola; Mara Della Pergola; Maria Chiara Della Pergola; Roberto Della Rocca; Tullio Della Seta; Massimo Della Valentina; Mirna Dell’ariccia; Marco Delvai; Adelia Denti; Romano Dentoni; Patrizia Deotto; Cinzia Derine; Tobia Desalvo; Giovanni Di Bartolo; Augusto Di Benedetto; Carlo Di Castro; Claudia Di Cave; Alessio Di Dio; Sabrina Di Giacomo; Roberto Di Giovan Paolo; Giuseppe Di Lena; Franco Di Leo; Franca Di Leonardo; Nina Di Majo; Enrico Di Mambro; Anna Maria Di Marco; Antonio Di Meglio; Bettina Di Nardo; Giuseppe Di Nardo; Silvia Di Nola; Piero Di Porto; Nicoletta Di Rocco; Anna Di Segni; Marcello Di Segni; Archita Francesco Di Serio; Andrea Di Veroli; Vinicio D’intino; Vittorio D’ippolito; Anna Dolfi; Francesco Donolato; Roberto D’ooriano; Giovanni Yanai Dossena-frank; Michel Dreifuss; Luca Dresda; Piero Duca; Guido Duiella; Daniele D’urbino; Antonio Duva; Martin Ebert; Ramad El’dib; Gabriella Ert; Peggy Eskenazi; Giulia Fabbretti; Gabriele Fabbrici; Fausto Facheris; Michele Fadda; Miryam Fadlun; Simone Falco; Anna Falco Dello Strologo; Luisa Faldini; Sabrina Faller; Dalia Fano; Gino Fantozzi; Silvia Fargion; Vittoria Ketty Fargion; Salvatore Fasano; Davide Fascio; Andrea Fassò; Mario Fasulo; Emma Fattorini; Sira Fatucci; Fulvia Fazio; Giancarlo Fazzi; Giorgio Valentino Federici; Giuliano Federici; Giuseppe Federici; Nicola Federici; Shirly Fein; Mauro Felicori; Andrea Felis; Andrea Fellegara; Manuel Felsani; Massimo Ferlini; Filippo Ferlito; Alessandro Ferrara; Paola Ferraresi; Margherita Ferrari; Enrico Ferrario; Fabrizio Ferrazzi; Giovanni Ferrero; Ilia Ferrero; Elio Ferrillo; Patrizia Ferrione; Luigi Ferro; Lidia Fersuoch; Tiziana M. Ficacci; Andrea Ficosecco; Giuseppina Fidilio; Maria Giuseppina Filingeri; Marco Filippa; Mario Filosi; Luca Finazzi; Lia Finzi; Rita Finzi; Graziano Fiordelmondo; Roberto Fiorentini; Daniele Fiorentino; Francesco Aldo Fiorentino; Mauro Fioroni; Daniele Fischer; Andrea Fishman; Giovanna Foa; Mario Fortunato; Marta Fragala’; Vespa Francesco; Giuseppe Franchetti; Letizia Franchetti; Alessandro Franchetti Pardo; Vittorio Franchetti Pardo; Damiano Franchetto; Alessandro Franco; Giovanni Franco; Luca Frappola; Amelia Frascaroli; Margie Friesner; Paola Friggeri; Sara Frizza; Emanuela Fubini; Paola Fubini; Andrea Alfonso Funzi; Ruggero Gabbai; Sara Gabbai; Paola Gabbrielli; Renato Gabriele; Francesca Gabrini; Ilaria Gadda Conti; Mario Gaeta; Lorenzo Gaiani; Massimo Gaidano; Alessandro Galatioto; Sergio Gallo; Franco Gallone; Giacomo Gambale; Riccardo Gandolfi; Valeria Gandus; Elisa Garfagna; Pupa Garribba; Massimo Gatti; Laura Gattullo; Cesare Gaudiano; Manlio Gaudioso; Francesco Gavilli; Marco Gay; Linda Gean; Monica Gemelli; Giuseppe Genovese; Sara Gentile; Angela Gerosa; Cecilia Ghelli; Maurizio Giancola; Libero Gianelli; Meucci Gianmichele; Luca Gianni; Marialetizia Gianni; Nicolò Gianotti; Barbara Giardini; Ada Gigli; Simone Giglioli; Gianfranco Ginelli; Delia Giolito; Marco Giordani; Chiara Giorgi Alberti; Flaminia Giorgi Rossi; Claudia Giove; Marco Giuliani; Gianpaolo Giuliano; Alessandro Golinelli; Sandra Golini; Eleonora Gorgati; Franco Gori; Giorgio Gori; Camilla Gotz; Alfonso Grassadonio; Daniele Grasselli; Monica Barbara Grassi; Maurizio Grasso; Andrea Graziani; Giorgio Greco; Monia Greco; Laura Greggio; Giovanna Grenga; Alberto Grenni; Caterina Grio; Elena Grondona; Marina Grossi; Gianni Gualberto Morelenbaum; Fernando Guarino; Cleo Guarna; Giulia Guarnieri; Angelino Guerini; Lorenzo Guerini; Alessandra Gulotta; Elisa Gusberti; Victoria Habib; Guido Haschke; Claudia Hassan; Leone Hassan; Luciano Hassan; Silvia Hassan; Dario Hayun; Simonetta Heger; Daniela Heimler; Guido Hermanin De Reichenfeld; Maurizio Illuminato Tessari; Gerardo Imbriano; Carla Incelli; Filippo Indovino; Mauro Invernizzi; Grazia Maria Ippolito; Michele Maria Ippolito; Sergio Israel; Donata Izzo; Michela Jesurum; Rachele Jesurum; Joseph Jona Falco; Toni Jop; Martino Kahan; Lia Krivacek; Giovanni La Croce; Stefania La Penna; Salvatore La Rosa; Maria Ornella Lai; Maurizio Landieri; Pietro Mario Landini; Enzo Lanza; Alexandra Lappon; Sauro Laranci; Alberto Lasagni; Umberto Lascar; Giorgio Latis; Flavia Lattanzi; Paolo Lattanzio; Alessandro Laudani; Giuseppe Lauri; Mario Lavia; Patrizia Lavia; Caterina Lazzarini; Marina Lazzati; Stefano Leandro; Maria Laura Ledda; Alberto Legnaioli; Roberto Lehmann; Franco Lenarduzzi; Giovanna Leoni; Alessandra Leproux; Luca Letizia; Alberto Levi; Giorgio Levi; Marta Levi; Roberto Levi; Tamara Levi; Susanna Levi Minzi; Sandra Levis; Maurizio Lichtner; Claudio Ligas; Benedetto Ligorio; Riva Lilette; Dennis Linder; Tommaso Lingeri; Nicolò Liparoti; Vittorio Liuzzi; Maurizio Lo Re; Antonio Lombardi; Michela Lombardi; Emilio Lonardo; Fabio Lopez Nunes; Patrizio Raphael Loprete; Tiziana Lorenzetti; Caterina Luceri; Pierluigi Luceri; Marina Lucidi; Andrea Luzi Ghisleri; Claudio Giuseppe Luzzatti; Maria Patrizia Maccotta; Marianna Madia; Renata Magarini; Ettore Maggi; Roberto Maggi; Massimo Maggiaschi; Alice Valeria Magiar; Rosa Magiar; Vittorio Maglia; Silvana Magnani; Emilia Magnarelli; Enrico Magnelli; Alessio Magnolfi; Franco Magnone; Emilio Maio; Gianluca Maiorano; Marisa Malagoli Togliatti; Elena Malaspina; Ilenia Malavasi; Antonio Malerba; Gabriella Malfatto; Armando Malta; Alfonso Mambella; Annalisa Michal Mambretti; Fausto Manasse; Mila Manasse; Stefania Manca; Paola Mancinelli; Luigi Manconi; Giulio Manfredi; Simone Manfredi; Benedetta Manghi; Eva Mangialajo Rantzer; Tito Mangialajo Rantzer; Daniela Manini; Fabio Manunza; Elfrida Manzella; Irene Manzi; Giacomo Manzoli; Enrica Mapelli; Ana Isvelia Marà; Tullia Marach; Dino Marchese; Giorgio Marchesini; Patrizio Marchetti; Piergaetano Marchetti; Sergio Marchi; Giuseppe Marcocchi; Esterina Marcovecchio; Fabrizio Marcucci; Massimiliano Marena; Romano Maria; Gianluigi Mariani; Giulia Mariani; Goffredo Mariani; Maria Cristina Mariani; Daniela Marigo; Edoardo Marinelli; Massimiliano Marinelli; Angela Marino; Annalisa Marino; Caterina Rosa Marino; Mariano M. Marino; Danilo Marinucci; Floriana Maris; Gianluca Maris; Chiara Marra; Sergio Marra; Tina Martelloni; Paolo Martinelli; Emilio Martini; Flavio Martino; Marco Marzano; Alvise Marzo; Antonello Mascia; Gianvito Mastroleo; Pietro Masturzo; Silvio Matalon; Annio Matteini; Marco Matteini; Giovanni Matteoli; Roberto Matteucci; Enzo Mattina; Cinzia Mattiucci; Giuliana Mattone; Pietro Maturi; Marco Mayer; Marco Mazza; Lucia Mazzoni; Giandomenico Me; Evelina Meghnagi; Giovanna Melandri; Maurizio Melani; Luciano Mele; Maurizio Melino; Alberto M. Melis; Graziella Meloni; Samuele Menasce; Paola Meneganti; Maria Luisa Meneghetti; Pier Giovanni Menicatti; Greta Menta; Fiorella Merante; Francesca Mercanti; Bruno Isaia Merlin; Mara Merlino; Claudio Francesco Merlo; Fausta Messa; Leonardo Messana; Salvatore Metrangolo; Giuliana Michelini; Leonardo Micucci; Daniela Midena; Marzia Miele; Sandra Mieli; Emanuela Migheli; Rosanna Migliore; Michele Migone; Gianstefano Milani; Anna Mileti; Enzo Minervini; Stefano Minin; Margherita Miserocchi; Roberta Miserocchi; Claudia Mizrahi; Santina Mobiglia; Raffaella Molena; Marco Moneta; Emanuele Marco Mongiovì; Roberto Montanari; Augusto Montaruli; Marco Montesso; Eugenia Monzeglio; Enrico Morando; Alberto Moreni; Armando Moreschi; Alessandro Moretti; Donata Moretti; Carlotta Morgana; Paola Morgante; Claudio Mori; Guido Mori; Maurizio Mori; Roberto Morini; Carla Morlotti; Daniele Moro; Andrea Moroni; Francesco Moroni; Marina Morpurgo; Andrea Morroni; Stefano Moscatelli; Nyranne Moshi; Marzia Motti; Fulvio Mozzachiodi; Anna Mozzo; Lucilla Musatti; Tullia Musatti; Vanni Musi; Niccolò Musmeci; Giuliano Vittorio Mussati; Federico Musso; Tommaso Autari Musso; Sabatino Mustacchi; Carla Muzi; Sergio Muzi; Giovanni Tomaso Muzio; Ilaria Myr; Emilio Nacamulli; Simona Nacamulli; Enrico Naccari; Alberto Nahmijas; Ferruccio Nano; Alesssandro Napoli; Hanna’ Nassisi; Angelo Natale; Sara Natale Sforni; Dahlia Nathaniel; Giovanni Neiman; Isabella Nespoli; Marina Nezi; Sandra Niccoli; Angela Nicolini; Emma Nicolosi; Piergiorgio Nicolosi; Antonio Nicosia; Carmelo Nigrelli; Elisabetta Nobiloni; Silva Nocentini; Livia Noris; Deborah Norzi; Paola Notari; Claudio Pietro Nuti; Eugenio Occhialini; Paolo Odasso; Alessandro Oderda; Carla Olivari Flick; Alessio Francesco Olivieri; Mario Ongaro; Melania Oppenheimer Di Leo; Elvira Orebi; Giovanni Orfei; Benedetta Origo; Gabriella Orlandi; Fulvio Orlando; Marisa Ostolani; Giovanni Oteri; Diana Ottolenghi; Patrizia Ottolenghi; Paolo Maria Ottone; Daniela Ovadia; Mauro Pacilio; Antonio Padoa Schioppa; Elena Padovani; Raffaele Padrut; Marco Pagani; Stefania Pagani; Simone Paganoni; Alessandro Pagliaro; Ivana Paisi; Paola Paladini; Paola Palazzi; Nicoletta Pallini; Giovanni M. Pallone; Laura Palmieri; Gaetano Palombelli; Alessandro Palumbo; Antonio Pandolfo; Giovanni Panettiere; Silvia Panichi; Giorgio Panizzi; Angelo Pappadà; Alessandro Pardini; Fabio Pari; Giulia Parini Bruno; Alessandro Paris; Augusto Parisi; Vito Parisi; Ferruccio Parri; Silvio Paschi; Riccardo Pasqualetti; Andrea Patanè; Lorenza Patriarca; Marisa Patulli Trythall; Pietro Paviotti; Vittorio Pavoncello; Claudio Pecora; Enrico Maria Pedrelli; Marco Pedretti; Egidio Pedroni; Giuseppe Pedroni; Giorgia Pellarin; Erica Pellegrini; Giuseppe Pellegrino; Vincenzo Pellegrino; Susanna Pellicci; Nelly Pepe; Marilena Permunian; Emilia Perroni; Donatina Persichetti; Paolo Peruzzi; Gloria Pescarolo; Oliviero Pesce; Gianluca Pessoni; Franco Peta; Raffaella Petrilli; Cosimo Petrolino; Claudio Petruccioli; Valeria Pezzi; Paolo Pezzino; Cesare Pianciola; Cinzia Piantanida; Elizabeth Picard; Oreste Picari; Donatella Picciau; Paolo Piccinini; Alberto Piccioni; Emanuela Piccioni; Maurizio Picciotto; Piero Piergiovanni; Paolo Pietrosanti; Simonetta Piezzo; Paola Pilati; Massimo Pinardi; Roberta Pinotti; Maiia R. Piovano; Federica Piperno; Livia Piperno; Marina Piperno; Rachele Laura Piperno; Rossella Piperno; Silvia Piperno; Stefano Piredda; Salvatore Pirino; Tano Pirrone; Domenico Pisanelli; Biagio Pisapia; Alberto Pisci; Rodolfo Pisoni; Franca Pistilli; Gabriella Pistone; Giovanni Piva; Luciana Pizzin; Elisabetta Pizzini; Stefano Pogelli; Arianna Poma; Anna Pompili; Deborah Pompili; Chiara Pontecorvo; Alessandro Porcelluzzi; Gianfranco Porcu; Luciana Porrino; Andrea Portaleone; Piero David Portaleone; Anna Maria Portera; Pier Paolo Portinaro; Julie Rebecca Poulain; Davide Pozzi; Maria Antonietta Pranteda; Carlotta Rebecca Praolini; Erika Prenner; Cesare Prevedini; Mariella Principato; Roberto Principe; Salvatore Prisco; Roberto Proietto; Vania Protti Traxler; Diana Puglisi; Davide Puntillo; Achille Quarello; Caterina Quareni; Antonio Quatela; Alessio Quintavalle; Davide Raba’; Giancarlo Rabbai; Gianmaria Radice; Daniele Radzik; Andrea Ragazzini; Giorgio Ragazzini; Massimo Ragazzini; Rodolfo Ragionieri; Alessandra Rambaldi; Antonella Rampino; Paola Rampoldi; Nadia Ranalli; Samantha Randi; Tito Rantzer; Renato Rapino; Fiorello Rathaus; Tobia Ravà; Vittorio Rava’; Anna Elisa Ravenna; Marcella Ravenna; Giuseppe Ravera; Roberto Reali; Guido Regina; Sarah Regina; Andrea Rényi; Aldo Repeti; Daniele Repetto; Edmondo Rho; Marco Riboldi; Claudio Ricci; Roberto Ricciuti; Paolo Rietti; Paolo Rigamonti; Massimo Rimoldi; Sara Rinaudo; Daria Ripa Di Meana; Gabriella Ripa Di Meana; Virginia Ripa Di Meana; Maria Chiara Risoldi; Sileno Rita; Carlo Riva; Franca Roberta Riva; Paolo Rocca; Giulia Rocchi; Roberto Rocciolo; Fabio Roda; Gianfranco Rodano; Luciano Roffi; Stefano Roffi; Francesca Rolandi; Marco Rolando; Andrea Rollin; Carlo Romagnoli; Scilla Roncallo; Barbara Ronchetti; Emanuele Ronchetti; Maddalena Ronconi; Carla Roscioli; Nicola Rosselli; Mia Rossetti; Alessandra Rossi; Ivo Rossi; Marcello Rossi; Maria Carla Rossi; Stefano Rossi; Alessandro Rosso; Maurizio Ruben; Fabiola Ruggieri; Susan Runeckles Ciancio; Rita Russo; Maria Gabriella Rustici; Chiara Sabatini; Oreste Sabatino; Ada Sabattini; Alberto Sabbadini; Manuela Sabbadini; Mauro Sabbadini; Miriam Sabbadini; Andrea Sabbatini; Viviana Saccani; Adolfo Sacchetta; Emanuela Sacchi; Laura Lea Sacerdote; Andrea Sacerdoti; Giorgio Sacerdoti; Michele Sacerdoti; Silvio Sacerdoti; Claudio Sagoleo; Franca Salina; Mariolina Salio; Sergio Salomone; Bruno Salvatici; Renzo Salvatici; Stefania Salvio; Stefano Sancio; Massimo Sandri; Ilda Sangalli Riedmiller; Valeria Sannucci; Anna Rosa Santi Villari; Simonetta Santini; Simone Santucci; Daniela Santus; Annamaria Saponara; Michele Sarfatti; Piera Sassaroli; Sandra Sassaroli; Enrico Sasson; Giulio Saturnini; Antonio Savoia; David Sbardella; Claudio Scaccianoce; Augusto Scacco; Giorgio Scanu; Giuliano Scappi; Antonio Scaramuzza De Marco; Irene Scarpati; Pietro Scarpulla; Bruno Scazzocchio; Lionella Scazzosi; Mario Scazzosi; Regina Schapirer; Augusto Schieppati; Luisella Schreiber; Nicolas Schwalbe; Ariela Sciunnsch; Maria Eugenia Sciuto; Marinella Venera Sciuto; Simona Scolari; Silvia Scota; Angela Scozzafava; Marzio Scudino; Delia Rina Sdraffa; Stefania Sebastiani; Luisa Secondo; Domenico Segna; Emanuele Segre; Guido Segre; Lia Segre; Patrizia Segre; Vera Segre; Andrea Selis; Filippo Sensi; Giacomo Tiberio Sepe; Patrizia Serafini; Riccardo Serafini; Flavio Serato; Marina Sermoneta; Mirella Serri; Claudio Sestieri; Analia Setton; Ileana Sforni; Rosanna Sgaravato; Carlotta Sgubbi; Livia Shamir; Shel Shapiro; Edmon Shimon; Fiorenzo Sicuri; Enrica Signorelli; Barbara Silvera; Maria Silvera; Livio Sirovich; Guido Snichelotto; Paolo Soddu; Loredana Soderini; Francesco Somaini; Rodolfo Soncini Sessa; Giovanni Carlo Sonnino; Graziano Sonnino; Giovanni Sora; Lorenzo Sornaga; Marco Sornaga; Sabina Sornaga; Andrea Spadaccini; Mirella Spadini; Ottavio Spiazzi; Luigi Spina; Giovanni Staiano; Alessandro Starnini; Marco Steiner; Maria Teresa Stiffan; Oliviero Stock; Igor Stojanovic; Tiziana Strabello; Elettra Stradella; Ivano Strizzolo; Paola Suardi; Ida Sznajder; Gian Giacomo Tabet; Antonio Tagliacozzo; Franca Tagliacozzo; Lia Erminia Tagliacozzo; Luciano Tagliacozzo; Sergio Tagliacozzo; Annamaria Tagliavini; Carlo Tanara; Aldo Tanchis; Gustavo Tani; Fausto Tanzarella; Ugo Targetti; Francesco Tarquini; Luciana Tartaglia; Patrizia Tauber; Sonia Taurino; Dante Tazza; Giuliano Tedesco; Alexander Tenenbaum; Mariateresa Tenore; Elena Teolis; Mauro Terlizzi; Claudia Terracina; Roberta Terracina; Benedetto Terracini; David Tesoriere; Daniela Testa; Antonio Testini; Antonella Tiburzi; Desi Tinelli; Marco Tinti; Nereo Tiso; Maurizio Titton V.; Massimo Tivegna; Fioralba Todo; Rossella Todros; Marco Gabriele Tofani; Emilio Antonio Alessandro Tomei; Giorgio Tonini; Francesca Torchi; Enrico Torchia; Anna Tornati; Donatella Torre; Tiziana Tosi; Matteo Tosin; Massimo Tramontin; Vittorio Tranquilli; Massimo Trebitsch; Alberto Trenini; Benedetta Treves; Giuseppe Trifilò; Paolo Trovato; Thomas Trovato; Maria Trozzo; Corrado Truffi; Giorgio Tulli; Elisa Carmen Turone; Fabio Turone; Mauro Ugazio; Piervincenzo Uleri; Nicoletta Umano; Anna Maria Uncini; Monika Unger; Luca Urbinati; Graziella Uziel; Lilj D. Uziel; Antonella Vacca; Marzia Vaccari; Danilo Vaccaro; Chiara Vaggi; Maurizio Vais; Paolo Maria Vajani; Alessandro Valabrega; Enrica Valabrega; Stefano Valabrega; Adriana Valabrega Tedeschi; Rosella Valcarenghi; Miriam Valdameri; Catia Valentini; Alberto Vallarin; Guido Valli; Cecilia Valmarana; Vincenzo Valori; Giorgio Van Straten; Luigi Vanni; Ugo Vanni; Claudio Varini; Gianfranco Varvesi; Marisa Vassallo; Laura Vasta; Andrea Vecchia; Serena Veggetti; Claudio Velardi; Milka Ventura; Piero Ventura; Sandro Ventura; Alessandra Vercesi; Orio Vergani; Giancarlo Veronese; Silvano Veronese; Miriam Vertes; Sara Vescovi; Severino Vettorato; Sergio Patterio Vettore; Luca Vettorello; Maurizio Vianello; Aurelio Maria Vicari; Cosima Vicari; Giuseppe Paolo Vigano’; Stefania Viglianesi; Ottavio Viglione; Ilaria Villa; Tiziana Villa; Giorgia Villa Galatioto; Carla Villagrossi; Paolo Villani; Francesco Villano; Luigi Viola; Mauro Viola; Stefano Viotto; Carlo Visco Gilardi; Paola Vita Finzi; Micaela Vitale; Ariodante Vitali; Fabrizio Vitali; Francesco Vitari; Vittorio Viterbo; Carlo Vitti; Piero Vitti; Aglaia Viviani; Rosella Vivio; Marco Volante; Paolo Volterra; Alberto Voltolini; Susanna Voltolini; Isabella Weiss; Beniamino Weiss Levi; Raùl Wittenberg Cohn; Marina Wolff; Orith Youdovich; Antonio Zaccagnino; Eleonora Zaccarelli; Franca Zacchei; Mario Zaccherini; Giuseppe Zambon; Paola Zamboni; Giuseppe Zammito; Sandra Zampa; Walter Zampieri; Michele Zampino; Isidoro Zandonà; Mariella Zanetti; Stefano Zani; Stefano Zanini; Flavio Zanonato; Roberta Zarfati; Claudio Zecchi; Buni Zeller; Mario Zerbini; Alberto Zevi; Giovanna Zincone; Nicola Zingaretti; Marcello Zinola; Catia Zironi; Francesco Zito; Marinella Zonta; Carlo Vittorio Zucca
Aggiornato alle 15 del 5 Giugno 2024

Israel Is Falling Into an Abyss
David Grossman , The New York Times , 1 Marzo 2024
Mentre la mattina del 7 ottobre si allontana, i suoi orrori sembrano solo aumentare. Ancora e ancora, noi israeliani ci raccontiamo ciò che è diventato parte della storia formativa della nostra identità e del nostro destino. Come per diverse ore i terroristi di Hamas abbiano invaso le case degli israeliani, ucciso circa 1.200 persone, stuprato e rapito, saccheggiato e bruciato. Durante quelle ore da incubo, prima che le Forze di Difesa Israeliane si riprendessero dallo shock, gli israeliani hanno avuto un’idea dura e concreta di ciò che potrebbe accadere se il loro Paese non solo subisse un duro colpo, ma cessasse davvero di esistere. Se Israele non fosse più.

Ho parlato con persone ebree che vivono fuori da Israele e che hanno detto che la loro esistenza fisica – e spirituale – si è sentita vulnerabile durante quelle ore. Ma non solo: Qualcosa della loro forza vitale era stato preso, per sempre. Alcuni sono stati persino sorpresi dall’entità del bisogno che avevano dell’esistenza di Israele, sia come idea che come fatto concreto.
Mentre l’esercito iniziava a contrattaccare, la società civile si stava già arruolando in massa nelle operazioni di soccorso e logistiche, con molte migliaia di cittadini che si offrivano volontari per fare ciò che il governo avrebbe dovuto fare se non fosse stato in uno stato di paralisi incosciente.
Al momento della pubblicazione, secondo i dati del Ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas, più di 30.000 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Tra questi ci sono molti bambini, donne e civili, molti dei quali non erano membri di Hamas e non hanno avuto alcun ruolo nel ciclo della guerra. “Non coinvolti”, come li chiama Israele in conflittese, il linguaggio con cui le nazioni in guerra si ingannano per non affrontare le ripercussioni dei loro atti.
Il famoso studioso di cabala Gershom Scholem ha coniato un detto: “Tutto il sangue scorre verso la ferita”. Quasi cinque mesi dopo il massacro, Israele si sente così. La paura, lo shock, la furia, il dolore, l’umiliazione e la vendetta, le energie mentali di un’intera nazione – tutto questo non ha smesso di fluire verso quella ferita, verso l’abisso in cui stiamo ancora cadendo.
Non possiamo mettere da parte il pensiero delle ragazze e delle donne, e anche degli uomini, a quanto pare, che sono stati violentati dagli aggressori di Gaza, assassini che hanno filmato i loro crimini e li hanno trasmessi in diretta alle famiglie delle vittime; dei bambini uccisi; delle famiglie bruciate vive.
E degli ostaggi. Quegli israeliani che da 146 giorni sono tenuti nei tunnel, alcuni forse in gabbia. Sono bambini e anziani, donne e uomini, alcuni dei quali sono malati e forse stanno morendo per l’ossigeno e le medicine insufficienti e per la mancanza di speranza. O forse stanno morendo perché i normali esseri umani esposti al male assoluto e demoniaco spesso perdono l’innata voglia di vivere, la voglia di vivere in un mondo in cui sono possibili tanta malvagità e crudeltà. In cui vivono persone come i terroristi di Hamas.
L’enormità degli eventi del 7 ottobre a volte cancella la memoria di ciò che è venuto prima. Eppure, circa nove mesi prima del massacro, nella società israeliana si stavano manifestando crepe allarmanti. Il governo, con Benjamin Netanyahu a capo, stava cercando di far passare una serie di provvedimenti legislativi volti a indebolire fortemente l’autorità della Corte Suprema, infliggendo così un colpo letale al carattere democratico di Israele. Centinaia di migliaia di cittadini sono scesi in piazza ogni settimana, tutti quei mesi fa, per protestare contro il piano del governo. La destra israeliana sosteneva il governo. L’intera nazione stava diventando sempre più polarizzata. Quella che una volta era una legittima discussione ideologica tra destra e sinistra si era evoluta in uno spettacolo di profondo odio tra le varie tribù. Il discorso pubblico era diventato violento e tossico. Si parlava di dividere il Paese in due popoli separati. L’opinione pubblica israeliana sentiva che le fondamenta della sua casa nazionale stavano tremando e rischiavano di crollare.
Per coloro che vivono in Paesi in cui il concetto di casa è dato per scontato, devo spiegare che per me, attraverso la mia lente israeliana, la parola “casa” significa una sensazione di sicurezza, di difesa e di appartenenza che avvolge la mente di calore. Casa è un luogo in cui posso esistere con facilità. Ed è un luogo i cui confini sono riconosciuti da tutti, in particolare dai miei vicini.
Ma tutto questo, per me, è ancora immerso in un desiderio di qualcosa che non è mai stato pienamente raggiunto. Attualmente, temo che Israele sia più una fortezza che una casa. Non offre né sicurezza né agio, e i miei vicini nutrono molti dubbi e richieste sulle sue stanze e sulle sue mura e, in alcuni casi, sulla sua stessa esistenza. In quel terribile sabato nero, è emerso che non solo Israele è ancora lontano dall’essere una casa nel senso pieno del termine, ma non sa nemmeno come essere una vera fortezza.
Tuttavia, gli israeliani sono giustamente orgogliosi del modo rapido ed efficiente in cui si radunano per offrire sostegno reciproco quando il Paese è minacciato, sia da una pandemia come la Covid-19 che da una guerra. In tutto il mondo, i soldati della riserva sono saliti sugli aerei per raggiungere i loro compagni già chiamati alle armi. Andavano “a proteggere la nostra casa”, come dicevano spesso nelle interviste. C’era qualcosa di commovente in questa storia unica: Questi giovani uomini e donne si sono precipitati al fronte dai confini del mondo per proteggere i loro genitori e nonni. Ed erano pronti a dare la vita. Altrettanto commovente è stato il senso di unità che prevaleva nelle tende dei soldati, dove le opinioni politiche non erano importanti. Tutto ciò che contava era la solidarietà e il cameratismo.
Ma gli israeliani della mia generazione, che hanno vissuto molte guerre, si stanno già chiedendo, come facciamo sempre dopo una guerra: Perché questa unità emerge solo nei momenti di crisi? Perché solo le minacce e i pericoli ci rendono coesi e fanno emergere il meglio di noi, e ci sottraggono anche alla nostra strana attrazione per l’autodistruzione, per la distruzione della nostra stessa casa?
Queste domande provocano un’intuizione dolorosa: La profonda disperazione provata dalla maggior parte degli israeliani dopo il massacro potrebbe essere il risultato della condizione ebraica in cui siamo stati nuovamente gettati. È la condizione di una nazione perseguitata e non protetta. Una nazione che, nonostante i suoi enormi successi in tanti campi, è ancora, nel profondo, una nazione di rifugiati, permeata dalla prospettiva di essere sradicata anche dopo quasi 76 anni di sovranità. Oggi è più chiaro che mai che dovremo sempre vigilare su questa casa fragile e penetrabile. È stato chiarito anche quanto sia radicato l’odio di questa nazione
Nelle manifestazioni a cui partecipano centinaia di migliaia di persone, nei campus delle università più prestigiose, sui social media e nelle moschee di tutto il mondo, il diritto all’esistenza di Israele viene spesso contestato con entusiasmo. Una critica politica ragionevole che tenga conto della complessità della situazione può cedere il passo – quando si tratta di Israele – a una retorica dell’odio che può essere raffreddata (se mai lo sarà) solo dalla distruzione dello Stato di Israele. Per esempio, quando Saddam Hussein uccise migliaia di curdi con armi chimiche, non ci furono appelli a demolire l’Iraq, a cancellarlo dalla faccia della terra. Solo quando si tratta di Israele è accettabile chiedere pubblicamente l’eliminazione di uno Stato.
I manifestanti, le voci autorevoli e i leader pubblici dovrebbero chiedersi cosa c’è in Israele che provoca questo disgusto. Perché Israele, tra i 195 Paesi del pianeta, è l’unico ad essere condizionato, come se la sua esistenza dipendesse dalla buona volontà delle altre nazioni del mondo?
È nauseante pensare che questo odio omicida sia rivolto esclusivamente a un popolo che meno di un secolo fa era stato quasi sradicato. C’è anche qualcosa di irritante nel tortuoso e cinico collegamento tra l’ansia esistenziale degli ebrei e il desiderio espresso pubblicamente da Iran, Hezbollah, Hamas e altri che Israele cessi di esistere. È inoltre intollerabile che alcune parti cerchino di costringere il conflitto israelo-palestinese in un quadro colonialista, dimenticando volontariamente e ostinatamente che gli ebrei non hanno un altro Paese, a differenza di quanto avviene per gli altri popoli.
I colonialisti europei a cui vengono falsamente paragonati, e oscurano il fatto che gli ebrei non sono arrivati in terra d’Israele per conquistare, ma in cerca di sicurezza; che la loro forte affinità con questa terra ha quasi 4.000 anni; che è qui che sono emersi come nazione, religione, cultura e lingua.
Si può immaginare la gioia maliziosa con cui queste persone calpestano il punto più fragile della nazione ebraica, il suo senso di estraneità, la sua solitudine esistenziale – quel punto da cui non ha rifugio. È questo punto che spesso la condanna a commettere errori fatali e distruttivi, distruttivi sia per i suoi nemici che per se stessa.
Chi saremo – israeliani e palestinesi – quando questa lunga e crudele guerra sarà terminata? Non solo il ricordo delle atrocità inflitte l’uno all’altro ci separerà per molti anni, ma anche, come è chiaro a tutti noi, non appena Hamas ne avrà la possibilità, metterà rapidamente in atto l’obiettivo chiaramente indicato nel suo statuto originale: il dovere religioso di distruggere Israele.
Come possiamo quindi firmare un trattato di pace con un tale nemico?
Eppure, che scelta abbiamo?
I palestinesi faranno i conti da soli. Io, come israeliano, mi chiedo che tipo di persone saremo quando la guerra finirà. Dove indirizzeremo il nostro senso di colpa – se saremo abbastanza coraggiosi da provarlo – per ciò che abbiamo inflitto a palestinesi innocenti? Per le migliaia di bambini che abbiamo ucciso. Per le famiglie che abbiamo distrutto.
E come impareremo, per non essere mai più sorpresi, a vivere una vita piena sul filo del rasoio? Ma quanti vogliono vivere la propria vita e crescere i propri figli sul filo del rasoio? E quale prezzo pagheremo per vivere in costante vigilanza e sospetto, in perenne paura? Chi di noi deciderà di non voler – o di non poter – vivere la vita di un eterno soldato, di uno spartano?
Chi resterà qui in Israele, e quelli che resteranno saranno i più estremi, i più fanaticamente religiosi, nazionalisti, razzisti? Siamo condannati a guardare, paralizzati, mentre l’audacia, la creatività, l’unicità di Israele viene gradualmente assorbita nella tragica ferita dell’ebraismo?
Chi resterà qui in Israele, e quelli che resteranno saranno i più estremi, i più fanaticamente religiosi, nazionalisti, razzisti? Siamo condannati a guardare, paralizzati, mentre l’audacia, la creatività e l’unicità di Israele vengono gradualmente assorbite nella tragica ferita dell’ebraismo?
Queste domande probabilmente accompagneranno Israele per anni. Esiste, tuttavia, la possibilità che una realtà radicalmente diversa sorga per contrastarle. Forse il riconoscimento che questa guerra non può essere vinta e, inoltre, che non possiamo sostenere l’occupazione all’infinito, costringerà entrambe le parti ad accettare una soluzione a due Stati che, nonostante i suoi svantaggi e i suoi rischi (primo fra tutti, che Hamas prenda il controllo della Palestina in un’elezione democratica), è ancora l’unica praticabile?
Questo è anche il momento per gli Stati che possono esercitare un’influenza sulle due parti di usarla. Non è il momento della politica spicciola e della diplomazia cinica. È un momento raro in cui un’onda d’urto come quella che abbiamo vissuto il 7 ottobre ha il potere di rimodellare la realtà. I Paesi coinvolti nel conflitto non vedono che israeliani e palestinesi non sono più in grado di salvarsi da soli?
I prossimi mesi determineranno il destino di due popoli. Scopriremo se il conflitto che dura da più di un secolo è maturo per una risoluzione ragionevole, morale e umana.
È tragico che questo avvenga – se davvero avverrà – non per speranza ed entusiasmo, ma per stanchezza e disperazione. D’altra parte, questo è lo stato d’animo che spesso porta i nemici a riconciliarsi, e oggi è tutto ciò che possiamo sperare. E quindi ci accontenteremo. Sembra che abbiamo dovuto attraversare l’inferno stesso per arrivare al luogo da cui si può vedere, in una giornata eccezionalmente luminosa, il bordo lontano del cielo.
David Grossman

Il Diario di Eshkol Nevo da Israele, quinta puntata: «I segni di un incubo che non vuole finire»
di Eshkol Nevo
Scrivo narrativa. Ho sempre scritto narrativa. Ho sempre trovato molto più interessante rispondere alla domanda «cosa sarebbe potuto succedere» piuttosto che alla domanda «cos’è successo». Ai miei studenti di scrittura creativa insegno: la realtà rappresenta un buon materiale di partenza. Prendete il necessario, ma non lasciate che vi limiti. Per trasformare un evento biografico che vi è successo in una storia, lo dovete portare all’estremo. Se quello che vi è capitato era in carattere 12, quando scrivete ingranditelo a carattere 48. Sarà più incisivo, più pericoloso, e perciò più interessante. Ma cosa fare durante una guerra, quando la realtà stessa si estremizza, fuoriesce dai propri confini e diventa infinitamente più drammatica? Dal 7 ottobre immagazzino momenti. Ascolto molto. Documento. Per la prima volta nella mia vita scrivo la realtà, così com’è.
Soltanto quando arrivo sul taxi che è venuto a prendermi dopo la conferenza do un’occhiata al cellulare per controllare le notizie, e subito mi sfugge di bocca un’esclamazione: oh! No! Il tassista si ferma con uno stridio di freni. Accosta. Cos’è successo? Si gira verso di me, allarmato. Dall’accento capisco che è arabo. Ha dimenticato qualcosa nella sala, signore? Vuole tornare indietro? No, rispondo, lasci perdere, sono le notizie. Una cosa che ho letto sul sito delle notizie. Cos’è successo? Insiste, vuole sapere. Capisco che non ho scelta, devo raccontare altrimenti non si riparte. È Idan Amedi, il cantante Idan Amedi, gli dico, è stato gravemente ferito a Gaza. Non lo conosco, dice l’autista. Che canzoni canta? Canzoni bellissime, dico, canzoni che ti toccano l’anima. Me ne canta una? chiede. Canticchio il ritornello di Parte del tempo e la prima strofa di Dolore dei combattenti, fermandomi apposta prima del ritornello sugli incubi e il sangue. Il tassista non le riconosce. Mi faccia vedere una foto, prega. Cerco su Google una foto di Idan Amidi senza uniforme. Gliela mostro. Ah, sorride, è Sagi, l’attore di Fauda. Che uomo. Sì, confermo, Idan recita in Fauda ed è un vero uomo. Dopo che ci siamo trovati d’accordo l’autista si tranquillizza, mi restituisce il telefono e si reimmette nel traffico. Le strade sono vuote. La notte è silenziosa. Una luna quasi piena illumina l’autostrada. Se credessi in Dio, pregherei.

Stiamo per congedarci dalla nostra figlia soldatessa, siamo venuti a trovarla alla base. La prima visita dall’inizio della guerra. Mia moglie le consegna gli ultimi contenitori di plastica pieni di cibo. Le sorelle più piccole scattano una foto assieme a lei. Poi un’altra, da un’angolazione diversa. Il mio sguardo vaga, si sposta all’esterno. Attraverso la vetrata noto una soldatessa che si avvicina a un soldato. Sono distanti una decina di metri, che lei percorre veloce. Di volata. Lui si muove verso di lei più lento. Più pesante. Più impolverato. Un attimo prima di toccarsi, entrambi spostano il fucile dietro la schiena in un gesto quasi coordinato, così da potersi abbracciare. Si abbracciano a lungo. Poi scostano un pochino la testa per baciarsi sulla bocca. Non piangevo dall’inizio della guerra. Non ci riuscivo. Ma qualcosa nel modo in cui lei gli ha carezzato la testa mentre lo baciava. Nel modo in cui lui si è lasciato andare tra le braccia di lei. Papà? Mia figlia, la soldatessa, mi guarda sorpresa. Piangi? Annuisco. Non ti preoccupare, papino, mi rassicura, sabato prossimo torno in licenza. Andrà tutto bene.
Mio padre ha costruito una casa nel kibbutz Malkia per potersi ritirare in campagna negli anni della pensione, ma quando l’ha terminata mia madre si è rifiutata categoricamente di vivere vicino a Hezbollah. Così la casa non ha abitanti permanenti ed è diventata il nostro rifugio. Mi sono rifugiato nella casa di Malkia durante il Covid, mi ci sono rifugiato quando dovevo rivedere i miei libri, mi ci sono rifugiato ogni volta che volevo ascoltare la mia voce interiore. Adesso non ho più un posto dove rifugiarmi. A Malkia — riferiscono i vicini evacuati in un albergo nella città di Tiberiade — ci sono solo carri armati e soldati, e qualche agricoltore rimasto a occuparsi del raccolto dei kiwi. Cosa sarà successo ai cavalli? Penso all’improvviso. Le passeggiate e il maneggio erano l’attività preferita delle mie figlie a Malkia. Una piacevole passeggiata di mezz’ora, lungo la recinzione del confine, su quegli splendidi puledri.
Mando un messaggio a Rotem del maneggio: come state? Non risponde. Immagino che un missile anticarro di Hezbollah abbia distrutto il recinto delle scuderie e i cavalli siano fuggiti al galoppo. Ma dove? Anche loro, in effetti, non saprebbero dove scappare. Dopo una settimana mi risponde con un lungo vocale: il giorno in cui hanno evacuato gli abitanti del kibbutz è arrivato un camion, i cavalli sono stati caricati e trasferiti in un’altra scuderia che li ospita, a Kfar Vradim. Stanno bene lì? chiedo. Secondo lungo messaggio vocale, questa volta in tono più addolorato. Per la verità no, ammette Rotem. Sono irrequieti, non si sentono a casa, non arrivano bambini a cavalcarli, non ci sono lezioni di equitazione, Mika è depressa e si fatica a portarla a fare un giro, Blondie è nervosa, ha mollato un calcio a uno stalliere. Anche gli altri vorrebbero tornare alla loro stalla, dice Rotem. Hanno nostalgia. Aspettano solo che questo periodo terribile finisca.
Sono mesi, ormai, che Galit, la nostra vicina a Malkia, non può ricevere ospiti a casa sua come ama fare, fra due chiacchiere a cuore aperto e una lettura di tarocchi. Inizialmente l’hanno trasferita in un deprimente albergo a Tiberiade. Poi ha trovato un appartamento temporaneo a Pardes Hanna. Mi sento una chiocciola senza guscio, mi ha scritto questa settimana. Una lumaca. Perciò siamo andati a trovarla. Ci siamo incontrati in un caffè e abbiamo cercato di non parlare della guerra, ma tutti gli argomenti portano al 7 ottobre. Prima di salutarci ha tirato fuori un contenitore di plastica. È frutta del vostro giardino. Cosa? Come? Ieri sono stata a Malkia, ha confessato. Non ne potevo più. Ti hanno lasciato entrare? ho domandato, stupefatto. Non ho chiesto il permesso, ha ribattuto. C’è qualcuno nel kibbutz? ho voluto sapere. Non c’è anima viva. Persino i cavalli hanno trasferito a Kfar Vradim. Cos’hai fatto mentre eri lì? Ho chiesto perplesso. Ha alzato le spalle, mi sono seduta in salotto a respirare aria di casa. Poi ho raccolto i pomeli e le arance dal vostro giardino, era un peccato lasciarli lì. Dopodiché sono iniziati i boom e me ne sono andata. Una volta in macchina apro la scatola di plastica e scopro che Galit ha sbucciato i frutti e li ha riposti in spicchi perché ci fosse più comodo mangiarli. Chissà perché, è proprio questo dettaglio a spezzarmi il cuore.
La mia figlia minore mi telefona. Sente dei rumori in casa, mi prega di rientrare in fretta dal lavoro. Le rispondo che ci metterò mezz’ora e chiede che nel frattempo rimaniamo al telefono. Le domando cosa sente esattamente. Mi sussurra: qualcuno parla dentro casa. Le dico, va bene, continuiamo a parlare fino a che non arrivo. Sussurra, la batteria sta per scaricarsi. Allora metti il telefono in carica, suggerisco. Non posso, sussurra di nuovo, sono attaccata alla porta e il caricatore è distante. In che senso? Non capisco. Perché sei attaccata alla porta? Sono attaccata alla porta e tengo la maniglia, per impedirgli di entrare se ci provano, sussurra, e io mi rendo conto che, anche se il 7 ottobre non eravamo in Israele, e anche se abbiamo cercato di proteggerla dall’orrore, qualcosa è comunque filtrato. Allora adesso riattacchiamo e tu mi richiamami solo se le voci si avvicinano, le propongo. Accetta. Premo l’acceleratore. Supero da destra. Supero da sinistra. Brucio un semaforo rosso. Quando arrivo, la casa è silenziosa. Apro la porta ed entro. Sono pronto al peggio. Non c’è nessuno. Mi precipito verso la sua stanza. Busso alla porta. Chiede chi è e le rispondo, papà. Apre, mi si butta tra le braccia, piange. Le dico che è stata molto coraggiosa.
La mia ex studentessa mi racconta che i messaggeri dell’esercito hanno cercato lui, il padre, e solo dopo averlo rintracciato a casa della nuova compagna a Holon hanno potuto notificare anche a lei. È la procedura se i genitori sono divorziati. Bisogna sincronizzare l’annuncio. Il suo ex marito è seduto di fronte a noi, sul divano, mentre lei me lo racconta. È curvo. Non sapevo che avessero divorziato. E adesso il loro figlio è stato ucciso a Gaza. Significa che saranno uniti per sempre, penso. Nel lutto. Nella nostalgia. Nel sapere cosa avrebbe potuto essere, e invece. Ma forse chiunque divorzia e ha figli non si separa mai davvero. Suo figlio aveva la ragazza, mi racconta la madre. Una storia seria. Già da due anni. Si sono conosciuti nella gelateria dove lavoravano insieme.
Eccola lì, indica una ragazza a disagio, con una treccia bionda, seduta su una sedia di plastica vicino alla finestra. Nessuno si avvicina a confortare lei. Il fidanzato di mia zia Margalit è stato ucciso nella guerra del Kippur, mi torna in mente, e ha continuato a parlarne per anni. Mi ha sempre stupito, quanto fosse vivo per lei. Quanto non riuscisse a dimenticarlo. Forse non si riesce mai a separarsi davvero da una persona a cui non si ha avuto la possibilità di dire addio. Arriva una nuova ondata di visitatori a portare le condoglianze. Restano in piedi e cercano un posto per sedersi. Mi alzo, e mentre mi congedo dalla mia studentessa e dal suo ex marito mi offro di aiutare, in caso vogliano fare qualcosa con tutte le lettere lasciate dal figlio. È così che mi comporto quando non so come salutare: offro aiuto.
«Ciao Eshkol, sono Tomer, papà di Omri Schwartz, caduto a Gaza poco più di un mese fa. Questo foglio si trovava tra l’equipaggiamento che ci hanno restituito insieme a lui. L’ho letto alla cerimonia per il trentesimo giorno dalla sua sepoltura». Clicco sulla fotografia allegata e scopro che è un brano dell’ultima pagina di Nostalgia, che contiene un elenco di buoni propositi per il futuro e termina con la frase «E poi, voglio tornare a casa». Sono seduto al food truck di Sho’eva. Mi sono fermato lungo la strada mentre viaggiavo da Gerusalemme verso casa, in teoria per bere un caffè ma di fatto per restare in giro più a lungo: attenua un pochino l’oppressione al petto. Avevo intenzione di rispondere ad alcune mail di lavoro, e all’improvviso questo WhatsApp. Quando guidi sotto la pioggia battente che infuria sui finestrini dell’auto e passi sotto un ponte, di colpo cala il silenzio. Assordante. Così mi sento quando leggo il WhatsApp di Tomer, papà di Omri. Lo rileggo. E anche il brano allegato. Mi manca l’aria. Tutte le promesse che Omri non potrà mai realizzare. Rifletto a lungo su come rispondere a suo padre Alla fine scrivo: «La ringrazio per avermi scritto. Mi emoziona sapere che ha letto queste parole alla cerimonia per Omri. Vi mando un abbraccio e le mie condoglianze, sono disponibile per qualunque cosa vi possa servire». Il cielo ricomincia a piangere. I lavoratori del food truck piegano le sedie e poi chiudono del tutto. Sono costretto ad andare a casa. Questa guerra va avanti da cinque mesi ormai, calcolo, genitori perdono figli e figli perdono genitori, da entrambe le parti, e non ci sono segni che l’incubo stia per finire. Sulle colline vicino a Sha’ar Hagai i mandorli fioriscono in una meravigliosa nuvola candida e io non ho alternative, devo chiamare a raccolta tutte le risorse della mia immaginazione per credere che alla fine qui nascerà una realtà diversa.

Evento : La Sinistra Israeliana e il trauma del 7 ottobre
Roma , 3 febbraio 2024 ore 17:30 Circolo PD Italia -Lanciani, via Catanzaro 3

Eshkol Nevo, il diario di guerra: la finta normalità e le lacrime all’improvviso
di Eshkol Nevo
Lo scrittore israeliano: «Ogni mattina scorro la lista dei caduti, il cuore batte forte Io dico di sì a ogni richiesta: mi riempio l’agenda perché non mi resti il tempo per la tristezza»
Alzarsi al mattino. Aprire gli occhi. Allungare la mano verso il cellulare. Entrare nel sito delle notizie. Scorrere la lista dei caduti. Ogni mattina il portavoce dell’esercito pubblica i nomi dei soldati uccisi a Gaza il giorno precedente. L’occhio si posa sui nomi. Il cuore batte forte. Una prima lettura, veloce, per assicurarmi che tra i morti non ci sia nessuno che conosco. Il bilancio finora, dopo due mesi e mezzo di guerra, è: il figlio di una cara amica. Il figlio di un’allieva. Il fratello della migliore amica di mia figlia.
Stamattina non riconosco nessun nome. Grazie a Dio. Seconda lettura, più lenta. Per rispetto ai caduti. Chi abbiamo perso stanotte. Quali giovani vite sono state stroncate. Nelle fotografie sembrano sempre bambini travestiti da soldati. Poi alzarsi dal letto. Costringersi ad alzarsi dal letto anche se il corpo è pesante, pesantissimo. Ti tira giù, nella disperazione. Indossare pantaloni sportivi. Uscire fuori, in strada, e iniziare a correre. Questa faccenda della corsa non l’avevo mai capita. È sgradevole per il corpo. Non c’è una trama. Non c’è il pallone.
Ero abituato a guardare gli uomini della mia età mentre correvano e pensare che ci sono modi migliori per risolvere la crisi di mezza età. Da quando è iniziata la guerra, corro anch’io. Tutte le mattine. Mi sono ripromesso di continuare fino a che non sarà finita. Come Forrest Gump. Non ho scelta. È impossibile iniziare la giornata con tutta questa tristezza in gola. Serve qualcosa per riequilibrare. Qualcosa che inietti un briciolo di speranza nel sangue. Le strade sono deserte, è prestissimo. Ovunque, sugli alberi, sulle facciate dei palazzi, nelle piazze, sono appese le fotografie degli ostaggi. Correndo ci passo davanti. Mi domando chi di loro è già tornato. Chi è ancora lì, in un tunnel buio. E chi non tornerà più. Rientro. Doccia. Accendo il telefono. Una foto da A. Finalmente. Tiro un sospiro di sollievo.
Un mese fa A. mi ha scritto un messaggio su WhatsApp. Voleva condividere che i miei libri lo hanno accompagnato nei momenti chiavi dell’esistenza e raccontarmi che adesso la sua squadra sta combattendo a Gaza. Mi ha chiesto se potevo mandare a lui e ai suoi ragazzi il mio ultimo libro con una dedica personale a ciascuno. Tornavano per ventiquattro ore e poi sarebbero ripartiti per Gaza. Una sera ho lasciato le copie con le dediche nell’armadietto del contatore elettrico. Al mattino non c’erano più. Da allora non ho più ricevuto notizie da A. Stavo iniziando a preoccuparmi sul serio, temevo che gli fosse successo qualcosa. Ma adesso è arrivata la fotografia. Sei soldati con il libro in mano, le facce sfocate dai pixel. Probabilmente erano arruolati in un’unità segreta. Non lo so né lo voglio sapere. Gli scrivo che gli auguro ogni bene, di tornare a casa sani e salvi. Nella casella di posta elettronica trovo un’altra richiesta da parte di un soldato. Questa volta è un riservista, si chiama Eliezer, è dislocato al confine settentrionale. Chiede se «posso andare da loro a leggere uno dei miei racconti?».
Gli scrivo di sì, certo. In questo periodo dico di sì a tutto. A qualsiasi richiesta. Mi riempio l’agenda perché non mi resti il tempo per la tristezza. Più tardi io ed Eliezer ci accordiamo. Ma la settimana successiva arriva un altro soldato a prendermi alla stazione del treno. Non Eliezer. A quanto pare Eliezer è stato trasferito in un’altra base. Non ti preoccupare, dice Oren che è venuto al suo posto, sei in buone mani.
Oltrepassiamo tutti i posti di blocco, proseguiamo in strade deserte e raggiungiamo un avamposto proprio sul confine. Per tutta la settimana ho rimosso il fatto che quella è zona di guerra e io mi sto mettendo in pericolo, e ora è troppo tardi per cambiare idea. Incontro i soldati. Mi aspettano sotto un grande telone di stoffa. Parliamo di amicizia, della strada non presa, di cosa significa essere israeliani in questi giorni. Poi gli leggo un racconto.
Dopo due paragrafi boom, un boato. Piuttosto forte. Mi fermo e ricordo che Oren ha detto che in caso di lanci di missili ci saremmo dovuti precipitare nel rifugio mobile. Ma nessuno dei riservisti fa un passo. Penso tra me e me, beh, o trovano il mio racconto davvero avvincente oppure sanno qualcosa che io non so. E proseguo nella lettura. Dopo qualche altro paragrafo si sente un altro boom. Più vicino. E giusto prima della fine del racconto, in una sorta di pausa drammatica, l’ultima esplosione, vicinissima. Quando finisco di leggere mi spiegano che i boom erano «provocati dalle nostre forze». Dopodiché fanno domande sul racconto, e sui finali a aperti, e sulla vita. Alla fine Oren mi riaccompagna al treno e per strada dice che sente che questo momento contiene anche il potenziale per un tikkun interno, una riparazione, della nostra società. Gli rispondo che lo credo anch’io. Stabiliamo di rincontrarci dopo la guerra.

Nessuno sa quando succederà. Forse tra un mese. Forse tra un anno. Nel frattempo si è creata una nuova quotidianità. Una pseudo-quotidianità. Come se l’anima si stesse abituando. Come se la vita tornasse alla normalità. Ma non è vero. Ogni tanto qualcuno crolla. Ogni tanto quel qualcuno sono io. Ieri, ad esempio. Ho parcheggiato l’auto vicino al nuovo stadio di calcio che da ormai due mesi resta deserto, inutilizzato. All’improvviso alla radio hanno trasmesso una canzone di Marianne Faithfull, The ballad of Lucy Jordan. Il testo della canzone non parla di soldati. O di guerra. Tutto sommato racconta la storia di una donna di trentasette anni che si rende conto che non guiderà più una macchina sportiva a Parigi mentre il vento le scompiglia i capelli. Non c’era motivo per cui questa canzone mi facesse piangere. Eppure ho pianto come un bambino, nel parcheggio dello stadio di calcio. A fine canzone mi sono asciugato le lacrime, sorpreso della mia stessa reazione, e sono andato a insegnare scrittura creativo. Che scelta avevo. Gli studenti mi aspettavano in classe e tutte le classi in cui sono entrato negli ultimi due mesi sono classi terapeutiche. Tutti sono al limite. Tutti sono traumatizzati in un modo o nell’altro e si aspettano qualcosa da me. La responsabilità dell’energia nella stanza è mia. La responsabilità dell’energia nella maggior parte delle stanze in cui entro, è mia. Perciò ogni mattina vado a correre e bevo un espresso e dopo un altro e dopo un terzo e penso alle crisi che ho vissuto in passato e poi superato e penso alla prossima primavera in Italia e all’appartamento in piazza Emanuele Filiberto, poi entro nella stanza e aiuto le altre persone a esprimere i loro sentimenti, o a dimenticarli, e aiutare gli altri è il modo migliore per aiutare se stessi, ce lo insegna il buddhismo, e gli studenti sono grati, dell’opportunità di scrivere, dell’opportunità di stare insieme, anche se durante l’incontro siamo corsi due volte nel rifugio perché sono partite le sirene d’allarme, io li saluto e torno alla mia auto in cui ho pianto e mi avvio e un minuto dopo scatta un altro allarme e io seguo le direttive: scendo dal veicolo. Mi sdraio accanto all’auto. Metto le mani sopra la testa. Aspetto cinque minuti. Intanto penso alle cose che non ho ancora avuto il tempo di fare, per esempio un viaggio in Colombia, o vedere la mia figlia maggiore sotto il baldacchino nuziale, e cosa succederebbe se morissi adesso. Poi mi alzo e riprendo a guidare, passo attraverso la piazza dove fino a tre mesi fa manifestavamo per la democrazia e contro il governo. In quella piazza adesso non ci sono manifestazioni. Ma ce ne saranno. Ne sono sicuro. Insieme alla tristezza, sta montando anche la rabbia. Monta e si affina. Il momento in cui chiederemo le dimissioni del primo ministro più catastrofico della storia di Israele arriverà. Sono settimane che scrivo l’articolo in cui esorto Netanyahu ad andarsene a casa. Ma mi trattengo. Mi mordo forte la lingua. Questi sono tempi di guerra, non di politica.
Quando arrivo a casa dormono tutti, il soggiorno è silenzioso. Accendo la Cnn per vedere le immagini da Gaza. Sui canali israeliani le immagini di Gaza non le mostrano. Come se l’empatia nei confronti dei civili indifesi a Gaza potesse abbattere il morale della nazione. A Rafah la pioggia cade su donne e bambini che non hanno un tetto sotto cui ripararsi. C’è una ragazzina che ricorda vagamente la mia seconda figlia. Trema di freddo. Ha fame. Ho la tentazione di cambiare canale, ma rimango. La guerra è una cosa atroce. Non possiamo dimenticarlo. Anche se viene imposta, ed è stato Hamas a imporre la guerra a noi e a Gaza, non ci ha lasciato nessuna alternativa, la guerra è una cosa atroce. La vittoria vera in questa guerra arriverà solo se sarà seguita dalla pace.
Traduzione di Raffaella Scardi
PROFILO
BRUNO SEGRE
(1930-2023)
Bruno Segre ha osservato il XX secolo e l’inizio del XXI da una posizione leggermente defilata: è stato un testimone con tutti gli strumenti per comprendere ciò che accadeva intorno a lui
11 DICEMBRE 2023

In Storie di un’altra Italia. Incontri e ritratti (Edizioni Casagrande, 2023) ho riunito le storie di una serie di personaggi nati nel XX secolo che mi è capitato di incontrare perlopiù di persona a partire dagli anni Novanta. Alcuni celebri (Umberto Eco, Stajano, Giulia Maria Crespi), altri raccontati attraverso chi li ha conosciuti molto da vicino, come Giulio Einaudi nelle parole del fratello Roberto, o Pier Pasolini in quelle del cugino Nico Naldini. Poi ci sono i ritratti di maestri di inapparenza come Gianni Antonini, braccio destro di Raffaele Mattioli alla Ricciardi, o Roberto Cerati, direttore commerciale dell’Einaudi degli anni d’oro. Scrittori come Marisa Bulgheroni o Manlio Cancogni, ma poi tanti nomi meno noti come Bruno Segre (1930-2023) che collaborò a questa testata negli ultimi anni di vita con pezzi molto lucidi sul Medioriente. La sua vita merita di essere conosciuta.
Camignolo, Canton Ticino, 1976. Sono, con Emanuele Segre, ospite della casa di campagna dei genitori: Bruno e Matilde. I nostri rispettivi genitori ci hanno iscritto alla scuola media sperimentale di via Vivaio, a Milano, e rapidamente abbiamo fatto amicizia. Gli esperimenti consistevano in una scuola a tempo pieno, in insegnamenti pluridisciplinari e nell’apprendimento di uno strumento musicale. Emanuele è divenuto un chitarrista classico che si esibisce in tutto il mondo; quanto a me, dopo tre anni di studio del pianoforte riuscivo a eseguire Coccinella con due dita. Pur avendo nel tempo notizie della famiglia Segre e dei progressi della carriera di Emanuele, ho rivisto Bruno, credo, solo nel 2012, in occasione di un suo incontro per il Giorno della Memoria organizzato dal Comune di Milano. Era gennaio e, terminata la conferenza, scambiammo due parole, ma il clima non induceva a trattenersi in chiacchiere. In quegli anni stavo andando a caccia di chi aveva conosciuto di persona Adriano Olivetti e ricordavo vagamente che Bruno aveva lavorato per l’azienda di Ivrea; così, qualche mese più tardi trascorsi un intero pomeriggio a parlare con lui del mondo intorno a Olivetti. Lo aveva frequentato in gioventù e aveva partecipato all’esperienza del Movimento Comunità, di cui era stato membro attivo, vivendo per qualche anno a Ivrea nella seconda metà degli anni Cinquanta. C’era poi tornato negli anni Settanta, lavorando, tra Milano e il Canavese, ai servizi culturali della Olivetti con Renzo Zorzi.
Nella conversazione affiorarono però altre esperienze che sembravano essere state più importanti per lui. Mi ripromisi quindi di tornare a intervistarlo, ma, come sempre accade, c’erano sempre delle cose più urgenti da fare. Poi una domenica, era il 2015, apparvero due pagine su «La Repubblica» in cui, con Antonio Gnoli, Bruno ripercorreva le principali tappe della sua esistenza. Al momento ebbi l’impressione di essermi lasciato soffiare uno scoop. Poi, riflettendo, pensai che c’era ancora molto altro da dire e, alla successiva Buchmesse, ne parlai con Fabio Casagrande, che lo aveva intervistato per l’«Archivio Storico Ticinese» sulle sue esperienze di insegnamento negli anni del Sessantotto ticinese. Bruno aveva vissuto in Canton Ticino tra il 1964 e il 1969, quando aveva insegnato nella Scuola magistrale di Locarno. Dovette abbandonare la Svizzera perché fu accusato dalla dirigenza scolastica di aver fomentato le proteste degli studenti, insieme ai colleghi e amici Sandro Bianconi e Virgilio Gilardoni (ma la sua frequentazione del Ticino è proseguita nei decenni successivi). Dissi a Fabio che qualcuno avrebbe dovuto intervistarlo. Lui mi esortò: «Fallo tu». Risposta ineccepibile per un editore. Con Bruno fu facile combinare. Lessi un po’ di suoi articoli «militanti», soprattutto sulla politica di Israele negli ultimi anni e sui suoi riflessi sulla comunità ebraica in Italia.
Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 abbiamo trascorso due giornate insieme tra Canton Ticino e Milano. Abbiamo parlato delle sue origini, della sua vita, delle sue idee. La conversazione è ruotata intorno al concetto di identità ebraica per un cittadino italiano della sua generazione – è nato nel 1930 –, ma Bruno Segre aveva il dono di raccontare e riflettere allo stesso momento; perciò la chiacchierata ha assunto un andamento narrativo.
In Storie di un’altra Italia. Incontri e ritratti (Edizioni Casagrande, 2023) ho riunito le storie di una serie di personaggi nati nel XX secolo che mi è capitato di incontrare perlopiù di persona a partire dagli anni Novanta. Alcuni celebri (Umberto Eco, Stajano, Giulia Maria Crespi), altri raccontati attraverso chi li ha conosciuti molto da vicino, come Giulio Einaudi nelle parole del fratello Roberto, o Pier Pasolini in quelle del cugino Nico Naldini. Poi ci sono i ritratti di maestri di inapparenza come Gianni Antonini, braccio destro di Raffaele Mattioli alla Ricciardi, o Roberto Cerati, direttore commerciale dell’Einaudi degli anni d’oro. Scrittori come Marisa Bulgheroni o Manlio Cancogni, ma poi tanti nomi meno noti come Bruno Segre (1930-2023) che collaborò a questa testata negli ultimi anni di vita con pezzi molto lucidi sul Medioriente. La sua vita merita di essere conosciuta.
* * *
Camignolo, Canton Ticino, 1976. Sono, con Emanuele Segre, ospite della casa di campagna dei genitori: Bruno e Matilde. I nostri rispettivi genitori ci hanno iscritto alla scuola media sperimentale di via Vivaio, a Milano, e rapidamente abbiamo fatto amicizia. Gli esperimenti consistevano in una scuola a tempo pieno, in insegnamenti pluridisciplinari e nell’apprendimento di uno strumento musicale. Emanuele è divenuto un chitarrista classico che si esibisce in tutto il mondo; quanto a me, dopo tre anni di studio del pianoforte riuscivo a eseguire Coccinella con due dita. Pur avendo nel tempo notizie della famiglia Segre e dei progressi della carriera di Emanuele, ho rivisto Bruno, credo, solo nel 2012, in occasione di un suo incontro per il Giorno della Memoria organizzato dal Comune di Milano. Era gennaio e, terminata la conferenza, scambiammo due parole, ma il clima non induceva a trattenersi in chiacchiere. In quegli anni stavo andando a caccia di chi aveva conosciuto di persona Adriano Olivetti e ricordavo vagamente che Bruno aveva lavorato per l’azienda di Ivrea; così, qualche mese più tardi trascorsi un intero pomeriggio a parlare con lui del mondo intorno a Olivetti. Lo aveva frequentato in gioventù e aveva partecipato all’esperienza del Movimento Comunità, di cui era stato membro attivo, vivendo per qualche anno a Ivrea nella seconda metà degli anni Cinquanta. C’era poi tornato negli anni Settanta, lavorando, tra Milano e il Canavese, ai servizi culturali della Olivetti con Renzo Zorzi.
Nella conversazione affiorarono però altre esperienze che sembravano essere state più importanti per lui. Mi ripromisi quindi di tornare a intervistarlo, ma, come sempre accade, c’erano sempre delle cose più urgenti da fare. Poi una domenica, era il 2015, apparvero due pagine su «La Repubblica» in cui, con Antonio Gnoli, Bruno ripercorreva le principali tappe della sua esistenza. Al momento ebbi l’impressione di essermi lasciato soffiare uno scoop. Poi, riflettendo, pensai che c’era ancora molto altro da dire e, alla successiva Buchmesse, ne parlai con Fabio Casagrande, che lo aveva intervistato per l’«Archivio Storico Ticinese» sulle sue esperienze di insegnamento negli anni del Sessantotto ticinese. Bruno aveva vissuto in Canton Ticino tra il 1964 e il 1969, quando aveva insegnato nella Scuola magistrale di Locarno. Dovette abbandonare la Svizzera perché fu accusato dalla dirigenza scolastica di aver fomentato le proteste degli studenti, insieme ai colleghi e amici Sandro Bianconi e Virgilio Gilardoni (ma la sua frequentazione del Ticino è proseguita nei decenni successivi). Dissi a Fabio che qualcuno avrebbe dovuto intervistarlo. Lui mi esortò: «Fallo tu». Risposta ineccepibile per un editore. Con Bruno fu facile combinare. Lessi un po’ di suoi articoli «militanti», soprattutto sulla politica di Israele negli ultimi anni e sui suoi riflessi sulla comunità ebraica in Italia.
Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 abbiamo trascorso due giornate insieme tra Canton Ticino e Milano. Abbiamo parlato delle sue origini, della sua vita, delle sue idee. La conversazione è ruotata intorno al concetto di identità ebraica per un cittadino italiano della sua generazione – è nato nel 1930 –, ma Bruno Segre aveva il dono di raccontare e riflettere allo stesso momento; perciò la chiacchierata ha assunto un andamento narrativo.
Presto dovette fare i conti con la sua identità ebraica. Un primo trauma furono, nell’autunno del 1938, le leggi razziali, che non gli consentirono di proseguire gli studi in una scuola pubblica
Ho sbobinato e messo in ordine, poi Bruno ha rivisto integralmente il tutto, annotando, precisando, aggiungendo. Che razza di ebreo sono io è un libro suo a tutti gli effetti.
Che razza di ebreo è stato Bruno Segre? La risposta rimane aperta, a partire dalle origini dei genitori: la famiglia paterna ha seguito il classico processo di assimilazione degli ebrei italiani tra Otto e Novecento, quella materna è di origine irlandese. Le carte quindi si sono mescolate da subito, con un cosmopolitismo di fondo che ha reso Bruno un cittadino del mondo con la consapevolezza di essere il risultato di una stratificazione di storie. Presto però dovette fare i conti con la sua identità ebraica. Un primo trauma furono, nell’autunno del 1938, le leggi razziali, che non gli consentirono di proseguire gli studi in una scuola pubblica. «La mia è stata un’infanzia abbastanza solitaria», mi ha detto con il suo classico understatement, ma non poteva dimenticare di essere diventato da un giorno all’altro «un invisibile».
Un secondo trauma fu la morte del padre nel giugno 1941, quando fu colpito da un ictus fatale dopo che la sua domanda di assimilazione (una pratica che il regime fascista offriva agli ebrei di nazionalità italiana per recuperare i propri diritti civili, ma che si rivelò poco più che un bluff) fu respinta. Fu la madre, Kathleen, a superare le trappole mortali della guerra, specie dopo l’8 settembre, quando condusse i due figli minorenni nelle campagne attorno ad Ascoli Piceno dove, in qualche modo, la sfangarono. Nei racconti di Bruno ci sono immagini che restano scolpite: il ritorno a Milano su un camion, con la madre e la sorella accanto al guidatore, mentre lui, seduto dietro in mezzo a un carico di mele, scorge l’Italia sconvolta dalle conseguenze della guerra; oppure le perlustrazioni in bicicletta nella Milano del 1945 distrutta dai bombardamenti, di notte ancora buia e pericolosa per il rischio di incontrare sbandati in armi.
Luminoso, oggi quasi un miraggio, il ricordo di Israele, visitata nel 1961, in un viaggio con Matilde e la sorella Laura. Allora sembrava un’utopia in grado di realizzarsi; così Bruno pensò seriamente di fare aliyah, di tornare alla terra dei padri, quando scoppiò la Guerra dei sei giorni (1967) e per un momento si pensò che il giovane Stato rischiasse la sopravvivenza. Ci tornò dieci anni dopo, con Emanuele, ma i semi dell’intolleranza erano già stati gettati. I territori occupati ponevano problemi quotidiani di convivenza, un tema a cui Segre si dedicò, in maniera inaspettata, a partire dal 1991, quando era da poco in pensione. Un amico dei tempi di Ivrea lo aveva coinvolto in Nevé Shalom (Wāħat as-Salām, il nome in arabo), un villaggio cooperativo e un esperimento di convivenza tra 25 famiglie ebraico-israeliane e 25 arabo-palestinesi. L’amico morì improvvisamente e toccò a Bruno occuparsi della sezione italiana dell’associazione a sostegno del villaggio, il che significava andare in Israele tre-quattro volte l’anno per cercare di dirimere difficoltà di ogni genere, proseguendo un’esperienza che provai a sintetizzare così: «Una goccia nell’oceano». La risposta di Bruno («Sì, però esiste») è quella di un costruttore di ponti, pronto a ricostruirli ogni volta che vengono distrutti. Bisognerebbe aggiungere che le conversazioni con lui sono sempre state scandite dal suo sense of humour, dal contagioso ottimismo con cui incoraggiava chi incontrava sul suo cammino, dalla sua capacità di analisi della situazione internazionale, con particolare riferimento a quella di Israele, di cui non ha mai smesso di occuparsi. Sullo sfondo c’era la ricerca di spiritualità di una persona che restava integralmente laica.
“Già, che razza di ebreo sono io? È una domanda che mi sto ponendo da un po’ di tempo. Sarò forse capace di rispondere il giorno in cui, finalmente, diventerò adulto?”
La vita di Bruno è cambiata dopo la morte, nel 2018, di Matilde, la colonna portante dell’intera famiglia – non solo per i sessant’anni di matrimonio, ma per avere condiviso tutto «nella buona e nella cattiva sorte». Bastava entrare in casa Segre per capire come Matilde sia stata il cuore pulsante della famiglia, colei che teneva insieme tutto e tutti. Torinese, severa e dolce al tempo stesso, è stata una madre e una nonna non solo dei tre figli e dei cinque nipoti ma degli amici dei figli e dei nipoti. Ricordo che dopo aver completato Che razza di ebreo sono io, chiesi a Matilde se lo avesse letto in bozza. Rispose che lo avrebbe fatto con calma perché le storie raccontate nel libro le aveva ascoltate già tante volte. Come ha rammentato la figlia Vera, in occasione della commovente celebrazione laica al cimitero di Lambrate, era diventata una perfetta Jewish mother senza in realtà esserlo. Intenzione di Bruno è stata quella di seppellire Matilde, secondo una tradizione della famiglia Segre, nel cimitero di Monticelli d’Ongina, ma l’autorizzazione è stata negata dal rabbino della comunità di Parma, che ha giurisdizione su quel cimitero, perché non era di origine ebraica. Un’amarissima sorpresa per lui che, dopo averla metabolizzata (e non è stato facile) ne ha fatto lo spunto per Il funerale negato (2020), un altro libretto che abbiamo fatto insieme dove, al di là del caso personale, Bruno ha ragionato sulla persistente mancanza di spirito laico nel nostro Paese, «l’ombra lunga dei Patti Lateranensi», per citare il sottotitolo.
Bruno Segre ha osservato più di due terzi del XX secolo e l’inizio del XXI da una posizione leggermente defilata: non è stato un protagonista, ma un testimone con tutti gli strumenti per comprendere quello che accadeva intorno a lui.
Così finisce la riflessione sulla sua identità: «Già, che razza di ebreo sono io? È una domanda che mi sto ponendo da un po’ di tempo. Sarò forse capace di rispondere il giorno in cui, finalmente, diventerò adulto?»
Bruno è mancato nell’agosto 2023. Lo avevo incontrato il mese prima e, seppur molto provato, non aveva perso il suo spirito leggero che rendeva molto attraente la sua frequentazione. Alla notizia della sua morte ho pensato che il mondo aveva perso un uomo giusto.

Etgar Keret: “Hamas massacra gli ebrei e tradisce i palestinesi”
Lo scrittore israeliano: “Questo è un periodo felice per gli estremisti. Il governo Netanyahu deve andare via prima che la guerra finisca, non dopo: è un nodo gordiano affidare a chi ha creato questa situazione il compito di risolverla”
TEL AVIV – Dal soggiorno della sua casa assolata poco lontano dal centro di Tel Aviv, Etgar Keret riflette sul suo Paese e quanto gli è accaduto dal 7 ottobre a oggi con lo sguardo quanto più possibile distaccato e tagliente che si ritrova nei suoi libri. «È come stare in una serie Netflix, ma di quelle brutte – racconta mentre ci prepara un caffè che, per sua stessa ammissione, non sa fare –: nella prima stagione c’è “Il Governo”, con personaggi come Smotrich e Ben Gvir (il riferimento è ai due ministri dell’ultradestra dell’esecutivo Netanyahu, ndr). Nella seconda “Il Golpe”, ovvero la riforma giudiziaria. La terza sarebbe intitolata “Il Massacro”. Tu, spettatore, resti seduto a chiederti cosa conterrà la quarta stagione, cosa altro può accadere di orribile».
Keret parla accarezzando Hanzo, il coniglio bianco che da otto anni fa compagnia alla famiglia e che in queste settimane, più che mai, ha la funzione di calmante collettivo della casa. Ha appena finito, come fa ogni fine settimana da metà ottobre a questa parte, di inviare via WhatsApp pensieri e parole a chi, nella crisi, si è rivolto a lui. «Persone che non trovavano le parole, o che dicono di non saper scrivere. Per la maggior parte, mi hanno contattato sui social network, chiedendomi di scrivere per loro, o le ho incontrate nei vari eventi a cui ho partecipato. Ogni sabato metto insieme le mie “note” e gliele mando». Fra i destinatari ci sono una ragazzina che ha perso il padre il 7 ottobre, l’ex fidanzata di un soldato che è a Gaza, e molti altri: ogni storia è un mondo a sé. «Magari un giorno confluirà in un libro?», chiediamo. «Non so. Per settimane non sono riuscito a scrivere nulla che fosse fiction. Solo qualche giorno fa mi è venuto un racconto: un ultraortodosso che cerca disperatamente la preghiera giusta, convinto che se la troverà riuscirà a salvare il mondo».
A salvare il suo di mondo, Keret non pensa affatto: a differenza della generazione di scrittori precedenti alla sua, David Grossman, Amos Oz, Abraham Yehoshua, questo 56nne non ha mai voluto essere la voce di Israele, né mettere il tema della convivenza con “l’altro”, inteso come i palestinesi, al centro della sua opera. Ma oggi al confronto è impossibile sfuggire.
Signor Keret, come sta Israele?
«Sicuramente non siamo più quelli che eravamo due mesi fa. Posso dirle come mi sento io: un po’ meno essere umano, un po’ più scarafaggio. Ha molto a che fare con la maniera in cui abbiamo vissuto il 7 ottobre: dentro le stanze delle persone che stavano per morire o per essere rapite. Quel giorno nessuno ha risposto: né l’esercito, né le istituzioni. Chi aveva bisogno di aiuto ha chiamato la televisione: e noi in diretta abbiamo sentito le suppliche di queste persone e poi le abbiamo viste scomparire, gradualmente, sotto ai nostri occhi. In contemporanea, hanno iniziato ad arrivare le immagini delle bodycam di Hamas. Un Paese intero ha vissuto l’orrore in prima persona: questo spiega la totale identificazione che c’è ora nelle storie degli ostaggi e delle loro famiglie, come se fosse un reality show. C’è gente che sta male per loro, per questo gioco a eliminazione che abbiamo vissuto sera dopo sera per una settimana, come fosse “Squid Games”. Settecento famiglie di sono fatte avanti per adottare la piccola Abigail (la bambina di quattro anni che ha visto i genitori uccisi a Kfar Aza ed è stata liberata sei giorni fa, ndr), come se non avesse una famiglia. Abbiamo perso la lucidità, viviamo in uno stato di costante confusione. La mia sfida, ora che ho messo a fuoco questa dinamica, è restare lucido. Ogni tanto mi dico “Vai e prenditi cura del tuo coniglio, altrimenti impazzirai”. E così faccio».
E allora da dove si riparte?
«Questa è una domanda difficile. Le persone più colpite dall’attacco del 7 ottobre sono quelle che più avevano lavorato per costruire ponti, da una parte e dall’altra. Gli abitanti dei kibbutz, gente di sinistra per la maggior parte, che lavorava con e per la popolazione di Gaza. Ma anche gli arabi-israeliani che sono stati licenziati o si sono dimessi perché avevano troppa paura a venire a lavorare. Su Facebook tante persone mi hanno detto: “E ora? Ora tu e quelli come te vi scuserete?”. Scusarci di cosa? Di essere stato contro Hamas mentre il vostro primo ministro (il riferimento è a Netanyahu, ndr) li faceva crescere? Questo è un periodo felice per gli estremisti. Non so da dove ripartiremo, ma credo che la sfida debba essere cambiare questo governo prima che la guerra finisca, non dopo: è un nodo gordiano affidare a chi ha creato questa situazione il compito di risolverla».
Lei ha scritto parole molto belle su come la sinistra israeliana si senta tradita dall’appoggio del mondo progressista per la causa palestinese. Può spiegarci cosa intendeva? Che cosa è che sfugge ai progressisti, secondo lei?
«Faccio un passo indietro e le dico che se guardo le cose a distanza, è l’intero mondo a essere impazzito, non solo chi parla di Israele: è qualcosa di più grande di questo conflitto e ha molto a che fare con i social, con la velocità con cui si prendono posizioni su cose che non si conoscono: salvo poi dimenticarle. Come le bandiere dell’Ucraina, sostituite da quelle palestinesi. Io dico che prima di parlare di Medio Oriente devi almeno – sottolineo, almeno – esserti letto due voci di Wikipedia: quella su Hamas e quella su Netanyahu. Poi, possibilmente, un paio di capitoli di libri di Storia su questa regione. Non venite a dirmi che quelli del 7 ottobre erano palestinesi che si battevano per i due Stati: hanno ucciso in nome del fondamentalismo religioso, è l’Iran a cui rispondono, non alla causa palestinese. Forse che si battevano per i palestinesi era vero anni fa, non lo è più oggi: non parlavano di Palestina, parlavano di uccidere ebrei. Hanno massacrato anche stranieri, donne con l’hijab, chi quel fondamentalismo non lo condivide».
Nei Territori palestinesi però il consenso per Hamas cresce. La gente dice di essersi sentita abbandonata per anni: dai Paesi arabi, dalla comunità internazionale: e che Hamas è l’unica ad aver fatto qualcosa.
«Prima di tutto, la crescita di Hamas è anche frutto delle politiche di Netanyahu: l’idea che ha portato avanti per vent’anni che la violenza di Hamas poteva essere contenuta, interfacciandosi con loro piuttosto che con un partner pragmatico, laico, che non tira fuori Allah ma vuole risolvere le questioni. Io credo che se lei chiedesse in privato alla gente di Ramallah o di Gaza se davvero Hamas ha fatto qualcosa di positivo per la causa palestinese, avrebbe una risposta molto diversa da quella che danno in pubblico. Credo che nessuno pensi che più di 14mila morti, le case distrutte, le famiglie devastate, i rifugiati abbiano contribuito a far avanzare la causa palestinese».
Vorrei tornare sul senso di abbandono di cui abbiamo parlato prima: in queste settimane, abbiamo visto gli israeliani attaccare le Nazioni Unite e le grandi ong, il Comitato internazionale della Croce rossa, chi invoca il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dei civili: non sono eccessive queste critiche?
«Conosco una persona che è a Gaza: ha bisogno di medicine, è sopravvissuto all’Olocausto. Ho sentito di bambini marchiati con le marmitte delle moto: e in mezzo a tutto questo, la Croce rossa rifiuta di portare medicine perché non è il suo mandato. A me pare una follia: non solo questo, molto altro mi pare una follia. Pensate davvero che gridare “From the river to the sea”, dal Fiume al Mare, convincerà Israele a fermare le bombe? O piuttosto non ci farà pensare che non c’è nulla di cui possiamo discutere con chi dice certe cose? Non capisco le dinamiche come quelle delle organizzazioni omosessuali che sfilano per un’organizzazione che vuole uccidere gay e lesbiche. Mi pare che sempre più persone vivano lontane dalla realtà, quella autentica, non quella che pensiamo che sia autentica».
dalla nostra inviata Francesca Caferri

Nevo: un abisso ci divide (anche dagli amici). L’ora più buia prima dell’alba
di Eshkol Nevo
Il racconto dello scrittore: la vicina che ha perso un figlio, la gioia per gli ostaggi liberati, le case svuotate dei vicini e quelle distrutte dei palestinesi. «Penso ancora che si debba trattare. Ma non con Hamas»
I miei amici italiani si felicitano con me per il ritorno degli ostaggi. Finalmente un barlume di speranza! mi scrivono. Non che io non sia d’accordo con loro. La scena di Ohad Munder di nove anni che si precipita di corsa tra le braccia del papà in ospedale dopo essere stato rilasciato, credo di averla vista già cinque volte. E la rivedrò molte altre nei prossimi giorni, perché abbiamo tutti un disperato bisogno di grazia.
Ma qualcosa dentro di me respinge le reazioni entusiastiche. Come anche le critiche unilaterali al mio Paese, basate su informazioni parziali, superficiali. Quasi esistesse un abisso, che per ora non sono ancora riuscito a colmare, tra me e gli amici che vivono fuori da Israele. Un’incomprensione profonda e molesta. In che modo la posso annullare?
La vicina
Potremmo iniziare con Dalia, di Malkia, un piccolo kibbutz al confine con il Libano. Dalia di fatto è la mia vicina, perché la casa dove vado a scrivere da qualche anno a questa parte e nella quale ho trovato rifugio durante la pandemia, è proprio accanto alla sua (l’ha costruita mio padre con l’idea di trasferirsi lì da pensionato, ma quando era pronta è arrivata mia madre e dopo una sola occhiata ha dichiarato: io vicino a Hezbollah non ci abito! Così la casa è diventata un rifugio per figli e nipoti in cerca di tranquillità lontano dal trambusto della città). Abbiamo incontrato Dalia fin dalle nostre prime visite a Malkia e siamo profondamente legati. È una delle persone più generose che io abbia mai conosciuto.
Adora avere ospiti, ti invita per una cena e una chiacchierata cuore a cuore. A partire dall’8 ottobre, però, Dalia non può più aprire la sua casa agli ospiti. Come tutti coloro che abitano vicino al confine settentrionale se n’è dovuta andare a causa degli attacchi di Hezbollah e abita in un albergo deprimente a Tiberiade. Io qui sto diventando matta, mi ha scritto ieri. E ha aggiunto: la cosa più intollerabile è che nessuno ha idea di quando potremo tornare a casa. In effetti, quando potranno tornare? penso. E non so cosa risponderle. Quale sistema potrà garantire loro che i terroristi di Hezbollah non attraversino il confine una notte qualunque, per rapirli come ha fatto Hamas al sud?
Andiamo avanti: Iris vive da ormai molti anni a Sderot. A una manciata di chilometri dal confine con Gaza. Ma anche lei e i suoi figli ora sono profughi. All’inizio li abbiamo ospitati a casa nostra. Adesso sono in un albergo. La mattina del 7 ottobre lei non era in città. La sua figlia maggiore invece sì. È rimasta nascosta nel rifugio dentro casa per dodici ore, convinta che sarebbe morta. Iris è una psicoterapeuta del movimento, ma adesso non ha chi aiutare, perché la maggioranza dei suoi pazienti arrivava dai kibbutz vicini a Gaza. Sono stati massacrati, oppure rapiti. E poi non sa se i suoi figli accetteranno mai di tornare a vivere a Sderot. D’altra parte, chi comprerebbe il suo appartamento in un momento simile? Andiamo a trovarla nell’albergo. Il contrasto tra il lusso della lobby e il caos che imperversa è stridente. Ci racconta che nell’albergo tutti sono al limite della sopportazione. Tra la gente scoppiano litigi, baruffe, e la situazione peggiora ogni giorno, non ce la fanno più a stare lì, ma non hanno altro posto dove andare.
La forza di ricominciare
Le proponiamo di trovare uno spazio in cui potrà riprendere almeno le sue sedute terapeutiche, così tornerà a guadagnarsi da vivere, e le promettiamo aiuto nel pubblicizzarle. Ci ringrazia ma dice, onestamente, che non è certa di avere la forza di tirarsi su e rimettersi al lavoro.
Sulla via del ritorno, dopo avere salutato Iris, penso: come potrà mai tornare a dormire tranquilla nella sua casa a Sderot, dopo quello che è successo il 7 ottobre? Mentre Hamas controlla ancora la Striscia di Gaza?
E non posso ignorare le immagini di Gaza. Persone che vagano tra le macerie delle loro case. Alcuni di loro hanno partecipato ai saccheggi e alle violenze avvenuti il 7 ottobre. Sono cose risapute, documentate. Dopo che i terroristi di Hamas hanno sfondato la recinzione, una folla scatenata li ha seguiti. Non tutti hanno partecipato a quelle atrocità, rammento a me stesso mentre guardo la Cnn. Non tutti. Queste persone, che adesso cercano tra le macerie qualche oggetto personale (la distruzione è enorme, inimmaginabile), sono a loro volta vittime di Hamas, che dopo il ritiro di Israele da Gaza ha scelto di impegnare le sue risorse in terrorismo e missili invece che in costruzione e benessere. Dove troveranno le forze per ricostruire le loro case distrutte, sapendo che a qualsiasi ora, in qualunque giorno, finché Hamas sarà al potere, potrà iniziare un nuovo ciclo di distruzione e sofferenza?
Il processo di pace
Io sono fra gli israeliani che per anni hanno sostenuto il processo di pace. Ho scritto articoli. Ho parlato alle manifestazioni. Ho creduto veramente, e credo ancora, che dobbiamo condurre trattative dirette con i palestinesi e giungere con loro a un accordo a lungo termine. E che siamo noi, la parte più forte, che le dobbiamo avviare. Che dobbiamo accettare compromessi, cedere. Ma non con Hamas. Per carattere sono più incline ai punti interrogativi che ai punti esclamativi. Però a volte le cose sono chiare. Non c’è spazio per dialogo e compromessi con chi ammazza bambini, stupra donne e rapisce anziani.
Ricordo a me stesso che dopo la sconfitta dei nazisti in Europa è iniziato un periodo di prosperità. Penso che dopo la sconfitta dell’Isis il Medio Oriente ha tirato un sospiro di sollievo. Chi, come me, crede che esista una possibilità di pace tra Israele e i palestinesi e gli Stati arabi, deve ripudiare Hamas e sperare che venga sconfitto in questa guerra e smetta di governare da Gaza.
Le strade vuote
Sono stati giorni di tregua, una tregua che mentre leggete questo articolo è già finita. Ma le strade erano rimaste comunque vuote. Quando cala il buio, ci si chiude in casa a guardare il telegiornale. Ieri sera all’improvviso hanno bussato alla porta. Chi poteva essere? In passato avremmo semplicemente aperto. Adesso ci avviciniamo sospettosi. Sbirciando dallo spioncino. Buio. Non si vede niente. Allora chiediamo: «Chi è?». «Marcelle», risponde la voce all’esterno. A mia moglie torna in mente, è vero, ha avvisato che sarebbe passata. Le apriamo la porta e la invitiamo a entrare. Abbraccia mia moglie a lungo. Il figlio di Marcelle è stato ucciso da Hamas durante il festival musicale a Re’im il 7 ottobre. È stato sepolto nel cimitero della nostra città e Marcelle ha deciso, dopo la settimana di lutto stretto, di trasferirsi in città per stare vicino alla sua tomba. Qui però non conosce nessuno e non ha la forza di tirarsi su e prepararsi da mangiare. Le donne del quartiere si sono organizzate per cucinare a turno, ogni giorno una diversa prepara anche per lei.
Marcelle prende la pentola da mia moglie. Un sorriso piccolo, mesto, le rianima il viso. La invitiamo a fermarsi con noi, ma lei ringrazia ed esce nel buio con la pentola. Serriamo la porta alle sue spalle. Ci sediamo per seguire le notizie. Mostrano a ripetizione Ohad Munder che corre tra le braccia del papà in ospedale, e io ripenso al verso di una canzone israeliana che amo: «Prima dell’alba è sempre il momento più buio».
(Traduzione di Raffaella Scardi)

Eshkol Nevo: «Noi, il male e la sfida: non farci contagiare»
di Eshkol Nevo
Lo scrittore israeliano sul suo ritorno in patria. «Solo immaginare il futuro ci può aiutare». E i piccoli «momenti di grazia» che si manifestano nella vita quotidiana
Il 7 ottobre, quando è avvenuta la carneficina, ero in Italia. A Torino, in un bell’appartamento, vicino a Piazza Emanuele Filiberto. In quelle stesse ore mia moglie e le mie figlie erano in volo per Israele. Il loro aereo non ha ricevuto l’autorizzazione ad atterrare per timore che i missili colpissero l’aeroporto ed è stato dirottato su Cipro. L a maggior parte dei passeggeri è sbarcata a Cipro e poi ha trascorso la settimana successiva nel vano tentativo di trovare una maniera di raggiungere Israele. Mia moglie e le mie figlie hanno deciso di tornare assieme all’equipaggio in Italia. Da me.
Le ho aspettate a casa. Ho imbandito la tavola, una grossa insalata, una frittata speciale, formaggio, pane fresco. Nel frattempo leggevo notizie spaventose e guardavo video terrificanti diffusi da Hamas. Sono arrivate la sera molto tardi, stanche, tristi e affamate. Hanno mangiato e sono andate a dormire. La mattina presto mi ha svegliato il suono di un messaggio in arrivo sul mio telefono. Era il mio amico Assaf. Credo che Yftach, il figlio di Shira, sia stato ucciso, scriveva. Puoi controllare se è proprio lui? Era accaduto il peggio. Yiftach Yavets, il figlio di Shira, che conosco da quando è nato, era morto nella battaglia il primo giorno di guerra. Mia moglie si è svegliata. Gliel’ho raccontato. Ho pianto tra le sue braccia. Non piangevo da vent’anni, da quando c’è stato l’attentato nel Sinai.
Il giorno dopo, mentre viaggiavo in treno, ho parlato di Yiftach e Shira con alcuni amici israeliani. Ho pianto di nuovo. La sera ho partecipato a un evento a Milano. È stata dura. Non trovavo parole. Ho chiesto al moderatore che si facesse un minuto di silenzio in memoria di Yiftach. Lui ha accettato. Centinaia di italiani hanno taciuto in ricordo di un ragazzo bello, intelligente, sensibile, che non conoscevano e non potranno più conoscere. Il moderatore ha cercato di parlare con me di fake news. Di verità e falsità. Mi sono innervosito. Gli ho detto: quale falso? Guarda i video di Hamas e credici. Questa è la faccia del male, il male nel mondo esiste e se non lo fermeremo arriverà fino alla vostra casa. Ai vostri figli.
Sono tornato a Torino, ai miei studenti alla Scuola Holden. Ho confuso il fuso orario di Israele con quello italiano. Sono arrivato tardi. Io non sono mai in ritardo. In venticinque anni non ho mai tardato a una lezione. Ho detto agli studenti: farò del mio meglio per continuare a insegnarvi fino a quando io e la mia famiglia non troveremo un volo per Israele. Ma in classe non ci saranno più risate. Ho il cuore in pezzi. Gli studenti si sono dimostrati empatici, nonostante nessuno di loro si fosse mai trovato in una situazione del genere e quindi non potessero capire veramente.
Ci è voluto parecchio tempo prima che trovassimo i biglietti per tutti su un volo per Israele. Nel frattempo molti amici, da Israele, suggerivano: rimanete in Italia. È meglio. Qui è l’inferno. Nessuno esce di casa. Si dorme con un coltello sotto il cuscino. Noi rispondevamo: non ci passa nemmeno per la testa. Abbiamo una figlia nell’esercito. Dal momento in cui è iniziata la guerra, ci telefona in Italia sei volte al giorno implorandoci di tornare. Una sua conoscente è stata ammazzata al rave. Un’altra è stata rapita, è a Gaza, ostaggio. La sua migliore amica si è salvata per miracolo perché i terroristi di Hamas, per puro caso, non sono entrati nella sua postazione. Non mi è possibile uscire dalla base, ci ha spiegato nostra figlia, ma mi farebbe bene sapere che siete qui vicini.
Cinque giorni dopo il massacro ho incontrato per la prima volta i miei studenti in Israele via Zoom, nell’ambito di quello che abbiamo deciso di chiamare «spazio di scrittura». Non «laboratorio di scrittura». Perché fosse chiaro che sono protetti. All’inizio dell’incontro ho detto che non dovevano scrivere bene, belle parole. Solo esprimere le loro emozioni. E che io non avrei commentato come al solito, ma mi avrebbe fatto piacere leggere in chat quello che scrivevano. Ho detto loro che una delle domande che mi tormentano in questi giorni è come si combatte la malvagità pura di Hamas senza esserne contagiati. Come possiamo continuare a credere nella bontà insita nell’uomo, dopo quanto abbiamo visto questa settimana? La chat si è pian piano riempita di piccoli momenti di grazia. Una donna aveva offerto a un’altra di bere dell’acqua dalla sua bottiglia dopo un allarme. Un uomo aveva fumato una sigaretta con calma, sul balcone, un minuto tutto per sé. Un bambino aveva abbracciato la mamma senza rendersi conto di come la stava confortando. Un cane, accorgendosi della tristezza del padrone, si era accucciato al suo fianco.
Ho guardato le facce dei miei studenti su Zoom. Erano molto pallidi. Non era il pallore già familiare dai giorni del Covid. Era un pallore diverso. Più profondo. Più preoccupante. Ho pensato: è tempo di tornare a casa.
Mentre ci avvicinavamo alle coste di Israele, l’uomo seduto accanto a me ha asserito con assoluta sicurezza: non stiamo atterrando come sempre a Ben Gurion. Non siamo sulla rotta normale. Ho il brevetto da pilota. Lo so. Ci portano a Eilat. Forse a Cipro. Ho guardato fuori dall’oblò. Non sapevo se credere a quello che vedevano i miei occhi o a quello che diceva l’uomo con il brevetto da pilota. Siamo atterrati a Ben Gurion. Non ci sono stati i soliti applausi. In generale, i passeggeri hanno mantenuto un silenzio assai poco israeliano durante tutto il volo. Abbiamo preso un taxi. Le strade erano vuote e l’autista furibondo nei confronti del governo e del fallimento dei servizi segreti. Agitava le mani mentre parlava e a un certo punto ho pensato che avrebbe perso completamente la testa, e anche il controllo dell’auto. Nei giorni successivi ho scoperto che il tassista era solo un’avvisaglia. Tutte le persone che conosco, senza alcuna eccezione, sono al limite. A un passo dal baratro.
Mentre eravamo in Italia, si è trasferita a casa nostra una famiglia scappata dalla zona vicina alla Striscia di Gaza. Amici. La madre non era riuscita a spiccicare parola per tutta la settimana. Si limitava a messaggi WhatsApp con richieste pratiche: dov’è il telecomando del condizionatore? Come funziona il forno? Avete una seconda chiave di casa? Metà dei suoi amici sono stati assassinati o rapiti nel Sabato Nero, ci ha scritto. Perciò è sotto choc. In lutto. Non è in grado di parlare. La sera prima del nostro rientro mi ha scritto che lo Stato aveva messo a disposizione una camera in un albergo, si trasferivano lì. Quando siamo entrati in casa e ho aperto il frigorifero, ho visto che ci avevano lasciato dei cioccolatini per ringraziare. Piccoli momenti di grazia. Di notte è partita la sirena d’allarme. Siamo corsi nel rifugio in pigiama. Abbiamo un rifugio in condivisione con i nostri vicini, una famiglia di sei persone. Ci si stringe tutti in uno spazio grande un quarto di un’aula della scuola Holden. Si sta lì dentro per dieci minuti. Dopodiché si può uscire. Il padre della famiglia dei vicini non c’era. Non ci sarebbe stato bisogno di chiedere alla madre, ma l’ho fatto ugualmente e lei ha risposto: sì, è arruolato tra i riservisti. In questo momento è al confine nord. Non so quando tornerà. Al mattino c’è stato un altro allarme. Le figlie sono rimaste a casa perché le scuole erano chiuse. Al supermercato scarseggiavano molti prodotti perché il Comando del fronte interno aveva dato indicazione di approvvigionarsi per l’eventualità di lunghe permanenze nei rifugi. Gli amici esitavano a incontrarsi per paura di lasciare i figli soli. Indifesi. Eppure, provavo una sensazione innegabile che si faceva più netta di ora in ora: essere a casa era bello.
Il giorno dopo sono andato a trovare Shira. La shivà, la settimana di lutto stretto, era già terminata. Era a casa da sola. Rughe nuove incise sul viso. Ci conosciamo da trent’anni, abbiamo lavorato insieme. È una delle donne più solide che abbia mai incontrato. Ci siamo seduti sul balcone a leggere in silenzio un libriccino che lei e Yiftach avevano creato insieme e intitolato Poesia per Shabbat. Da quando lui si era arruolato nell’esercito si scambiavano una poesia ogni venerdì. Un dialogo, una poesia di lui e una di lei. Ogni poesia rivela un diverso aspetto delle loro anime. Poi mi ha fatto leggere un biglietto di auguri che il figlio le aveva scritto qualche anno fa per il compleanno. Un amore così esplicito e aperto da parte di un figlio per sua madre, le ho detto, non è affatto scontato. Lo so, ha annuito con le lacrime agli occhi, avevamo un legame speciale. Abbiamo rievocato i giorni in cui lo portava, piccolissimo, nel posto dove lavoravamo. Una volta mi aveva pregato di tenerlo mentre partecipava a una riunione. Poi mi ha chiesto consiglio sulle parole da scrivere sulla lapide. Per me è importante, ha detto, che si sappia che ha salvato civili innocenti. Non ti puoi immaginare in quanti mi scrivono. Per ringraziare. Abbiamo riflettuto a lungo e alla fine abbiamo trovato una frase che la soddisfaceva. Poi si è alzata e ha detto che stavano per arrivare i rappresentanti del ministero della Difesa, si doveva preparare per la visita. L’ho abbracciata. Ho pensato che non esiste nulla che si possa fare o dire per consolare una mamma che ha perso suo figlio.
La stessa sera sono andato a un incontro per gli sfollati del kibbutz Mefalsim, ospiti in un albergo a Herzliya. La maggioranza dei membri del kibbutz è sopravvissuta al massacro del 7 ottobre grazie alla strenua resistenza della squadra di sicurezza locale. Ma i loro amici delle comunità vicine sono stati uccisi o portati a Gaza come ostaggi e loro, mentre venivano evacuati, sono passati davanti a cadaveri di bambini, donne e anziani, buttati lungo la strada. Quando lo spettacolo è cominciato sono stato contento di aver chiesto l’accompagnamento di alcuni musicisti. La musica sembrava aiutare il pubblico più delle parole. Mentre i musicisti suonavano ho osservato le facce dei presenti. I loro corpi. Sembrava che ne avessero succhiato fuori la vita, l’anima. Restavano solo dei gusci vuoti.
Con il passare dei giorni mi rendo conto che non solo i membri del kibbutz Mefalsim, ma tutte le persone che conosco soffrono di qualche trauma. Un caro amico, con cui vado a camminare la sera da anni, dal 7 ottobre ha paura di uscire di casa. Una coppia di amici, di solito dotati di eccellente senso dell’umorismo, ha passato un’intera serata nel nostro salotto senza che l’ombra di un sorriso sfiorasse le labbra. Il figlio è nell’esercito. Sono preoccupati. La donna ha detto: sono traumatizzata e consapevole di esserlo.
Tengo due o tre incontri al giorno, su Zoom, con studenti e lettori. Con gli studenti, cerco di aiutare a trovare parole che possano descrivere le loro sensazioni: trovare parole ti restituisce un minimo di controllo, o quanto meno ti illude di trovarlo, nel mezzo del caos che ci ha travolti. Per i lettori cerco racconti che possano confortare, rincuorare, regalare speranza. Uno di loro mi ha scritto nella chat: la storia che ci siamo raccontati sulla nostra vita sicura in questo posto si è spezzata. Non ci possiamo più credere. Aiutaci a trovare una storia nuova.
Durante un incontro su Zoom con dei bambini, dopo che avevo letto loro i miei libri per piccoli, la moderatrice ha chiesto: avresti qualche consiglio per i bambini che in questi giorni hanno paura, su come affrontarla? Non ero preparato. Non sono uno psicologo, né un esperto di resilienza. Perciò ho risposto di pancia: due cose mi fanno bene in questo periodo. Una è aiutare gli altri, essere disponibile per loro. Così pensi meno a te stesso. L’altra è immaginare e ricordare. Non rimanere costantemente in questo momento difficile, angosciante, ma riandare a momenti piacevoli e belli del passato e immaginare un futuro migliore che ci aspetta.
Ancora non so quale sarà la nuova storia che verrà scritta dopo questa guerra. È troppo presto per saperlo. Una cosa però mi è chiara.
Il 7 ottobre, Hamas ha cercato di spezzare lo spirito degli israeliani. Il fatto che stupri, saccheggi e sevizie siano stati documentati dalle telecamere frontali degli assassini e diffusi come video sui social media, dimostra che era una mossa di guerra psicologica premeditata. Mi inorgoglisce il fatto che sia successo l’esatto opposto di quanto pianificato da Hamas: le crudeltà del 7 ottobre hanno giustamente risvegliato negli israeliani i ricordi della Shoah e dei pogrom contro gli ebrei avvenuti nel passato, ma invece di spezzarci, ci siamo uniti. Rialziamo la testa consapevoli che non abbiamo altro posto dove andare. Questo è il nostro Paese e dobbiamo combattere perché continui a esistere. Le organizzazioni che protestavano contro il governo hanno ridiretto la loro energia, attività e intraprendenza nel sostenere chi è partito a combattere. Più del cento per cento dei riservisti richiamati si sono presentati. Chi non ha più l’età per combattere si offre volontario per prestare servizio ai confini. Israeliani che vivono all’estero rientrano per partecipare allo sforzo collettivo. Le diverse tribù che compongono la società israeliana, che fino allo scoppio della guerra erano divise in due fronti opposti riguardo al sistema giuridico, adesso agiscono unite, fianco a fianco. In reazione al trauma sorgono ogni giorno nuove iniziative. Mentre scrivo questo diario, mia moglie e nostra figlia in cucina preparano vaschette di cibo da mandare a chi combatte a Gaza. La figlia soldatessa si è ripresa e viaggia su e giù per il Paese, svolgendo qualunque compito le venga assegnato. I miei amici offrono aiuto alle decine di migliaia di israeliani, del sud e del nord, che sono stati evacuati dalle loro case. Fanno spettacoli, curano, ascoltano, ospitano, mandano abiti. Si ha la sensazione che non ci sia una sola persona in Israele non coinvolta in qualche modo in iniziative che, una per una e tutte insieme, dimostrano che non ci siamo spezzati. E che, insieme, vinceremo.
E c’è un’altra cosa chiara, e perché lo sia anche ai miei lettori fuori da Israele la scrivo qui senza mezzi termini. Perché questa storia possa avere un lieto fine, Hamas non ne può fare parte. Chi spera, come me, nella pace del Medio Oriente, deve augurarsi una inequivocabile, rapida, sconfitta di Hamas in questa guerra. Chi pensa, come me, che i palestinesi hanno diritto all’autodeterminazione, deve sperare che questa organizzazione terroristica, più micidiale dell’Isis, smetta di rappresentarli. Chi soffre, come me, anche per il dolore degli abitanti di Gaza in questi giorni, deve sperare che Hamas smetta di governare la Striscia.
Dicono che la guerra durerà diversi mesi. Spero vivamente di no. Altre madri come Shira, da ambo le parti, perdono i loro figli ogni giorno. Altra distruzione. Altro dolore.
Sfrutto tutte le capacità della mia immaginazione e guardo avanti, a primavera. La guerra è finita. Gli ostaggi sono stati rilasciati. Hamas non usa più Gaza come base per il terrorismo. Ci sono nuovi accordi di sicurezza e anche un orizzonte politico. Il primo ministro Netanyahu si è dimesso a causa delle responsabilità per questo disastro. Lo sostituisce un leader più coraggioso, più attento, che ha una vera visione per questa regione. Gli abitanti ai due lati del confine tornano alle loro case distrutte e iniziano a ricostruire.
Io parto per Torino, con il cuore in pace. Torno al mio bell’appartamento in Piazza Emanuele Filiberto.
La sera sento le campane della chiesa, non più le sirene d’allarme.

ISRAELE, IL SUDAFRICA, L’ALGERIA E NOI
Che cosa si sottintende quando, soprattutto in alcuni ambienti intellettuali di sinistra, si parla di decolonizzazione a proposito di Israele?
Anna Momigliano , Il Mulino
23 OTTOBRE 2023
Mi rendo conto che si pone un problema di opportunità. Mentre scrivo, fatti atroci si susseguono a velocità sostenuta, a Gaza c’è una crisi umanitaria senza precedenti, il numero di morti palestinesi ha superato quello delle perdite israeliane. E allora comprendo bene che, quando mi metto a discutere di categorie analitiche e dei torti di una parte della sinistra verso gli israeliani, il rischio di sembrare fuori luogo c’è tutto. Eppure, mi dico, il bello di scrivere per una rivista che si fregia di contribuire a tenere a galla quel poco di dibattito intellettuale che resta in Italia sta anche qui, nell’avere il lusso di fermarsi a ragionare su come ragioniamo.
Mettiamo da parte, per un secondo, i fatti di queste settimane, per riprenderli più in là. Negli ultimi anni ci sono stati due sviluppi interessanti del dibattito a sinistra. Primo, la riscoperta dei valori anticoloniali, che già in passato hanno avuto un peso rilevante, ma che recentemente sono stati rispolverati e attualizzati come chiave di lettura della contemporaneità. Secondo, la diffusione del framing dell’apartheid per descrivere l’occupazione dei Territori palestinesi. È un tema delicatissimo, di cui mi ero occupata sul fascicolo n. 2/2023, ma, in estrema sintesi, può essere riassunto così: Israele controlla di fatto la Cisgiordania, seppure non l’abbia formalmente annessa; in Cisgiordania vivono palestinesi e coloni israeliani, ma ai primi si applica la legge militare, ai secondi la legge civile; i primi non possono votare il governo che di fatto decide delle loro vite, i secondi sì; dunque c’è un territorio dove convivono due popolazioni, una sola delle quali gode di pieni diritti; e l’applicazione di due leggi e due sistemi di diritto a due popolazioni che vivono nello stesso luogo è, per definizione, apartheid.
Dunque, si diceva, abbiamo avuto queste due evoluzioni nel dibattito a sinistra. E si tratta, nella mia opinione, di due sviluppi positivi.
Adesso però veniamo ai fatti di oggi. Quello che è successo è che Hamas ha massacrato centinaia di civili israeliani, uomini, donne e bambini, stanandoli nelle loro case, e una parte della sinistra – certamente minoritaria, ma non del tutto marginale – l’ha considerato un atto di resistenza anticoloniale. In alcuni casi, ha persino festeggiato. Gli episodi più estremi arrivano dagli Stati Uniti: il professore di storia a Cornell che ha definito l’attacco di Hamas “esilarante” ed “energizzante”, perché sovvertiva il monopolio della violenza; oppure la docente di American Studies all’Università della California che ha twittato “è facile avvicinare i giornalisti sionisti, hanno case con indirizzi, figli a scuola” aggiungendo hashtag con coltello insanguinato. Nella mia bolla ho pizzicato gente a sfottere sui social media conoscenti israeliani – non il popolo israeliano in astratto, eh, persone reali con cui avevano studiato e lavorato – che stavano sotto le bombe. Meno agghiacciante, ma più sintomatica, l’ormai famigerata dichiarazione di una trentina di associazioni studentesche di Harvard, secondo cui “il regime di apartheid israeliano è l’unico responsabile della violenza”, dove il problema stava nell’affermare che ci fosse una responsabilità – dunque una colpa – unica. Ergo, se ne deduce che gli assassini abbiano agito secondo diritto, o per lo meno senza passare dalla parte del torto.
Altri si sono già soffermati sulla bancarotta morale che questi ragionamenti tradiscono. Io però vorrei soffermarmi sulla bancarotta intellettuale che si nasconde dietro a certe uscite. C’è gente che, da una posizione sedicente di sinistra, si schiera a favore dell’attacco indiscriminato contro i civili israeliani, di stampo marcatamente terroristico – nel senso più letterale del termine, ovvero il cui obiettivo è terrorizzare la popolazione. E lo fa perché è convinta che terrorizzare la popolazione israeliana, all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti di Israele, sia un atto di decolonizzazione. Lo fa perché pensa che Israele – non solo i Territori occupati, ma Israele in sé – debba essere decolonizzato. Alla radice di questo modo di pensare, c’è un approccio pigro, approssimativo (e, non ultimo, frutto di un’assenza di riflessione) sulla natura coloniale di Israele. Che, per carità, esiste, ma meriterebbe di essere affrontata in modo quanto meno serio.
Davanti a intellettuali di sinistra che difendono attacchi terroristici contro la popolazione israeliana, il parallelo immediato è quello con l’Algérie française
Davanti a intellettuali di sinistra che difendono attacchi terroristici contro la popolazione israeliana, il parallelo immediato è quello con l’Algérie française. Per più di cento anni, tra il 1848 e il 1962, l’Algeria è stata parte integrante della Francia (non, dunque, una colonia, com’era stata in precedenza), pur mantenendo una caratteristica tipicamente coloniale: la maggioranza dei suoi abitanti, arabi musulmani, non aveva diritto di cittadinanza, ma conviveva con una grande minoranza (circa il 10%) di abitanti di origine francese, che godeva di piena cittadinanza. Quando il movimento per la liberazione algerina si energizzò, a partire dagli anni Cinquanta, lanciò una serie di azioni, anche violentissime e di natura esplicitamente terroristica, contro la popolazione civile dei pieds-noirs: l’obiettivo era rendere la loro vita impossibile, convincerli ad andarsene. La decolonizzazione passava dal cacciare i francesi, non soltanto la Francia. Molti da sinistra, con i dovuti distinguo, solidarizzavano con questa lotta, dove il fine giustificava i mezzi.
Tornando ai giorni nostri, è evidente che una fetta, piccola ma non trascurabile, della sinistra occidentale legge la realtà israeliana secondo il paradigma algerino. L’oppressione palestinese si risolve perseguitando la popolazione israeliana al punto da convincerla a fare le valige: è la decolonizzazione, bellezza. Quello che sfugge è che c’è una differenza, fondamentale, tra Israele e l’Algérie française: a differenza dei pieds-noirs, gli israeliani non hanno una “Francia” a cui tornare. Si ha un bel dire “rimandiamoli da dove vengono”, ignorando che molti israeliani discendono da luoghi – il Marocco, lo Yemen, la Polonia – dove sarebbe impensabile ritornare. Più seriamente, poi, la popolazione israeliana è radicata lì, ormai esiste una realtà normalizzata, una nazione, un’identità israeliana, che magari a qualcuno può non piacere ma è un dato di fatto.
Israele non è l’Algeria. È un caso di quello che alcuni studiosi definiscono, con efficacia, “settler-colonialism” che ricorda più Stati Uniti, Canada e, non per ultimo, il Sudafrica (anche l’Algeria era un esempio di “settler-colonialism”, ma un po’ peculiare, visto il mantenuto rapporto con la metropoli). Il termine, che spesso viene usato, non sempre con cognizione di causa, anche tra i militanti anti-israeliani più beceri, in realtà è assai utile per guardare con lucidità la realtà sul campo. Arnon Degani, un accademico israeliano che consiglio di leggere, ha scritto a proposito un interessante articolo divulgativo su “Haaretz”. “Il settler-colonialism non è semplicemente un colonialismo che ha insediamenti. È una formazione storica che spesso è un complemento dei progetti coloniali ma che, va sottolineato, è analiticamente distinto”. E ancora:
“La violenza coloniale punta a sottomettere […] ma la violenza settler-coloniale riduce la popolazione indigena al punto da arrivare a un dominio unicamente dei coloni. È così che siamo arrivati a Stati settler-coloniali come Canada, Australia e Stati Uniti, nazioni che ospitano molti studiosi che usano il termine per delegittimare Israele”.
Poi prosegue:
“Per gli Stati settler-coloniali di successo l’assimilazione e l’eliminazione hanno lavorato insieme […]. In un certo senso ciò che viene eliminato non è il corpo fisico della popolazione indigena ma la sua rivendicazione esclusiva”.
Secondo Degani la summa della mentalità legata al “settler-colonialism” la si può trovare in un verso del cantautore socialista americano Woody Guthrie: “This land is your land, this land is my land / […] This land was made for you and me”.
Chi giustifica Hamas in chiave anticoloniale, parte dall’assunto che Israele sia un po’ come l’Algeria, che i colonizzatori debbano essere cacciati, e va da sé che li si caccia con le cattive
Ora, vorrei tornare al paragone col Sudafrica. Come ho scritto sopra, trovo l’utilizzo della parola apartheid piuttosto azzeccata per descrivere l’Occupazione dei Territori palestinesi. Resta però un paradosso. I più accaniti tra i detrattori di Israele, quelli convinti che le azioni di Hamas siano giustificabili in quanto atto di decolonizzazione, si ostinano a usare questo termine, apartheid… ignorando che le loro posizioni negano di fatto le similitudini col Sudafrica. Come già detto, chi giustifica Hamas in chiave anticoloniale, parte dall’assunto che Israele sia più come l’Algeria, che i colonizzatori debbano essere cacciati, e va da sé che li si caccia con le cattive, seminando morte e terrore. Eppure, la lezione del Sudafrica non potrebbe essere più diversa. Lì si era di fronte a una popolazione di origine straniera, ma “nativizzata”, che opprimeva una popolazione indigena stricto sensu. Lì la decolonizzazione è passata dalla richiesta di diritti e di uguaglianza, anche attraverso la lotta armata, non dalla cacciata degli “invasori”, che invasori ormai non erano più. L’apartheid in Sudafrica è stata sconfitta, guarda un po’, abbattendo l’apartheid, non cacciando l’uomo bianco.
Trovo ridicolo, e anche un po’ triste, che alcuni di coloro che utilizzano il termine “apartheid” in continuazione, poi si mostrino quanto meno disinteressati ad abbattere l’apartheid in sé, come si è fatto in Sudafrica, perché per loro il nemico non è mica la diseguaglianza, è la presenza di un popolo che non dovrebbe stare lì, “a casa di qualcun altro”. Trovo ridicolo, e anche un po’ triste, che in un’epoca in cui la sinistra parrebbe avere recepito quanto sia odiosa e nativista l’idea di rimandare qualcuno “a casa sua”, ancora perduri il convincimento che si possa rispedire “a casa”, con violenza mostruosa, un popolo intero che una casa non ce l’ha.

Israele-Hamas, l’ora più difficile
Maurizio Molinari – La Repubblica
GERUSALEMME – A tre settimane dall’attacco a sorpresa subito da Hamas, lo Stato ebraico si trova davanti ad uno dei momenti più difficili della sua esistenza. Il motivo è la sovrapposizione fra molteplici sfide, tutte con ben pochi precedenti. La prima e fondamentale riguarda la garanzia della propria sicurezza: la violenza medioevale di Hamas ha polverizzato una dottrina basata su prevenzione, intelligence ed alta tecnologia, riportando in prima fila il ruolo dell’esercito tradizionale che negli ultimi anni era stato ridimensionato. In secondo luogo, c’è la necessità di ricostruire la deterrenza di Israele rispetto ai vicini più minacciosi – non solo Hamas ma anche Hezbollah e Jihad islamica – ottenendo dei risultati sul campo in grado di allontanarli in maniera decisiva dai propri confini.
“Pensavamo di poter convivere con una tigre feroce davanti alla finestra, ma il Sabato Nero ci ha brutalmente ricordato che ciò espone a rischi drammatici” afferma Yuli Eldestein, capo della commissione Esteri e Sicurezza della Knesset. E come se non bastasse c’è anche l’incertezza sulle dimensioni del campo di battaglia: l’assedio da parte delle milizie filoiraniane presenti in Libano, Siria, Cisgiordania, Iraq, Gaza, Yemen e dallo stesso Iran espone ogni angolo di Israele al rischio di subire attacchi di qualsiasi tipo.
Da qui la situazione di “emergenza nazionale” che ha ben pochi precedenti da quando nel 1948, al momento di nascere, Israele si trovò ad affrontare con ben pochi mezzi l’invasione simultanea degli eserciti di sei nazioni arabe. Come se non bastasse, di mezzo c’è una crisi degli ostaggi con un numero tale – almeno 220 – da aprire una profonda ferita nella società israeliana, anche perché si sovrappone a racconti e testimonianze sui dettagli delle atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre scorso che hanno risvegliato in milioni di cittadini gli incubi delle persecuzioni subite dagli ebrei nel corso della Storia. E ancora: a fronte della solidarietà arrivata dai governi di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e molte altre democrazie occidentali, gli israeliani si sentono feriti dalle proteste filo-Hamas negli atenei americani come nelle piazze di Londra, Parigi e Milano perché sembrano ignorare il dolore causato dalla morte violenta di oltre 1400 connazionali – molti dei quali mutilati, decapitati, bruciali e violentati – ed il ferimento di almeno altri 5400 a causa di un’operazione terroristica pianificata nei minimi dettagli dai jihadisti di Gaza al fine di uccidere il più alto numero di civili in maniere talmente brutali da far impallidire il ricordo delle stragi di Isis.
E non è ancora tutto perché “la resilienza sociale di Israele è indebolita a causa delle 40 settimane di proteste popolari contro la riforma della Giustizia del premier Benjamin Netanyahu – spiega l’accademico Manuel Trajtenberg – a cui ora si somma la sfiducia nella leadership di un capo politico che porta la responsabilità di aver subito il più grave attacco a sorpresa dalla guerra del Kippur del 1973”. Per non parlare dello scenario di una pace regionale con l’Arabia Saudita congelato dall’attacco di Hamas e di un orizzonte di convivenza con l’Autorità nazionale palestinese di Mahmoud Abbas (Abu Mazen) che, come assicura l’analista Yigal Karmon, “si potrà riprendere a considerare solo quando questa profonda ferita sarà rimarginata”.
C’è però anche un altro scenario ed a tratteggiarlo è David Meidan, l’ex negoziatore israeliano che trattò per cinque anni con i fondamentalisti di Gaza riuscendo ad ottenere nel 2011 la liberazione del soldato Gilad Shalit: innescare dall’eliminazione di Hamas una scossa tale per l’intera regione da far nascere “una nuova architettura di sicurezza”, basata sulla normalizzazione israelo-saudita e sulla formula dei “Due popoli per due Stati”, proprio come avvenne nel 1978 quando, appena cinque anni dopo la guerra del Kippur, Anwar Sadat e Menachem Begin siglarono a Camp David l’accordo di pace israelo-egiziano che resta il più strategico perno della stabilità in Medio Oriente.
Insomma, assediato dall’esterno, lacerato all’interno ed obbligato a ridefinire in fretta la strategia di sicurezza, Israele va incontro ad uno dei momenti più difficili dei propri 75 anni di esistenza, le cui conseguenze possono ridefinire gli equilibri dell’intera regione.

David Maidan e Manuel Trajitenberg
Il ferma-maniglia
Ognuno se lo costruisce in casa, come può. C’è chi usa un manico di scopa, altri preferiscono una trave di legno, altri ancora un ferro. Ciò che conta è che sia lungo quanto una porta del proprio appartamento e ad un’estremità abbia un foro per incastrarsi alla maniglia. Stiamo parlando del ferma-maniglia ovvero l’oggetto rudimentale di cui ogni famiglia israeliana sente di aver bisogno dopo il “Sabato Nero”.
Il ferma-maniglia serve per chiudere dall’interno il “mamad” – la stanza di sicurezza che ogni israeliano ha dovuto costruirsi in casa per proteggersi dai razzi – per trovare rifugio in caso di pericolo. Le testimonianze dei sopravvissuti al pogrom di Hamas sono inequivocabili sul “mamad”: quando i terroristi non sono riusciti a sfondarlo o a bruciarlo, i civili hanno avuto la possibilità di salvarsi. Da qui l’importanza di porte e finestre blindate ma soprattutto di un blocca-maniglia che renda impossibile forzarlo da fuori. Ci sono mariti e mogli che fanno a turno per verificare la capacità di chiudere in fretta il “mamad” “a prova di Hamas”.
Così come ci sono bambini che dal 7 ottobre vogliono dormire solo dentro il “mamad” – e non più nelle loro camerette – perché si sentono più protetti. Per i genitori è solo una delle conseguenze del pogrom avvenuto nelle comunità del Negev Occidentale: c’è chi non fa più uscire i figli da soli e chi ha ripensato in fretta orari di lavoro e tragitti urbani. La possibilità di incontrare un terrorista come quelli che hanno fatto strage di civili è diventata una feroce variabile della vita quotidiana. Se durante la Seconda Intifada il pericolo arrivava salendo su un autobus o entrando in un locale pubblico – perché i terroristi entravano in abiti civili, mischiandosi alla gente per farsi saltare in aria – e se negli anni Settanta gli israeliani impararono a temere i dirottamenti aerei o i pacchi abbandonati nelle strade, oggi le vite di milioni di persone si ridefiniscono con nuovi comportamenti quotidiani per proteggere la propria sicurezza dentro le pareti di casa. Perché Hamas ha dimostrato con la ferocia che intende raggiungere ovunque ed uccidere, mutilare e bruciare ogni singolo abitante di Israele, solo in quanto tale.
A svolgere un ruolo importante per coordinare la difesa del fronte interno è Yuli Edelstein, presidente della commissione Esteri e Sicurezza della Knesset, a cui spetta mettere a punto tutti i relativi interventi legislativi: dalla chiusura delle scuole alla sospensione delle rate dei mutui, dal versamento di una percentuale importante degli stipendi ai riservisti fino alle macro-misure per sostenere il sistema economico.
“È la prima volta nella nostra Storia recente che l’emergenza per un conflitto investe l’intero territorio nazionale, neanche un piccolo centro è escluso – spiega Edelstein, seduto nel suo ufficio a Gerusalemme – e questo significa che dobbiamo pianificare una miriade di attività”. Come, ad esempio, spostare oltre 150 mila cittadini dai villaggi lungo i confini con Gaza e Libano trovandogli alloggi ed accoglienza altrove nel Paese, incluse le tendopoli a fianco di Eilat. A sostenere Edelstein è l’esperienza maturata contro il Covid-19 quando era ministro della Salute: “Ci sono molti aspetti comuni con quanto avvenuto allora perché anche adesso è l’intero Paese a fermarsi e bisogna considerare ogni tipo di impatto sociale”.
Per avere un’idea di cosa intende basta osservare il via vai di automobili private nei centri di raccolta dove migliaia di cittadini arrivano per far arrivare ai soldati qualsiasi cosa possa servirgli: dai beni alimentari agli indumenti, ai caricatori cellulari. Una imponente catena umana, tutta a base volontaria, che si auto-gestisce – per telefono o con appositi siti web – ed ogni singolo giorno pensa a come sostenere gli oltre 360 mila riservisti richiamati per affiancare le truppe di leva così come le famiglie sfollate dal Sud e dal Nord del Paese.

Yuli Edelstein
Il nemico ibrido
L’attacco del Sabato Nero ha rivoluzionato l’idea di terrorismo da cui Israele deve proteggersi. Fino al giorno prima c’era un consenso, fra militari e intelligence, sul fatto che Hamas fosse un’organizzazione terroristica simile alle molte che Israele ha dovuto combattere nella sua storia – da Settembre Nero autore della strage di atleti alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 all’Olp responsabile dell’attentato di Zion Square a Gerusalemme nel 1975, dall’assalto all’asilo del kibbutz di Maalot nel 1976 firmato dal Fronte per la liberazione della Palestina al massacro di Natanya nel marzo 2002 compiuto proprio da Hamas – con in più la caratteristica di dover amministrare dal 2007 la Striscia di Gaza e quindi le conseguenti responsabilità oggettive nei confronti di oltre due milioni di abitanti palestinesi.
“Si è trattato di un grave errore perché Hamas non è solo tutto ciò ma anche qualcosa di più” afferma Yigal Karmon, direttore del centro studi “Memri” sul Medio Oriente e unico analista ad aver previsto – in settembre – l’attacco del 7 ottobre. “Questo qualcosa in più è l’ideologia che muove Hamas, la stessa che ha generato Al Qaeda e Isis – spiega – e nasce dalla genesi del movimento dei Fratelli musulmani nella prima metà del Novecento” con l’obiettivo di fondere tutti gli Stati arabi per dare vita ad un grande Califfato. È un’ideologia che predica la Jihad, persegue la distruzione degli infedeli – ebrei e cristiani – e la sottomissione dei musulmani “corrotti” nonché la sottomissione del mondo intero ad una versione fondamentalista dell’Islam che “si propone di riportare il mondo intero a XV secoli fa”.
“L’errore di Israele è stato umano – sottolinea Karmon – perché ha creduto che con questa ideologia si potesse convivere”. A dispetto di una Costituzione di Hamas che prevede, in maniera esplicita, la distruzione di Israele e l’uccisione degli ebrei, ed ignorando ciò che l’intelligence israeliana ha continuato a raccogliere negli ultimi mesi: prove evidenti, concrete, su ciò che si stava preparando. Se però sono state “non considerate, ignorate, sottovalutate” aggiunge Karmon “è perché non solo il premier Benjamin Netanyahu ma anche i suoi predecessori e l’intero establishment della sicurezza, da anni, credeva nella politica di far leva sui fondi del Qatar per Hamas al fine di “pagare la pace””.
Proprio così: Israele si è fidata dell’Emiro Al-Thani del Qatar, in ragione dei legami fra Doha ed i Fratelli musulmani, ed ha consentito agli inviati qatarini di far arrivare, ogni mese, valige con milioni di dollari in contanti a Gaza. Hamas assicurava al Qatar, e dunque indirettamente ad Israele ed agli Stati Uniti, che quei soldi servivano ad amministrare la Striscia e a pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici ma “la realtà era ben diversa perché ogni razzo, mitra, esplosivo, motocicletta, tunnel e arma di Hamas è stata pagata con quei fondi”.
Se dunque l’Iran è il più importante alleato militare di Hamas, la fonte di armi, intelligence e addestramento, “è invece il Qatar l’origine delle sue maggiori entrate economiche” sottolinea Karmon, aggiungendo che “l’errore strategico di Netanyahu e dell’apparato di sicurezza nazionale è stato credere alla tesi del Qatar che la pace poteva essere acquistata”.
Così come la Casa Bianca, prima con Donald Trump e poi con Joe Biden, si è fidata del Qatar come mediatore con i talebani afghani – venendo sorpresa dal blitz con cui si impossessarono di Kabul il 15 agosto 2021 – adesso è il turno di Israele a dover prendere atto che la mediazione qatarina con Hamas, ha consentito ai jihadisti di Gaza di avere le risorse necessarie per attaccarla. “Ciò non significa – precisa Karmon – che Doha sapesse in anticipo dei piani di Hamas ma pone un problema politico gigantesco sulla credibilità di Doha come garante dell’affidabilità dei gruppi jihadisti”.
A questo bisogna aggiungere che Hamas riceve, ogni mese, donazioni “caritatevoli” raccolte da una vasta rete di moschee e centri di cultura islamica controllati dai Fratelli musulmani – anzitutto negli Usa, in Gran Bretagna ed in Turchia – nel pieno rispetto delle leggi vigenti in questi Paesi. “È questo network di finanziamenti che sostiene imam e moschee che diffondono l’ideologia dei Fratelli musulmani, della Jihad Islamica, di Al Qaeda, di Isis e di Hamas” sottolinea Karmon, il cui obiettivo “non è politico di ottenere questo o quel risultato ma strategico, sottomettere il mondo alla Jihad”.
C’è questa radice ideologica del nemico alla genesi della difficoltà di combatterlo perché l’obiettivo di sottomettere con la violenza il mondo alla Jihad può rinnovarsi, da un secolo all’altro, da un Paese all’altro, anche solo con la diffusione di un testo, un video o l’audio di un sermone. A conferma della difficoltà della sfida contro questa ideologia, quando nel 2014 gli Stati Uniti hanno deciso di creare una coalizione internazionale – con la partecipazione di Paesi europei, mondo arabo, guerriglia curda, Iran e Russia – per sconfiggere Isis di Abu Bakr al-Baghdadi hanno avuto bisogno di ben quattro anni per smantellare lo Stato jihadista che era stato creato a cavallo dei confini fra Iraq e Siria.
Hamas, al pari di Isis, è dunque un nemico ibrido che somma al controllo militare di territori anche amministrazione, cibo, moschee e scuole coraniche per le popolazioni sottomesse. La brutalità dei suoi seguaci nasce da un’ideologia che recluta facendo leva su messaggi pseudo-religiosi disseminati grazie all’uso delle più moderne tecnologie, per finanziarsi come per diffondere la cultura della morte.
Un conflitto su tre livelli
Karmon studia la Jihad dal suo studio nel centro di Gerusalemme mentre poco lontano da Tel Aviv vive Jacob Amidror, in una casa dove ospita alcuni rifugiati da villaggi del Nord che sono stati completamente evacuati per proteggerli dal rischio di attacchi degli Hezbollah libanesi. Si tratta di un madre e due figlie. Amidror le ospitò già in occasione della guerra in Libano del 2006: sono passati 17 anni, la madre adesso ha i capelli grigi, le figlie sono cresciute ma dormono nelle stesse stanze che avevano allora.
“La storia per molti versi si ripete – dice Amidror, già consigliere per la sicurezza nazionale di Netanyahu e fra i più apprezzati analisti di strategia israeliani – ma questo conflitto è diverso dagli altri”. E mette l’accento su “diverso” per spiegare: “Si tratta di un conflitto che si sviluppa su tre livelli, il primo e più diretto, è la guerra iniziata da Hamas contro di noi con le atrocità contro i civili, perché ora Israele deve rispondere e cancellare Hamas, è il nostro popolo a chiedere questa risposta. C’è però un secondo livello ovvero la necessità di schiacciare Hamas per ricostruire la capacità di deterrenza israeliana contro simili nemici, a cominciare da Hezbollah in Libano, facendogli capire che ciò che capita ora a Hamas capiterà anche a loro se dovessero mai pensare di attaccarci in maniera simile. Infine, il terzo livello, perché lo scontro fra Hamas e Israele è un tassello del conflitto più ampio fra le democrazie ed i suoi nemici di cui il presidente americano Joe Biden ha parlato nel discorso alla nazione del 19 ottobre”.
Amidror conosce profondamente Israele ma anche in America si sente a casa. La sua lettura del conflitto iniziato da Hamas tiene assieme più necessità: Israele deve sconfiggere Hamas, impedire a Hezbollah di attaccarci ed aiutare l’America a confrontarsi con un asse di nemici che include l’Iran, fornitore di armi alla Russia di Vladimir Putin come nessun’altra nazione ad eccezione della Corea del Nord.
Si apre dunque un fronte parallelo a quello dell’Ucraina perché anche Kiev da una parte combatte per difendere la propria esistenza dall’aggressione russa e dall’altra fa parte dello schieramento delle democrazie occidentali alle prese con la minaccia della Russia, intenzionata a cambiare a suo vantaggio l’architettura di sicurezza, non solo europea.
“Qui in Medio Oriente, lo scontro fra democrazie e autocrazie dipenderà dalla nostra capacità di sconfiggere Hamas nella Striscia” sottolinea Amidror, secondo il quale la campagna israeliana sarà assai diversa da quanto finora abbiamo visto nei precedenti interventi di terra a Gaza – l’ultimo risale al 2014 – perché ora il fine è sradicare completamente l’organizzazione jihadista. “Per tentare di capire cosa potrà avvenire dobbiamo guardare al precedente del 2002, quando Israele intervenne nella West Bank e pose fine alla Seconda Intifada scatenata da Yasser Arafat dopo aver rifiutato a Camp David da Bill Clinton ed Ehud Barak la più ampia e seria offerta di far nascere uno Stato palestinese in Cisgiordania e Gaza”.
L’attacco di terra
Le parole di Amidror spiegano perché c’è una convergenza fra gli analisti militari in Israele sulla tipologia di intervento che l’esercito sta preparando a Gaza.
La sconfitta della Seconda Intifada avvenne infatti con un’operazione anche allora di terra che Ariel Sharon, allora premier, coordinò meticolosamente per eliminare le cellule più violente – soprattutto Hamas ma non solo – che bersagliavano le città israeliane con attentati e attacchi suicidi. “Si trattò di identificare ed eliminare tutti i gruppi terroristi in uno spazio urbano altamente popolato – ricostruisce Amidror – fu molto difficile e servirono quattro anni di tempo, ma i soldati caduti passarono da un numero molto alto nei primi due anni a molto meno in seguito, fino a diminuire in maniera decisiva”.
Ora Israele non ha quattro anni di tempo per liquidare Hamas, ma quando il premier Netanyahu parla di “tutto il tempo necessario” lascia intendere che non sarà una campagna breve. La richiesta ai civili di Gaza di spostarsi verso Sud lascia intendere che gli israeliani vogliono entrare da Nord, per crearvi la base da cui operare dentro Gaza City, dove ritengono si trovino la maggior parte delle infrastrutture militari di Hamas. “Avremo molto morti, sarà un’operazione difficile in presenza della popolazione civile, dobbiamo aspettarci giorni molto difficili” ammette Amidror, aggiungendo però che “c’è una grande coesione nel Paese sulla necessità di entrare e distruggere Hamas perché non possiamo vivere avendo accanto dei terroristi che operano come facevano i nazisti”.
Putin addio
In attesa delle operazioni di terra, possono esserci pochi dubbi che le conseguenze della guerra con Hamas stanno già ridefinendo la posizione di Israele fra Washington e Mosca. Se dall’inizio della guerra in Ucraina il governo Netanyahu aveva tentato di mantenere un difficile equilibrio fra Kiev e Mosca – inviando solo aiuti umanitari a Volodymir Zelensky e senza applicare le sanzioni al Cremlino – ora la scelta di Putin di schierarsi con Hamas è inequivocabile, polverizzando tutto il resto.
“Nell’ultimo anno vi sono stati ben 26 incontri pubblici fra esponenti del governo russo e di Hamas” osserva Yuli Edelstein – e dall’indomani del 7 ottobre Putin non ha mai condannato il pogrom contro di noi”. Il motivo è il legame a doppio filo fra Mosca e Teheran.
“L’Iran è cruciale per Putin a causa dell’invio di armi, a cominciare dai droni, che garantisce all’esercito russo in Ucraina – osserva Edelstein – e questa è una priorità strategica che fa passare in secondo piano il legame con Israele che il leader del Cremlino aveva spesso citato in pubblico, definendoci ad esempio l’unico Stato russofono fuori dai confini dell’ex Unione Sovietica”. La guerra in Medio Oriente giova d’altra parte tatticamente a Putin per distrarre l’America dalla campagna ucraina ed anche per fomentare divisioni interne nei Paesi dell’Occidente.
“Questo non significa che la Russia sia stata al corrente dei piani di Hamas contro di noi, ma le conseguenze sono inequivocabili – termina Edelstein, già fra i leader del movimento dei Refusnik, gli ebrei sovietici che si battevano per la libertà di emigrazione in Israele – Putin ha fatto una netta scelta di campo a favore dell’Iran”. Da qui l’attenzione di Gerusalemme per la volontà di Casa Bianca ed Eliseo di creare una “coalizione contro Hamas come già fatto contro Isis”. Non perché Israele abbia bisogno di aiuti militari sul terreno ma in quanto potrebbe generare un sostegno politico capace di sostenere lo Stato ebraico sulla scena internazionale una volta iniziato l’intervento.
Ostaggi, corsa contro il tempo
La sorte degli israeliani deportati da Hamas nella Striscia di Gaza si sovrappone all’incombere dell’operazione di terra. Per comprenderne il perché bisogna ascoltare David Meidan, l’ex alto funzionario del Mossad, nato in Egitto ed immigrato in Israele quando aveva un anno di età, che il 18 ottobre 2011 riuscì ad ottenere la liberazione del soldato Gilad Shalit da parte di Hamas dopo cinque anni di difficili trattative, in cambio del rilascio di 1027 detenuti e terroristi dalle carceri israeliane.
“Molti degli ostaggi presi da Hamas hanno una doppia cittadinanza e vi sono poi numerosi casi umanitari, c’è spazio per negoziare il rilascio di entrambi i gruppi in tempi stretti” spiega Meidan, sottolineando come l’amministrazione Biden sta esercitando una pressione molto forte sul Qatar affinché spinga i fondamentalisti della Striscia a liberarli. I motivi della trattativa sono molteplici e sotterranei. Da un lato c’è Doha, perché i qatarini hanno un problema di credibilità da riscattare in quanto sono stati loro negli ultimi dieci anni ad assicurare ad Occidente, Israele e mondo arabo che era possibile venire a patti con Hamas.
Se il premier qatarino, Mohammed al-Thani, è impegnato in prima persona ad ottenere il rilascio di ostaggi stranieri ed umanitari è perché ben consapevole della necessità di impedire che Doha ridiventi una nazione paria, sospettata di complicità con il terrorismo islamico, come già avvenuto fra il 2017 ed il 2021 quando fu Riad a guidare il Consiglio di Cooperazione del Golfo ad isolarla, imponendole dure sanzioni a causa del legame con i Fratelli musulmani. Ma c’è dell’altro perché, aggiunge Meidan “anche Hamas ha un problema da risolvere” dato dal fatto che “più Paesi arabi, dall’Egitto al Qatar, hanno visto nella brutale violenza contro i civili israeliani un comportamento che insulta i principi dell’Islam”.
È proprio la necessità per Hamas di far fronte a queste critiche – aspre ma mai pubbliche – ad aver spinto Khaled Mashaal, ex capo del Politburo, a liquidare in tv i rapimenti come eseguiti da “civili di Gaza”, fino alla liberazione dei primi quattro ostaggi – prima due israelo-americane, poi due anziane israeliane – al fine di provare un presunto atteggiamento “umanitario” dei jihadisti. La trattativa è però una corsa contro il tempo, perché l’inizio dell’intervento di terra incombe e Meidan ritiene che “per avere successo deve includere non solo gli stranieri ed israeliani con doppio passaporto ma anche tutti gli ostaggi umanitari” perché “fare una selezione escludendo i civili israeliani” riproporrebbe da parte di Hamas comportamenti analoghi a quelli delle selezioni eseguite dai nazisti “risultando inaccettabile alla nostra opinione pubblica”. Quando Meidan dice “casi umanitari” intende “anziani, donne e bambini” perché “vi sono bambini molto piccoli ed anche madri con figli” ovvero persone che non sarebbero in grado di sopravvivere in caso di guerra aperta.

Il funerale di Dana Bachar e di suo figlio Carmel, al cimitero di Gan Shlomo. Israele centrale, 24 ottobre 2023 – Foto AFP
Golda Meir o Chamberlain?
A Tel Aviv la piazza davanti al museo di Arte moderna è lo specchio della sovrapposizione fra le due ferite aperte di Israele. A prima vista ciò che domina la piazza è il lungo tavolo apparecchiato con le “Challot” – il pane del sabato – con 222 posti, quanti sono i rapiti da Hamas.
Le famiglie degli ostaggi vengono sulla piazza, sostano in un luogo a pochi metri di distanza e raccontano il loro dramma. E sulla stessa piazza i nomi dei rapiti sono stati aggiunti al monumento che ricorda la guerra del Kippur del 1973 – anche allora un attacco a sorpresa – raffigurando l’episodio biblico del Sacrificio di Isacco. Ma a ben vedere sul selciato biancastro c’è dell’altro. Scritte e volantini che raccontano le 40 settimane di protesta contro il premier Netanyahu e la sua riforma della Giustizia che hanno mobilitato, ogni sabato sera, decine di migliaia di persone.
Sulla parete esterna del museo un grande poster ricorda la Dichiarazione di indipendenza di Israele, letta da David Ben Gurion, proprio per sottolineare quei valori fondamentali della democrazia israeliana che i manifestanti rimproverano a Netanyahu di non rispettare. La sovrapposizione plastica, nello stesso spazio fisico, della lacerazione politica causata dalla riforma della Giustizia con la lacerazione emotiva provocata dalle atrocità di Hamas, spiega perché sulla figura del premier le divisioni restino profonde.
Se nei quindici giorni seguiti al “Sabato Nero” l’ostilità contro Netanyahu sembrava sopita, ora torna a manifestarsi con la voce di chi, come alcune delle persone che sostano sulla piazza, sostiene che “il responsabile della mancata difesa del Paese è lui ed ora non può guidarci contro Hamas”.
A spiegare questo bivio è Amos Gilad, ex generale, già stretto collaboratore del premier Itzhak Rabin ed una delle voci più presenti nelle proteste di piazza. “Molti parlano dello scenario delle dimissioni di Netanyahu a campagna militare finita, facendo il paragone con quanto fece Golda Meir dopo la guerra del Kippur – dice – ma io credo che sarebbe un grave errore, Netanyahu non è Golda Meir, a guerra finita cercherebbe di sopravvivere politicamente dando la colpa a qualcun altro e, poiché è lui il responsabile politico di quanto avvenuto, deve andarsene subito”.
Lo scenario di un premier che si dimette in Israele durante un conflitto in corso ha un unico precedente: Menachem Begin che, nel 1983, circa un anno dopo l’inizio della guerra in Libano, quando il numero dei caduti israeliani arrivò a superare i 500, andò nel suo ufficio e firmò le dimissioni, lasciando la guida del governo al compagno di Likud, Itzhak Shamir.
“Netanyahu non è Begin e non lo farà – aggiunge Gilad – ma la Storia ci consegna il precedente di Neville Chamberlain che, nella Gran Bretagna in guerra con la Germania nazista, dopo quasi un anno di errori ed umiliazioni si dimise assumendosi la responsabilità di tali fallimenti. Ed arrivò Winston Churchill”.
Questo significa che la discussione sulla responsabilità del fallimento nella difesa del Paese il 7 ottobre non aspetta la fine della campagna di Gaza: è già cominciata. C’è chi afferma, come Amidror, che “la responsabilità di aver creduto alla tesi del Qatar sulla possibilità di comprare la coesistenza con Hamas” sia “dell’intero sistema politico-militare” e dunque è un errore identificare nel premier il solo capro espiatorio, e chi invece come Gilad ritiene che “il Chamberlain d’Israele debba dimettersi subito per consentire al Paese di unirsi davvero”.
Attorno ai tavolini di un caffè di Ramat Aviv due ufficiali della riserva parlano fra loro, facendo capire quanto profonda è la lacerazione: “Netanyahu non ha mai voluto combattere guerre vere e proprie perché nei momenti decisivi esita sempre, per questo ha consentito agli ufficiali americani di essere coinvolti nella nostra pianificazione più segreta” afferma il più anziano, mentre l’altro ribatte “ora abbiamo un unico premier, dividersi su di lui sarebbe l’errore più grande, liquidiamo Hamas e poi torneremo a parlare di politica”.
Una nazione da ricostruire
Poco lontano dal Kanyon di Ramat Aviv ha sede l’Istituto nazionale di studi sulla sicurezza (Inss) guidato da Manuel Trajtenberg, l’economista già stretto collaboratore dei premier Ehud Olmert e Benjamin Netanyahu nonché ideatore nel 2006 del primo Consiglio economico per la sicurezza nazionale dello Stato ebraico. Ciò che distingue Trajtenberg è incrociare le conoscenze su economia e sicurezza per definire l’agenda delle priorità per il Paese. Davanti al Sabato Nero non esita a definire Israele “in uno stato di shock collettivo” perché il successo dell’attacco a sorpresa ha fatto venir meno “alcune certezze fondamentali” come “la solidità del sistema di sicurezza” e il “culto per l’alta tecnologia”. A cui bisogna aggiungere il venir meno della “resilienza sociale” dovuta alle proteste di strada contro la riforma della Giustizia.
“Israele è una nazione da ricostruire” afferma Trajtenberg, sottolineando che “si tratta di un momento di grande difficoltà” ma anche “con alcuni precedenti che dimostrano come queste transizioni appartengono al dna del Paese”. Il caso più evidente è il 1973 “quando l’attacco a sorpresa subito da Egitto e Siria portò a scuotere le coscienze tutti in maniera talmente profonda che nel 1977 per la prima volta il Likud arrivò, con Menachem Begin, alla guida politica del Paese” e “nel 1978 vi furono gli accordi di pace di Camp David con l’Egitto di Sadat”.
E ancora: “È stata l’iper-inflazione del 1985, quando si toccava il 500 per cento l’anno, a spingerci verso le riforme economiche che hanno generato la Start Up Nation dell’alta tecnologia” e nel 2002 la Seconda Intifada con i kamikaze che si facevano esplodere a raffica nelle città israeliane portò “a rendersi contro che l’Olp di Yasser Arafat non poteva essere un partner per la pace” aprendo il terreno al dialogo con le nazioni arabe del Medio Oriente che ha portato agli Accordi di Abramo del 2020 con Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Marocco e Sudan.
“Nel dna di Israele c’è la capacità di affrontare le trasformazioni più inattese e profonde, uscendone più forti” assicura Trajtenberg, secondo il quale “adesso l’agenda da affrontare è costituita dai problemi che abbiamo scelto di non discutere troppo a lungo”.
Sono tre. Ecco di cosa si tratta. Primo: “Gli ortodossi saranno presto il 30 per cento della popolazione, c’è fra loro una nuova positiva tendenza all’integrazione, a cominciare dall’aumento di coloro che fanno il servizio militare, e bisogna spingerli a dare un maggiore contributo alla vita del Paese, senza nulla togliere al loro modo di vita, ma per farlo lo Stato deve diminuire i sussidi pubblici alle scuole religiose perché li spingono a isolarsi”.
Secondo: “Gli arabo-israeliani sono oltre il 20 cento della popolazione, al loro interno il tasso di criminalità è molto alto, dobbiamo investire per migliorare la loro qualità di vita, di studio, affinché la violenza scenda e l’educazione aumenti”.
Terzo: “I palestinesi sono i nostri vicini, parlare ora di convivenza sembra impossibile dopo quanto avvenuto con Hamas perché il livello di fiducia nei confronti di Gaza e della West Bank non è mai stato così basso, ma ciò non toglie che la maggioranza di chi risiede fra Gaza e Ramallah non vuole la guerra con noi” e dunque “serve una nuova generazione di leader israeliani capaci di dialogare con una nuova generazione di leader palestinesi” ovvero coloro che verranno dopo Mahmud Abbas.
Trajtenberg non si nasconde che si tratta di “argomenti ora quasi impossibili da affrontare per chiunque” ma vede nella volontà degli israeliani di battersi sulla riforma della Giustizia – tanto quelli contrari che i favorevoli – la possibile genesi di una “rottura positiva rispetto al presente”. “Vincendo questa sfida – assicura – Israele ne uscirà più forte e coesa”.
Il fatto che proprio il cuore del movimento anti-Netanyahu oggi sia impegnato a sostenere ovunque la mobilitazione delle truppe contro Hamas “testimonia che qualcosa sta avvenendo nelle viscere del Paese”. E gli occhi sono su quei leader emergenti nell’economia, della “Start Up Nation”, che si sono imposti durante le manifestazioni anti-riforma: dal venture capitalist Eyal Waldman – la cui figlia Danielle con il fidanzato è stata assassinata al rave party del Nova Festival – a Moshe Redman, volto di spicco dell’hi-tech. “Proprio come avvenuto in Italia dopo Tangentopoli, quando a cadere furono Craxi ed Andreotti e ad emergere furono Berlusconi e Prodi – afferma David Meidan – credo che anche in Israele la nuova generazione di leader verrà dal mondo dell’economia”.
C’è però anche un’altra Israele che bussa alle porte: “Nelle unità speciali dell’esercito i sionisti religiosi sono la maggioranza mentre alla mia epoca eravamo pochissimi ed a prevalere erano i laici – dice il generale Amidror – questo significa un cambiamento importante nelle viscere della nazione, con la mobilitazione di nuove energie capaci di generare leadership”.
Occhi puntati su Ramallah
Quando i leader israeliani, politici e militari, affermano che non è loro intenzione occupare la Striscia di Gaza dopo l’eliminazione di Hamas, pongono la questione di chi la governerà a guerra finita.
L’Onu è già presente con scuole e centri medici gestiti dall’Agenzia Unrwa e ciò significa che il suo personale – magari rafforzato o affidato a nuove forme di intervento – potrebbe svolgere un compito di assistenza umanitaria nel breve termine agli oltre 2,3 milioni di residenti civili. Ma resta la questione del governo nel medio-lungo termine ovvero la gestione dell’amministrazione pubblica che dopo il ritiro unilaterale di Israele nel 2005 passò all’Autorità nazionale palestinese e dopo il colpo di mano del 2007 venne presa con la forza da Hamas.
“La soluzione più logica può essere quella di restituire il governo della Striscia all’Autorità palestinese” afferma Yigal Karmon. Ma questo scenario porta con sé l’interrogativo su chi può essere in grado di governare Ramallah con credibilità politica ed energia personale tali da riprendere il controllo della Striscia e, di conseguenza, riprendere il negoziato con Israele per arrivare ad una definitiva composizione del conflitto.
Al momento alla Muqata siede – dal 2015 – il presidente Mahmud Abbas e David Meidan sottolinea che “a dispetto dell’età e di una salute a volte considerata precaria, fino a quando resta lui, dobbiamo negoziare con lui”. Tantopiù che Abbas, pur protagonista di serie crisi con Israele e autore in settembre di dichiarazioni incendiarie come quelle sulla Shoà (“Hitler ha combattuto gli ebrei per il loro ruolo sociale e non per la loro fede”), non ha fatto venire meno la cooperazione nella lotta al terrorismo e per mantenere la sicurezza nella West Bank.
Le parole pronunciate da Abbas dopo il pogrom del 7 ottobre sul fatto che “Hamas non rappresenta la causa palestinese” avvalorano il suo ruolo di leader di un nazionalismo che resta basato sul Fatah, un movimento laico, ostile al fondamentalismo religioso di Hamas. Ma Abbas è anche alla guida di un sistema di potere gestito da famigliari e stretti collaboratori imputato – da anni – di corruzione endemica a scapito dello sviluppo della West Bank. Sono queste accuse, molto diffuse nelle città palestinesi, che lo rendono poco credibile, vulnerabile, politicamente instabile. Da qui la costante attenzione di Israele, Stati Uniti ed Europa su possibili alternative.
I nomi più popolari che circolano nella West Bank sono due: Mohammed Dahlan e Marwan Barghouti. Dahlan è nato a Gaza, ha guidato Fatah nella Striscia e vive negli Emirati, dove gestisce affari economici di grande successo con l’evidente sostegno di Abu Dhabi: potrebbe essere l’uomo giusto per unificare i palestinesi con il sostegno del Paese arabo in questo momento al centro della normalizzazione dei rapporti con Israele.
Ma “Dahlan non scalda i cuori dei palestinesi – aggiunge Karmon – a differenza di quanto avviene per Marwan Barghouti”. La popolarità di Barghouti nasce dal fatto di essere stato uno dei leader della Prima ed anche della Seconda Intifada, quando furono proprio i suoi “Tanzim” a compiere alcuni dei più sanguinosi attentati contro Israele. Per questo Barghouti sconta nelle carceri israeliane ben cinque ergastoli e incarna la figura di uno dei nemici più feroci dello Stato ebraico.
“Scarcerarlo per il nostro governo – osserva Manuel Trajtenberg – significherebbe tentare di ripetere l’operazione Nelson Mandela in Sudafrica ovvero puntare sulla sua popolarità per favorire una vera, profonda riconciliazione”. Sulla carta è uno degli scenari possibili ma Karmon mette le mani avanti: “Dopo quanto avvenuto il 7 ottobre nessun israeliano sano di mente accetterà mai uno Stato palestinese indipendente in Cisgiordania, temendo che possa trasformarsi in un’altra Gaza, che ci attaccherebbe senza interruzione”.
Per il fondatore di Memri, “nel breve periodo l’unica soluzione possibile è quella a cui pensò anni fa Yitzhak Rabin, assegnando alla West Bank e magari anche a Gaza, una completa autonomia ma senza armi e soprattutto del tutto staccata da noi, con una barriera ancora più consistente di quella che fece costruire Ariel Sharon al termine della Seconda Intifada”. Le immagini che abbiamo visto in questi giorni in più località della Cisgiordania, con abitanti degli insediamenti ebraici che abbattono i grandi cartelli rossi ai confini con le aree controllate dall’Autorità palestinese danno la temperatura di quanto sta avvenendo in Giudea e Samaria – i nomi ebraici della West Bank – dove la popolazione israeliana non sembra più intenzionata a rispettare i confini stabiliti dagli accordi di Oslo nel timore di subire attacchi come quelli che hanno insanguinato il Negev Occidentale. Anche perché in alcuni centri, come Hebron, il fondamentalismo è molto radicato mentre Jenin è divenuta nell’ultimo anno l’epicentro delle attività di nuovi gruppi violenti, protagonisti di attentati anti-israeliani.
La sfida sulla narrativa
C’è infine un fronte di sfida fra Israele e Hamas che ha a che vedere con la narrazione di quanto avvenuto il 7 ottobre. Gli abitanti dello Stato ebraico hanno vissuto l’eccidio di civili e le atrocità compiute dai jihadisti come una ripetizione delle più brutali persecuzioni del passato. Come riassume David Meidan: “È come se avessimo scoperto centinaia di Anne Frank” per la moltitudine di civili che sono stati obbligati a rifugiarsi in casa propria nella speranza di sfuggire alla caccia all’ebreo messa in atto dai jihadisti con mappe, liste di nomi ed istruzioni precise tese a massimizzare la strage di civili.
Hamas invece, nelle parole di Khaled Mashaal, ex capo del comitato centrale ora in Qatar, ribatte che “non è affatto vero che abbiamo ucciso dei civili”: si tratta di “propaganda sionista” tesa a far dimenticare “i crimini commessi contro la popolazione di Gaza con l’assedio economico e con i bombardamenti aerei”.
Per avvalorare questa versione il ministero della Sanità di Gaza, controllato come tutta l’amministrazione locale da Hamas, si è affrettato ad imputare ad Israele la bomba esplosa sull’ospedale battista di Al-Hali lo scorso 17 ottobre, “provocando 500 morti”. In realtà prima i portavoce militari israeliani, poi alcuni fra i maggiori quotidiani internazionali – dal “Wall Street Journal” al “New York Times” – hanno dimostrato con abbondanza di documenti che ad essere esploso sull’ospedale è stato uno dei razzi difettosi lanciati dalla Jihad islamica palestinese verso Israele: poco dopo il lancio è caduto dentro la Striscia, come avviene nel caso di un quinto degli ordigni.
Pur smentita, la notizia della “strage israeliana a Gaza” ha consentito a Hamas in più Paesi occidentali – dagli Stati Uniti alla Francia fino all’Italia – di oscurare il pogrom del 7 ottobre con le accuse di “crimini contro l’umanità” commessi da Israele. Una motivazione che si ritrova nelle manifestazioni pro-Hamas avvenute, in Europa come negli Stati Uniti, segnate da un’aggressività crescente contro gli ebrei: a Viale Padova, Milano, gridando a squarciagola “Togliete i confini, uccideremo gli ebrei” così come nella “Cooper Union” di New York City, dove una folla di facinorosi pro-Hamas ha assediato nella libreria gli studenti ebrei, minacciando di sfondare le porte per aggredirli. È l’aggressività contro gli ebrei in genere a ribadire la sovrapposizione fra antisionismo ed antisemitismo, evidenziando i pericoli che vengono dalla banalizzazione del pogrom di Hamas. Ma, nonostante ciò, la narrazione dei jihadisti sul 7 ottobre appare consolidata, facendo leva su gruppi organizzati, pubblicazioni web e manifestazioni in Nordamerica ed Europa contro i “crimini di Israele”. Cancellando con un colpo di spugna le “centinaia di Anne Frank” frutto del pogrom nei villaggi civili del Negev.

Se gli oppressi diventano oppressori
di Antonio Scurati
33 gruppi di studenti di Harvard hanno pubblicato una lettera nella quale dichiarano di considerare “il regime di Israele responsabile di tutte le violenze causate da vent’anni di apartheid a Gaza”
Talvolta gli oppressi divengono oppressori. Non mi riferisco qui ai figli delle vittime della Shoah che opprimono il popolo palestinese. Mi riferisco, invece, ai figli del privilegio americano che odiano attivamente i cittadini di Israele.
I fatti. La settimana scorsa ben 33 gruppi di studenti di Harvard pubblicano una lettera aperta nella quale dichiarano di considerare “il regime di Israele totalmente responsabile di tutte le violenze causate da vent’anni di apartheid a Gaza”. Stando a questi studenti della più prestigiosa università del mondo, i massacri di Hamas sarebbero responsabilità dei massacrati e non dei massacratori.
Si tratta dello stesso argomento usato da Adolf Hitler al principio del 1942 per giustificare l’imminente sterminio degli ebrei d’Europa da lui deciso. Esagero? Non esagero: “Il giudaismo trama una guerra mondiale internazionale per annientare, diciamo, i popoli ariani, mentre non saranno i popoli ariani che saranno annientati, ma il giudaismo“. Questo il concetto espresso da Hitler durante il suo discorso allo sportpalast di Berlino del 30 gennaio 1942; e questa la precisazione fornita a Goebbels in una conversazione privata nel febbraio dello stesso anno: “È inammissibile qualsiasi sentimentalismo, in questo caso. I giudei si sono meritati la catastrofe che vivono oggi. Così come vengono annientati i nostri nemici, anch’essi andranno incontro al proprio annientamento“.
Ebbene, di fronte a quest’aberrazione, per due giorni il vertice dell’ateneo tace. Poi, soltanto il terzo giorno, dopo proteste di insigni ex studenti e minacce da parte di ricchi donatori di interrompere i finanziamenti, la presidente di Harvard, Claudine Gay, prende timidamente le distanze tenendo, però, una posizione cautamente neutrale. E si tenga presente che ciò accade nel contesto di una crescente diffusione di comportamenti manifestamente ostili, e talvolta discriminatori, da parte degli attivisti universitari statunitensi nei confronti dei loro colleghi ebrei.
Com’è possibile? È possibile perché da anni negli Stati Uniti e altrove gli attivisti di movimenti per la liberazione degli oppressi usano aggressivamente tecniche di boicottaggio e di stigmatizzazione. Sulle loro piattaforme social attaccano violentemente chiunque dissenta dalle loro posizioni gettando su di lui un marchio d’infamia in modo da declassarlo a un livello inferiore. Insomma, lo strumento dello stigma, usato per millenni dalle società tradizionali per identificare, degradare ed emarginare i soggetti cosiddetti “devianti”, viene ora sistematicamente usato dai paladini dei discriminati per discriminare a loro volta.
È un fenomeno molto più vasto dell’attivismo anti-israeliano. L’antisemitismo mascherato da antisionismo — cartina di tornasole di ogni falsa coscienza occidentale — di parte della élite studentesca statunitense rivela la natura aggressiva, illiberale e oscurantista della sinistra radicale movimentista americana. Da un decennio, oramai, nelle università statunitensi frange estremiste impediscono ai docenti di letteratura di insegnare letteratura (i grandi autori del canone occidentale sono banditi in quanto fautori della supremazia bianca, compresa Margaret Atwood, rea di femminismo tradizionale); conculcano il pluralismo e la libertà d’espressione in nome di quella stessa libertà, ostracizzano l’intero passato — impedendone la comprensione — per conto di un presente arbitrario e assoluto (la cosiddetta cancel culture); mettono in permanente e inappellabile stato d’accusa intere categorie di persone, a prescindere dalle loro responsabilità individuali, in nome dei diritti della persona (soprattutto i maschi caucasici adulti ma anche le donne che vogliano perseverare nel pensarsi e definirsi come tali e, come abbiamo visto, all’occorrenza, anche gli ebrei); disconoscono i diritti della maggioranza in nome della difesa di quelli delle minoranze. Fanno, insomma, il deserto e la chiamano cultura.
C’è un’aria di famiglia in questi paladini degli oppressi pronti a trasformarsi in oppressori. L’accecamento ideologico, il rifiuto sdegnoso dell’universalismo illuminista, il complottismo compulsivo, l’elitarismo mascherato da avanguardismo, l’autoproclamata superiorità morale, il perenne sindacato a difesa di sé stessi, il bisogno insopprimibile di sentirsi antagonisti del sistema, il desiderio sfrenato di un nemico da odiare. Sono tutte cose che abbiamo già visto e già sentito. Non vi suonano famigliari? Non vi ricordano il fanatismo settario delle sedicenti avanguardie della rivoluzione comunista mondiale quando negli anni sanguinosi della lotta di classe affermavano che in certi momenti della storia le ragioni del proletariato devono prevalere su quelle dell’umanità?
Nel mondo culturale accade oggi qualcosa di analogo. Attivisti aggressivi illiberali, che si ergono ad avanguardia intellettuale di una presunta rivoluzione politica, antropologica e sociale, pretendono di trasformare le ragioni di sacrosante lotte minoritarie nel torto di imporre alla maggioranza una ridefinizione integrale del suo modo di parlare, di pensare, di amare e di vivere. Di fronte a queste minoranze rissose, la maggioranza, spaventata, si fa silenziosa. E anche questo lo abbiamo già visto.
Mi è capitato centinaia di volte di raccogliere in privato sfoghi di intellettuali di sinistra esasperati da istanze estremiste propagandante come del tutto ovvie dai rappresentanti più radicali della ideologia gender o della cancel culture. Critiche che non diventano mai pubbliche per paura dello stigma.
E non è solo un tema che riguardi gli Stati Uniti o piccole cerchie intellettuali. L’intera nostra atmosfera culturale inizia ad essere opprimente. Su troppe questioni vitali la scena si va sempre più polarizzando agli estremi, dominata dagli attivisti di una sinistra militante e minoritaria, apparentemente contrapposti ma in verità funzionali alla reazione di estrema destra. È giunto il tempo che nel campo culturale la maggioranza silenziosa torni a parlare.

Antonio Scurati

Israele, tra il dolore e la guerra
di Maurizio Molinari
l reportage. Il pogrom del 7 ottobre perpetrato da Hamas ha risvegliato gli incubi del passato. Stretto nella morsa dell’Iran, il Paese intero prepara la risposta. Per sopravvivere
GERUSALEMME – A due settimane dal pogrom del 7 ottobre, Israele affronta la sua ora più difficile. Le atrocità di Hamas hanno risvegliato i fantasmi della Shoah, l’attacco a sorpresa ha svelato la vulnerabilità delle difese militari, gli oltre duecento ostaggi detenuti a Gaza lacerano il Paese e lo scenario di un conflitto su più fronti con i gruppi armati creati da Teheran — non solo Hamas e Jihad Islamica nella Striscia ed in Cisgiordania ma anche Hezbollah libanesi, Houti yemeniti, milizie sciite in Iraq e Siria — espone tutti gli oltre nove milioni di abitanti al rischio di trovarsi in prima linea. Anche per una nazione abituata da oltre 75 anni a battersi contro vicini che vogliono cancellarla dalla mappa geografica, è una miscela di rischi e incognite che ha ben pochi precedenti.
Tutto inizia con il risveglio da parte di Hamas dei fantasmi della Shoah e per capire cosa significa per Israele bisogna ascoltare la ricostruzione di quanto avvenuto durante il pogrom jihadista dalle voci degli scampati. Perach Filo, sopravvissuta all’Olocausto, era sola in casa nel kibbutz di Be’eri quando sono arrivati i terroristi. Si è chiusa nel mamad — la stanza di sicurezza che ogni casa possiede — con mezzo litro d’acqua, mezzo filone di pane ed una coperta. È rimasta lì per quasi due giorni, gestendo da sola il poco cibo che aveva, facendo i propri bisogni e restando in assoluto silenzio mentre ascoltava i jihadisti che le distruggevano la casa e sparavano contro la porta blindata del mamad tentando di sfondarla.
«Ero chiusa lì dentro e ringraziavo in continuazione Dio per quel mezzo litro di acqua, quel poco pane e quella coperta che avevo portato con me perché mi hanno consentito di andare avanti», racconta, evocando in chiunque la ascolti i ricordi di chi ha subito le persecuzioni naziste. Di chi sa che anche una sola fetta di pane può consentire di sopravvivere. E dai manuali della sopravvivenza ebraica esce anche quanto avvenuto quando Perach Filo ha sentito che i jihadisti si erano allontanati: si è calata da sola dalla finestra del mamad, ha acceso una piccola vettura e da sola ha raggiunto i militari israeliani che fuori dal kibbutz stavano combattendo.
Voci dal pogrom
A Be’eri sono stati commessi alcuni dei crimini più orrendi. È qui che sono stati trovati corpi di bambini bruciati. Fra i primi ad averli visti c’è un responsabile di Zaka, l’associazione che recupera i resti, anche i più piccoli, di ogni singolo essere umano, per potergli dare sepoltura. Quando tenta di descrivere ciò che ha esaminato, allarga le braccia, non riesce a trovare le parole, gli si chiude la gola, ammette di non essersi mai trovato davanti a qualcosa del genere.
Ariel Zohar ha 13 anni, è di Nir Oz ed ha avuto l’intera famiglia sterminata. Si salvato perché di primo mattino — l’attacco è iniziato poco dopo le 6 — era andato a correre. Come chi si salvò dalla razzia degli ebrei di Roma del 16 ottobre 1943 — anche quello era un sabato — solo perché era uscito per comprare le sigarette. Zohar fra una settimana farà il suo bar-mitzwà — la maggiorità religiosa — con al fianco l’unico parente che gli è rimasto, il nonno scampato alla Shoah. Quando la Storia si fonde.
Orrore a Nir Oz
Nir Oz è uno dei quattro kibbutzim più devastati, assieme a Kfar Aza, Be’eri e Nahal Oz, fra le 22 località israeliane dove Hamas ha fatto oltre 1.200 morti, 2.500 feriti e catturato almeno 210 ostaggi. Ma Nir Oz, più isolato rispetto agli altri, ha una particolarità: è l’unico dove Hamas non ha incontrato resistenza, i suoi uomini armati sono entrati ed hanno potuto fare ciò che volevano, senza fretta né ostacoli, facendo strage e poi tornando tranquillamente a Gaza. Visitarlo oggi consente di comprendere il metodo di operare che hanno seguito: prima uccidere tutti i civili che erano a portata di fuoco, poi bruciare le case dove c’era ancora chi si era rifugiato nei mamad. Hanno bruciato qualsiasi luogo dove ritenevano vi fosse una vita umana, casa per casa. Anche l’asilo. Almeno un terzo dei 350 residenti di Nir Oz è stato ucciso, carbonizzato o deportato a Gaza. Uomini, donne, anziani e bambini.
L’efferata precisione con cui Hamas ha operato a Nir Oz, bruciando le persone vive nelle proprie case, evoca gli Einsatzgruppen — le truppe speciali delle SS — impiegate dai nazisti in Europa Orientale per uccidere, ovunque li trovassero, il più alto numero di ebrei nel tempo più rapido, prima dell’inizio della fase industriale dello sterminio con i forni crematori. I manuali di Hamas trovati dai militari di Tzahal indosso ad alcuni terroristi — datati ottobre 2020, lasciando intendere i tempi della pianificazione — provano che la scelta dell’uccisione di ogni singolo civile, in qualsiasi modo possibile, era l’obiettivo fondamentale dell’intera operazione. Catapultando nel cuore del XXI secolo il metodo della caccia all’ebreo, le cui prime testimonianze risalgono alla notte della Storia: quando nell’Antica Persia il malefico Aman pianificò la distruzione di tutti gli ebrei o quando nel Medioevo i soldati della Prima Crociata devastarono i villaggi ebraici in Renania.
La lista di Halil
E poi c’è il racconto della signora Tasa di Nativ Ha-Asarà, neanche 45 anni, che ha perso il marito e un figlio. Ecco cosa dice: «I terroristi sono arrivati a colpo sicuro, avevano in tasca una mappa delle case con la lista dettagliata delle nostre famiglie che vi abitavano, sapevano quanti figli c’erano in ogni abitazione ed anche chi aveva animali domestici». La sovrapposizione con le SS che bussavano alle porte con le liste delle persone da portare via non deve neanche essere fatta: è nelle menti di chiunque ascolta. E la signora Tasa va avanti: «L’unica persona che può avergli dato informazioni così dettagliate è Halil, il giovane arabo di Gaza che per anni è vissuto con noi, curando giardini, pitturando le pareti e riparando ogni cosa, era diventato uno di noi, lo consideravamo un uomo di pace, il nostro legame con Gaza. Invece Halil gli ha dato i nostri indirizzi e nomi». Come i collaborazionisti che in tanti Paesi europei tradirono senza alcuna remora vicini di casa, amici di scuola e conoscenti ebrei, consegnandoli ai nazifascisti, e voltandosi dall’altra parte.
Sono storie che entrano dentro le viscere di chiunque in Israele, sovrappongono le atrocità di Hamas a quelle dei persecutori del passato, fanno percepire a giovani e giovanissimi che quanto commesso dai nazisti ai loro nonni si è ripetuto ora. Per un popolo abituato a vivere la Storia come un unico evento immanente — ricordando ogni anno l’Uscita dall’Egitto come se fosse avvenuta oggi — significa il risveglio degli incubi più orribili. Scoprendo che la Notte dei Cristalli, i pogrom zaristi e la caccia agli ebrei si sono ripetute nel 2023. Dimostrando la sovrapposizione fra antisionismo ed antisemitismo. Certo, la storia dell’odio antiebraico insegna che ogni antisemita impara, ripete ed aggiorna le tattiche del predecessore, anche a distanza di secoli, ma nessuno finora osava pensare che perfino gli aguzzini di Adolf Hitler potessero avere degli emulatori nell’era del web e dell’iphone.
E non è tutto perché le immagini girate dalle telecamere di sicurezza dei villaggi devastati mostrano i saccheggi, da parte dei civili di Gaza mischiati ai terroristi: bambini che rubano le biciclette, uomini che svaligiano case, prendono televisori, rubano carte di credito dai corpi morti, catturano ostaggi personali. Come se fossero al supermercato. In un fotogramma di Be’eri si vede un anziano in jalabiya che esce da un’auto di Hamas, zoppica, aiutandosi con il bastone, ma procede con passo veloce, per seguire i terroristi dentro il kibbutz. Sono immagini di pogrom perché nella Russia zarista come a Baghdad nel 1941 o a Tripoli nel 1945 la gente comune si mischiava ai gendarmi armati, gettandosi contro gli ebrei non solo per scannarli ma anche per depredarli di tutto. Ecco perché, che si tratti di ebrei di origine europea o araba, ashkenaziti o sefarditi, le testimonianze del 7 ottobre devastano il cuore di ogni israeliano.
Eroi improvvisati
Ad evocare il passato ci sono anche i racconti di singoli atti di eroismo da parte di chi si è opposto al pogrom, agendo d’istinto durante le lunghe ore di assenza dell’esercito preso di sorpresa. Come Shifka, una poliziotta madre di dieci figli, che appena saputo del massacro in corso al Rave Party è salita sull’auto e si è diretta a Nova ingaggiando — con altri tre agenti — un combattimento durato 13 ore. Finito il quale, hanno tirato fuori dalle pile di giovani uccisi quelli che ancora respiravano. Oppure Tali Haddad, madre di un giovane ferito sempre a Nova che, corsa in suo aiuto, con la propria auto ha salvato 12 vite. O il soldato beduino che, dentro una base sopraffatta, si toglie la divisa, resta in maglietta bianca, imbraccia un fucile e grida in arabo ai terroristi di andare verso di lui, fingendosi uno di loro, e quando gli sono vicinissimi gli spara a bruciapelo, uccidendoli. Il racconto della scelta dei singoli di agire solo con le proprie forze davanti al Male è un altro tassello della strage, completa ed integra le testimonianze delle vittime.
Il brutale risveglio
È questo il racconto che ha generato la scossa collettiva, risvegliando Israele sul pericolo della distruzione di un Paese che si era oramai abituato a considerarsi una “Start Up Nation”, protagonista delle innovazioni del XXI secolo. Gli israeliani si sentivano proiettati verso le nuove mete della conoscenza globale ma hanno scoperto che devono ancora battersi con tutte le forze per guadagnare il più primordiale dei diritti: quello all’esistenza. Da qui la sensazione di essere in bilico, che questa nazione torna a percepire, proprio come avvenne nel 1948 o nel 1967.
All’epoca della Dichiarazione di Indipendenza, infatti, David Ben Gurion leggendola si impose su molte resistenze interne, da parte di chi riteneva che gli ebrei erano troppo pochi e troppo male armati: sarebbero stati travolti facilmente dagli assai più potenti eserciti arabi, non c’era speranza di farcela. E nelle settimane precedenti alla guerra del 1967 Levi Eshkol, allora premier, fece scavare le fosse comuni dimostrando di prendere assai sul serio le minacce quotidiane dell’Egitto di Gamal Abdel Nasser di travolgere il giovane Stato, sterminarne gli abitanti e gettare a mare i pochi che sarebbero sopravvissuti. Più volte, nella sua breve Storia, Israele si è trovato davanti a sfide senza precedenti, talmente imponenti da poterlo sopraffare. Come fu anche l’attacco a sorpresa di Egitto e Siria nella Guerra del Kippur del 1973, quando l’esercito di Anwar Sadat sciolse con potenti getti d’acqua i bunker costruiti nella sabbia dal generale Bar Lev lungo il Canale di Suez e i tank di Hafez Assad dilagarono sulle Alture del Golan, arrivando alle soglie di Tiberiade. Quanto sta avvenendo in questi giorni ha molte analogie con questo passato.
Vivere sottovoce
Israele teme il peggio e torna, d’istinto, a comportarsi come avveniva nei primi decenni di esistenza, quando lo stato d’emergenza era quotidiano. Ecco perché il Paese vive sottovoce. A Machanè Yehuda, il mercato popolare della Gerusalemme ebraica, i venditori ci sono e le botteghe sono aperte ma non si grida più per attirare gli acquirenti. A Rechov Yafo, la strada principale, prevale il vuoto e nei negozi aperti, coperti di bandiere, le uniche musiche che si ascoltano sono canzoni che evocano l’origine del Paese, come “Erev Shel Shoshanim”, la sera delle rose che Yafa Yarkoni cantò nel 1957. I ristoranti più cari e per turisti sono in gran parte chiusi mentre restano aperti i locali più piccoli, a volte angusti, come “Rahmo” a Machanè Yehuda e “Pinati” su King George Street: pochi tavoli e tovaglie di carta, dove operai e famiglie vengono da sempre per mangiare con pochi sheqel, humus caldo con falafel o con carne.
Ascoltando Kol Israel, la radio che ogni ora aggiorna su tutto. Il traffico è scomparso e con lui l’assordante suono dei clacson. Le strade di Gerusalemme che fino a due settimane fa sembravano diventate troppo strette per una città con 800 mila anime, adesso tornano ad essere troppo grandi per i pochi veicoli che vi transitano.
Il motivo è che una buona parte della popolazione, qui come ovunque, è sotto le armi. Sono rimasti in città solo i più giovani, gli anziani, i funzionari necessari per tenere aperti uffici pubblici e trasporti, uomini o donne non più in età per essere richiamati. La parte più produttiva, vitale, creativa, d’Israele semplicemente non si vede più: è altrove a preparare la difesa più difficile e imprevista. I più anziani ricordano che fu così anche prima del 1967 — quando le ostilità arrivarono dopo tre settimane di assedio dei Paesi arabi — e dopo l’attacco a sorpresa del 1973. Tutti sanno cosa sta avvenendo perché ogni famiglia ha qualcuno sotto le armi: padri, madri, figli e figlie, nipoti.
E come avveniva negli anni Sessanta e Settanta, l’unica cosa nota è se i propri cari in divisa sono “al Nord”, “al Centro” o “al Sud”, i tre fronti da presidiare. Shalom, con un figlio e tre nipoti — due maschi ed una femmina — richiamati, lo spiega così: «Ci hanno detto in che area sono, non cosa stanno facendo, quello che rischia di più è mio nipote al Sud». Quando dice «al Sud» gli occhi diventano rossi. Shalom ha 83 anni, ha visto tutte le guerre e in molte ha combattuto, è un insegnante, appartiene alla vecchia generazione laburista, non ama il premier Netanyahu né il Likud ma dice «ora dobbiamo eliminare questi barbari, poi torneremo ad occuparci di politica». A pensarla come lui è Harel Wiesel, il proprietario della rete di grande distribuzione “Fox”, uno dei businessmen più in vista del Paese, indomita voce di spicco del movimento di protesta contro la riforma della Giustizia proposta dal governo. Ecco le sue parole: «Davanti a ciò che è successo non c’è più destra o sinistra, Netanyahu è il premier di tutti, è il mio premier, se non vinciamo contro Hamas non ci sarà più alcuna Israele, le mie idee adesso non contano, ciò che conta è l’esistenza della nostra nazione e del nostro popolo».
Il padre di Harel Wiesel sopravvisse ad Auschwitz, i figli sono nelle unità speciali e lui sente la responsabilità del momento: il ruolo dei civili che restano a casa è unire il popolo. Congelando le laceranti divisioni interne che nelle ultime 40 settimane hanno indebolito il Paese. Per questo c’è un’altra Israele, che non si vede a occhio nudo, fatta di decine di migliaia di persone che ovunque possibile si incontrano ed organizzano iniziative per sostenere i soldati e prepararsi ad affrontare un lungo conflitto. Ci sono catene di volontari — donne e uomini — che cucinano in continuazione per inviare pasti caldi ai militari, organizzano come trasportarli, preparano gruppi di docenti online se il conflitto dovesse causare la chiusura prolungata delle scuole e pensano alle attività da far svolgere ai bambini in tenera età. Più i centri urbani sono piccoli, più i gruppi di volontari sono meticolosi. L’effervescenza è sotterranea ma è ovunque, chiunque può fa qualcosa. Ma sempre sottovoce. È una nazione che torna alle origini, perché è lì che c’è la ricetta della sopravvivenza.
Accerchiati dall’Iran
La pianificazione della vita civile in tempo di guerra ha una partecipazione universale e ricorda quanto avvenne nel 1948, allorché la guerra d’Indipendenza fu combattuta in ogni angolo del Paese, dentro ogni città, villaggio e kibbutz. Come potrebbe essere anche ora. Perché il nemico non è solo Hamas ma anche l’Iran che lo sostiene, assieme a tutti i gruppi militari che eseguono gli ordini di Teheran. C’è un’infografica iraniana, pubblicata online da Iran International News, che descrive la strategia di Teheran: attaccare lo Stato Ebraico da ogni direzione usando i missili a lungo raggio e tutte le milizie armate create dai Guardiani della rivoluzione in Libano, Siria, Iraq, Yemen, Gaza e Cisgiordania.
Questo significa che l’operazione di terra nella Striscia può rivelarsi solo uno dei teatri di combattimento. «Due settimane fa nessuno di noi immaginava che l’Iran volesse realizzare il piano di distruggere Israele — afferma l’analista Alon Ben David dagli schermi di Canale 13 — ma ora dobbiamo fare i conti con questa realtà». Ciò comporta essere uno dei fronti del conflitto fra le democrazie ed i loro nemici di cui il presidente Joe Biden ha parlato giovedì notte agli americani. Anche per questo all’inizio di Rechov Yafo, proprio dove fino al 1967 passava il confine che divideva la città, il “Putin Pub” ha chiuso i battenti, ed anche la sua insegna non c’è più.

Nei giorni dell’orrore Israele ha ritrovato l’unità smarrita
di Bernard-Henri Lévy
Il racconto del viaggio da Ashhelon a Sderot fino al kibbutz martoriato di Kfar Aza e all’incontro con Herzog e Gantz. Ora si respira un’atmosfera di fraternità che contrasta con i mesi sull’orlo d’una guerra civile
Come al tempo della guerra dei sei giorni e della guerra del Kippur, come al tempo delle guerre del Libano e delle prime guerre di Gaza… in questo funesto 7 ottobre arriva la notizia del pogrom in corso nella terra che gli ebrei credevano fosse per loro un rifugio. E io, come faccio ogni volta da mezzo secolo, per principio, per essere là, proprio là, al fianco di questo Israele fragile e forte, imperturbabilmente democratico nonostante gli si neghi l’esistenza, salgo sul primo volo.
Vado ad Ashdod e Ashkelon, città costiere vicine alla Striscia di Gaza nelle quali, quando suonano le sirene, i pochi automobilisti in circolazione fermano l’auto in mezzo alla strada e si gettano in un fosso. Faccio una deviazione per andare a Be’er Sheva, che si trova più a Est, alle porte del deserto, e ospita il Soroka Medical Center, presso il quale vedo una processione di elicotteri scaricare feriti a un ritmo infernale. Poi torno verso Sderot che, ogni volta che scoppia una guerra, è la più esposta fra le città del Sud e mi accorgo di averla sempre vista sotto una pioggia di missili.
Che aspetto ha Sderot quando i bambini vanno a scuola, quando possono ridere e giocare invece di stiparsi nelle cantine degli edifici di viale Abergel dalle quali, nonostante lo spessore del cemento, si sentono fischiare i razzi? Che aspetto ha Sderot quando non ci si imbatte, in mezzo alla via Menachem Begin deserta, sul cadavere gonfio, con le gambe nerastre nude e l’arma ancora accanto, di uno jihadista ucciso durante le ultime fasi dell’assalto che, come altri più distanti, non si è avuto il tempo di coprire con una coperta di emergenza o con un lenzuolo?
E chi è Yossi, 83 anni, quando non deve trascorrere la notte in cantina sentendo, sopra la sua testa e quelle dei nipoti, i passi degli assassini che lo cercano – sanno che c’è, lo chiamano per nome, chiamano per nome i bambini che lui supplica, in silenzio, portando un dito alle labbra, di non rispondere e di non piangere… e per due volte gli assassini scendono e cercano di aprire la porta senza chiavistello contro la quale egli spinge con le sue poche forze, per tenerla ferma e far credere che sia murata… com’è il suo sguardo, quando non ha quell’aria spiritata e giovanile che il gesto da «padre coraggio» vi ha infuso?
Questa mattina Sderot è una città morta. Le sue strade sono vie dolorose e deserte in cui ci si domanda per chi brilli il sole. Il comandante della caserma dei pompieri è stato ucciso a bruciapelo mentre cercava di spegnere l’incendio divampato nella casa di una coppia di disabili ed è solo in occasione del suo funerale che incontro qualche persona: il sindaco; alcuni cecchini, posizionati all’ingresso, che a turno vengono a raccogliersi davanti al feretro; i pompieri, uniti in un dolore muto.
L’atmosfera da città fantasma, la morte che sovrasta tutto, lo scheletro del commissariato di polizia che si è dovuto distruggere per stanare gli ultimi terroristi e lo strano spettacolo di Gideon Levy, giornalista di Haaretz e vedette del fronte pacifista, in amichevole conversazione con un soldato che porta la kippah davanti alle macerie della facciata, spezzano il cuore. Verso Sud, nei kibbutz dove gli islamisti di Hamas hanno compiuto i loro massacri, la situazione è più dura. Quando arrivo a Kfar Aza, l’esercito ha finito di rimuovere il grosso dei cadaveri. Seguo un’unità di Zaka, un’organizzazione, più o meno integrata nell’esercito, che ha il compito di recuperare resti umani al fine di dare ai corpi, una volta ricomposti, una sepoltura degna, umana ed ebraica.
L’unità è composta da volontari civili e militari. Alcuni sono infuriati per l’incuria del governo, un altro, quando l’unità si raccoglie in cerchio, per la pausa caffè, nel giardinetto di un kibbutz devastato e trasformato in quartier generale, spiega che nessuno può mai fare nulla per fermare la follia del branco.
Sono laici e religiosi che fino alla settimana scorsa si battevano per essere esonerati dal servizio militare ma, quando la guerra è stata dichiarata, si sono precipitati, come tutti i riservisti, come chiunque altro, a raggiungere le proprie unità. Regna un’atmosfera di fraternità che contrasta con gli ultimi mesi trascorsi sull’orlo di una guerra civile. Conta il compito sacro di andare a recuperare, fra le case della zona Ovest, vicine alla barriera di sicurezza in cui gli aggressori hanno aperto una breccia, un pezzo di carne annerita, un piede intatto rimasto infilato nella scarpa, una traccia di Dna, una macchia di sangue.
Presto però ci dobbiamo fermare perché ci imbattiamo nel corpo di uno jihadista e temiamo che possa essere minato. Subito dopo c’è un momento di panico perché pare che ci siano due terroristi nelle vicinanze: si sarebbero appena infiltrati attraverso una nuova breccia, o attraverso la stessa ma allargata, non si sa. Sentiamo un drone sopra di noi e una serie di detonazioni sorde e ravvicinate. A quel punto arriva un’unità da combattimento: alcuni soldati si posizionano con un ginocchio a terra, altri si arrampicano sul tetto, altri ancora si dirigono a balzi verso la barriera di sicurezza tagliata con le cesoie, dalla quale proviene un fascio di scintille.
Mi fanno entrare in una casa sventrata, i cui abitanti sono stati uccisi. Vi resterò per due ore senza nient’altro da fare che ascoltare un vicino sopravvissuto che mi racconta l’assalto e mi accompagna nelle stanze di quel teatro di supplizi. L’intonaco del soffitto sgretolato dai proiettili… I muri crivellati di colpi… Il divano color crema che un’esplosione ha sollevato da terra e scaraventato, attraverso il salone, fino alla vetrata in frantumi… Nella stanza da letto dei genitori vedo il letto disfatto, bigodini, pantofole distrutte… In quella dei bambini un gatto a pile che miagola ogni mezz’ora… In cucina, una tazza di cioccolata intatta, il tostapane, lo sciroppo per la tosse, un peluche, il cesto per la biancheria rovesciato… In fondo a un corridoio c’era la camera blindata, gli assalitori non sono riusciti ad aprirla e hanno dovuto farla saltare con una granata.

Non credevo di potermi emozionare tanto davanti a degli oggetti inanimati. Né davanti al ritratto a carboncino, appeso al muro, di un sessantenne con la camicia ampia, il gilet senza maniche, la pipa in bocca e il cappello floscio gettato all’indietro, che mi ricorda i contadini di Steinbeck o i pionieri di Israele dei romanzi di Abraham Yehoshua o di Amos Oz.
Del resto, che cos’è Kfar Aza? E che cos’ha in comune con Sa’ad, Bé’eri e Re’im, le altre località martiri di questa zona di Israele? Non sono, giustamente, delle località. Né soltanto villaggi. Sono kibbutz, le comunità rurali tipiche dell’Israele degli esordi che qui resistono ancora oggi. Sono la testimonianza vivente di un Israele libertario e liberale, i cui abitanti spesso sono fra i più ferventi sostenitori della pace con i palestinesi.
Hamas contro i kibbutz. Le Einsatzgruppen islamiste contro i seguaci di una delle poche utopie del XX secolo che non sia finita in pezzi. Anche questo fa parte del senso della guerra che sta per cominciare.
Non c’è modo, nel momento in cui scrivo, di prevedere come sarà l’offensiva di terra dell’Idf, se sarà a tappeto o mirata, lunga o breve, né di dire se ci sarà davvero… A Gerusalemme però ho incontrato Yitzhak Herzog, l’undicesimo presidente di Israele; il suo potere, in linea di principio, è puramente simbolico ma il suo carisma e il discredito in cui è caduto Netanyahu ne hanno fatto una figura centrale della scena politica nazionale.
Non pronuncia mai la parola «vendetta». Nemmeno per un momento, questo ex avvocato intriso di cultura ebraica e di umanesimo si discosta dall’atteggiamento saggio e misurato che ha sempre avuto. Ma percepisco che è inquieto. Quasi impaziente. È convinto di una cosa: il massacro del 7 ottobre è la «peggiore tragedia della breve storia di Israele». E di un’altra: Hamas non è «né un’organizzazione di resistenza né un movimento di liberazione nazionale, è un gemello dello Stato islamico». E il mondo occidentale – insiste – ora si trova al «momento della verità»: capirà che è impossibile non punire chi ha sgozzato i ragazzi del festival musicale Supernova? Farà in modo, assieme a Israele, «che chi ha ordinato questa infamia, che si trovi a Gaza, a Doha o a Teheran, non possa farlo mai più?» E che cosa dirà l’Europa davanti allo spettacolo di quella che «il nostro amico Claude Lanzmann», in un bel film, chiamava la ritrovata forza degli ebrei?
A Tel Aviv, incontro l’ex vicepremier Benny Gantz prima che accetti la proposta di Netanyahu di entrare nel governo di unità nazionale. Sa di correre un rischio politico personale. Ma non è più una questione personale, mi dice. Prova ne sia che si è ripromesso di lasciare il Gabinetto nel momento stesso in cui la guerra sarà vinta… Prima però bisogna combatterla. Bisogna rendersi conto che lo Stato ebraico, minacciato lungo tutte le sue frontiere, è sull’orlo del precipizio. E bisogna tenere presente che ci sono momenti difficili in cui tutto Israele, sotto la duplice spinta dei nemici all’esterno e, all’interno, del cedimento degli animi, rischia di sprofondare. Per Gantz come per il presidente, non ci sono dubbi: i palestinesi non sono nemici di Israele ma Hamas deve assolutamente essere distrutta.
E poi ho visto le unità dell’Idf sul campo, posizionate intorno alla Striscia di Gaza, che si preparano a entrare in azione con bulldozer antimine, carri armati veri e finti e una miriade di riservisti. Il rombo dei cingoli dei carri armati che si scaldano. Gli elicotteri sopra le nostre teste, il brusio indistinto di questa massa di giovani donne e uomini, venuti da tutte le nazioni del mondo per affrontare una delle prove più tragiche della storia dello Stato.
Riusciranno a salvare allo stesso tempo il loro popolo e gli ostaggi? Sapranno restare fedeli alla morale ebraica che, per esempio, al pronto soccorso di Be’er Sheva impone – l’ho visto con i miei occhi – di curare sia gli jihadisti catturati, sia i bambini ebrei miracolati?
E la famosa purezza delle armi, tanto cara ai pionieri di Israele? Quella tohar haneshek secondo cui in ogni unità dell’Idf, assieme agli uomini d’armi, devono esserci uomini di legge e di principi capaci di discutere o respingere un ordine se non lo ritengono conforme al diritto internazionale o all’etica? Che valore avranno, quegli imperativi, di fronte al cinismo smisurato di un avversario che prende in ostaggio il suo stesso popolo e non esita a farne un bersaglio, se in quel modo può trasformarlo in uno strumento di propaganda?
Che cosa farà l’Egitto, nazione a suo dire alleata e sorella del popolo palestinese? Aprirà la sua frontiera alle centinaia di migliaia di gazawi a cui verrà chiesto di lasciare la parte settentrionale della Striscia per mettersi al riparo dalle bombe che cadranno sui depositi di munizioni, i centri di comando e i tunnel di Hamas? E questi giovani soldati torneranno vivi da Gaza? Fra loro ci sono persone di sinistra e di destra. Sostenitori di Netanyahu e suoi oppositori, che loro malgrado lo riconoscono come comandante in capo. Ebrei che portano i tefillin e altri che non li portano. Non ho sentito nessuno di loro negare che questa guerra, ahimè, sia giusta e che sia necessario vincerla.

Vietato difendersi
Amira Hass , Haaretz

I palestinesi che vivono sotto l’occupazione israeliana in Cisgiordania non possono proteggersi dalle aggressioni dei coloni. E’ il risutato di un sistema che da decenni alimenta il suprematismo ebraico.
Ai palestinesi della Cisgiordania è vietati difendersi -difendere le loro vite, la loro terra o le loro proprietà-dagli aggressori ebrei. L’autodifesa contro i coloni ebrei in Cisgiordania è un reato che può avere conseguenze molto pesanti, l’arresto, un processo, il carcere o la morte. Non è una questione di interpretazione, ma una sintesi della contorta realtà dietro l’omicidio del palestinese Qosei Mitan, avvenuto ad agosto nel villaggio di Burqa, in Cisgiordania, e dietro alla farsa dell’arresto di Amar Asliyyeh, ferito da colpi di arma da fuoco, e dei suoi tre figli, accorsi per impedire agli invasori di entrare nel loro villaggio.
Ai palestinesi non è permesso usare armi per difendersi né pietre o bastoni, e non gli è nemmeno permesso difendere gli altri. Tutto queste cose sono considerate una sorta di “sabotaggio” o, nel migliore dei casi, disturbo della pace, non solo quando ad attaccare sono persone inviate in veste ufficiale -soldati e poliziotti- ma anche se sono semplici ebrei in abiti civili.
Il divieto è sancito dalla legislazione militare, da una prassi radicata nell’esercito israeliano, dai pubblici ministeri e dai tribunali, in un’atmosfera di supremazia ebraica, e anche dagli accordi di Oslo. E’ una rete complessa in cui ogni componente è collegato a un altro e lo tiene in piedi.
La missione primaria
Non c’è da stupirsi che lo Shin bet (i servizi segreti israeliani) e l’esercito siano preoccupati. Non servono informazioni dai collaboratori o sofisticate apparecchiature per sapere che questa realtà è come un contenitore di bombe a grappolo che qualsiasi colono con il fucile può far saltare in aria. Ma lo Shin bet e l’esercito sono ostacolati da una realtà che loro stessi hanno plasmato e mantenuto. La rete spiega come gli attentati siano possibili e perché i loro autori siano numerosi tra gli ebrei osservanti e timorati di Dio.
Secondo il diritto internazionale, i soldati hanno l’obbligo di garantire il benessere della popolazione civile protetta (occupata). Ma l’esercito non rispetta la legge, perché il progetto mirato al furto della terra, che Israele tutela, è in conflitto con il benessere di quelle persone. L’esercito non le protegge dalla violenza dei civili ebrei perché la sua missione primaria in Cisgiordania è proteggere i cittadini israeliani. O, più precisamente, gli ebrei tra loro, in particolare quelli che portano avanti il progetto di espropriazione in cui sono coinvolti gli insediamenti. Anche se non tutti i comandanti e i soldati si identificano con il piano di insediamento, negli anni l’obbligo di difendere solo i coloni ebrei è stato interiorizzato. Generazioni di soldati sono state addestrate a credere che non proteggere i palestinesi sia un valore, un principio indiscusso e un ordine. Di conseguenza i soldati restano in disparte quando ci sono i pogrom contro i palestinesi, o addirittura aiutano i rivoltosi ebrei ad attacarli e a espellerli dalla loro terra. E quando gli attivisti di sinistra accompagnano i palestinesi, il fatto che siano ebrei non li aiuta. I soldati attacano ed espellono anche loro.
“Nessuna marcia, raduno o picchetto deve svolgersi senza un permesso del comandante militare”, afferma l’ordine 101 del 1967 sul divieto d’incitamento e propaganda ostile. I palestinesi sanno che se si mettono a difendere un pastore o un contadino, i soldati li “disperderanno” con i mezzi a loro disposizione: dai gas lacrimogeni alle percosse fino ai proiettili.
Per qualche motivo l’esercito non era lì il 4 agosto, quando un gruppo di coloni devoti si sono messi a pascolare il loro gregge sul terreno di Burqa. Un fatto strano visto che i militari stazionano lì vicino all’avamposto di Ramat Migron giorno e notte. Ma anche se ci fossero stati, sicuramente avrebbero disperso “l’assembramento illegale” dei residenti di Burqa e non i coloni invasori. Questo succede in ogni villaggio palestinese dove la terra o le sorgenti sono occupate dai coloni, o nei frutteti palestinesi che i coloni vandalizzano.
Negli ultimi mesi è successo, per esempio, nel villaggio di Qaryut, a nord di Ramallah. Ogni venerdì, un gruppo di israeliani provenienti dagli insediamenti vicini (Eli, Shiloh e i loro avamposti) va a fare il bagno nella sorgente al centro del villaggio, un metodo per espropriarla (dopo essersi impossessati delle sorgenti di altri tre villaggi della zona). L’esercito si trova nelle vicinanze (e arriva addirittura prima dei coloni) per impedire ai residenti palestinesi di cacciare i coloni invasori, tra cui ci sono anche bambini piccoli.
Poi ci sono le incursioni notturne nelle case degli abitanti che osano opporsi a queste invasioni: arresti e processi davanti a giudici militari israeliani, seguiti da mesi di prigione e pesanti multe per far sì che i residenti si arrendano e non cerchino di cacciare gli invasori dalla loro terra.
La legge militare impedisce ai palestinesi di possedere o usare armi. I coloni israeliani, che (quando gli fa comodo) sono soggetti invece alla legge israeliana, ottengono licenze dal ministero della sicurezza nazionale.
Gli agenti delle forze di sicurezza palestinesi ricevono da Israele il permesso di possedere armi, ma solo nei territori della Cisgiordania designati come area a, controllati dall’Autorità Nazionale Palestinese (Anp). Possono portarle per periodi limitati nell’area b (sotto il controllo civile palestinese e militare israeliano) dopo aver seguito estenuanti regole di coordinameento. Fuori di queste enclave, gli accordi di Oslo gli impediscono di agire. In ogni caso, anche nelle aree a e b, non possono far rispettare la legge e l’ordine quando i coloni attaccano i palestinesi. I poliziotti palestinesi non sono autorizzati a mostrare le armi per tenere a bada i rivoltosi ebrei, figuriamoci a usarle (se lo facessero sarebbero portati in carcere come terroristi). Non possono arrestare gli ebrei nei territori palestinesi, tanto meno fuori.
All’Anp è vietato processare i coloni per incursioni e vandalismo in un tribunale palestinese. ” La polizia palestinese sarà responsabile degli incidenti di ordine pubblico che coinvolgono solo i palestinesi”, dice l’articolo 13 dell’accordo provvisorio di Oslo. L’Anp, guidata da Abu Mazen, rispetta religiosamente questa clausola e non è riuscita ad adattare metode e tattiche alla nuova realtà.
L’articolo 15 degli accordi di Oslo stabilisce che ” entrambe le parti prenderanno tutte le misure necessarie per prevenire atti di terrorismo, crimini e ostilità reciproci” e “contro le loro proprietà”. C’è molta falsa simmentria in questa frase, perché l’Anp non è uno stato sovrano e, come il suo popolo, è soggetta all’occupazione militare israeliana, che non ha intenzione di contrastare la violenza dei coloni. L’Anp non può proteggere il suo popolo, ma ha l’obbligo di agire contro di lui.
La polizia, la sicurezza e i servizi segreti civili e militari dell’Anp, che arrestano le persone per aver criticato la leadership e che Israele vuole dalla sua parte per riprendere le operazioni a Nablus e Jenin, non sono presenti nelle decine di villaggi e comunità sottoposte al terrore quotidiano dei coloni israeliani.
Ad agosto la comunità palestinese di Al Qabun, composta da dodici famiglie (86 persone) di pastori, ha dovuto abbandonare la valle del Giordano a causa delle violenze degli avamposti circostanti. E’la quarta comunità della zona costretta a fuggire negli ultimi mesi per una combinazione di molestie dei coloni, divieti di costruzione e movimento decisi dall’amminiistrazione civile israeliana e per l’assenza di una forza che la proteggesse.
Questa contraddizione e l’ingiustizia che rifette tormentano molti palestinesi in servizio nelle forze dell’Anp. Dovrebbero preoccupare anche i leader di Al Fatah e dell’Anp. Non è chiaro per quanto tempo e a quale costo personale e politico potranno continuare a contenere la rabbia popolare contro di loro.
Amira Hass (Gerusalemme, 28 giugno 1956) è una scrittrice e giornalista israeliana che lavora per il quotidiano Haaretz. È conosciuta a livello internazionale per aver descritto la vita dei palestinesi in Cisgiordania e a Gaza, dove lei stessa ha vissuto per alcuni anni.

In memoria di Bruno Segre
| Intellettuale di origine ebraica, viveva tra l’Italia e il Canton Ticino. Partecipò alle proteste del Sessantotto con Virgilio Gilardoni e Sandro Bianconi |
| Alberto Saibene |
| È agosto il più crudele dei mesi. I figli Vera, Emanuele e Lia informano che il loro amatissimo papà, così abituato a risorgere, questa volta non ce l’ha fatta. Avevo visto per l’ultima volta Bruno a luglio, e pur malconcio, chiacchierammo a lungo e ridemmo insieme. Il saper cogliere il lato umoristico delle situazioni, anche le più complicate, era una sua caratteristica spiccata. |
| Non associo Bruno all’idea di morte, piuttosto a quella di rinascita. Lo aveva fatto molte volte in vita sua. Nel 1938, espulso in quanto ebreo dalle scuole del Regno, seppe adattarsi a una condizione di invisibile. Nel 1941, superò il trauma della morte improvvisa del padre e fu a fianco della madre e della sorella in tante peripezie durante la Seconda guerra mondiale. Trascorsero i mesi dopo l’8 settembre nascosti in un casolare dell’ascolano e solo la solidarietà dei contadini del posto gli permise di non morire di fame. Dopo la Liberazione tornarono a Milano su un camion che trasportava mele. La madre Kate, di origine irlandese, e la sorella sedute accanto all’autista, Bruno dietro a osservare il paesaggio di un’Italia sconvolta dalla guerra. Così anche gli apparve Milano bombardata, pericolosa di notte per gli sbandati che si aggiravano armati, mentre nella casa di famiglia di via Donizetti trovarono una soubrette allora famosa con cui cominciarono una faticosa convivenza. Ognuno aveva avuto la sua dose di guai durante la guerra e così al Parini, poi nella facoltà di filosofia, Bruno stette zitto e imparò a guardare avanti piuttosto che indietro. Dopo la laurea con Antonio Banfi e una serie di lavori da precario della cultura d’epoca fu affascinato dal progetto di mondo nuovo che Adriano Olivetti propugnava col Movimento Comunità. |
| Si trasferì a Ivrea nel ’55, appena sposato con Matilde, torinese, di famiglia non ebraica. Si occupò di temi sociali e poi politici, senza mai entrare in azienda, ma respirò l’aria di quella Ivrea oggi mitizzata, fino a che il tracollo delle elezioni politiche del 1958 gli fece cambiare aria. Un viaggio in Israele nel 1961 lo entusiasmò: davanti ai suoi occhi stava nascendo un mondo nuovo, senza classi sociali, con un senso di comunità fortissimo. Non si trasferì in Israele perché nel frattempo stavano nascendo i figli. Lasciò invece l’Italia del boom economico per trasferirsi in un Canton Ticino ancora rurale. |
| Per una scuola più giusta |
| Era il 1964 e il Cantone cercava docenti di lingua italiana. Insegnò alla Scuola Magistrale di Locarno dove, allo scoccare del fatidico ’68, solidarizzò (di fatto incoraggiò) gli studenti che protestavano per una scuola più giusta. Era insieme agli amici Sandro Bianconi e Virgilio Gilardoni. Li affiancava Libero Casagrande. Ricominciò all’ufficio pubblicità della Olivetti. Fu in rapporti con Franco Fortini, allora esterno, ed ebbe a scontrarsi con Renzo Zorzi. Lo conobbi in quegli anni perché divenni compagno di classe del figlio Emanuele, poi chitarrista di fama internazionale. Ricordo la casa piena di libri di via Lupetta e quella piena di giornali di Camignolo, in Canton Ticino. A pensarci fu il primo intellettuale (a parte mio padre, che era uno scienziato) che incontrai sul mio cammino. Dopo una serie di altri lavori, tra cui quello di stretto collaboratore del sindaco Tognoli (gli scriveva i discorsi), raggiunta l’età della pensione, cominciò una nuova fase della sua vita. Per un caso divenne responsabile dell’associazione Amici di Neve Shalom/Wahat as-Salam, un progetto di convivenza in un villaggio israeliano tra ebrei e palestinesi. “Una goccia nell’oceano” rilevai. “Però esiste” fu la sua risposta. |
| Avevo ripreso la sua frequentazione tra 2014 e 2015. Ne sono nati due libri-intervista: ‘Che razza di ebreo sono io’ (Casagrande, 2016) e ‘Il funerale negato’ (Una città, 2020). Il mio compito fu soprattutto stimolarlo. Bruno aveva la capacità di riflettere e raccontare nello stesso tempo. Pur completamente laico, sapeva di provenire da una storia molto antica, con implicazioni sociali e politiche che si riverberano sul presente. Come ho detto, più che il passato però, gli interessava il futuro. Era un attento osservatore dello scenario politico internazionale, preoccupatissimo dalla deriva confessionale e autoritaria di Israele, ma attento a cogliere ogni segnale di speranza. Pur pessimista, non si rassegnò mai. La colonna della sua vita fu Matilde, un porto sicuro delle sue inquietudini. Era sempre pronto a partire per luoghi lontanissimi per discutere e ragionare anche con chi la pensava in maniera molto diversa da lui. Col tempo era diventato un saggio e un punto di riferimento per molti di noi, attratti dalla sua leggerezza, dal suo spirito lieve. |
| Mancherà a molti, ma sono certo che il suo ricordo e il suo esempio ci verranno in soccorso nelle ore dell’affanno. |

Addio a Meir Shalev
L’11 Aprile 2023 lo scrittore Meir Shalev è scomparso e un altro scrittore Etgar Keret ne ha fatto l’elogio funebre. Sara Ferrari ce lo racconta.
Etgar Keret e Meir Shalev: un doppio ritratto allo specchio
Un ricordo dello scrittore da poco scomparso a partire dall’elogio a lui dedicato composto da Keret, a sua volta analizzato a partire da Shalev…
Quando un importante esponente della cultura muore, oltre alla significativa perdita prodotta dalla sua scomparsa, ci tocca ormai con una certa frequenza la non trascurabile seccatura di dover sopportare una ridda di elogi funebri vacui o fuori luogo. Un fastidio che si è oltremodo intensificato nell’era di internet e dei social network: la “corsa al R.I.P.” sembra essere, infatti, un’altra delle manifestazioni dello smodato desiderio di presenzialismo dei nostri tempi. Ciò nonostante, anche in circostanze simili, individui intelligenti e sensibili sanno regalarci momenti di rara bellezza.
Lo scrittore Meir Shalev, tra i più amati in Israele, tanto dal pubblico quanto dalla critica, è scomparso nei giorni scorsi ed Etgar Keret ne ha scritto l’elogio funebre perfetto. Se ve lo siete perso, potete recuperarlo qui, nella traduzione inglese. Non soltanto le parole di Keret rispecchiano perfettamente l’immagine dello scrittore di Nahalal, ma rappresentano altresì una testimonianza aggraziata e densa di umanità, un omaggio commosso e frutto di un’ammirazione autentica. Eppure a prima vista Etgar Keret e Meir Shalev non potrebbero apparirci più diversi.

Scrittore Tel avivi per eccellenza il primo, contemporaneo se non addirittura post-moderno, proiettato nel futuro, laddove il secondo, nato lo stesso anno della fondazione dello Stato ebraico nell’iconico moshav di Nahalal, è più che mai legato alla storia delle origini di Israele, con i suoi richiami alla generazione degli haluzim, di cui nei suoi romanzi ha ricostruito magistralmente gioie, dolori e piccole manie. Etgar Keret ci racconta la solarità un po’ rude della città con le sue mille solitudini. Meir Shalev ci offre, invece, la contemplazione della Terra d’Israele e la sua bellezza quasi incantata. Come dimenticare, ad esempio, il delizioso libriccino Il mio giardino selvatico, l’ultima opera di Shalev comparsa in italiano nel 2020, una cronaca innamorata del succedersi delle stagioni nella valle di Yizrael tra i profumi di fiori selvatici e le melodie di uccelli. I personaggi di Etgar Keret sono figure fugaci, quasi imprendibili nella rapidità con la quale attraversano le pagine. Non c’è tempo di approfondirne la psicologia, di analizzarne le motivazioni, eppure ci restano incastrati dentro, nella loro perenne ricerca di un briciolo di amore e di felicità in questo mondo freddo e ostile. Le loro azioni spesso smarginano nell’illogico, nel surreale (ricordate la giovane donna che si incolla i piedi al soffitto per scongiurare l’addio dell’amato nel racconto Colla pazza?), tuttavia, in maniera del tutto paradossale, sono mille volte più sagge della ragione stessa. Ben diversi sembrerebbero i personaggi costruiti da Meir Shalev, i piedi ben piantati sul suolo di Israele, anche quando portano il nome di Abramo e Giacobbe, in un meraviglioso attorcigliarsi di mito e storia reale, di passato biblico e attualità. Anche nelle opere di Meir Shalev si possono rintracciare evidenti segni di attrazione per l’immaginario e il fantastico, i quali derivano tanto dal retaggio folclorico-popolare di inizio Novecento, quanto dalle prove successive di Shemuel Yosef Agnon e A.B. Yehoshua, cui inoltre avrebbe attinto David Grossman. Sin dal celebrato Roman russi (“La montagna blu”, in italiano), dedicato proprio alle vicende dell’insediamento ebraico nella Palestina del Mandato, Meir Shalev tende a farci riconsiderare la possibilità di cose che abbiamo automaticamente classificato come irrealizzabili. E in effetti, come si sono chiesti alcuni critici, che cosa potrebbe essere più impossibile del compimento del sogno della costruzione della casa ebraica in Terra d’Israele da parte di un pugno di sognatori dell’Est Europa? A questo proposito, Etgar Keret ha raccolto, per così dire, un testimone già presente nella letteratura israeliana, elevandolo all’ennesima potenza.
E ancora: come lo stesso Etgar Keret nota nel suo elogio funebre, Meir Shalev, da laico qual è, possiede una notevole conoscenza dei testi biblici, dei quali è stato appassionato interprete in alcuni volumi che purtroppo non sono mai stati tradotti in italiano. Mi piace ricordarne uno in particolare, il geniale Reshit, “Principio”, che documenta tutte le prime volte della Bibbia e raggiunge profondità interpretative sconcertanti e bellissime. Al contrario, nei racconti di Etgar Keret non troviamo traccia del passato della lingua ebraica. Il suo stile di scrittura sembra essersi liberato dal peso della tradizione per restituirci una lingua nuda, precisa, semplice. Questo perché nelle opere di Etgar Keret il legame con la tradizione opera su piani differenti, nella struttura stessa del racconto e dei suoi legami con la letteratura sovente visionaria dello shtetl.
Un’ultima osservazione: nel discorso commemorativo dedicato a Meir Shalev, Etgar Keret scrive che gli scrittori sempre gli ricordano animali di diversa natura. Meir Shalev però gli ricorda un albero, “saldamente radicato nella propria lingua, nella propria eredità e nella natura entusiasmante che lo circonda”. Mentre scrivo queste righe, provo a pensare a Etgar Keret, a cosa mi ricordi la sua penna così precisa ed emozionante. Probabilmente non un animale, ma una sorgente di acqua fresca che zampilla allegra su pietre antiche, levigate e lucide, e scorre scorre e nessuno sa dire fin dove arriverà.
Sara Ferrari – JoiMag

Se il conflitto interno alla società alimenta la democrazia d’Israele
di Maurizio Molinari Repubblica 28 marzo 2023
La storia dello Stato ebraico è costellata di scontri causati dalla natura rivoluzionaria del sionismo e dalle sue differenti identità
La grande protesta popolare che da dodici settimane sfida la riforma della Giustizia proposta dal premier Benjamin Netanyahu è senza precedenti nei quasi 75 anni di vita dello Stato ebraico: forza politica e aggressività verbale delle manifestazioni ripropongono la dirompente energia che ha distinto i conflitti più aspri durante l’intera parabola ultracentenaria del movimento sionista, concludendosi sempre con un vincitore ed uno sconfitto. A rendere drammatico lo scontro è il fatto che, per gli opposti campi, ha in palio qualcosa che vale ancor più della riforma ovvero l’identità stessa della democrazia israeliana.
Da un lato c’è il premier, sostenuto dalla coalizione più a destra mai arrivata alla guida del governo, che si propone di riformare la Giustizia – ed in primo luogo la Corte Suprema – per “sanare gli eccessi” dovuti ad uno “strapotere dei giudici” e dall’altra c’è il fronte della protesta che imputa proprio a questo progetto la “fine dello Stato di diritto” e la “morte della democrazia” a causa della volontà di “sottomettere il potere giudiziario a quello esecutivo e legislativo” con norme come la possibilità per la Knesset (il Parlamento) di respingere con un voto le sentenze della Corte Suprema.
È in questa caratteristica identitaria, totale, del conflitto politico che si ritrova e riconosce la natura rivoluzionaria all’origine di un movimento come il sionismo che, alla fine dell’Ottocento, si propose di porre fine alla Diaspora bimillenaria per dare vita ad uno Stato ebraico nell’antica terra dei padri. Basti ricordare che, nel 1903, Teodoro Herzl – fondatore del sionismo moderno e leader politico vincitore del primo Congresso sionista nel 1897 – guardava con favore all’offerta britannica di creare il nuovo Stato in Uganda ma venne su questo sfidato e sconfitto dal rivale Chaim Weitzman che lo aveva accusato di tradire il suo stesso progetto originario.
Venti anni dopo, con l’immigrazione ebraica che aveva creato i primi insediamenti nella Palestina sotto mandato britannico, il conflitto si ripropose, ancor più radicale: da un lato c’erano i sionisti “idealisti” arrivati in gran parte dall’ex impero russo in coincidenza con la rivoluzione bolscevica per creare “un nuovo modello di ebreo”, legato alla rinascita della propria terra, e dall’altra c’erano i sionisti accusati di essere “opportunisti” perché arrivavano spinti solo dalla necessità di trovare un rifugio dall’antisemitismo europeo negli anni in cui l’America del presidente Coolidge chiudeva le porte agli immigrati.
Il conflitto fra “idealisti” e “opportunisti” fu assoluto, totale, fino a quando fra i primi non si impose David Ben Gurion, obbligando gli uni e gli altri a far prevalere la necessità di creare al più presto lo Stato tanto più che l’Europa era in preda al nazifascismo. Ma anche Ben Gurion, primo premier nel 1948, non fu da meno in quanto ad accese rivalità: nel suo caso sul fronte opposto c’era Zeev Jabotinsky, leader dell’Irgun revisionista, che immaginava uno Stato ad economia capitalista – e non socialista come Ben Gurion – nonché esteso su tutto il territorio dell’ex mandato britannico – inclusa l’attuale Giordania – mentre Ben Gurion accettava i compromessi territoriali con gli arabi-palestinesi pur di arrivare in fretta allo Stato.

Lo scontro fra l’Haganà – la forza paramilitare dei sionisti socialisti di Ben Gurion – e l’Irgun di Jabotinsky arrivò fino all’uso del fuoco quando, poco dopo la nascita dello Stato, i primi fecero fuoco sui secondi per impedire lo sbarco delle armi della nave “Altalena”, poco a Nord di Tel Aviv. Quei 16 morti causati dallo scontro armato fra Haganà e Irgun sulla spiaggia di Kfar Vitkin restano ancor oggi una ferita profonda nel movimento sionista, un monito immanente sul rischio a cui si va incontro quando la sfida, identitaria e di potere, per la guida del movimento prende il sopravvento sulla necessità di unirsi per difendersi da chi nel mondo circostante arabo-musulmano, allora come oggi, ancora nega il diritto degli ebrei ad avere uno Stato.
È stata la somma fra la natura rivoluzionaria del sionismo ed il fatto di essere composto da una miriade di correnti ed identità differenti specchio della Diaspora – socialisti, comunisti e revisionisti, laici e osservanti, ashkenaziti e sefarditi, tedeschi e nordafricani, galiziani e yemeniti – a dar vita a questi scontri epocali, che con la nascita dello Stato si sono trasferiti dentro la vita politica.
Dalla decisione del kibbutz Ein Harod di dividersi in due negli anni Cinquanta fra sostenitori ed avversari di Josif Stalin all’incontenibile avversione fra i leader laburisti e il Likud di Menachem Begin esaltata dalla guerra in Libano nel 1982, fino al duello politico senza esclusione di colpi – che ha tenuto banco per oltre una generazione – fra due alleati dello stesso partito come Shimon Peres e Yitzhak Rabin. Ed all’omicidio politico proprio di Rabin nel 1995 da parte di Igal Amir, un estremista di destra contrario agli accordi di Oslo siglati due anni prima con i palestinesi di Yasser Arafat.

Netanyahu, erede di Begin e leader del Likud, è riuscito per oltre venti anni a navigare attraverso queste lacerazioni politiche – alleandosi con i partner più diversi – ed alle ultime elezioni ha portato con sé l’estrema destra di Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, sostenitrice di posizioni di forte rottura, dai rapporti con gli arabi alla sfida frontale sulla Giustizia. Ma non è tutto perché dietro la vittoria alle ultime elezioni di questa coalizione si intravede l’emergere di una nuova generazione di israeliani che non si riconosce nella laica Tel Aviv o nei kibbutzim fondati in gran parte da immigrati askenaziti ed europei perché più legata ai valori della tradizione, più di origine sefardita e più presente negli insediamenti della West Bank. Ecco perché la resa dei conti sulla riforma della Giustizia cela anche un conflitto frontale sull’identità dello Stato. Seguendo il metodo rivoluzionario dello scontro continuo, identitario e totale, per sostenere una società democratica come se fosse un ponte sempre in bilico.

Israele, la terra e l’anima
di David Grossman
L’intervento dello scrittore alla manifestazione di sabato contro la riforma della giustizia annunciata dal governo Netanyahu
Quello che segue è il testo del discorso pronunciato dallo scrittore israeliano dal palco della manifestazione di sabato a Tel Aviv (alla quale hanno partecipato più di 100 mila persone) contro la riforma della Giustizia annunciata dal premier Netanyahu.
Incontro sempre più persone, soprattutto giovani, che non vogliono continuare a vivere qui. Che si sentono alienati da quanto accade e ciò li rende, a malincuore, degli estranei in patria. Israele come lo conosciamo oggi ha smesso di essere la loro casa e, per non soffrire a causa di questo senso di estraneità, si sono rifugiati in una sorta di “esilio interiore”.
È una sensazione che comprendo, ma fa male. Perché lo Stato di Israele è stato fondato per essere il luogo nel mondo in cui ogni ebreo, e il popolo ebraico, si sentano a casa. E se così tanti israeliani si sentono “esuli nel proprio Paese”, è chiaro che qualcosa sta andando storto.
Mi sembra che molti condividano questo sentire, gente di destra, di centro e di sinistra, ebrei e arabi, laici e religiosi. Quelli che sono stati sconfitti alle elezioni e persino quelli che hanno vinto: ossia coloro il cui giubilo di vittoria non riesce a nascondere quella sottile sensazione di panico quando constatano il vero prezzo del loro trionfo, e soprattutto quando iniziano a configurare i volti dei partner con cui condividono la vittoria.
Nel ricorrere del 75mo anniversario dalla sua fondazione, Israele si trova di fronte a una lotta fatale sulla propria identità: sui tratti della sua democrazia, sul ruolo dello Stato di diritto, sui diritti umani. Sulla libertà di creazione e sulla libertà di espressione artistica. Sull’autonomia dell’informazione pubblica.
Si tratta di una lotta contro leggi volte a istituzionalizzare il razzismo e la discriminazione, a umiliare le minoranze. Una battaglia contro politici cinici, alcuni dei quali corrotti, determinati a ridefinire la giustizia in modo unilaterale, antidemocratico. E in un batter d’occhio.
Amiche e amici, lo so, non è facile uscire di casa e manifestare settimana dopo settimana, rimanendo imbottigliati nel traffico, a volte per ore. Ma ciò che stiamo facendo qui è un atto di grande risveglio. È l’inizio del ritorno dall’esilio – soprattutto quello interiore, paralizzante – verso casa.
In questa folla enorme e variegata, ci sono quanti – come me – cui brucia nei cuori e toglie il sonno il futuro dei diritti Lgbt o dell’istruzione, così come dell’occupazione (dei Territori palestinesi, ndt).
Sono qui in piazza con noi rappresentanti di molte organizzazioni che nel quotidiano non si occupano di proteste. E c’è anche chi – come nelle precedenti manifestazioni – da sempre si identifica con la destra.
Tutte queste persone oggi sono pronte a mettere da parte, per un po’, la propria agenda, per unirsi attorno alla cosa più importante, critica e urgente.
E lo facciamo perché, dietro al programma unilaterale e oppressivo della “riforma giudiziaria”, vediamo una casa in fiamme.
E capiamo che se lo Stato di diritto viene danneggiato in maniera critica anche tutte le altre battaglie importanti si disintegreranno gradualmente.
Per tutti questi motivi mi rifiuto di essere un esule in patria e penso sia così anche per voi. Altrimenti non saremmo qui. Manifestiamo perché ci rifiutiamo di essere passivi, ci rifiutiamo di rimanere indifferenti. Ci rifiutiamo di essere esuli nel nostro Paese.
Adesso è il momento, amiche e amici, è l’ora buia. Ora è il momento di alzarsi e gridare che questa terra è parte della nostra anima. Ciò che accade oggi determinerà cosa ne sarà di essa, chi saremo noi e chi saranno i nostri figli.
Perché, se lo Stato di Israele sarà così diverso e lontano dalla speranza e dalla visione che lo hanno creato, si può dire che in un certo senso – un pensiero terrificante – non sarà più.
Ma se vogliamo – e ovviamente noi lo vogliamo – che lo Stato di Israele continui a esistere e a prosperare, non deve allontanarsi dalla speranza e dalla visione sulla cui base è stato creato.
Voi – centotrentamila persone riunite qui stasera – voi siete la speranza, voi siete la visione, voi siete l’opportunità.

Israele alle urne
Lunedì 17 Ottobre si è tenuto l’incontro con Aldo Baquis e Gabriele Eschenazi sulla situazione politica in Israele alla vigilia del nuovo voto. qui trovate il link per vedere ed ascoltare il dibattito.
https://www.facebook.com/1000037…/videos/1644643622599903/

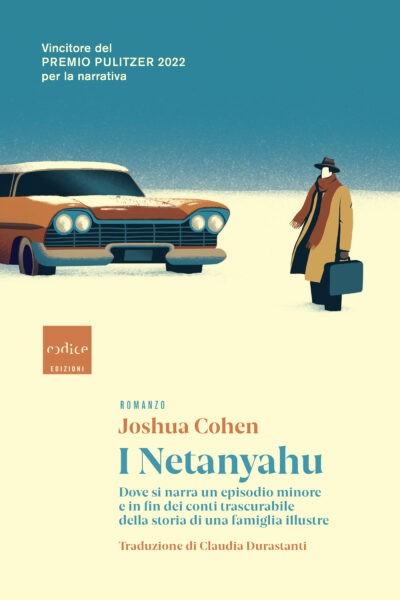
I Netanyahu , il nuovo libro di Joshua Cohen, vincitore del Premio Pulitzer 2022
Anna Momigliano 1 settembre 2022
Rivista Il MUlino 2022

Nell’estate del 2018, un venerdì di giugno, Joshua Cohen andò a trovare Harold Bloom nella sua casa di New Haven. Erano passate poche settimane dalla morte di Philip Roth, dettaglio che qui ha un suo peso, e l’invito era arrivato direttamente, con un’e-mail, dal mostro sacro della critica letteraria, che, a 88 anni, sentiva di avere qualcosa da dire a quel giovane, o quasi giovane, scrittore ebreo americano.
Di quell’incontro Cohen avrebbe scritto un resoconto, a stretto giro, sulla “Los Angeles Review of Books”: “Veniamo da un retaggio simile, Joshua, ma ricorda: le nostre vite sono separate da mezzo secolo,” gli disse Bloom. “Tutti gli scrittori della mia generazione ormai se ne sono andati.” Dove per “scrittori” Bloom intendeva “scrittori ebrei americani” e per “generazione” intendeva quella, appunto, di Philip Roth e Joseph Heller, coetanei di Bloom, ma anche di Saul Bellow e Bernard Malamud, di un decennio più anziani, insomma una generazione con cui è difficile confrontarsi (non ci metto Chaim Potok perché Bloom, che pure ne curò edizioni critiche, lo considerava un autore minore). Ma, soprattutto, una generazione che è entrata a fare parte della cultura americana partendo da una posizione di outsider, quando gli ebrei erano ancora un gruppo socialmente distinto, e respinto, con codici culturali e linguistici altri, un piede a New York e l’altro ancorato in uno shtetl dell’Europa orientale. “La mia prima lingua era lo yiddish, l’inglese non era ancora arrivato nella nostra casa, e neppure nella nostra zona del Bronx,” racconta Bloom.
Ora, premiamo il tasto fast forward fino al 2021. Quando si scopre che, in quella chiacchierata a New Haven, Harold Bloom ha raccontato anche qualcos’altro, di cui non c’era traccia nel resoconto sulla “L.A. Review”. Pare che, quando era un giovane professore a Yale, a Bloom fu affibbiato il compito di “coordinare una visita nel campus di uno sconosciuto storico israeliano di nome Ben-Zion Netanyahu,” ovvero il padre del futuro primo ministro Benjamin Netanyahu. E lo scopriamo perché Cohen ci ha scritto un romanzo, delizioso e perturbante, che poi ha vinto il premio Pulitzer: I Netanyahu. Dove si narra un episodio minore e in fin dei conti trascurabile della storia di una famiglia illustre. In Italia arriverà il 7 settembre, tradotto da Claudia Durastanti e pubblicato da Codice.
Se il titolo è I Netanyahu, al plurale, un motivo c’è. Il romanzo, densissimo e relativamente breve (poco più di 250 pagine), ruota attorno all’intero clan dei Netanyahu, e allo sconvolgimento che portarono, in appena pochi giorni, in una tranquilla cittadina universitaria americana. C’è Ben-Zion, descritto come uno storico che si sente in missione per conto di Dio, o meglio del popolo ebraico, dalle credenziali accademiche controverse, tanto basate più sull’ideologia che sui fatti sono le sue ricerche, almeno nella ricostruzione che ne fa Cohen. C’è sua moglie Tzila, personificazione della yiddish mame invadente, e ci sono i tre figli: Yonathan, il futuro eroe martire, che sarebbe morto guidando la missione per liberare gli ostaggi a Entebbe nel 1976, e qui rappresentato come un adolescente dongiovanni; Benjamin, il figlio di mezzo, il futuro primo ministro che tutti conosciamo, il più famoso della famiglia, ma che nel romanzo funge per lo più da spalla di Yonathan; e infine Ido, il minore, destinato a diventare medico e poi autore teatrale senza infamia e senza lode, qui in veste di ciclone col pannolino.
Al clan dei Netanyahu, tutti personaggi storici, sono affiancati altri personaggi che strettamente storici non sono, anche se non è difficile capire a chi siano ispirati. A partire dal protagonista, un tale professore Ruben Blum, alter ego di Harold Bloom, che però è un economista, non un critico letterario, e non insegna a Yale, ma in un immaginario college di medio prestigio. La dicotomia tra Netanyahu, nel senso di Ben-Zion, e Blum (o Bloom?) è il perno su cui ruota la vicenda. Da un lato l’aggressività e l’ossessione persecutoria di Netanyahu, figlio del Sionismo revisionista, di destra, che fu di Ze’ev Jabotinsky, in quegli anni relegato ai margini della vita politica e intellettuale israeliana ma destinato a diventare maggioritario nel tempo. Dall’altro lo spaesamento di Blum, accademico di successo, certo, ma di successo recente; professore rispettato, ma ancora guardato dall’alto in basso dai suoi colleghi, che appartengono all’élite anglosassone protestante, e infatti si sentono d’imporgli di fare da anfitrione a uno storico israeliano, perché, questo il sottotesto, tra voi ebrei vi capite. Netanyahu è pervaso da un senso di precarietà esistenziale, Blum da una precarietà sociale, entrambi sentimenti molto ebraici, il timore dell’annientamento, da un lato, e dall’altro la paura di essere ricacciati nei ghetti da cui si era appena usciti: è lo scontro tra l’israeliano e l’ebreo della diaspora.
Ma c’è un’altra tensione, più sottotraccia, che si fa sentire: la contrapposizione, più o meno implicita, tra cosa significa essere ebrei in America oggi e cosa significava esserlo ieri, l’antitesi tra l’identità di chi scrive e l’identità di chi è descritto.
Blum incarna un momento liminale dell’esperienza ebraica in America, quando gli ebrei cominciavano a non essere più, o prevalentemente non più, relegati ai margini della società ma non erano ancora pienamente accettati a fianco dei protestanti anglosassoni, tanto che il lettore noterà tracce del mondo di Pastorale Americana, o quello di Ombre sullo Hudson. Era l’epoca in cui sono cresciuti Philip Roth e Harold Bloom. Non è, evidentemente, il mondo di Joshua Cohen, che, classe 1980, è cresciuta in un’America dove gli ebrei, o, meglio, un certo tipo di ebrei laici, colti e benestanti, erano già perfettamente integrati nel tessuto socio-economico e dove, in alcuni campi, come appunto la letteratura, alcuni codici dell’identità ebraica erano addirittura permeati al di là della loro giurisdizione (basti pensare all’utilizzo che David Foster Wallace, già una generazione prima di Cohen, faceva della parola yiddish “nudnik”).
Cohen fa parte della stessa leva di scrittori ebrei americani che ha prodotto Shalom Auslander (1970); Jonathan Safran Foer (1977), Gary Shteyngart (1972), Rivka Galchen (1976) e Ben Lerner (1979) e che potremmo definire la prima generazione di scrittori cresciuti in un’America, in una certa America, dove l’identità ebraica era interamente normalizzata. In alcuni di questi autori c’è una marcata spinta a giocare con i modelli che li hanno preceduti, non una ma due generazioni prima, a confrontarcisi, a rivisitare l’identità ebraica con la sua alterità, che oggi è sempre meno un’alterità, o che, forse, lo è in modo più sottile. E’ precisamente quello che fa Cohen, ne I Netanyahu, quando mette in scena lo scontro-incontro tra Ben-Zion Netanyahu, il padre del premier che avrebbe plasmato l’Israele di oggi, e l’alter ego di Harold Bloom, il raffinato intellettuale nato in un East Bronx dove ancora si parlava yiddish. L’unica pecca, che non è gran cosa, sta nell’avere messo un po’ troppa carne al fuoco, nell’ansia di dire molto, e forse spiegare un po’ troppo, in poco spazio.
Dell’opera di certi poeti Bloom diceva che si faceva sentire l’angoscia dell’influenza, un rapporto irrisolto con l’eredità lasciata dai loro precursori. Lo stesso si potrebbe dire di certi scrittori contemporanei e, tra questi, Cohen è senza dubbio uno dei più brillanti.
Anna Momigliano

Rivista il Mulino 2022

Addio a Corrado Israel De Benedetti, un pioniere del Sionismo
3 Agosto 2022 da Mosaico
Corrado Israel De Benedetti è mancato nel suo Kibbutz, Ruchama, il 2 agosto, all’età di 95 anni. Nato a Ferrara nel 1927, nel novembre 1949, dopo le traversie della guerra e dell’occupazione nazista, scelse l’alyà in Israele, alla quale si era addestrato nel movimento pionieristico Hechaluz, e con i compagni si stabilì nel kibbuz di Ruchama nel Neghev settentrionale (che era stato fondato da ebrei russi nel 1911) dove ha speso tutta la sua lunga e straordinaria esistenza.
Nel 2013 aveva ricevuto l’onorificenza Stella al Merito del Lavoro rilasciata dal Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano.

Ha raccontato le sue scelte, i suoi amori, la sua passione per Israele e il sionismo, in diversi libri: I sogni non passano in eredità (Giuntina, 2001) nato per chiarire “a chi l’ha scritto e a chi lo vorrà leggere il succedersi dei cambiamenti nella vita di un kibbuz, che hanno portato questo modello di vita comunitaria a un graduale rigetto dei valori socialisti su cui si fondava. Cause ed effetti del processo tuttora in corso si possono intravedere seguendo le vicende di un membro del kibbuz, uno tra le decine di migliaia che scelsero di vivere questa esperienza straordinaria”; Anni di rabbia e di speranze, 1938-1949 (Giuntina, 2003) dove, dalla scuola ebraica di via Vignatagliata alla strage del 15 novembre 1943, dalla fuga in Romagna al ritorno a casa si snoda la storia di un ragazzo ebreo ferrarese negli anni bui delle persecuzioni, della guerra, del terrore. Ma con il ritorno a Ferrara comincia un’altra avventura: l’affermazione della propria identità ebraica, la militanza nel movimento sionista, la preparazione per l’emigrazione in Israele, alla ricerca di una nuova vita e di nuove speranze; Racconti di Israele (Le Château Edizioni, 2011) e Un amore impossibile nella bufera (Claudiana, 2013) del quale disse “Sul mio romanzo è stato detto che non ci sono tre protagonisti, ma è la Storia che è la protagonista; ed è quello che ho cercato di dire, perché l’atmosfera che si respirava a Ferrara nell’estate del ’38, quando eravamo giovani noi, cambiò radicalmente nel settembre con le Leggi razziali e ancora di più nel luglio del ’40, quando l’Italia entrò in guerra. La mia generazione ha dovuto chiudere il cassetto dei sogni cercando di rimanere con la testa fuori dall’acqua”. E ancora: “È come se avessimo un’idea molto chiara della vita; ci siamo sposati giovani, abbiamo scelto la nostra vita da giovani e la vita stessa è iniziata da subito. Uno dei meriti, forse l’unico, che ho ricevuto dalla Storia è stato quello di dover scegliere la strada che volevo percorrere”. E la strada è stata quella dell’alyià, del kibbuz.

Corrado Israel De Benedetti era nato a Ferrara nel 1927, da una famiglia della media borghesia ebraica ferrarese. Il padre, ufficiale di carriera del Regio Esercito Italiano, ne fu espulso in seguito alle leggi razziali. Negli anni della Repubblica Sociale Italiana la famiglia si nasconde sotto falso nome in Romagna, per evitare la deportazione. Dopo la Liberazione De Benedetti si iscrive all’Università di Ferrara. Contemporaneamente entra nel movimento Hechaluz che organizza giovani ebrei per emigrare in Palestina. È in questa prospettiva che nel 1947, lascia Ferrara e la famiglia per recarsi con un gruppo di compagni nella fattoria di S. Marco (Pontedera) e prepararsi alla vita di kibbuz. Per due anni è membro della direzione del movimento Hechaluz e redattore dell’omonimo quindicinale che si stampa a Pisa. Nel novembre 1949 “sale” in Israele e con i compagni raggiunge il kibbuz di Ruchama nel Neghev settentrionale. In kibbuz ha ricoperto l’incarico di direttore d’azienda e successivamente di segretario. Ha fatto parte della direzione economica del movimento kibbuzistico; più volte è stato inviato in Italia a rappresentare sia il movimento giovanile sia l’Organizzazione Sionistica Mondiale. È stato membro della direzione del Partito Merez, della sinistra israeliana.

È morto Abraham Yehoshua, scrittore israeliano di fama internazionale
Aveva 85 anni. Autore di romanzi di successo da “Un divorzio tardivo” a “L’amante”. L’ultimo era dedicato all’Italia
di Wlodek Goldkorn La Repubblica 14 giugno 2022
Il suo ultimo libro, specie di congedo da questo mondo, è stato un libro d’amore per l’Italia, Paese che Abraham B. Yehoshua, scomparso all’età di 85 anni, considerava la seconda patria. La figlia unica, un romanzo breve o “una novella italiana” come diceva l’autore, ambientato fra Venezia e Padova, è anche un omaggio a una delle due identità dello stesso scrittore. In questa caso: l’identità che lui definiva mediterranea. La prima era, ovviamente, quella dell’israeliano. Israeliano, a sua volta, significava “pienamente ebreo”, al contrario dei confratelli e consorelle della diaspora, divisi fra l’attaccamento al ricordo mitologico di Gerusalemme e la vita nei luoghi in cui abitano, e per questo nevrotici. Yehoshua, sionista convinto, teorizzava la necessità degli ebrei di essere una “nazione normale”, con un territorio, una sovranità e una lingua: l’ebraico moderno. Valga un ricordo personale. Era gennaio 2011. Sul display del telefono appare il nome con cui lo chiamavano gli amici, Buli. “Sono ad Auschwitz”, dice. Racconta le sue emozioni e poi: “Ho un’idea in proposito”. Quell’idea, semplificando e radicalizzando, era: la Shoah è stata la conseguenza del rifiuto degli ebrei di misurarsi con la categoria della Patria.
Il fascino dell’autore e della persona
Scrittore che con le parole sapeva fare qualunque cosa (ci torneremo), il fascino che Yehoshua esercitava da persona su chi l’abbia conosciuto da vicino, era dovuto alla sua genuina curiosità: non smetteva di porre domande, era impaziente ad avere le risposte; a un certo punto, dell’Italia voleva sapere tutto, e stava sognando di prendere per un certo periodo una casa, in Toscana o in Umbria; e poi la sua generosità, il senso dell’amicizia: dava moltissimo ma chiedeva altrettanto, soprattutto esigeva onestà e senso critico (“dimmi cosa non ti piace”, esortava, “non mi devi confermare nella mia capacità di scrivere”) e potrei continuare.
Yehoshua amava presentarsi come “quinta generazione nata a Gerusalemme”, a sottolineare il suo radicamento nella Terra degli antenati. Il padre, Yaakov, discendente di una famiglia originaria di Salonicco, era un orientalista, aveva molti rapporti con gli arabi palestinesi della città, verso la fine della vita scrisse un’opera di dodici volumi sulla comunità sefardita locale. La madre Malka Rosilio, veniva da una famiglia di rabbini del Marocco, adorava la cultura, la lingua francese, l’Europa. Ecco, Yehoshua, qualche volta raccontava che l’idea di scrivere Il signor Mani, un romanzo che narra appunto cinque generazioni di ebrei sefarditi e il loro rapporto forte con Gerusalemme e con l’identità di famiglia, considerato il suo capolavoro, gli venne in mente durante i funerali del padre. Che volle che il luogo del suo eterno riposo fosse un vecchio cimitero, quasi caduto in disuso, fra lapidi divelte.
Contraddizioni e creatività
Sostenitore della “normalità” sinonimo della “sovranità”, come si diceva, Yehoshua era anche un uomo pieno di meravigliose (perché foriere di creatività) contraddizioni. E così, nel 1967, al ritorno di una lunga permanenza a Parigi, assieme alla moglie Rivka, psicoanalista saggia, intelligente e bellissima, che gli amici chiamavano Ika e di cui era follemente innamorato fino alla fine degli ultimi giorni di lei (nel 2016, da quel lutto non era mai uscito, e il rapporto con lei lo raccontò, sublimato, in Il tunnel), tornati dunque da Parigi, i due decisero di stabilirsi a Haifa. Haifa è una città laica, porto di mare, raffinerie e forte presenza di residenti arabi. Non avevano alcuna intenzione di abitare in una Gerusalemme, la cui parte orientale, compreso il Muro del Pianto, era stata appena conquistata da Israele. “Troppi simboli, troppa religione, troppo pesante il passato”, spiegava. E del resto, a un certo punto, Yehoshua cominciò a teorizzare la necessità dell’oblio, come fatto psico-politico. La troppa memoria degli ebrei e dei palestinesi, paralizzava ogni sforzo di trovare la soluzione al conflitto. Quale soluzione? Uno Stato binazionale, ebrei e arabi insieme, perché altrimenti l’occupazione si sarebbe trasformata in apartheid.
Si è detto che nessuno come lui sapesse usare le parole in ebraico. La sua padronanza della lingua sfiorava la perfezione, così come l’architettura dei romanzi. Su incipit lavorava per settimane, qualche volta mesi, perché nelle prime pagine doveva esserci il Dna di tutta la storia. Fatto questo, i protagonisti conquistavano una certa autonomia rispetto all’autore. Diceva: “Sai, quello (e faceva il nome del protagonista inventato) mi ha sorpreso, ha fatto il contrario di quello che mi sarei aspettato”. Oppure: “Volevo farlo morire ma si è rifiutato”. E rideva. E per tornare alla scrittura, in ogni romanzo cambiava registro e ogni protagonista aveva una voce diversa, originale e difficile da imitare. Anche nei romanzi meno riusciti, ci sono pagine e pagine di vero virtuosismo, con una maniacale attenzione ai dettagli, quasi tecnici. Lui citava l’influenza che subì di Faulkner e di Kafka (“per me la martora animale antico, del racconto Nella nostra sinagoga, di Kafka, è l’essenza dell’ebraismo”) e ricordava quanto da giovane fosse affascinato da surrealismo. Dopo un lungo periodo a Haifa, si trasferì a Tel Aviv per essere vicino ai nipoti. Abitava in una casa luminosa. Quando sentì dire che sapeva descrivere la luce come pochi altri, forse solo come Camus la luce algerina, rispose di non essere bravo a descrivere gli oggetti e allora si fa aiutare dalla luce.
Fra i romanzi che resteranno a lungo: Un divorzio tardivo, L’Amante, Viaggio alla fine del Millennio, Cinque stagioni, Ritorno dall’India. Ma ha scritto pure saggi e opere teatrali. Lodatore della normalità era invece maestro nel raccontare l’impossibilità di essere normali e i disastri della vita familiare. Eppure, ripeteva: “Sono l’ultimo difensore della famiglia”.
Nell’estate sempre del 2011, Yehoshua, assieme a Ika, era a Pietrasanta. Gli proposi di venire a Sant’Anna di Stazzema. Mi chiese perché. Gli risposi che volevo fargli vedere un luogo di dolore altrui. Raccontare la sua commozione durante la visita richiederebbe la sua penna. Quelle vittime, italiane, assassinate dai nazisti, erano fratelli e sorelle, parte della famiglia.
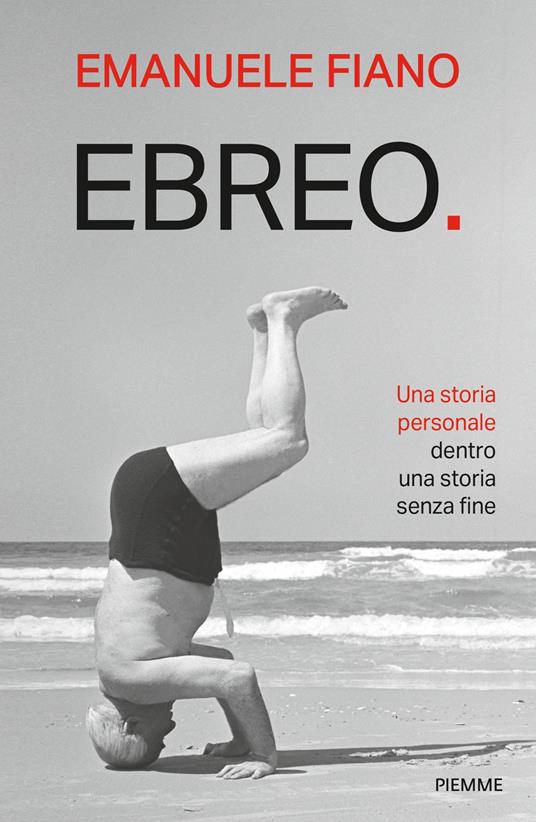
La rivoluzione ebraica nel nuovo libro di Emanuele Fiano
Michele Serra – La Repubblica 28 Febbraio 2022
L’identità ebraica, alla luce dalla grande varietà e disparità delle sue espressioni storiche, dal colono israeliano nazionalista all’intellettuale disincantato, dall’inestirpabile legame con le radici culturali e religiose a una rivendicata indifferenza soprattutto nei confronti delle seconde, è davvero molto complicata da definire. Ebrei sono Philip Roth e Woody Allen, ebrei gli haredim ultraortodossi di Gerusalemme, ditemi se esiste un nesso percepibile…
Ciò che risulta evidente anche al profano è che la millenaria diaspora, culminata con il genocidio programmato dal nazismo, non è bastata a disperdere un seme culturale così tenace da sembrare indistruttibile. Un seme irriducibile a qualunque luogo comune o pregiudizio “razziale”, compreso quello “buono” della cosiddetta superiorità ebraica: “gli ebrei sono più intelligenti”. A quest’ultima, diffusa opinione, che rimanda a una differenza indimostrabile (antiscientifica, si direbbe con un termine molto di moda), Emanuele Fiano dedica alcune delle migliori pagine del suo libro Ebreo. Una storia personale dentro una storia senza fine.
Il libro ha il pregio (e il coraggio) di calare nella storia privata dell’autore i tanti contenuti saggistici e bibliografici, come se ragionamenti e sentimenti, teoria ed esperienza fossero, gli uni senza gli altri, insufficienti a capire, e a farsi capire. Così, nel lungo racconto, il giovane Fiano, ancora adolescente, mette a fuoco il disagio della differenza non solamente di fronte allo spregio razzista manifestato da alcuni “sancarlini” (furono una sottospecie dei “sanbabilini”), ma anche quando, durante una visita medica, il dottore, scoprendo che Emanuele è circonciso, elogia, con intenzione benevola, la superiore intelligenza degli ebrei. Ottenendo, al contrario, un effetto di muto fastidio.

Figlio di un deportato ad Auschwitz (unico scampato della sua famiglia), deputato del Pd, architetto, milanese e per anni dirigente della comunità ebraica della sua città, Fiano mette sul tavolo i tanti materiali del suo ebraismo assecondando un’idea di partenza, diciamo un’idea ordinatrice, che fa da filo conduttore all’intero racconto, dalle esperienze giovanili nei kibbutz socialisti alle letture adulte, dal doloroso rapporto con una memoria familiare straziata dalla Shoah al suo lavoro politico, dalla discussione sui testi sacri alla vita quotidiana di un italiano come tanti. L’idea è questa: dall’Illuminismo in poi – diciamo dall’inizio della modernità culturale – l’ebraismo in larga parte si è secolarizzato. E in virtù delle sue stesse radici religiose e culturali ha generato un pensiero al tempo stesso critico dell’esistente e ottimista sul futuro. Comunque teso a “non rimanere nella condizione che ti ha generato”, a cambiare, migliorare, muoversi, mettersi in cammino.
Accadde, nel Settecento, che il messianesimo della tradizione (l’attesa del Messia e della salvezza) “fu collegato all’idea del progresso eterno e del compito infinito dell’umanità di perfezionarsi”. Al concetto di “redenzione”, cioè del ritorno salvifico a un Regno passato, subentra quello di “progresso”, un lungo cammino senza fine verso il futuro, verso condizioni umane più degne, libere dalla schiavitù. L’attesa messianica si trasforma “nel compito di realizzare la giustizia nella storia, un compito che ogni uomo deve assolvere in prima persona”.
Questa lettura dell’ebraismo trova evidenti argomenti a favore nell’impressionante numero di pensatori e leader politici ebrei che, a cominciare da Marx, hanno segnato la storia dei movimenti rivoluzionari e di liberazione. Lo stesso concetto di “liberazione” (ne parla anche Gad Lerner nel suo libro L’infedele, con accenti molto simili a quelli di Fiano) è impresso nell’identità ebraica quasi come un dovere, o un’investitura.
La ricerca di territori dove trovare scampo, la fuga dalle persecuzioni, tutto ciò che Fiano chiama “il giogo del presente”, non respingono verso il passato e verso la nostalgia, spingono verso il futuro e verso il mutamento. È la “futura umanità” del socialismo che si libera dalle proprie catene perché ha deciso, finalmente, di mettersi in viaggio. “Il viaggio – scrive Fiano – è l’immagine che più si addice a raccontare cosa sia l’esperienza ebraica”.
Fiano non pretende dogmaticamente “vera” questa lettura “di sinistra” dell’ebraismo, ma la sposa fortemente, anche come portato della sua esperienza individuale, fino a sostenere che “la matrice del pensiero ebraico è una matrice di progresso, chi non la interpreta così fa un torto alle nostre radici”.
A questa lettura molto politica dell’identità ebraica, Fiano affianca una lettura profondamente laica (mi permetto di definirla così) anche della tradizione religiosa e testuale. “Nell’ebraismo la dottrina non esiste e al suo posto c’è la discussione sui testi, l’accumulo indefinito delle chiose ai libri sacri, la riflessione che ai pensieri di chi è morto aggiunge quelli dei vivi”. Questa concezione non dottrinaria dell’ebraismo è rivendicata spesso, se non soprattutto, da molti ebrei non ortodossi e non credenti, che rivendicano il metodo della confutazione, della discussione, del dubbio come matrice anti-dogmatica della cultura ebraica, e come veicolo formidabile di perfezionamento intellettuale (ahi, qui si rischia di ricadere nel mito della “superiore intelligenza” degli ebrei). Vengono in mente gli spettacoli di Moni Ovadia, il proverbiale umorismo ebraico (niente come lo humour necessita di un cortocircuito critico…), lo stuolo interminabile di talenti ebrei in campo artistico e intellettuale.
E a costo di addentrarsi in un terreno minato va detto che sì, qualcosa di “diverso”, nelle radici dell’ebraismo, deve pure esserci, visti i copiosi frutti nonostante persecuzioni e ghetti. C’è un “modulo pedagogico”, come lo definisce Fiano, che dal libro dell’Esodo trascina e costringe chi lo adotta a non farsi mai bastare quello che è scritto, quello che già c’è. Come scrive David Bidussa a proposito del Talmud, “accanto a questi testi e intorno a questi testi rimane un margine di bianco considerevole. La cultura ebraica e l’ebraismo è esattamente quel margine bianco, ovvero è la possibilità e la plausibilità di aggiungere altri testi. Ovvero di continuare il testo”.
Il libro. Ebreo di Emanuele Fiano è edito da Piemme (pagg. 169, euro 17,50)

Amos Gitai, Rabin: l’inquieta memoria della speranza infranta
Percorsi. «Yitzhak Rabin. Cronache di un assassinio», per La nave di Teseo. Il 4 novembre 1995 il premier laburista fu ucciso a Tel Aviv da un colono di estrema destra. In un volume l’epilogo, momentaneo, del lungo lavoro svolto dal regista israeliano intorno a quella vicenda. «Lui era un generale e io solo un architetto costruttore di film. Sono probabilmente le normali relazioni tra una figura che plasma la realtà e un’altra che modella la memoria»
Come il tratto che contraddistingue da sempre le sue opere, anche la lunga indagine che Amos Gitai ha dedicato all’uccisione del primo ministro israeliano Yitzhak Rabin assomiglia ad un ostentato piano sequenza, in grado di catturare senza apparente contraddizione, o proprio in virtù della loro natura irriducibile, tutti gli elementi della scena. Rabin cadde il 4 novembre del 1995 a Tel Aviv, al termine di un comizio in difesa della pace, sotto i colpi di un giovane colono estremista, Ygal Amir. La sua scomparsa aprì la strada all’affermazione della destra nazionalista e religiosa e la chiuse alla possibilità di un dialogo costruttivo nella prospettiva di una pace giusta con i palestinesi, processo in cui il politico laburista si era impegnato in prima persona – e proprio per questo fu ucciso – siglando nel 1993 gli accordi di Oslo con il leader dell’Olp Yasser Arafat; entrambi saranno insigniti l’anno successivo del Nobel per la pace.
I VENTICINQUE ANNI trascorsi da quella tragedia non hanno mutato la prospettiva dello sguardo di Amos Gitai, ne hanno piuttosto affinato ulteriormente le lenti critiche, messo a punto in modo ancora più esplicito l’orizzonte all’interno del quale si iscrive quella che lo stesso regista israeliano definisce come la «strategia cinematografica, teatrale e museale» che ha sviluppato intorno alla figura e all’omicidio di Rabin. L’esito, necessariamente solo momentaneo di questo percorso è raccolto in Yitzhak Rabin. Cronache di un assassinio che La nave di Teseo propone ora nella bella traduzione di Raffaella Patriarca (pp. 240, euro 30). Il libro ripercorre l’ispirazione e gli snodi dell’«opera Rabin», la serie di lavori dedicati da Gitai all’argomento fin dal 1994 e che sembra costituire una sorta di percorso interno, ad un tempo intimo e assolutamente politico, come spesso solo la drammaturgia riesce ad essere, nel più vasto corpus narrativo del regista, tanto da racchiuderne non solo alcuni dei segni distintivi, ma, si sarebbe portati a credere, anche tutta la determinazione e l’urgenza del racconto.
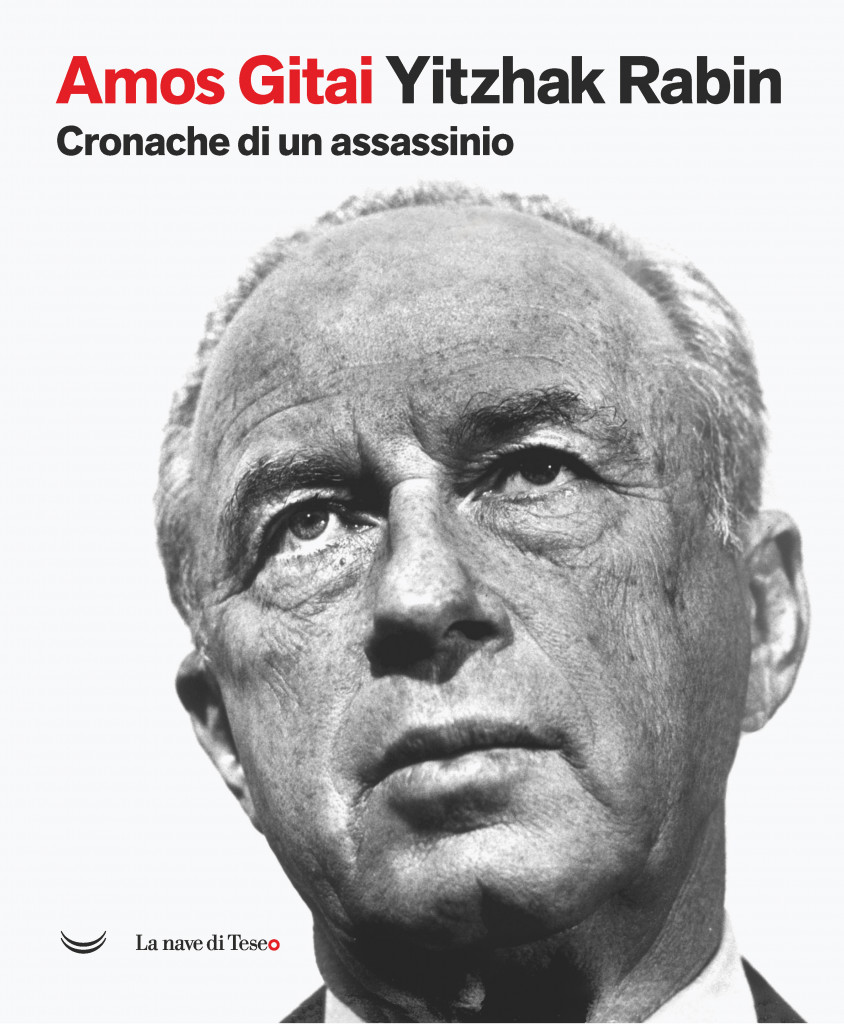
Due piani, strettamente intrecciati, definiscono l’itinerario, perché Gitai appare rispondere implicitamente a due tipi di interrogativi: da un lato c’è l’intellettuale critico auto-esiliato a Parigi dopo che in Israele le sue opere subiscono spesso la censura e l’ostracismo delle autorità che sceglie di tornare a Gerusalemme proprio in seguito all’elezione di Rabin considerata l’inizio di una possibile svolta. Dall’altro c’è «il costruttore di film», definizione che il regista utilizza per delineare il proprio lavoro anche in riferimento all’opera del padre, come lui architetto, Munio Gitai Weinraub, tra i protagonisti del Bauhaus e, dopo la fuga dal nazismo verso Israele progettista del Museo dell’Olocausto dello Yad Vashem, che si misura con la storia che si fa presente del suo Paese.
GITAI STESSO AFFIDA a due poemi, intorno a cui si muove il volume che si compone anche dei testi di critici, storici e dei suoi più stretti collaboratori, il senso ultimo di questo intimo procedere che lo interroga a più livelli ad ogni passo. «Rabin era un generale e io sono solo un architetto, figlio di architetto, padre di architetto, costruttore di film. Sono probabilmente le normali relazioni tra una figura che plasmava la realtà e un’altra che modella la memoria», scrive il regista in Mi sono seduto alla scrivania per cercare di scrivere su Rabin.
Ciò che si svolge davanti e dietro alla macchina da presa sembra perciò indagare le tracce che quell’atto sta lasciando nel suo stesso compiersi. Accanto al gesto affettuoso, all’emozione, alla paura, emerge ciò che lo storico israeliano Ouzi Elyada definisce come la costante «proprietà riflessiva» della storia per immagini proposta da Gitai. E, come aggiunge il critico Antoine de Baecque, a lungo firma di Libération, è il concetto di «luogo della memoria», preso in prestito da Pierre Nora, a permettere di «analizzare la “contro-storia” collocata dal regista nei luoghi che gli sono cari, come se, in un immaginario israeliano particolarmente attento agli spazi della memoria, Amos Gitai forgiasse una sua propria architettura della memoria, sempre critica nei confronti della storia ufficiale del suo Paese».
NEL VOLUME SCORRONO le immagini e il significato dei lavori cinematografici, a partire dai quattro documentari riuniti sotto al titolo di Give Peace a Chance che raccontano gli sforzi compiuti dal governo Rabin nella costruzione di un dialogo costruttivo con i palestinesi. Si passa quindi a The Arena of Murder, il film girato attraverso Israele all’indomani dell’assassinio del premier e che testimonia dell’emozione di un Paese ferito – ai funerali di Rabin parteciparono circa un milione di persone – ma allo stesso tempo profondamente diviso e dove i segnali della minaccia rappresentata dall’estrema destra erano già evidenti.
L’approdo, parziale, arriva con Rabin, the last day, una nuova pellicola che nel 2015, a vent’anni esatti dalla tragedia torna ad indagare sulla vicenda, mettendo insieme immagini di repertorio e «fiction» per dare voce ai molti interrogativi rimasti ancora senza risposta, a partire dalle responsabilità dei politici nazionalisti, primi fra tutti quel Benjamin Netanyahu che sarebbe diventato Primo ministro dopo l’uccisione di Rabin, che avevano più volte indicato alle piazze degli estremisti proprio Rabin come un simbolo da eliminare.
Decine di ore di girato, centinaia di interviste, un’indagine che in parte si sovrappone a quella svolta sull’accaduto dalla Commissione d’inchiesta ufficiale che sceglierà però di non approfondire «la cultura dell’odio» che aveva condotto a quell’omicidio, malgrado proprio a Gitai il giudice Meir Shamgar, alla guida della Commissione, spiegherà l’«obbligo» per la società israeliana di procedere ad una profonda «introspezione» riguardo a quanto è accaduto.
PER IL REGISTA ISRAELIANO si tratta però solo di una parte del lavoro d’inchiesta svolto intorno alla figura di Rabin e alla sua tragica fine. Vanno infatti ricordate anche un’opera teatrale, delle mostre – una delle quali legata all’uscita di Rabin, the last day è passata anche per il Maxxi di Roma nel 2016 – e un’altra, dal titolo Yitzhak Rabin/Amos Gitai, allestita presso la Bibliothèque nationale de France di Parigi è stata accompagnata dalla donazione all’istituzione francese da parte di Gitai dell’enorme massa di documenti, oltre 30mila tra immagini, girato e testi che costituiscono l’insieme dell’«opera Rabin».
COME IN BUONA PARTE dell’itinerario d’autore del regista, anche il sogno incarnato da Rabin e il suo rapido e tragico tramonto si intreccia con quesiti che riguardano l’intera vicenda storica israeliana. Gitai ricorda come Rabin avesse parlato apertamente del ruolo svolto nel 1948 come ufficiale dell’esercito che cacciò i palestinesi dalle loro case, spiegando come il solo fatto di averlo ammesso creava le condizioni per la fiducia necessaria al dialogo, Allo stesso modo, evoca due donne, Rosa della famiglia Rabin e Esther della propria che sventolavano la bandiera rossa il primo maggio e immaginavano la nascente Israele intrecciata ai miti di un socialismo umanista che si affermava attraverso i kibbutz.
Un percorso simile a quello che Gitai ha compiuto alcuni anni fa ricostruendo in un volume attraverso la corrispondenza di sua madre, Efratia Gitai (Storia di una famiglia ebrea, Bompiani, 2012), il senso di una scommessa, la portata di un’utopia che si è misurata tra mille contraddizioni con la rudezza della realtà. Il punto, scrive Gitai, è che l’omicidio di Rabin ha per molti versi rappresentato la fine definitiva di un percorso, di un processo storico verrebbe da dire. E l’orribile realtà che è sotto gli occhi di tutti sta lì a dimostrarlo. Bisogna perciò continuare ad interrogarsi, «affinché nessuno dimentichi. E ognuno di questi atti, a modo suo, diventi un gesto civile di conservazione e archiviazione dei ricordi».
Guido Caldiron Il Manifesto 15-01-2022

La difficoltà di comprendere Israele
Le questioni irrisolte del Medio Oriente condizionano l’immaginario della collettività
Dalla ricerca dell’Osservatorio Antisemitismo del CDEC , curata da Betti Guetta qui potete trovare il dossier intervistando ventidue persone provenienti da mondi diversi, a cui hanno dato il loro contributo, tra gli altri, anche Lia Quartapelle ,Gad Lerner, Wlodek Goldkorn, Roger Abravanel, Massimo Cacciari.
Il tema Israele è un sottofondo permanente delle interviste. Alcuni intervistati pensano che l’antisemitismo sia anche trascinato dall’avversione verso Israele, che la politica dello Stato ebraico sia sfruttata per rafforzare tendenze antisemitiche. La difficoltà di comprendere Israele sembra rappresentare nell’immaginario collettivo il fantasma di un ebreo riemerso dopo la Shoah.
“C’è una forma molto strisciante di antisemitismo che in realtà è un antisemitismo tra virgolette di tipo etico o perché è legato allo Stato di Israele. Uno più classico di discriminazione originaria che ha più radici nella destra e questa nuova forma di antisemitismo che purtroppo ha più radici nelle frange di sinistra”. “Allora diciamo che l’antisraelismo è una situazione in cui Israele è percepito e raccontato e descritto allo stesso modo del fantasma dell’ebreo. Come la radice di ogni male è quel paese che muove tutte le fila e questo si esprime anche in una certa fissazione su Israele. Persone che di fronte a tutte le ingiustizie del mondo scelgono di occuparsi di una sola o prevalentemente di quella ingiustizia. Oppure che cercano di attribuire delle cose a Israele che non ci sono…Anche lì sento subito una vena dell’antisemitismo. Che molto spesso va insieme con l’antiamericanismo,che è un’ossessione identitaria di sinistra”.
“È chiaro che spesso la politica dello Stato di Israele è strumentalmente sfruttata per rafforzare tendenze antisemitiche. […] Le nostre città sono sempre più multietniche con presenza sempre più forte di cittadini musulmani. È da questi settori della nostra popolazione che possono provenire spinte antisemitiche rilevanti: un vero accordo tra israeliani e palestinesi aiuterebbe a combatterle alla radice”.
Qualcuno commenta il conflitto arabo-israeliano come scontro religioso tra musulmani estremisti ed ebrei per cui l’antisemitismo deriva dall’interpretazione integralista della religione. “Nasce a mio giudizio da due tipi di fattori: uno di carattere politico e uno, di cui si parla poco ma esiste, di carattere religioso […] Allo stesso tempo però non dobbiamo sottovalutare il fenomeno che si sta diffondendo anche in Europa, come per esempio la Francia, di un antisemitismo di carattere religioso… nella fattispecie penso ad alcune componenti estremiste di religione musulmana”.
Nelle discussioni tra antisionismo, antisraelismo e antisemitismo c’è chi cerca di fare dei distinguo ma per alcuni non è sempre facile distinguere tra la critica ad Israele e l’antisemitismo. “Le politiche di Israele possono essere giudicate come le politiche di qualsiasi altro paese ma usare stereotipi antisemiti e proiettarli sullo Stato ebraico è antisemitismo verbale”.
Molti intervistati, sottolinea Guetta, ritengono che la demonizzazione dello Stato di Israele da parte dell’estremismo sia di sinistra che di destra aumenti l’antisemitismo. Il conflitto in Medio Oriente “non è la causa della nuova sollevazione di antisemitismo, anche se viene fin troppo facilmente correlato”. L’antisemitismo si è adattato alle condizioni attuali, sotto forma di antisraelismo. In quanto Stato ebraico Israele è l’espressione più visibile della vita ebraica contemporanea e, quindi, il magnete “naturale”dell’attuale antisemitismo.
“Ritengo che sia legittimo criticare le politiche degli Stati-nazione (Israele incluso) in base alle proprie posizioni politiche e morali. Ritengo sempre ingiustificabile e pericoloso mettere in campo generalizzazioni categoriali per cui ‘tutti’ gli israeliani sono, pensano, fanno…”. “Mi sembra di poter dire che non ci sia una forte relazione tra l’antisemitismo diffuso tra la popolazione e invece quello relativo al ruolo dello Stato ebraico e al conflitto con i palestinesi che ha sue complessità e la sua storia”.
“Come fai a dire ‘Io sono contro lo Stato di Israele ma sono a favore degli ebrei’: secondo me le cose vanno di pari passo e se sei a favore dello Stato sei anche a favore degli ebrei”. “Indubbiamente su alcune parti dell’opinione pubblica – ben informata, attenta alle vicende internazionali e alla tutela dei diritti umani – la politica di Israele condiziona negativamente l’atteggiamento nei confronti degli ebrei che vivono in Italia, alimentando posizioni critiche e sentimenti di ostilità”.
“Penso che molti antisemiti siano inconsapevoli, se gli dai dell’antisemita si offendono…una volta se ne sarebbero vantati. Adesso invece lo prenderebbero come un affronto, convinti che la loro sia una critica allo Stato e alla politica dei governi. Non si rendono conto che nei confronti di Israele esercitano un’attenzione diversa e usano pure degli argomenti diversi da quelli che userebbero per altri governi”.
Abu Mazen vede il ministro della Difesa Gantz: per la prima volta in Israele dopo anni
Rossella Tercatin La Repubblica 29 dicembre 2021
Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese a casa del membro del governo dello Stato ebraico a Rosh Haayin vicino a Tel Aviv. Al centro dei colloqui la cooperazione in materia di sicurezza ed economia, ma anche iniziative legate alla vita civile nei Territori palestinesi, in quelle che nel comunicato ufficiale del ministro israeliano sono state descritte come “misure volte alla costruzione di fiducia”. Critiche da Hamas e dall’opposizione guidata da Netanyahu
GERUSALEMME – L’ultima volta era stato per il funerale di Shimon Peres nel 2016, ma per ritrovare un colloquio diplomatico di livello simile bisogna risalire al 2010, nella residenza dell’allora premier Benjamin Netanyahu nell’ambito dei colloqui di pace promossi dall’amministrazione Obama. Un’altra era.
Non è di un accordo di pace che hanno parlato Gantz e Abu Mazen, ma il faccia a faccia è comunque considerato molto significativo. I due si erano già visti ad agosto a Ramallah: al centro di entrambi i colloqui cooperazione in materia di sicurezza ed economia, ma anche iniziative legate alla vita civile nei Territori palestinesi, in quelle che nel comunicato ufficiale del ministro israeliano sono state descritte come “misure volte alla costruzione di fiducia”.
Ho incontrato il presidente dell’AP, Mahmoud Abbas,” ha commentato Gantz su Twitter. “Abbiamo discusso dell’attuazione di misure economiche e civili e abbiamo sottolineato l’importanza di rafforzare il coordinamento in tema di sicurezza e prevenzione di terrorismo e violenza, per il benessere sia degli israeliani sia dei palestinesi.”
“Il Presidente Abbas ha incontrato il Ministro Gantz, e hanno discusso dell’importanza di creare un orizzonte politico che porti a una soluzione politica nel rispetto delle risoluzioni di legittimità internazionale,” le parole del consigliere di Abu Mazen Hussein al-Sheikh, ministro per gli Affari civili dell’ANP, che ha partecipato alla riunione.
In seguito al colloquio, il Ministero della Difesa israeliano ha approvato la regolamentazione dello status di 6.000 palestinesi residenti in Cisgiordania e 3.500 a Gaza, nonché il trasferimento di un anticipo del valore di cento milioni di shekel delle tasse che lo Stato ebraico riscuote per conto dell’ANP – dazi doganali, IVA e imposte sul reddito dei palestinesi che lavorano in Israele, come stabilito dagli accordi di Oslo. Inoltre, Gerusalemme concederà varie centinaia di permessi di ingresso per uomini d’affari e funzionari dell’Autorità.
Abu Mazen e Gantz hanno anche discusso possibili ulteriori misure volte soprattutto a rafforzare l’economia palestinese, che versa in uno stato di grave crisi, come l’abbassamento delle tariffe legate al trasferimento di carburante e l’incremento del numero di permessi di lavoro in Israele.
I due hanno affrontato il tema delle recenti tensioni in Cisgiordania: nelle ultime settimane, un venticinquenne israeliano è stato ucciso da fuoco palestinese vicino all’avamposto illegale di Homesh e si sono verificati diversi attacchi di civili israeliani provenienti dagli insediamenti contro civili palestinesi. Anche l’IDF è intervenuto per sedare proteste violente. A fine novembre un altro giovane israeliano era stato ucciso da un terrorista palestinese a Gerusalemme mentre si recava al Muro del Pianto.
L’incontro tra Abu Mazen e Gantz è stato condannato da Hamas, organizzazione terroristica che governa la Striscia di Gaza, che ha definito il colloquio “una coltellata all’Intifada.” Anche l’opposizione israeliana, guidata da Netanyahu, ha duramente criticato il faccia-a-faccia.

Intervista a Gadi Luzzatto Voghera: “Attentato alla sinagoga e quella sinistra antisemita”
Umberto De Giovannangeli — 17 Dicembre 2021
Il lodo Moro e quella ferita non ancora rimarginata tra l’ebraismo italiano e la sinistra. Il Riformista ne parla con una delle figure più autorevoli dell’ebraismo italiano: Gadi Luzzatto Voghera. Storico, ha insegnato Storia Contemporanea e Storia degli ebrei presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e al Boston University Study Abroad Program a Padova. È stato il direttore scientifico della Biblioteca e dell’Archivio della Comunità Ebraica di Venezia. Dal 2016 dirige la Fondazione Cdec, Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, a Milano. È autore, tra gli altri saggi, del volume Antisemitismo a sinistra (Einaudi, 2007). L’incipit è quanto mai di stringente attualità: «L’ebreo è la vittima ma anche il sionista, il lobbista, l’americano, e non semplicemente una persona. Dall’Ottocento ai giorni nostri. Anche a sinistra si fa inconsciamente spesso uso del linguaggio antisemita. È necessario saperlo vedere per poterlo sradicare».
Le rivelazioni de Il Riformista sulla tentata strage alla Sinagoga di Roma, il 9 ottobre del 1982, hanno aperto un dibattito molto sentito e anche doloroso. Si parte dal lodo Moro, che caratterizza quegli anni. Da storico come la vede?
Quel lodo era certamente il frutto di un compromesso anche all’interno di forze politiche che pure sul terreno governativo e parlamentare si contrapponevano. Evidentemente c’era un comune sentire soprattutto connesso a questioni di politica estera, al ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, al rapporto con i paesi arabi in generale e in particolare al conflitto israelo-palestinese. A prescindere da Aldo Moro, nella Democrazia cristiana c’era un’attenzione particolare, direi privilegiata, ai rapporti con i paesi arabi. Giulio Andreotti da ministro degli Esteri aveva negli anni precedenti guardato con particolare attenzione a relazioni privilegiate dell’Italia con i paesi arabi il che comprendeva anche una qualche forma di attenzione ad attività non soltanto diplomatiche ma, anche, purtroppo, di natura militare in Europa. Lo stesso tipo di attenzione c’era anche da parte di altre forze politiche appartenenti alla sinistra, certamente il Partito socialista di Bettino Craxi era molto legato all’Olp e a Yasser Arafat e manifestava un’attenzione specifica col mondo arabo…
E il Pci?
Il Partito comunista viveva come sempre in quegli anni tensioni complicate e travagliate al proprio interno che certamente risentivano di una forte dipendenza, dal punto di vista diplomatico, e di schieramento, nei decenni precedenti, dall’atteggiamento dell’Unione Sovietica su tutta l’area mediorientale e che vedeva dei nodi decisamente non risolti. In tutto questo, però, proprio nella contingenza di quei mesi, di quelle settimane, s’innestano quegli avvenimenti storici, politici, militari che hanno a che fare con l’Operazione Pace in Galilea, lanciata nel giugno del 1982 dal Governo d’Israele allora guidato da Begin, con l’obiettivo di chiudere i conti con la presenza militare dell’Olp nei campi profughi in Libano. Quell’operazione aveva aperto una questione militare e nello stesso tempo diplomatica, che era sulle prime pagine di tutti i giornali e quindi all’attenzione dello stesso Governo italiano. Da lì a poco ci fu la prima missione Unifil in Libano che vide una significativa presenza italiana tra i caschi blu dell’Onu. E si trattava di una prima volta della presenza militare italiana fuori dai confini nazionali. Quella fu una estate molto travagliata quanto ai rapporti tra la sinistra e il mondo ebraico in generale in Italia su quel nodo lì. La testimonianza più eclatante fu la manifestazione sindacale durante la quale fu deposta una bara davanti all’ingresso della Sinagoga di Roma. Fu un episodio che fu vissuto in maniera molto dolorosa dalla comunità ebraica. Si aprirono dibattiti giornalistici importanti che hanno anche spaccato trasversalmente la comunità ebraica al proprio interno sull’atteggiamento da tenere nei confronti della guerra in Libano. E in tutto questo si è innestato quell’atto terroristico che non era una novità sul terreno italiano…
In che senso?
Adesso lo sappiamo dalle carte, anche quelle meritoriamente portate alla luce da Il Riformista, ma devo dire che l’allarme era già scattato nelle comunità ebraiche italiane. È qualcosa che io ho vissuto in prima persona. Si sapeva che c’era un allarme e ci veniva restituito questo allarme dalle stesse questure a tutti i livelli. Era una cosa nota. Un po’ sono stupito da queste rivelazioni. Trovare nero su bianco con tanto di telex, cablo etc., che il giorno dell’attacco terroristico fosse stata sguarnita la sicurezza davanti alla Sinagoga di Roma da parte delle forze di polizia, questo è qualcosa di molto grave, che stupisce, e su cui va fatta chiarezza. Tanto più che era risaputo che le comunità ebraiche erano oggetto di possibili azioni terroristiche in Italia e in Europa. Una strategia del terrore che rifletteva peraltro un’articolazione interno all’arcipelago terroristico del mondo palestinese che non era nemmeno molto univoco nella sua operatività. Ognuno andava per la sua strada: Abu Nidal non chiedeva certamente il permesso ad Arafat per muoversi. In tutto questo, la sinistra si mancava di una certa consapevolezza…
A proposito di questo. “Il Riformista” ha titolato un’intervista a Piero Fassino così: “Ebraismo e socialismo sono fratelli. Cara sinistra è ora di capirlo”. La sinistra l’ha capito o ancora no?
Vede, io comincio ad avere qualche difficoltà a dare una cornice a cosa intendiamo per sinistra adesso. All’epoca, la sinistra aveva dei pilastri, anche se tardo ideologici, piuttosto visibili e anche una sostanza organizzativa a livello dei partiti molto chiara e molto dipendente da una struttura verticistica, per cui una volta presa una decisione, elaborato in qualche modo anche un sentiero di discussione, questa strada veniva intrapresa con una certa decisione. Dopodiché le ricadute a livello periferico ci mettevano un po’ a decantare, ma comunque sia c’era una visione. Posso dire cosa è rimasto come eredità di quello che fu fatto all’epoca. E ciò che fu fatto, a vari livelli, fu uno sforzo sia nel Pci che nel Psi estremamente significativo. Va ricordato peraltro, che il Governo dell’epoca era guidato da Giovanni Spadolini, leader di un partito, il Pri, che aveva posizioni storicamente pro Israele. D’altro canto, il Partito repubblicano si considerava un po’ l’erede dello spirito azionista e a quell’epoca parte essenziale della sinistra italiana, anche se poi aveva comportamenti governativi di centro. Adesso c’è l’’eco di quello su cui si lavorò all’epoca. Sono invecchiate molto le persone che hanno fatto parte di quella stagione, ci sono ancora degli strascichi organizzativi, penso a “Sinistra per Israele”, ad esempio, e a piccoli gruppi organizzati che si riconoscono nell’elaborazione che si fece all’epoca, in quel tentativo di comprendersi meglio al di là delle retoriche, che in quegli anni si basavano sull’idea che non ci potesse essere frattura tra ebraismo e sinistra per il semplice fatto che si proveniva tutti da una comune matrice antifascista. Un qualcosa che però non faceva i conti con quella che è poi stata l’elaborazione storiografica che ci restituisce altro rispetto a quello che era stato. Era più il frutto di una epica resistenziale su cui si era vissuti per decenni ma che non ci dava l’idea corretta di quello che era stata, solo per fare un esempio, l’adesione di una componente dell’ebraismo italiano al fascismo per diversi anni. Non c’era stato soltanto un arruolamento ipso facto degli ebrei in campo antifascista solo perché dal ’38 in poi erano stati perseguitati. C’è una storia più articolata, su cui ormai da tanti anni si sta lavorando a vari livelli. C’è un equivoco di fondo che ancora negli anni’80 si manteneva, però nello stesso tempo all’epoca quell’equivoco era necessario perché era evidente come fosse maturata una frattura su Israele.
Che cosa era successo?
Dal ’67 al ’72, su Israele era maturata una frattura forte tra la sinistra e una componente importante delle comunità ebraiche. Una frattura che nell’82 non era più sopportabile, per cui si attivo un percorso interessante, anche fruttuoso. Oggi rimangono dei pezzi sfrangiati della sinistra. Più che una mancanza di attenzione o di empatia da parte del mondo ebraico, che peraltro ha vissuto anch’esso una grande trasformazione, ciò che faccio fatica a capire, e non credo di essere il solo, è cos’è la sinistra in questo momento, soprattutto se c’è anche uno sguardo omogeneo delle componenti che in questo momento si riconoscono a sinistra, in relazione, ad esempio, al conflitto mediorientale. In mezzo ci sono stati tanti eventi. Uno di quelli fondamentali è che si è passati attraverso la stagione dell’elaborazione della memoria della Shoah, che ha cambiato molte carte in tavola. Ha cambiato lo sguardo stesso sul significato dello Stato d’Israele nello scacchiere internazionale e come componente essenziale, democratica, all’interno di un Mediterraneo molto complicato dal punto di vista democratico. Non siamo all’anno zero. Sicuramente c’è una conoscenza maggiore da parte del mondo non ebraico in generale, anche a sinistra, di quello che sono le sensibilità delle comunità ebraiche e dell’articolazione della società israeliana, come di quella palestinese. Allo stesso tempo, però, c’è il mantenimento di una serie di retoriche, su cui ho scritto un libro, dell’antisemitismo anche a sinistra che ha una sua lunghissima storia di permanenza di linguaggio che fa fatica a smuoversi. Da questo punto di vista, c’è ancora tanto da fare.


Attacco alla sinagoga, Fiano: “Grave e inquietante quanto rivelato dal Riformista, governo ci espose ai terroristi2
Umberto De Giovannangeli — Il Riformista – 11 Dicembre 2021
Il suo impegno politico nella lotta all’antisemitismo s’intreccia indissolubilmente con la storia personale e della sua famiglia. Emanuele Fiano, deputato del Partito democratico, già membro della segreteria nazionale Pd, è il terzo e ultimo figlio (dopo Enzo e Andrea) di Nedo Fiano (1925-2020), ebreo deportato ad ad Auschwitz e unico superstite di tutta la sua famiglia, e della moglie Rina Lattes. Nel gennaio 2021 ha pubblicato il libro Il profumo di mio padre, che racconta della sua vita di sopravvissuto della Shoah e del rapporto con il padre sopravvissuto ad Auschwitz.
Tra il 1998 ed il 2001 è stato presidente della Comunità Ebraica milanese, dal 2001 al 2006 è stato invece consigliere dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Nel 2017 è stato promotore di un disegno di legge sull’apologia del fascismo. Dal 2005 è segretario nazionale di Sinistra per Israele, associazione politica, che insieme a Piero Fassino e Furio Colombo che la presiede, si propone di sviluppare la conoscenza delle posizioni della sinistra israeliana e contrastare i pregiudizi anti-israeliani, che ritiene albergare anche in una parte consistente della sinistra italiana. In questo modo ha promosso iniziative che riguardano la convivenza interculturale e il confronto, come iniziative per il dialogo tra israeliani e palestinesi.
Le rivelazioni de Il Riformista riattualizzano una vicenda tragica, l’attacco terroristico alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982, e riaccendono i riflettori sul “lodo Moro”, quello che lei ha definito il “lodo insanguinato”. Cosa racconta quel lodo?
Racconta la situazione del nostro paese in quegli anni. Quel lodo di cui parliamo è evidentemente un elemento di scambio determinato da chi governava l’Italia, da chi aveva la responsabilità sulla politica estera di questo paese. Un patto non scritto in maniera formale, che prevedeva che le attività terroristiche dei movimenti palestinesi non avrebbero investito l’Italia. Uno scambio che contemplava, contemporaneamente, un appoggio alla politica palestinese. L’Italia sarebbe stata considerata un terreno di passaggio per le forze palestinesi e di converso la politica estera italiana avrebbe tenuto un profilo assolutamente filopalestinese. Questo intendiamo con questo terribile lodo che fece sposare all’Italia una posizione inaccettabile.
In una intervista a questo giornale, Riccardo Pacifici, per anni presidente della Comunità ebraica di Roma, ha rivelato un episodio alquanto emblematico. Alla signora Daniela Gaj, la mamma del piccolo Stefano Taché, il bambino ucciso nell’attacco alla Sinagoga, che si batteva perché anche lui fosse ricordato nella Giornata dedicata alle vittime italiane del terrorismo, fu motivata così l’esclusione del figlio: «È un ebreo, mica un italiano». Cosa c’è dietro questa terrificante affermazione?
C’è una terribile concentrazione di odio che avvenne in quel periodo e il mancato superamento di stereotipi cari alla cultura antisemita sia di matrice cattolica che di matrice politica. Quelli sono gli anni della manifestazione sindacale, a cui partecipava anche la Cgil, che depositò davanti alla Sinagoga di Roma una bara. Quelli sono gli anni della guerra in Libano del 1982 con la strage nei campi palestinesi di Sabra e Chatila, non opera dei militari israeliani ma delle milizie cristiano-maronite. Quella tragica vicenda determinò in Italia una trasposizione dell’odio verso Israele, che era visto come il massacratore dei palestinesi, falsando la realtà storica di quel momento, verso gli ebrei italiani. Quella manifestazione testimonia tutto ciò. E dà conto anche di una sinistra italiana che, a parte alcune lodevoli eccezioni in cui mi colloco assieme ai miei maestri di quegli anni tra i quali Piero Fassino e Giorgio Napolitano, che Riccardo Pacifici cita nella bella intervista al Riformista, e anche altri come Valter Veltroni e Francesco Rutelli, in quell’inizio degli anni ’80 sulla vicenda mediorientale si era schierata unicamente da una parte e questo fu trasfuso in una parte della cultura corrente italiana. Quella risposta che cita Riccardo Pacifici fa gelare il sangue e testimonia di un periodo che però, va detto, fortunatamente è passato. La frase ricordata da Pacifici coglie un particolare dell’epoca quanto al pregiudizio antiebraico, ma è ancora più grave e inquietante quanto ha portato alla luce Il Riformista con le carte ritrovate nell’archivio di Stato.
Perché più grave?
Qui c’è una collusione di apparati dello Stato. Le segnalazioni dei telex che avete pubblicato dicono che ci potrebbero essere attentati a obiettivi israeliani in Italia ma anche a sinagoghe, nell’ambito di qualcosa che organismi dello Stato adesso dovranno scoprire, e nonostante queste segnalazioni, le forze dell’ordine non agiscono. Qui si va oltre l’antisemitismo. Qui c’è un calcolo, che va investigato, di relazioni internazionali.
Cosa può fare oggi la politica perché sia fatta piena luce su quella pagina oscura della storia italiana?
Il Partito democratico ha presentato subito una interrogazione parlamentare a firma mia e di Lattanzio. Io penso che sicuramente se ne debba occupare, in Parlamento, l’organo che si occupa del funzionamento dei servizi segreti di cui ho fatto parte anch’io per diversi anni, che è il Copasir. Questo organismo può chiedere, ne ha le prerogative, la desecretazione di altri atti, per scoperchiare quello che c’è sotto questa spaventosa costruzione che ha portato a quel morto di due anni e a quei 37 feriti. In più mi pare, come è stato scritto, non c’è solo la possibile omissione colposa o addirittura connivenza colposa con chi ha provocato quelle vittime. Bisogna anche capire il ruolo di Abdel Osama al-Zomar, il palestinese che fu arrestato un anno dopo la tentata strage, al confine tra Grecia e Turchia con un carico di 60 kg di tritolo. Come avete ricordato, l’Italia ne chiese l’estradizione ma il terrorista palestinese fu immediatamente scarcerato dalla Grecia forse per evitare ritorsioni. Al-Zomar che era stato arrestato, che era stato multato, che era stato segnalato, che era conosciuto. Bisogna capire se all’interno di quel lodo sanguinoso ci fossero delle collaborazioni con alcuni palestinesi. Questo lo può sapere solo chi può scavare dentro queste carte ulteriormente. Voglio ricordare un altro episodio di quegli anni…
Quale?
Sigonella. Gli assassini di Leon Klinghoffer, sull’Achille Lauro, furono lasciati andare dall’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi. Gli americani chiedevano che fossero trattenuti a Sigonella, ma Craxi decise di lasciarli ripartire all’interno di un accordo con l’Olp. Stiamo parlando di persone che avevano ucciso a sangue freddo, a colpi di mitragliatrice, un povero anziano ebreo in sedia a rotelle che aveva la sola colpa di essere ebreo. Quel clima va ricostruito tutto. Ma a parte il clima, noi vogliamo sapere chi fece cosa e perché.
Perché quella vicenda di oltre 39 anni fa è ancora attuale?
Perché la difesa della libertà e della democrazia per ognuno che emana dalla nostra Costituzione, non può soggiacere a nessun accordo internazionale, palese o nascosto. Non ci possono essere accordi internazionali con forze terroristiche, come potrebbe essere stato in questo caso. La storia italiana è piena di racconti di omissioni e di segnalazioni a cui non ha corrisposto un’azione delle forze dell’ordine, negli anni bui della nostra Repubblica. Ed è ancora attuale perché la trasparenza deve essere una necessità che oggi più che mai è contemporanea. Tutto questo è contemporaneo, secondo me. Continua ad appartenere al rapporto che deve esserci tra le forze di sicurezza che lavorano nel segreto di un paese, e le sue politiche palesi. Dopodiché c’è una storia dell’antisemitismo e anche dell’antisionismo in Italia che, devo dire, è sicuramente migliorata. Nell’intervista, Pacifici può citare, nel Pci di allora, solo Fassino, Napolitano e Occhetto, e ricorda le parole di Giorgio Napolitano – l’antisionismo come forma moderna dell’antisemitismo -. E Pacifici li cita come una eccezione, perché il Partito comunista italiano dalla Guerra dei sei giorni in poi si era schierato con il blocco sovietico, schierato in quegli anni con l’Egitto di Nasser e con la Siria. Da allora c’è stata una evoluzione assoluta. Basta vedere quando oggi ci sono delle manifestazioni di solidarietà con Israele, perché ci sono attentati o per altre cose del genere, nel ghetto di Roma. Ricordo l’ultimissima, Enrico Letta era stato appena eletto segretario del Pd, c’erano tutti i segretari politici dell’arco parlamentare. Questo senza togliere che io, come Enrico Letta o Piero Fassino, ci batteremo sempre per una soluzione del conflitto israelopalestinese fondata sul principio “due popoli, due Stati”. È cambiato il rapporto della sinistra italiana, per lo meno nella quale mi riconosco io, quella parlamentare, con quella vicenda. In quegli anni purtroppo non era ancora così. Non che questo c’entri con quegli attentatori, ma centra con quella storia che abbiamo raccontato. E con il lodo Moro.


Intervista a Piero Fassino: “Ebraismo e socialismo sono fratelli, a sinistra è ora di capirlo”
Umberto De Giovannangeli — Il Riformista -14 Dicembre 2021
Se, come è vero, dietro al “lodo Moro” c’era anche un humus antisemita e antisionista che aveva attecchito anche a sinistra, Piero Fassino quel “lodo”, riportato alla luce da Il Riformista con le nuove rivelazioni sull’attentato terroristico alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982, che costò la vita al piccolo Stefano Taché, e il ferimento di 37 persone, quel lodo Fassino, già segretario dei Ds e sindaco di Torino, oggi parlamentare dem e presidente della Commissione Affari esteri della Camera, lo polverizza rivendicando una storia che non tutti a sinistra hanno ancora assimilato.
L’attentato alla Sinagoga di Roma, il “lodo Moro” e ancora, come ricordato da Emanuele Fiano in una intervista a questo giornale, la manifestazione sindacale, a cui partecipò anche la Cgil, con la bara deposta davanti alla Sinagoga. Cosa c’è dietro questa ferita non ancora rimarginata?
Le vicende degli anni ’80, comprese le reazioni all’attentato terroristico alla Sinagoga di Roma del 1982, vanno inquadrate nelle letture manichee e unilaterali con cui in quegli anni la sinistra guardava all’ebraismo e a Israele, tema spesso affrontato senza tener conto della storia, né dei processi politici reali. Sgombriamo il campo da alcune false verità…
Quali?
Intanto liquidiamo i pregiudizi antiebraici e antisemiti. L’ebraismo è una delle radici fondamentali della cultura, della storia e della civiltà europea. Basta pensare a città come Amsterdam, Praga, Vilnius, in Italia Livorno, e la stessa Berlino prima dell’avvento del nazismo, per sapere che l’ebraismo non è estraneo a noi, è una delle radici dell’identità europea. Punto secondo: il sionismo non è una forma di razzismo, come affermò anni fa una sciagurata risoluzione delle Nazioni Unite, che spesso continua essere evocata. Il sionismo nasce alla fine dell’Ottocento come un movimento di liberazione nazionale e sociale del popolo ebraico. E nasce insieme al movimento socialista, tant’è che molti dirigenti socialisti vengono da origini ebraiche – si pensi a Treves e Modigliani, leaders del Partito Socialista. E le interazioni tra movimento socialista e movimento sionista erano fortissime, come testimonia la prima tessera del movimento sionista fondato da Theodor Herzl, che aveva come immagine un bue che traina un aratro in un campo di grano con il sole all’orizzonte, cioè un simbolo socialista. L’ebraismo oltre che essere una radice della civiltà e della storia europea, è anche parte della storia del movimento socialista del continente. Nascono insieme e crescono insieme. Non solo, ma l’avvento del fascismo prima e del nazismo – e di molte dittature dello stesso stampo reazionario in Ungheria, Polonia, Romania – e le loro persecuzioni contro gli ebrei, rinsaldano ancora di più il rapporto tra l’ebraismo e la sinistra, in una solidarietà cementata dalla comune lotta contro un comune nemico. E nonostante lo stalinismo abbia tra le sue tare i pogrom anti ebraici, ciò non arriva fino al punto di recidere i rapporti tra il mondo ebraico e la sinistra. E nella Seconda guerra mondiale ancor di più: la resistenza al nazismo in Europa si salda alla lotta disperata delle comunità ebraiche per sottrarsi alle persecuzioni, ai campi di sterminio, all’Olocausto. E quando, all’indomani della Seconda guerra mondiale, le Nazioni Unite decidono che il mandato britannico sulla Palestina ceda il posto alla creazione di due Stati – lo Stato ebraico e lo Stato arabo-palestinese – sono le grandi potenze, Usa e Urss e tutti i paesi europei, a votare in favore di quella risoluzione, vissuta dalla sinistra come un atto di giustizia e di restituzione, dopo il dramma dell’Olocausto, di speranza e dignità al popolo ebraico. Nell’archivio della federazione torinese del Pci, ho ritrovato, quando ero segretario, una locandina raffigurante un piroscafo e l’indizione di una sottoscrizione dei Comunisti torinesi per raccogliere fondi per sostenere gli ebrei che partivano da Livorno per andare in Palestina.
Ma anche in quegli anni vi furono momenti difficili, come insegna la storia…
Assolutamente sì. In particolare, ancora una volta, dall’Unione Sovietica vennero campagne di persecuzione, come i pogrom scatenati per il presunto – e non vero – “complotto dei camici bianchi”, con cui si accusarono medici ebrei di aver ordito un complotto contro la salute di Stalin. Nonostante quel momento molto duro, il fatto che pochi anni prima si fosse combattuto insieme contro il fascismo e il nazismo, consentì di mantenere un vincolo di solidarietà, soprattutto in Italia e in Occidente. Né può essere dimenticato che anche molti dirigenti comunisti delle democrazie popolari dell’Europa centrale erano ebrei, protagonisti della resistenza antinazista. Tant’è che quando Stalin, per assoggettare quei paesi in modo ancora più ferreo al volere di Mosca, ne decapita i gruppi dirigenti, la principale accusa dei processi farsa è di essere “agenti sionisti”. E quel che accade a Slansky in Cecoslovacchia, a Rajk in Ungheria, a Gomulka in Polonia. Tragedie che testimoniano di quanto l’ebraismo fosse parte della sinistra anche al di là della cortina di ferro. Tuttavia il momento di profonda lacerazione tra sinistra e mondo ebraico avviene più avanti
Qual è questo momento di rottura?
Sono le due guerre dei Sei giorni nel ’67 e dello Yom Kippur nel ’73. Due guerre che si inscrivono totalmente nella contrapposizione bipolare di quegli anni tra campo comunista e campo occidentale. Per usare una espressione coniata di recente, quelle furono anche “guerre per procura”, perché dietro a Israele c’era il sostegno degli Stati Uniti e dietro ai paesi arabi c’era l’Urss. E in conseguenza del sostegno sovietico ai paesi arabi e ai palestinesi, anche tutta la sinistra mondiale si schierò dalla parte dei palestinesi. Lì si produce la lacerazione tra sinistra e mondo ebraico. Ci furono ebrei che in nome della fedeltà alla loro appartenenza, lasciarono i partiti della sinistra in cui militavano – il Pci, il Psi – e altri ebrei che in nome della loro militanza politica lasciarono la comunità ebraica. Fu un momento di lacerazione drammatica, denunciato da Umberto Terracini – uno dei fondatori del Pci con Togliatti e Gramsci – che si recò a Torino, a Milano, Roma, nelle città dove c’erano le comunità ebraiche più consistenti cercando di scongiurare quella rottura traumatica. Ed è in quel momento che si sono prodotti gli stereotipi, le rappresentazioni demonizzanti e i pregiudizi che arrivano ancora fino a noi nei confronti d’Israele. Quella lacerazione cancellò dalla memoria storica, collettiva, della sinistra tutto ciò che c’era stato prima, offuscando conoscenza e memoria di quel rapporto tra sinistra e mondo ebraico che invece dalla fine dell’Ottocento fino agli inizi degli anni’60 del Novecento era stato forte e solido. Nasce lì lo stereotipo d’Israele sentinella dell’imperialismo americano contrapposto alla volontà di riscatto di un mondo palestinese e arabo oppresso. Fino al punto da teorizzare una cosa che cozza con la verità della storia…
Vale a dire?
Che la nazione ebraica in quella terra sia una presenza estranea, imposta dall’occidente. Chiunque conosce e non manipola la storia, sa che da Mosè in avanti, quella è la terra dove il popolo ebraico ha sviluppato la sua storia, la sua civiltà, la sua religione. Rappresentare Israele come un corpo estraneo al Medio Oriente è un falso storico funzionale alla demonizzazione d’Israele. In quel contesto, va riconosciuto che ci fu un Partito comunista che – pur mantenendo atteggiamenti critici – decise di non rompere i rapporti con Israele ed è il Partito Comunista Italiano. Ricordo che in tutti i congressi del Pci di quegli anni, sempre tra i partiti esteri invitati vi erano formazioni politiche israeliane, oltre che dei palestinesi. Il Pci ha avuto questo merito, cioè quello di aver mantenuto aperto un filo di dialogo, anche quando il rapporto tra sinistra e mondo ebraico era turbato e ferito dalle vicende della storia. Poi nel 1982 la svolta…
A cosa si riferisce?
Alla guerra in Libano contro la quale si schierò una ampia parte di opinione pubblica israeliana e Shimon Peres promosse una grande manifestazione, rendendo evidente la esistenza in Israele di una dialettica democratica che contraddiceva la rappresentazione caricaturale di Israele come l’espressione dell’imperialismo. Quel fatto politico consentì alla sinistra italiana di rilanciare un rapporto con il mondo ebraico e Israele. E io e un gruppo di esponenti ebraici legati alla sinistra – ricordo Janiki Cingoli e Emanuele Fiano a Milano, Amos Luzzatto a Venezia, Ugo Caffaz a Firenze, Roberto Finzi a Bologna, Giorgio Gomel e il Martin Buber a Roma – aprimmo un dibattito su Israele e la sinistra. A Torino, come segretario del PCI, promossi un convegno dal titolo – per allora quasi “eretico” – “Medio Oriente: esiste anche una questione ebraica”. Era un fatto politico dirompente, perché fino a quel momento la sinistra riconosceva che c’era solo la questione palestinese. Affittammo in un albergo una sala per duecento persone. Ne arrivarono da tutta Italia più del triplo e c’era gente fin sulla strada. Esponenti del mondo ebraico che finalmente vedevano la possibilità di ricostruire e recuperare un rapporto con la propria appartenenza politica. E da quel momento in poi è decollato un intenso lavoro guidato da Giorgio Napolitano e da me. Insieme a Fiano, Cingoli e Furio Colombo fondammo “Sinistra per Israele” con la convinzione che solo riconquistando una lettura corretta di Israele e del mondo ebraico la sinistra avrebbe potuto dare un contributo ad una pace che desse soddisfazione anche alle aspirazioni del popolo palestinese. E poco dopo quegli eventi, entrato io nella segreteria nazionale del PCI, fui incaricato da Natta di coltivare i rapporti con il mondo ebraico italiano. Costruimmo un coordinamento con tutte le nostre presenze nelle varie comunità ebraiche. Demmo alle stampe perfino una piccola rivista “La quercia e il violino”, due simboli del mondo ebraico. Un lavoro che ebbe come culmine prima la visita di Napolitano in Israele, e poi di Occhetto con cui scegliemmo che prima missione internazionale del neonato PDS fosse in Israele e Palestina. Il Nuova partito era nato il 3 febbraio 1992 e noi il 29 aprile eravamo in Israele. Fu in quell’occasione che Occhetto, segretario nazionale del Pds, in un lectio all’Università di Tel Aviv, definí “il sionismo un movimento di liberazione nazionale e sociale del popolo ebraico che come tale va riconosciuto”.
Insomma, dopo la svolta della Bolognina, la svolta di Tel Aviv…
Tanto è vero che il giorno dopo i giornali israeliani uscirono a tutta pagina.
Che cosa c’è ancora fare, visto che dentro il mondo di sinistra il problema antisionista ancora esiste?
Esiste, ma molto meno. Tutta quell’azione che ho ricostruito ha fatto sì che posizioni di demonizzazione e di non riconoscimento d’Israele e del mondo ebraico, siano oggi nella sinistra assolutamente minoritarie. Non c’è alcun dubbio che il Partito Democratico sia schierato in modo chiaro per il pieno riconoscimento di cosa rappresenti Israele, politicamente e storicamente, naturalmente in una strategia politica che punta a favorire la soluzione “due popoli, due Stati”.
Soluzione che però continua a non realizzarsi….
Si, è un tema non ancora risolto. E lo è sulla base di un assunto che è connesso a quanto fin qui detto. Per un lungo periodo Israele restringeva la questione palestinese ad un problema di soli profughi. E reciprocamente i palestinesi e i Paesi arabi negavano a Israele il diritto di esistere. Uno scenario di reciproca negazione scandito in quarant’anni da cinque guerre (‘48,’56,’67, ‘73,’ 82) e numerose Intifada. In quello scenario le posizioni “pro palestinesi” e ostili a Israele erano fondate sull’assunto che in Terrasanta ci fosse una ragione, quella del popolo palestinese, e un torto, quello d’Israele. Mentre una soluzione “due popoli, due Stati”, non può che partire dall’assunto che in quella terra ci sono “due ragioni”: una ragione è l’aspirazione del popolo palestinese ad avere una patria. Ed è una ragione altrettanto fondata il diritto di Israele di vivere riconosciuto e in sicurezza. Ed è l’assunto su cui venne convocata nel 1991 la Conferenza di pace di Madrid – in cui per la prima volta palestinesi e israeliani si riconobbero reciprocamente, sedendosi allo stesso tavolo – aprendo la strada agli accordi di Oslo-Washington e alla intesa sancita dalla stretta di mano tra Rabin e Arafat, sotto lo sguardo garante di Clinton. Purtroppo il decorrere del tempo, fattore decisivo in politica, ha finito per logorare quella fiducia reciproca indispensabile per portare a buon esito un negoziato di pace così impegnativo. E in questi anni abbiamo nuovamente conosciuto aspre contrapposizioni e conflitti come la crisi di Gaza di qualche mese fa e l’emergere di formazioni radicali estreme come Hamas. Cosí come sono tornate a farsi sentire in Israele voci che contestano la possibilità per i palestinesi di avere un proprio Stato. Se si vuole spezzare questa spirale occorre ripartire dal principio su cui fu fatto l’accordo del ’93: il reciproco riconoscimento. E in questa ottica, gli “Accordi di Abramo” tra Israele e alcuni paesi arabi – Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein – sono utili perché danno risposta alla domanda di riconoscimento e di sicurezza di Israele, creando un clima utile alla ripresa di un dialogo tra Israele e palestinesi, perché è solo da un loro negoziato diretto che può scaturire la pace
Tutto questo, per tornare e chiudere con l’Italia, non significa anche rimuovere completamente, sul piano politico, culturale, storico, ciò che ancora resta vivo del “lodo Moro”?
In gran parte l’Italia lo ha già fatto, Nel senso che il nostro paese vuole essere equivicino, non equidistante. Cioè crediamo fortemente che la soluzione sia soltanto quello di un riconoscimento reciproco dei protagonisti per realizzare la soluzione “due popoli, due Stati”. E l’Italia opera per quell’obiettivo. Il che significa superare definitivamente l’acritico terzomondismo che negli anni ’80 era forte in Italia e non soltanto a sinistra.


ISRAELE-PALESTINA E LA DOTTRINA GOODMAN
Oggi non esistono gli elementi per risolvere nel breve periodo il problema dell’Occupazione. Ma, contemporaneamente, non è sostenibile andare avanti con l’Occupazione come si è fatto negli ultimi decenni. Come uscirne?
Anna Momigliano , Il Mulino 30/11/2021
Si fa un gran parlare, in Israele, e nella stampa internazionale, della dottrina del «conflitto ridotto». In ebraico, tzimtzum hasikhsukh, cioè riduzione, o contrazione, del conflitto, ma in inglese l’hanno tradotto «shrinking the conflict», ristringere il conflitto, che trasmette più ottimismo. In realtà, è quanto di più lontano dall’ottimismo, e anche il nome rischia di essere fuorviante, perché l’approccio riguarda soltanto una parte del conflitto, l’Occupazione della Cisgiordania.
La dottrina del «conflitto ridotto» è stata messa appunto qualche anno fa da Micah Goodman, filosofo e intellettuale pubblico piuttosto noto in patria, autore di molti libri e ricercatore del Shalom Hartman Institute, però se ne sta parlando ora perché sembra essere stata sposata, almeno in parte, o almeno a parole, dal nuovo governo israeliano, il primo successivo all’era-Netanyahu, dove due leader diversissimi tra loro, il centrista Yair Lapid e il nazionalista Naftali Bennet, condividono la carica di primo ministro a rotazione, in una coalizione che include anche la sinistra (Meretz, Labor) e la Lista Araba Unita. Sia Lapid che Bennet hanno parlato di «conflitto ridotto» nei loro discorsi e Bennet, pare, avrebbe scelto Goodman come consigliere ufficioso.
L’idea è che oggi non esistono gli elementi per risolvere nel breve periodo il problema dell’Occupazione; ma, contemporaneamente, non è sostenibile andare avanti con l’Occupazione come si è fatto negli ultimi decenni. Se l’Occupazione della Cisgiordania non può essere smantellata nel breve, e se non può essere nemmeno congelata, o peggio ancora espansa e consolidata, allora non resta che ridurla ai minimi termini. Non risolvere il conflitto, cioè l’Occupazione, né normalizzarla, cioè proseguire nell’annessione di fatto, bensì «ristringerla».
È un approccio interessante – secondo me, più per i presupposti da cui parte che per le sue conclusioni – ma limitato, che sottovaluta l’impatto di alcuni elementi, specie dal punto di vista dei palestinesi. Un’altra questione è poi l’applicazione che ne voglia davvero fare il governo israeliano. Qui sotto proverò a partire dalle premesse storiche e strategiche della dottrina-Goodman, per poi approfondirne i contenuti, analizzarne i punti di forza e le fragilità intrinsechi, e infine aggiungere una valutazione su come potrebbero essere applicate (o non applicate) nelle attuali condizioni politiche.
Il contesto storico e strategico. Dal 1967, Israele mantiene un’occupazione militare e la presenza di insediamenti civili nella Cisgiordania, o West Bank, dove abitano quasi tre milioni di palestinesi e circa mezzo milione di coloni israeliani (fino al 2005 manteneva un’occupazione analoga della Striscia di Gaza, su cui continua a imporre un blocco dei confini, insieme all’Egitto, e navale). Sebbene i palestinesi di Cisgiordania godano di qualche forma di autonomia, specie nella cosiddetta «area A» sotto il controllo dell’Autorità palestinese (Anp), questo di fatto significa che Israele ha il controllo sulla vita di milioni di persone che cittadini israeliani non sono, controllandone la libertà di movimento, e imponendo la presenza e le azioni delle sue forze di sicurezza. L’Occupazione potrebbe essere descritta come il controllo da parte di un governo di una popolazione che quel governo non ha la possibilità di eleggerlo.
Non c’è bisogno di essere fini analisti politici, né particolarmente filo-palestinesi, per capire che lo status quo è ingiusto. A rigor di logica, se ne esce in due modi: o Israele ritira la sua presenza militare dalla Cisgiordania (la formula «due popoli e due Stati» alla base del tentato processo di pace negli anni Novanta), o si estendono i diritti civili ai palestinesi (la cosiddetta «soluzione binazionale»). Quello che è successo sul campo, però, è un’altra cosa: negli ultimi decenni Israele ha consolidato l’Occupazione in quella che ha molti crismi, se non tutti, di un’annessione di fatto. La popolazione dei coloni è cresciuta e la loro presenza è stata normalizzata e integrata nella società israeliana. Dettaglio non piccolo, i coloni possono votare alle elezioni israeliane, nonostante Israele non abbia procedure per il voto all’estero, salvo per i diplomatici, e questo rende l’idea di come, sebbene non sia stata annessa, la Cisgiordania non sia neppure considerata propriamente «altro» dal territorio israeliano (detto con parole diverse, un comune cittadino israeliano non può votare da Londra, ma dalla West Bank sì). Uno dei risultati è che nello stesso territorio convivono due popolazioni, di cui soltanto una è coinvolta nel processo democratico per eleggere chi quel territorio di fatto lo controlla.
Per un certo periodo c’è stato nel panorama politico e culturale israeliano un blocco, prevalentemente di sinistra, che invocava il ritiro dai Territori, se non nel breve, almeno nel medio periodo, con diverse argomentazioni: etica, demografica, diplomatica e di sicurezza. L’argomentazione etica sosteneva che il dominio di un altro popolo è moralmente sbagliato. Quella demografica sosteneva che, col passare del tempo, l’Occupazione si sarebbe trasformata in un’annessione, e che dunque Israele si sarebbe trovata con un territorio dove i palestinesi sono la maggioranza, e due possibilità: concedere la cittadinanza a tre milioni di palestinesi, diventando uno stato binazionale democratico, o diventare, esplicitamente, un Paese non democratico, dove la maggioranza non ha diritto di voto. In altre parole, l’Occupazione rappresenterebbe la fine di Israele come Stato ebraico e democratico. L’argomentazione diplomatica sosteneva che l’Occupazione avrebbe spinto la comunità internazionale a isolare Israele, proprio come aveva fatto col Sudafrica negli anni Ottanta, con danni enormi per l’economia. L’argomentazione della sicurezza, infine, sosteneva che, a furia di opprimere i palestinesi, Israele si sarebbe ritrovato con una terza Intifada.
E il campo pro-Occupazione? A parole, persino Netanyahu dichiarò di sostenere la soluzione «due popoli, due Stati», ma nei fatti sappiamo bene che non fu così e che la sua destra ha fatto dello status quo un obiettivo. Chi, a parole o nei fatti, sostiene la necessità di continuare l’occupazione, lo ha fatto con tre argomenti, separati ma sovrapponibili. C’è la motivazione religioso-ideologica, il mito della Grande Israele, che vede nella West Bank un diritto del popolo ebraico e, come tutte le posizioni graniticamente religiose e ideologiche, non dà rilevanza ad altri argomenti. C’è la motivazione di sicurezza, per cui se Israele si ritirasse dai Territori diventerebbe più vulnerabile agli attacchi palestinesi. C’è poi una certa attitudine verso il dossier democrazia: da un lato, un autoconvincersi che non è vero che l’Occupazione costituisce un deficit di democrazia, perché Israele non ha mica annesso la Cisgiordania, e i palestinesi sono governati dall’Anp; dall’altro, il sottotesto che, se anche ci fosse, il deficit di democrazia non sarebbe poi così un problema; del resto non si può avere tutto.
Goodman, il filosofo, sostiene che hanno ragione sia la destra sia la sinistra, ma su cose diverse. La destra, dice, ha ragione sulla sicurezza e sulla diplomazia, mentre la sinistra ha ragione sull’etica, sulla demografia, e su una visione del futuro a lungo termine.
I due principali incentivi che potrebbero spingere Israele a un ritiro – il rischio di una terza intifada in Cisgiordania e la pressione internazionale – non si stanno concretizzando
La storia recente, nella visione di Goodman, dimostrerebbe che quando Israele si ritira da un Territorio occupato, quello che ottiene è meno sicurezza, non più sicurezza, come è successo dopo il disimpegno da Gaza nel 2005. Oggi a Gaza c’è Hamas, e da lì partono i razzi sulla popolazione israeliana, a cui Israele risponde peraltro con bombardamenti ben più letali, mentre sul confine con la Cisgiordania, dove l’Occupazione prosegue, la situazione è relativamente tranquilla. Inoltre, è evidente che le pressioni della comunità internazionale non hanno avuto un impatto tale da mettere in difficoltà l’economia israeliana. Insomma, i due principali incentivi che potrebbero spingere Israele a un ritiro – il rischio di una terza intifada in Cisgiordania e la pressione internazionale – non si stanno concretizzando.
La destra però sbaglia di grosso, secondo il filosofo, perché non coglie, o finge di non vedere, il deficit democratico intrinseco all’Occupazione e le conseguenze pratiche che rischia di avere. «Stiamo derubando un’altra nazione della sua libertà, e questo non è etico, non è ebraico e non è eppure sionista, perché il sionismo nasce dal principio dell’autodeterminazione dei popoli», ha detto in una delle sue lezioni. L’Occupazione non è solo sbagliata e antidemocratica, prosegue, ma alla lunga finirà per diventare una minaccia strategica. «Cosa succede se andiamo avanti con lo status quo nella Cisgiordania? Che con ogni probabilità l’Anp collasserà, e tre milioni di palestinesi saranno assorbiti in Israele e diventeremo uno Stato binazionale», dice Goodman, convinto che uno Stato binazionale tra due popolazioni ostili è di per sé pericoloso, e che porta Libano e Bosnia come esempi di «un esperimento finito male».
Se lo status quo non può essere smantellato ma neppure mantenuto, allora va «ridotto», ma come? Goodman suggerisce otto punti. Uno: garantire ai palestinesi libertà di movimento all’interno dell’Anp, costruendo strade che permettano di bypassare le aree a maggioranza ebraica, e dunque i checkpoint. Due: ampliare l’area A, quella dove i palestinesi hanno maggiore autonomia. Tre: facilitare il movimento dei palestinesi verso l’estero. Quattro: facilitare l’ingresso in Israele per ragioni di lavoro. Cinque: allocare terreni dell’area C, quella a maggiore controllo israeliano, ad attività commerciali palestinesi. Sei: nessuna espansione degli insediamenti, al di fuori dei grandi blocchi già a maggioranza ebraica. Sette: favorire il commercio internazionale. E, otto: fine della gestione israeliana delle imposte palestinesi.
I più critici dicono che è una foglia di fico. Un’Occupazione dal volto umano, questo il ragionamento, permetterebbe a Israele di mantenere la sua presenza in Cisgiordania, allora tanto vale lo status quo. Però questa obiezione non tiene conto del fatto che la tendenza attuale è di espansione continua delle colonie, e che se non viene fermata porterà a un punto di non ritorno. «Rimpicciolire» l’Occupazione è necessario non solo per renderla più tollerabile ma, soprattutto, per mantenerla reversibile.
La dottrina Goodman ha però ben altre debolezze. Per esempio, sottovaluta il peso della crisi a Gaza, dove la situazione è così tesa che rischia di fare saltare tutto. Poi, respinge di default la soluzione binazionale, quasi senza farsi domande. Il filosofo sembra ignorare, o non prendere sul serio, che alcuni palestinesi cominciano a vedere la loro lotta in termini più di diritti civili che di liberazione nazionale: visto che l’annessione-di-fatto c’è, conviene loro puntare a uno stato binazionale che dove presto sarebbero la maggioranza.
Infine, c’è il fermo dell’espansione degli insediamenti, che dovrebbe essere il cardine principale di un piano per indebolire l’Occupazione. Goodman in realtà propone di fermare l’espansione al di là dei blocchi urbani principali, e già su questo si potrebbe avere qualcosa da opinare. Ma la vera domanda riguarda l’intenzione di questo governo. La coalizione guidata da Bennet e da Lapid è composta anche da partiti che rappresentano gli insediamenti, e lo stesso Bennet è vicino a una parte dei coloni: davvero è pensabile metta loro un freno? Il rischio, insomma, è che l’esecutivo prenda solo gli aspetti più facili della dottrina-Goodman, qualche strada in più e qualche checkpoint in meno, ignorando il punto principale, il congelamento degli insediamenti. Senza quello, non c’è nessun vero ridimensionamento, e ogni mossa sarebbe davvero una foglia di fico.
Anna Momigliano


AMOS LUZZATO(1928-2020)
Bruno Segre Il Mulino 7 Dicembre 2021
In Italia i rabbini scrivono spesso articoli in cui denunziano le condizioni critiche delle comunità ebraiche. L’andamento demografico dell’ebraismo italiano – lamentano quei testi – è inquietante, caratterizzato dal rovinoso calo del numero degli iscritti e dalla scomparsa, a quanto pare irreversibile, di varie comunità minori. Con questo trend, affermano i rabbini, nel giro di pochi anni saranno progressivamente ridotte all’osso anche le due comunità maggiori, Roma e Milano. A tali denunce si accompagnano vigorose filippiche che rivelano, negli scriventi, una patetica nostalgia per «il mondo di ieri». Vi si prendono di mira, in particolare, i matrimoni misti, sempre più numerosi, la scarsa osservanza delle mitzwot e la generale tendenza di molti ebrei ad assimilarsi agli usi e ai costumi dei goyim. Il declino delle comunità italiane viene generalmente letto dai nostri rabbini nel segno di un deprimente pessimismo conservatore.
Rileggo gli scritti di Amos Luzzatto a distanza di un anno dalla scomparsa. E il suo pensiero, se lo paragono a quello attuale dei rabbini, mi appare decisamente più moderno, più equilibrato, più calato nel mondo e nei suoi problemi, e più aperto a orizzonti di speranza nel futuro. In un saggio pubblicato nel 2003, intitolato Il posto degli ebrei e dedicato fra l’altro a individuare le possibili vie che la costruzione della nuova Europa aveva allora dinanzi a sé, Luzzatto scriveva:
«L’Europa deve essere aperta e inclusiva delle culture e delle confessioni di minoranza, nella consapevolezza che queste ultime presentano una costante crescita per numero e per importanza … Se l’Europa deve aspirare a essere un fenomeno nuovo che nasce all’insegna del superamento di un passato di sopraffazioni, di lacrime e di sangue, allora deve essere soprattutto la patria di tutti coloro che la abitano e che intendono abitarla, portandovi una sintesi tra culture, religioni, lingue e costumi di vita diversi, all’insegna del rispetto reciproco».
Nato in una famiglia di antica tradizione ebraica, cacciato a dieci anni dalle scuole italiane in seguito alle leggi fasciste sulla «difesa della razza», costretto nel 1939 a emigrare nella Palestina mandataria con la madre e i nonni Lattes, rientrato in Italia dopo la fine della guerra, iscritto al Partito comunista dal 1946, impegnato per più di quarant’anni quale chirurgo in svariati ospedali, eletto presidente dell’Unione della Comunità ebraiche italiane per due mandati, dal 1998 all’inizio del 2006 – cioè in un periodo di impervia transizione, con la nuova destra postfascista al potere a Palazzo Chigi e un quadro politico nazionale e internazionale gravido di rischi –, Amos Luzzatto fu l’autorevole dirigente ebreo che nel 2003 si assunse la responsabilità di scortare il postfascista Gianfranco Fini nella sua storica visita allo Yad Vashem di Gerusalemme.
Nel 2008 la rivista di vita e cultura ebraica «Keshet», che dirigevo, celebrò l’ottantesimo compleanno di Amos dedicandogli un corposo Festschrift. Nelle pagine di apertura, quel fascicolo conteneva una calorosa lettera intitolata «Amos visto da vicino», nella quale Alisa, Gadi e Michele, i tre figlioli di Amos e Laura, scrivevano fra l’altro:
«Anche quando eravamo bambini Amos non è mai stato un uomo “privato”, chiuso nell’orizzonte della famiglia e della sua vita […] Amos si è sempre occupato attivamente di politica, ha fatto il chirurgo, non come un mestiere ma come un’avventura intellettuale e umana, ha continuato a studiare l’ebraismo anche in periodi in cui non era proprio di moda e poteva essere scomodo farlo in certi ambienti. Nel frattempo scriveva racconti, per bambini e per grandi, studiava matematica […] Come filo rosso, costante su tutto, Amos ha sempre tenuto la cultura al primo posto».
In coincidenza con l’ottantesimo compleanno, Amos stesso diede alle stampe nel 2008 l’autobiografia Conta e racconta (un titolo che si rifà a un versetto del libro di Daniele, «fai il tuo bilancio e parlane»), con il significativo sottotitolo Memorie di un ebreo di sinistra. Pubblicata a tre anni di distanza dalle dimissioni dalla presidenza dell’Ucei, quest’opera ha il grande pregio di restituirci un ampio quadro delle riflessioni che Luzzatto stesso ebbe a fare circa il proprio impegno nella vita pubblica italiana e nell’ambito della cultura degli ebrei.
«Mi dichiaro di sinistra», spiegava Amos, «e sostengo che si debba promuovere una cultura di sinistra, non certo un’ideologia. E mi dichiaro al tempo stesso ebreo; certo, non un ebreo ortodosso, ma uno che è cresciuto immerso nello studio della cultura ebraica. E mi dichiaro al tempo stesso europeo. Perché l’Europa ha avuto la filosofia, il teatro, l’arte, la matematica e la scienza. E voglio e devo capire perché ha avuto anche le Crociate, l’Inquisizione, i roghi, la tratta degli schiavi dall’Africa, il nazismo».
Per quanto concerne l’impegno in ambito ebraico, Luzzatto dichiarava di averlo perseguito essendo influenzato da più fattori indipendenti fra loro, ma in particolare dall’esigenza di comprendere meglio la sua stessa esperienza palestinese, quell’ebraismo che vi si era formato «con quel carattere non ortodosso, non sefardita, laico […] Intensificare i rapporti con Israele – chiariva Amos in Conta e racconta – significava e significa necessariamente entrare nell’ottica del pluralismo che non respinge neppure un ebraismo cosiddetto laico».
Amos fu membro del Consiglio dell’Unione delle Comunità ebraiche per ben diciannove anni, dal 1986 al 2006, ivi compreso il periodo in cui ne fu il presidente. Sosteneva di avere fatto, in tale veste, il suo lavoro «senza cercare di imporre una linea di parte, consapevole di rappresentare la totalità dell’ebraismo italiano». Così, quando assunse la presidenza succedendo a Tullia Zevi, volle definirne il carattere presentando una sua breve linea programmatica, articolata con equilibrio lungo tre assi che, in senso lato, si potevano ben qualificare come «politici».
Vi si affermava in primo luogo la necessità di una presenza pubblica dell’ebraismo in Italia, nella nostra società civile, «per sostenere le ragioni di uno Stato laico, equanime nei confronti di tutte le sue minoranze, religiose, linguistiche, di recente immigrazione; nessuna identificazione con precisi schieramenti politici ma apertura al confronto con tutti, con l’unica pregiudiziale del nostro antifascismo». In secondo luogo vi si sosteneva l’importanza di promuovere la cultura e la conoscenza della lingua ebraica, unitamente a un intenso rapporto con lo Stato d’Israele. E, in terzo luogo, vi si sottolineava la necessità di potenziare «il dialogo interreligioso, affrontando con civile dignità una serie di problemi ancora insoluti, malgrado l’indiscutibile innovazione portata dal Concilio Vaticano II, e parlando con il mondo musulmano dove le riserve politiche condizionano troppo spesso le relazioni religiose».
Nel frattempo Luzzatto non mancava di prendere parte di persona a iniziative di dialogo, soprattutto a quelle dette «interconfessionali» quali il Sae, l’Amicizia ebraico-cristiana, il Colloquio cristiano-ebraico di Camaldoli; e poi alle iniziative della Comunità di Sant’Egidio nonché a iniziative squisitamente culturali quali quelle promosse da «Biblia».
In una lettera scritta nel 2001 al pastore luterano Jürg Kleeman, Amos affermava:
«Dobbiamo guardarci dall’errore di personificare, per così dire, le nostre religioni facendole diventare i “soggetti” del dialogo. I soggetti rimangono sempre, con tutti i loro limiti, le donne e gli uomini che si riconoscono in queste religioni… le “persone” in dialogo hanno bisogno di parlarsi per confessarsi reciprocamente i propri dubbi, i propri dilemmi, le contraddizioni che non sanno risolvere. Se lo fanno con sincerità, essi diventano amici e alla fine cercano la strada per aiutarsi l’uno con l’altro […] si domanderanno assieme perché c’è ancora tanta malvagità a questo mondo, perché ci si uccide, perché tanti cercano rifugio nella droga […] perché si glorificano ancora le divise militarti e le battaglie […] Pensiamo a Giobbe. Egli aveva tanti dubbi. I suoi amici non ne avevano affatto. Egli cercava il dialogo, i tre amici gli rispondevano con monologhi […] Ma alla fine del libro, Dio apprezza la sincerità di Giobbe».
A proposito del contributo offerto da Luzzatto alle sessioni estive del Sae, il compianto Gioachino Pistone rilevava:
«Amos è stato non solo un grande hakham (in ebraico: “sapiente, saggio”) ma anche un grande morè (in ebraico: “maestro”), senza rinunciare mai alla profondità del messaggio. Con le sue conferenze, con le sue meditazioni, con la partecipazione ai gruppi di lavoro, con i suoi interventi di cui è difficile dimenticare l’acutezza e la ricchezza, unite alla chiarezza cristallina, Amos non solo ha trasmesso alle generazioni di cristiani che si sono succedute al Sae dei contenuti di conoscenza fondamentali ma – cosa che credo ancora più importante – ha insegnato loro a guardare e a rapportarsi in modo diverso al popolo d’Israele e a tutto ciò che lo rappresenta e lo definisce».
Nei primi anni di Luzzatto alla presidenza dell’Ucei, si tenne a Roma il primo gay pride italiano: un evento nel corso del quale vi furono pressioni perché il corteo non si avvicinasse troppo alle mura vaticane. In quella circostanza Amos – incurante di chi gli ricordava che l’omosessualità è condannata dalla Torà – insistette perché l’Ucei sostenesse senza mezzi termini i diritti degli omosessuali: minoranza irrisa, emarginata, assassinata anch’essa ad Auschwitz («noi con il triangolo giallo, voi con il triangolo rosa»). Secondo Luzzatto, il diritto a manifestare pacificamente, quando e dove avessero voluto, nel rispetto della Legge e all’interno del territorio gestito dalle autorità italiane, doveva essere sostenuto quale diritto irrinunciabile per i gay, come pure per altre minoranze quale sarebbe potuta essere quella ebraica, per ribadire la stessa laicità dello Stato come valore comune.
Un capitolo di Conta e racconta (intitolato La politica degli ebrei, gli ebrei nella politica) illustra in modo argomentato il senso che Luzzatto intendeva dare al suo impegnarsi di persona, in quanto ebreo, nella vita pubblica italiana. «Ho spesso detto – scriveva Amos – che anche se gli ebrei non vanno dalla politica, è la politica che va dagli ebrei (e non solo dagli ebrei) […] L’errore – proseguiva – non è quello di “fare politica”, semmai è quello di far coincidere le istituzioni ebraiche con un preciso schieramento politico che venga proclamato “il miglior amico degli ebrei”, generalmente sulla base di un’autentica autocertificazione». Richiamati, poi, alcuni temi politici che a suo parere sono di spiccato interesse ebraico, e precisamente: la laicità dello Stato, la democrazia, i diritti delle minoranze, il ripudio della violenza, la promozione della cultura, Amos rilevava che «istituzioni rappresentative pubbliche, come le nostre Comunità o la loro Unione, che si proclamano pluraliste (e anche unitarie, che non significa la stessa cosa di maggioritarie), dovrebbero essere rappresentate con modalità, forme e contenuti largamente condivisi, sempre nel rispetto dei principi qui enunciati». E infine, ricorrendo a parole profondamente meditate, che sottintendevano sofferti interrogativi, Amos dichiarava: «ho cercato di farlo con tutte le mie forze. Può darsi che non sempre ci sia riuscito, ma ho impegnato in questo sforzo tutta la mia attività in sette anni di presidenza, contro coloro che cercavano in tutti i modi di spingermi ad abbracciare posizioni di parte».
Nel ricordare qui con voi la vicenda di Amos Luzzatto alla testa della massima istituzione ebraica italiana, temo di non poter confermare che egli sia riuscito, al di là delle sue migliori intenzioni, a trasformare l’Ucei in uno strumento capace di guidare il piccolo rissoso mondo degli ebrei italiani verso quei valori che egli riteneva dovessero stare al centro dell’azione e degli interessi del nostro ebraismo. Sugli ultimi burrascosi mesi della sua presidenza, dal settembre 2005 al febbraio 2006, e sulle circostanze che lo indussero a dimettersi, sarebbe inutile cercare in Conta e racconta qualche cenno chiarificatore.
Per comprendere il dramma che Luzzatto visse in quel periodo, occorre tenere conto del fatto che la sua cultura politica era quella di un uomo formatosi negli anni dell’immediato dopoguerra, nella temperie culturale dettata da quella élite che fece nascere e crescere l’Italia repubblicana, contribuendo a dotarla di una Carta costituzionale per molti versi splendida e muovendosi all’interno del cosiddetto «paradigma antifascista e resistenziale». Durante la Resistenza e negli anni del dopoguerra, molti furono nel nostro Paese gli ebrei che tennero fede alla solidarietà antifascista militando nei vari partiti, in particolare in quelli della sinistra e in quelli laici che, assieme alla Democrazia cristiana, facevano allora parte dell’arco costituzionale.
Durante la Resistenza e negli anni del dopoguerra, molti furono nel nostro Paese gli ebrei che tennero fede alla solidarietà antifascista militando nei vari partiti, in particolare in quelli della sinistra e in quelli laici
Ma con il collasso e la scomparsa dell’Unione Sovietica, nel 1989, con la fine della Guerra fredda e la conseguente crisi della Prima Repubblica, vennero emergendo in un ruolo protagonista nuove formazioni politiche, quali la Lega e Forza Italia, estranee alla vicenda storica dell’antifascismo o addirittura, come nel caso di Alleanza nazionale, affondanti le radici nelle vicende storiche e nei valori dello stesso regime fascista. Fin dal loro sorgere, queste nuove forze dimostrarono d’avere inteso chiaramente quanto la storia e la memoria possano essere formidabili strumenti di lotta politica e ideale. Perciò, sfruttando anche con maestria il circuito tra media e politica, avviarono una spregiudicata e martellante «guerra della memoria», tesa a operare un profondo spostamento del clima civile, culturale e politico del Paese, e a spianare la strada al post-fascismo con la diffusione presso la pubblica opinione di un giudizio edulcorato e assolutorio dell’avventura fascista, e mediante la contestuale messa sotto accusa della Resistenza, considerata colpevole di troppi eccessi e soprattutto d’avere legittimato i comunisti. «L’antifascismo è un mito incapacitante» della storia italiana, ebbe a dichiarare in quel periodo il berlusconiano Marcello Pera quand’era presidente del Senato. Vi fu persino uno storico di vaglia, come Renzo De Felice che, dedicando l’ultimo periodo della sua vita a una tenace battaglia per superare il paradigma antifascista, propose un’implicita riabilitazione di Mussolini affermando, fra l’altro, che il suo regime rimase «al di fuori del cono d’ombra dell’Olocausto» e «come non fu razzista, non fu nemmeno antisemita».
L’eredità che vari anni di guerra della memoria lasciarono dietro di sé in Italia consistette in un profondo cambiamento dello spirito pubblico, frutto di una vera e propria «frattura delle memorie» e di una diffusa amnesia collettiva: fenomeni che – agevolati dalla progressiva scomparsa dei sopravvissuti e dei testimoni della persecuzione nazifascista – investirono anche il piccolo mondo degli ebrei, in nulla diversi da tutti gli altri italiani.
L’eredità che vari anni di guerra della memoria lasciarono dietro di sé in Italia consistette in un profondo cambiamento dello spirito pubblico, frutto di una vera e propria “frattura delle memorie” e di una diffusa amnesia collettiva
Così la galassia politica delle destre, con la quale Amos Luzzatto si dovette confrontare nella veste di presidente dell’Ucei, destinò all’oblio il paradigma antifascista sostituendolo con due altri paradigmi, quello anticomunista e quello antislamico: paradigmi che, assunti quali stelle polari anche dall’establishment di destra che da vari decenni andava governando lo Stato d’Israele, non per caso risultarono andare a genio alla maggioranza degli ebrei italiani, in particolare agli ebrei che egemonizzano la Comunità di Roma.
Fu dunque un ruolo ufficiale improbo, particolarmente ostico, quello che Amos, «ebreo di sinistra», si trovò a svolgere nell’Italia politica di quegli anni, esponendosi ad attacchi colmi di veleno provenienti da ogni parte, ma in particolare dall’interno della stessa comunità ebraica, attestata ormai in larga maggioranza su posizioni di destra.
Fedele alla sua cultura politica, Luzzatto si sforzò con lucido impegno di porre al centro dell’azione e degli interessi della massima istituzione del nostro ebraismo temi quali la laicità dello Stato, la democrazia, i diritti delle minoranze, il ripudio della violenza, la promozione della cultura. Ma il momento storico non era più tale da consentire che un simile impegno potesse svilupparsi con successo.
Mi accade ora dunque, come rammentavo all’inizio, di ritrovarmi al cospetto del cupo, chiuso pessimismo con il quale i rabbini assistono, apparentemente impotenti, al progressivo declino del nostro piccolo mondo. E tuttavia, il fare qui con voi memoria dell’alta figura e della lezione mirabile di Amos Luzzatto, mi induce a credere che sapremo reagire all’amnesia collettiva e al mediocre provincialismo autoreferenziale che da qualche decennio ci stanno ottundendo, e che riusciremo prima o poi a recuperare con orgoglio quella variegata creatività culturale che il mondo ebraico ha saputo, anche in Italia, storicamente produrre.
[Questo testo riproduce l’intervento tenuto dall’autore il 6 dicembre 2021 al XLI Colloquio ebraico-cristiano di Camaldoli.]
Bruno Segre


Colum McCann: “Vi racconto la pace tra un arabo e un israeliano”
di Andrea Bajani – Repubblica 21 Maggio 2021
La guerra non è l’unica scelta possibile. Come dimostra l’amicizia di Bassam e Rami, protagonisti reali del nuovo libro dell’autore irlandese. E di questo colloquio a distanza tra due scrittori sul potere delle storie
HOUSTON (Texas). Inizia tutto con un volo, e ancora non so che quella perdita dell’equilibrio diventerà il baricentro di quel che ci diremo. Ma è un fatto che da dentro il computer portatile in cui sto parlando con Colum McCann, di colpo decollo, vedo il soffitto della sua casa newyorkese, poi i pensili di una cucina, e lui che sorridendo mi poggia accanto al bollitore e si prepara un tè. Poco dopo prende la tazza con una mano e con l’altra il computer dentro cui ancora fluttua la mia faccia, e torniamo nel suo studio. Ed è così che finalmente ci parliamo, due scrittori europei ai due estremi dell’America.
Il volo di cui parliamo poco dopo cambia il tono alla conversazione. Sono gli aerei israeliani sopra la striscia di Gaza da cui piovono bombe, e i razzi di Hamas che in questi stessi istanti spaccano i cieli d’Israele. Tra le due traiettorie, le persone restano a terra senza vita. Colum McCann ha da poco pubblicato il suo nuovo romanzo, Apeirogon (Feltrinelli, traduzione di Marinella Magrì), al cui cuore c’è la stessa storia, quello stesso incendio che non smette mai di bruciare in Medio Oriente, visto con gli occhi di una pace impossibile, possibile nella condivisione delle storie. Rami e Bassam, due uomini sulle due sponde del conflitto, in comune la perdita di due figlie, Smadar e Abir, uccise da uno scontro che non finisce mai.
Abir (a sinistra), figlia del palestinese Bassam Aramin, uccisa a dieci anni da un proiettile israeliano fuori dalla sua scuola in Cisgiordania, e Smadar, israeliana, figlia di Rami Elhana, uccisa a 14 anni in un attentato suicida mentre faceva shopping con i suoi amici a Gerusalemme. L’attentatore era palestinese
“Abbiamo letto troppe volte notizie come queste” mi dice mentre si sistema sulla sedia, i libri impilati alle sue spalle in uno dei tanti set pandemici con cui abbiamo imparato a nostre spese l’arte della messa in scena. Il viso gli si raccoglie dentro una specie di sconfitta. “La storia purtroppo si ripete. Sappiamo già cosa diranno gli uni e che cosa diranno gli altri, e poi anche tutto il resto”. Il sentimento che lo prende è un misto tra la stanchezza, la rabbia, è una forma di estenuazione. La foresta non smette di bruciare da decenni, non è un incendio scoppiato a metà maggio, più spesso brucia da sola, ignorata, insieme a chi ci vive dentro. “Mi chiedo solo quando succederà che una nuova Greta Thunberg uscirà da scuola e comincerà a raccontare in un modo che sarà impossibile non ascoltare”.
L’ascolto è la parola chiave. “John Berger, che ha dedicato molta della sua vita al vedere, diceva che serviva un nuovo modo di ascoltare”. La letteratura si fonda su questo. C’è qualcuno che racconta una storia, e qualcuno che gli apre la porta e lo fa accomodare. E chi racconta non deve smettere mai di farlo. Ciascuno sa che questo comporta un rischio: chi racconta si espone, chi apre la porta contempla la possibilità che chi entra metta in disordine la casa. “Il rischio e il disordine sono due parole fondamentali”, mi dice sfogliando un libro in cerca di una citazione. Intanto New York entra nell’appartamento e nel microfono di Colum, il numero di clacson sembra dire una città ritornata a cento all’ora. La freddezza morbosa dei dispacci di questi giorni parla di traffico aereo chiuso su Tel Aviv, città in lockdown, barricate, fuochi appiccati alle auto e alle case. E di decine di bambini già uccisi, quando anche uno sarebbe già uno di troppo. “Cosa si può fare quando muore un bambino?” si chiede Colum McCann. “La lezione di Rami e Bassam è l’unica possibile: non smettere mai di raccontare la loro storia, la storia di Smadar e Abir”.
Le emozioni sono pericolose
Poco meno di dieci anni fa, insieme a Lisa Consiglio, Colum McCann ha fondato Narrative 4, un’organizzazione ormai diventata una realtà importante, che riunisce attori diversi, artisti, avvocati, attivisti. Si basa su un principio basico: scambiarsi le storie è l’unico modo per reagire. Decine di progetti in tutto il mondo, scambi tra ragazzi che condividono le proprie storie a distanza. “Il punto, per me, non è andare in Israele o nei Territori occupati a cambiare le cose. Il punto è far sì che ragazzi israeliani o palestinesi si raccontino ai coetanei in Kentucky o Algeria, ascoltino le storie altrui, e che poi tornino a casa. L’importante è tornare a casa cambiati dopo aver incontrato la storia di un altro”.
Narrative 4 e la scrittura sono i due versanti su cui McCann si muove, come cittadino e come autore: non a caso fu volando a Gerusalemme con la sua organizzazione che entrò in contatto con Rami e Bassam, a cui poi aprì le porte del romanzo che sarebbe venuto. Lo strumento, sui due fronti, è comune: lasciar entrare l’altro, essere disposti a cambiare il proprio punto di vista. L’empatia è il mezzo: farsi raccontare la storia da un altro, e poi restituirgliela. “Eppure l’emozione non basta, da sola. L’emozione va trasformata in azione. Senza l’azione l’emozione è molto pericolosa”.
Con i suoi 1001 brevi capitoli, Apeirogon, è la monumentale messa in scena di quanto la letteratura può fare in questo caso. Accettare la complessità del mondo, e fare di quella complessità una visione. Lasciar fuori la semplificazione, costruire uno spazio in cui ospitare il casino, come direbbe Beckett. “Dovremmo accettare di dire “non lo so”, o “sono confuso””, quando ci troviamo di fronte all’incendio che divampa a Tel Aviv. Il “non lo so” come strumento primo di azione conoscitiva, letteraria, politica. “Tutti sanno sempre, hanno tutti una versione da fornire”. Invece che il celebre “Io so” pasoliniano, “Io non so”, e per questa specifica ragione mi metto in ascolto con tutto il corpo. Raccontami la tua storia e io ti racconterò la mia, ne usciremo sconvolti.

Apeirogon tiene insieme tutte queste storie, facendo divampare per frammenti il rovescio esatto di quell’incendio che brucia ogni cosa. In un caleidoscopio che tiene insieme l’istinto enciclopedico a dire tutto e l’amore più vivo per tutto ciò che è umano, Colum McCann ci consegna in qualche modo una pietra miliare. Non tanto di come si risolve il conflitto in Medio Oriente, ma di come si possano trasformare lo sconforto in processo di conoscenza, la sconfitta in azione, la letteratura in pratica d’emergenza.
“L’emergenza è fondamentale, ma non nel significato cui ci riferiamo comunemente. Pensa agli uccelli quando si mettono in volo, alla forma che descrivono quando sono tutti insieme in un volo migratorio”. Si tratta di sistemi complessi chiamati “comportamenti emergenti”: presi tutti insieme sono molto più della somma dei singoli uccelli nello stormo. Avviene qualcosa di inspiegabile e misterioso, che solo la scienza sa descrivere ma non sa spiegare del tutto. Una massa in movimento aumenta la potenza a dismisura. Uno stormo: l’inspiegabile moltiplicazione della forza.
Ottimismo della volontà
La luce del Texas rovescia troppa luce nello schermo, chiudo la tenda del mio studio. Ed è così che nella penombra che unisce Houston a New York, Colum e io voliamo in un cielo molto più grande, inseguendo stormi migratori. “Non so cosa dire quando leggo notizie come queste, e non riesco a pensare che ci sia una via d’uscita. Ma come direbbe Gramsci: sono un ottimista della volontà, e penso quindi che raccontare la propria storia, continuare a farla, sia la via da praticare”. Forse una storia che vola da sola non è sufficiente, anche cento forse non saranno abbastanza. Ma migliaia di storie che battono le ali nel cielo di Tel Aviv, che dicono il dolore e l’insensatezza, possono far succedere qualcosa di stupefacente.
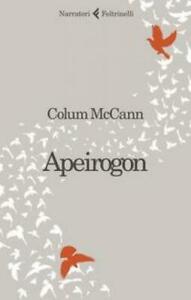

Egitto-Israele: pragmatismo al vertice
ISPI 14/09/2021
Il premier israeliano Naftali Bennett e il presidente egiziano Al Sisi si incontrano a Sharm el Sheikh. Un vertice che riflette il rapido cambiamento nelle prospettive bilaterali e regionali.
Per la prima volta in un decennio, un premier israeliano si reca in Egitto per una visita ufficiale. A interrompere dieci anni di ‘assenza’ è stato il nuovo primo ministro israeliano Naftali Bennett, che ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a Sharm el-Sheikh, sul Mar Rosso. Sul tavolo, le numerose questioni che agitano il Medio Oriente e che preoccupano il Cairo come Tel Aviv: la stabilità dell’area, la “minaccia” iraniana, il tracollo del Libano e il nodo di Gaza. L’enclave palestinese – isolata da Israele ed Egitto da quasi 15 anni, da quando è governata da Hamas – resta per Israele un problema costante. E che affonda sul nascere ogni speranza di un rilancio del processo di pace con i palestinesi, fermo dal 2014. Ma la spinta per ricucire un filo esile ma inevitabile di rapporti poggia anche sui comuni interessi: dal contenimento del radicalismo ed estremismo islamico, alle rotte del gas e dell’energia. Ieri alle spalle dei due leader svettavano, allineate, le bandiere dei rispettivi paesi. Un passo avanti nel processo di ‘normalizzazione’ in corso da qualche anno tra lo stato ebraico e i paesi della regione. Nelle scorse settimane era stata la volta di altri incontri di livello tra il ministro della Difesa Benny Gantz e il sovrano Abdallah di Giordania e lo stesso Gantz e il premier palestinese Mahmud Abbas. Qualcosa, forse poco, sembra muoversi davvero.
| Un decennio di alti e bassi? |
| L’ultimo premier israeliano a visitare l’Egitto nel gennaio 2011 era stato Benjamin Netanyahu. All’epoca, ricorda Radio France Internationale (Rfi), “le televisioni egiziane coprirono l’evento con un servizio breve, fatto di immagini quasi subliminali di due uomini tesi”. Pochi giorni dopo, le proteste di piazza avrebbero rovesciato il trentennale regno di Hosni Mubarak, e inaugurato un decennio turbolento, durante il quale i rapporti tra i due paesi hanno visto alti e bassi. In mezzo c’è stata l’ascesa dei Fratelli Musulmani al Cairo, il golpe militare di Al Sisi, l’Intifada del 2015, innumerevoli violazioni di cessate-il-fuoco e ben due guerre contro Gaza, quella del 2014 e quella del maggio scorso. Anche se in definitiva le relazioni degli ultimi anni sono state segnate soprattutto dalla cooperazione in materia di sicurezza, e in particolare dalla lotta ai gruppi terroristici nel Sinai. L’Egitto – primo paese con cui Israele ha stipulato accordi di pace nel 1979 – e Israele hanno collaborato anche nel settore energetico: dal 2020 lo stato ebraico esporta in Egitto il proprio gas. Inoltre, l’Egitto ha svolto un ruolo chiave nel mediare diverse tregue tra Tel Aviv e il movimento islamico di Hamas a Gaza. Qualcosa è cambiato? Se fin qui si sono limitati alla cooperazione su temi di comune interesse, ora la volontà è quella di far fare ai rapporti bilaterali un salto di qualità come dimostrato dalla riapertura del valico di Taba attraverso cui turisti israeliani passano per trascorrere le loro vacanze sul versante egiziano, e l’inaugurazione, da ottobre, di voli diretti Egyptair tra Il Cairo e Tel Aviv. E se la cornice dell’incontro di Sharm el-Sheikh è la stessa di dieci anni fa – da anni gli eventi politici di peso in Egitto si tengono a Sharm anziché al Cairo, per questioni di sicurezza – tutto il resto o quasi sembra cambiato. “Israele si sta aprendo ai paesi della regione”, ha detto Bennett con riferimento agli accordi di Abramo inaugurati durante l’amministrazione Trump. Il fatto che dal 2020 quattro paesi arabi – Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Marocco e Sudan – abbiano normalizzato i legami con lo stato ebraico è stato un punto di svolta. E soprattutto, come osserva il politologo Mostafa Kamel al-Sayed, a differenza dell’era Mubarak, “il regime di Al Sisi è riuscito ad addomesticare l’opposizione” dopo una capillare campagna di repressione: oggi, dopo 19 mesi passati in carcere, lo studente egiziano iscritto all’università di Bologna, Patrick Zaki, è comparso davanti ai giudici di Mansura, cittadina a nord del Cairo. Rischia una condanna a cinque anni per reati minori. Pragmatismo vs Pace? “L’Egitto sostiene tutti gli sforzi volti a raggiungere una pace globale in Medio Oriente, sulla base della soluzione dei due stati e della legittimità internazionale” ha detto il portavoce della presidenza egiziana al termine dell’incontro. Ma nonostante le aspettative, le speranze di una ripresa del processo di pace restano lontane. Poche settimane fa Bennett aveva riaffermato la sua netta opposizione alla creazione di uno stato palestinese e ha detto di non vedere all’orizzonte “alcuna svolta politica” con i palestinesi. Per il premier israeliano, leader del partito della destra ebraica Yamina, se il conflitto non può essere risolto, comunque si può “ridurne la portata dell’attrito”: il suo governo ha già approvato permessi di lavoro per i palestinesi in Israele, autorizzazioni edilizie per i palestinesi in Cisgiordania e permessi di residenza per migliaia di persone. Su questo, i due governi si intendono: il deterioramento della situazione economica a Gaza preoccupa molto l’Egitto, che teme un’esplosione della rabbia palestinese vicino ai suoi confini. Il Cairo ha cercato di realizzare un piano di ricostruzione che ha incontrato molti ostacoli da parte del movimento di Hamas che controlla la Striscia. Il vertice di Sharm emana dunque barlumi di pragmatismo, forse, ma non di pace. E di ‘successi’ personali: per Bennett, che forgia il suo profilo di ‘statista’ e per Al sisi, che vede l’incontro come un modo per ritornare a svolgere il ruolo di mediatore e accreditarsi con Washington. “L’Egitto vede le relazioni con Israele e gli sforzi per ricostruire Gaza come un percorso verso la Casa Bianca”, osserva un funzionario israeliano ad Haaretz, aggiungendo che il Cairo “ne ha bisogno” per deviare la pressione internazionale sui suoi diritti umani. |
| IL COMMENTO di Ugo Tramballi, Senior Advisor ISPI |
| “Che questo fosse il primo incontro dopo dieci anni, non deve ingannare: fra Egitto e Israele i legami sono stretti. Almeno sul piano strategico, meno su quello economico; almeno fra le leadership dei due paesi: l’ultimo incontro fra Bibi Netanyahu e Hosni Mubarak, nel 2011, provocò grandi proteste fra un’opinione pubblica che non ha mai apprezzato la pace con Israele. Ma i contatti fra i governi sono sempre stati intensi, soprattutto riguardo al contenimento della striscia di Gaza. L’ombra di un disimpegno dal Medio Oriente dell’amministrazione Biden è forse una ragione dell’incontro di lunedì: più per l’Egitto che per Israele. Nessun presidente americano si disimpegnerà mai dallo stato ebraico. La brutalità del regime di al-Sisi, tollerata da Donald Trump, è invece insopportabile per Biden. Una conferma delle intese strategiche con Israele non può che far piacere agli Usa”. |


Israele/Palestina: risposte problematiche a scomode domande
Dialogo tra Bruno Segre , Gabriele Eschenazi, Luciano Belli Paci, Bruno Piperno Beer
Bruno Segre : “Inizio a scrivere queste note sul Vicino Oriente la sera dell’1 giugno. Mentre registro con inquietudine l’estrema liquidità della situazione, mi rendo conto che sto rischiando di mettere qui per iscritto riflessioni che ben presto potrebbero rivelarsi aleatorie.

Bruno Segre
Mi pongo innanzitutto un paio di scomode domande. Dopo le gravissime violenze che nel maggio scorso hanno insanguinato e devastato i territori di Israele/Palestina, è ipotizzabile che la piccola regione compresa tra il Giordano e il Mediterraneo riesca a riemergere dal caos nel quale sembra ormai irrimediabilmente sprofondata? E ancora, più specificamente, è ipotizzabile che le popolazioni arabo-palestinesi che vivono da decenni in condizioni di umiliante sottomissione traggano, proprio dalle recenti vicende, le energie per puntare con successo all’emancipazione?
Per rispondere a tali quesiti, getto lo sguardo nella nebbia che avvolge quell’intricato complicatissimo scenario socio-etno-politico, mettendomi di volta in volta occhiali palestinesi, occhiali israeliani, occhiali degli ebrei della diaspora, in particolare della diaspora nordamericana, occhiali di chi negli USA tiene attualmente in mano le leve del potere.
A Washington, da quando gli elettori hanno costretto Donald Trump ad abbandonare il proscenio, il clima politico sta cambiando. A fine maggio il potentissimo Senatore repubblicano-trumpiano James Risch, che presiede la Commissione senatoriale per le relazioni estere, tiene bloccati 75 milioni di dollari che l’amministrazione Biden ha destinato ad aiuti umanitari per la popolazione di Gaza. Ma un gruppo di 145 membri democratici della Camera dei Rappresentanti, capitanato da Jamie Raskin e composto dai portabandiera dei più vari orientamenti ideologici del partito democratico, gli indirizza una lettera per sollecitarlo a rendere disponibile con urgenza quel finanziamento. Si tratta di un sussidio, scrivono i Rappresentanti, “disperatamente necessario per sopperire ai bisogni di centinaia di migliaia di civili palestinesi che devono ricostruire le loro esistenze all’indomani dei combattimenti svoltisi all’inizio di questo mese fra Hamas e Israele.” Tra i firmatari figurano parlamentari di cui sono note le scarse simpatie verso Israele, come Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, accanto a politici tradizionalmente filoisraeliani come Ted Deutch, Kathy Manning e Debbie Wasserman Schultz. Il Presidente Hadar Susskind dell’associazione ‘Americani per Pace Adesso’ dichiara: “Siamo lieti di appoggiare l’iniziativa assunta dal Rappresentante Raskin ed esprimiamo tutta la nostra stima ai 145 politici che hanno sottoscritto il suo appello. Esigiamo con loro che il Senatore Risch sblocchi quel finanziamento senza indugi.”
Il mantenere buoni rapporti con la presidenza degli Stati Uniti (con qualsivoglia presidente) costituisce per Israele (qualsivoglia uomo politico sia alla testa del governo) la migliore ‘assicurazione’ per tutelarsi nei rapporti con il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con la Corte Criminale Internazionale dell’Aia, e anche nei negoziati in corso con l’Iran, che Israele può sperare di condizionare soltanto a patto di conservare con chi governa a Washington una relazione positiva.
Qual è stato il ruolo del governo USA nella recente guerra Israele-Hamas? Durante i primissimi giorni del conflitto il presidente Biden ha offerto a Netanyahu un sostegno significativo, vuoi in sede di Consiglio di Sicurezza opponendo per ben due volte il veto a risoluzioni di condanna di Israele per violazione dei diritti umani, vuoi dichiarando a più riprese che Israele “ha il diritto di difendersi qualora subisca attacchi terroristici.” Con l’assumere tali posizioni Biden si è esposto a pesanti critiche dall’interno del suo stesso partito. Fra i democratici infatti, che dispongono ora della maggioranza in entrambi i rami del Congresso, va acquisendo un peso sempre più rilevante un settore che, in tema di rapporti Israele-Stati Uniti, non è più disposto ad aderire supinamente al tradizionale consenso bipartitico pro-Israele. La pretesa, da parte di una società immobiliare di ebrei ultraortodossi, di allontanare con la forza i residenti palestinesi da alloggi del sobborgo di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme est, che alcune famiglie ebraiche erano state costrette a lasciare nel 1948, suscita l’indignazione di senatori dello spessore di Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Chris Murphy. Nella seconda metà di maggio, diversi parlamentari autorevoli si rivolgono a Biden per invitarlo a congelare la fornitura a Israele di nuove armi, criticandolo tutte le volte in cui non assume, in conversazioni telefoniche con Netanyahu, un atteggiamento di maggiore fermezza.
Netanyahu, per parte sua, orbato del protettore Trump, lungi dall’esprimere a Biden gratitudine per il sostegno offerto all’inizio del conflitto, e dall’aderire ai suoi pressanti inviti alla moderazione, fa ricorso con ostentazione per vari giorni alla maniera brutale contro Hamas e contro la stessa popolazione civile di Gaza, sino a porre Biden in palese imbarazzo − com’era accaduto un decennio prima con il suo predecessore Barack Obama − e a spingere i rapporti israelo-americani molto vicino a un punto di rottura.
Ma a partire dal 2 giugno lo scenario politico regionale presenta all’improvviso connotati nuovi. In Israele, grazie all’iniziativa di Yair Lapid (il pragmatico leader del partito di centro Yesh Atid) e di Naftali Bennett (leader di Yamina, il partito dell’estrema destra nazional-religiosa dei coloni), sette partiti con orientamenti molto difformi − nazionalisti, centristi e progressisti − affiancati da un minipartito arabo-israeliano di ispirazione islamista (la Lista Araba Unita, Ra’am, guidata da Mansour Abbas) − un’assoluta ‘prima volta’ nella storia travagliata del Vicino Oriente − hanno dato vita a una coalizione di unità nazionale con il precipuo scopo di detronizzare Benjamin Netanyahu, lo storico ‘re’ di Israele. Il voto con cui la Knesset dovrebbe concedere la fiducia al nuovo esecutivo è previsto per il 13 giugno. Prima di quel giorno, però, tutto potrebbe ancora succedere: le trappole che Netanyahu, e con lui il Likud e i vari partiti religiosi ultra-ortodossi, potrebbero tendere alla fragile maggioranza che sta per disarcionarli e spingerli finalmente all’opposizione, sono davvero infinite come le vie del Signore. Se supererà indenne la prova del voto di fiducia, questo bizzarro ‘governo a otto’ dovrà comunque tenere testa alla quotidiana ostilità del Likud, ricompattare un sistema politico che quattro successivi turni elettorali andati a vuoto hanno profondamente dilaniato e voltare pagina per cercare di restituire alle istituzioni democratiche del Paese una dignitosa credibilità.
I quesiti scomodi in attesa di risposta saranno in tale circostanza davvero numerosi. Quanto a lungo una coalizione così eterogenea riuscirà a conservare la compattezza necessaria per reggere le redini del governo in un Paese in cui il ‘monarca’ Netanyahu ha favorito con spregiudicatezza per dodici anni ogni sorta di conflittualità: tra ebrei e palestinesi, tra ebrei e musulmani, tra destra e sinistra, tra religiosi e laici, tra ‘patrioti’ e ‘traditori’? Poiché Lapid e Bennett prevedono una premiership a rotazione biennale – riservando a Bennett la presidenza del Consiglio nel primo biennio, mentre a Lapid viene affidato il ministero degli Esteri −, quale reazione è lecito attendersi da parte della minoranza arabo-israeliana della Lista islamista Ra’am di fronte alle intenzioni che Bennett ha espresso in termini tanto netti: “quello con Lapid non sarà un governo di sinistra, non faremo ritiri e non consegneremo territori”? E a dispetto dei dinieghi del ‘falco’ Bennett, riusciranno gli otto partiti coalizzati a spingersi tanto avanti sino a proporre qualche sostanziale miglioramento nei rapporti con i palestinesi? Quale settore della complessa galassia palestinese trova la sua espressione nella Lista Ra’am, che con i suoi quattro voti assicura al governo una maggioranza risicatissima alla Knesset? Dopo i notevoli guasti operati da Donald Trump, questo inedito ‘governo del cambiamento’ si renderà conto di quanto è urgente l’impegno di normalizzare i rapporti con la Casa Bianca, nonché con la comunità ebraica nordamericana?
Per rendere meno ‘febbricitante’ e più pacato il rapporto con Washington, Bennett – un uomo di governo che si presenta sulla scena per la prima volta, e che negli USA nessuno conosce − e il suo ministro degli Esteri dovranno evitare di ostacolare − come era solito fare Netanyahu in maniera ossessiva − la ripresa delle trattative sul contenimento del nucleare iraniano: trattative che Barack Obama aveva a suo tempo portato a termine con successo e che Donald Trump si era affrettato a cancellare. Si preoccuperanno di sicuro, questi nuovi governanti, di ammorbidire i rapporti con il partito democratico USA, presso il quale negli ultimi anni è andato montando, e non soltanto tra gli esponenti dell’ala progressista, un sordo malumore per la politica aggressiva ed espansiva di Israele. Dovranno infine, Bennett e Lapid, cercare di ricostruire legami più solidi e positivi con la comunità ebraica d’oltre Atlantico, le cui preferenze elettorali vanno appunto al partito democratico: un compito reso ora più agevole grazie al fatto che dalla coalizione governativa sono finalmente esclusi i haredim, gli ultra-ortodossi. In virtù di tale esclusione Bennett, che pure è a capo di un partito di coloni religiosi, si sentirà libero di affrontare con minore intransigenza alcuni temi che investono la vita personale degli ebrei osservanti (il matrimonio, il divorzio, la conversione all’ebraismo): temi sui quali gli ultra-ortodossi israeliani hanno storicamente esercitato una pesante influenza, con esiti legislativi considerati ostici dalla diaspora d’oltre Atlantico in quanto hanno riproposto come cogente erga omnes la legislazione d’ispirazione ortodossa messa in vigore nello Stato ebraico dai haredim. A tal riguardo, qualora si rivelasse più malleabile dei governi che l’hanno preceduto, il governo Bennett-Lapid si farebbe apprezzare in particolare dai Conservative e Reform, che nella grande comunità degli ebrei USA sono largamente maggioritari.
Se è vero, in ogni caso, che il nuovo esecutivo dovrà in primo luogo misurarsi con il tema dei rapporti con la striscia di Gaza e del conflitto in corso da qualche tempo tra ebrei e arabi nelle città israeliane con popolazione mista, non sfugge a nessuno che, proprio in questi giorni, in Israele alcune forze politiche chiaramente di destra stanno accettando, senza particolari pudori, di dare vita a un governo di unità nazionale assieme a un partito arabo-israeliano di ispirazione islamista. Non costituisce ciò, di per sé, una premessa per possibili insperate relazioni più civili e umane tra ebrei e arabi in Israele e, chissà, persino tra israeliani e palestinesi nella Cisgiordania e a Gaza? In una prospettiva di tal genere, il cammino che gli uni e gli altri dovranno compiere è comunque ancora lunghissimo. Ed è un cammino che dovrà fare i conti non soltanto con le faglie che lacerano in profondità il mondo israeliano, ma anche con le varie contrastanti anime che da decenni creano tensioni e rivalità feroci all’interno della stessa galassia palestinese.
Nel corso degli scontri interetnici che nello scorso maggio hanno avuto come epicentro Gerusalemme est, in particolare a Sheikh Jarrah e alla moschea Al-Aqsa, la partecipazione dei palestinesi di Gerusalemme (che sono il 40 per cento circa della popolazione totale della città) è stata largamente meno rilevante di quella di dimostranti arabo-israeliani residenti in località diverse, del nord e del centro d’Israele. Degna di nota è stata la massiccia presenza di attivisti arabo-israeliani giovani, appartenenti a una generazione nuova: una gioventù che non aveva partecipato all’ultima intifada, nel settembre del 2000, una gioventù non necessariamente riconducibile a questo o a quel partito, persone che soltanto ora iniziano a prendere parte con vigore alla vita politica. Negli ultimi giorni del Ramadan, giunti a Gerusalemme a bordo di dozzine di autobus, questi attivisti di varia provenienza hanno affrontato la polizia di Israele a viso aperto, avviando un primo significativo cambiamento nelle relazioni tradizionalmente non facili fra i palestinesi di Gerusalemme – che il governo di Israele considera ‘residenti permanenti’ ma non ‘cittadini’ − e gli arabi con cittadinanza israeliana che vivono in altre località. Verso questi ultimi, infatti, in passato i gerosolimitani solevano esprimere un sordo risentimento accusandoli di godere, proprio grazie alla cittadinanza israeliana, di un relativo benessere, e di avere perciò dimenticato le sofferenze che i fratelli di Gerusalemme erano costretti a patire a causa della perdurante occupazione degli israeliani. “Noi, giovani arabi cittadini d’Israele,” ha dichiarato una ragazza di 22 anni di Baka al-Garbiyeh, nel nord di Israele, “prendiamo viva parte alle proteste perché [noi palestinesi] siamo un solo popolo, una sola nazione, dalla Galilea al Negev.” Già un paio di mesi prima delle recenti cruente vicende, tre gruppi di giovani politicizzati della città arabo-israeliana di Um al-Fahm, non lontana da Haifa, avevano dato vita al United Fahmawi Movement per organizzare dimostrazioni contro la polizia, sia a Um al-Fahm sia a Gerusalemme. Perfettamente attrezzati nel diffondere attraverso i social network informazioni circa il loro movimento, hanno lanciato su Twitter l’evocativo hashtag PLM, Palestinian Lives Matter quando hanno appreso che nella spianata delle Moschee stava scorrendo abbondante sangue palestinese.
Le vicende dello scorso maggio sono sfociate, com’è noto, in diffusi episodi di violenza locale tra arabi ed ebrei in varie città israeliane a popolazione mista, con incendi e devastazioni di sinagoghe e di moschee che hanno fatto temere lo scoppio di una vera e propria guerra civile. Ma infine l’attenzione dei media è andata ovviamente concentrandosi sullo scambio smisurato di missili e bombardamenti tra Hamas e Netanyahu, e sulle centinaia di morti innocenti che quel breve conflitto ha provocato. Hamas e Netanyahu: sono stati questi due gli interlocutori indiscussi di un’escalation scriteriata, convinti entrambi di disporre di un’ottima opportunità per capitalizzare consenso politico. Da questa partita, come s’è visto il 13 giugno, Netanyahu è uscito decisamente sconfitto. Ma sul versante opposto, è proprio sicuro che il movimento islamista che, finanziato dal Qatar e in parte dall’Iran, fa di Gaza la propria roccaforte, sia riuscito a intestarsi la leadership della resistenza palestinese e a scrollarsi di dosso le accuse di inconcludenza politica e governativa del suo regime inequivocabilmente autoritario?
Da poco meno di un secolo israeliani e palestinesi vivono all’ombra della grande storia, gli uni accanto-insieme-contro gli altri. In un recente articolo su France Inter Pierre Haski rileva con acutezza che la storia può esercitare un peso schiacciante soprattutto quando, veicolando insopportabili memorie traumatiche, si caratterizza come una storia non condivisa. E riflettendo su israeliani e palestinesi, l’opinionista francese si domanda se sia mai possibile che essi superino il conflitto in cui sono tragicamente coinvolti senza prima riconoscere gli uni i traumi e le cicatrici degli altri.
Affronta questo tema con osservazioni illuminanti Aluf Benn, redattore-capo del quotidiano israeliano Haaretz, che l’1 maggio 2021 − poco prima, dunque, che Israele e Palestina siano sconvolti dalle recenti violenze – pubblica un articolo intitolato “Gli ebrei israeliani dovrebbero smettere di temere la Nakba.” Ricorda, questo brillante giornalista, che dopo la guerra del 1948, in Israele è a lungo circolata come un mantra la tesi secondo la quale il problema dei rifugiati palestinesi sarebbe nato da un appello dell’Alto Comitato Arabo di Vigilanza che avrebbe ingiunto agli abitanti dei territori palestinesi l’evacuazione delle case e delle città. Gli storici dell’epoca non trovarono alcun documento che convalidasse quella tesi. Ma quantunque, fin dal 1959, lo studioso palestinese Walid Khalidi avesse rivelato che il racconto dell’ordinanza emessa dall’Alto Comitato Arabo di Vigilanza era una bufala fatta circolare da un propagandista americano sostenitore della destra sionista, echi di quella fake news riemergono ancor oggi in occasionali dibattiti circa le responsabilità morali dell’esodo dei palestinesi. Nel panorama molto vivace della giovane storiografia israeliana, inattesi indizi circa le vicende che portarono alla nascita di Israele e alla contemporanea diaspora dei palestinesi emersero dal libro (1988) del capofila dei ‘nuovi storici’ Benny Morris, Esilio: Israele e l’esodo palestinese, 1947-1949. A Morris, sottolinea Benn, va riconosciuto in particolare il merito di avere posto al centro di quelle vicende la decisione politica, che gli israeliani presero mentre la guerra era ancora in corso, di rendere sin da allora impossibile il ritorno dei rifugiati e di confiscare il loro territorio a tutto vantaggio delle città e dei villaggi ebraici. Alla radice dell’interminabile conflitto tra Israele e Palestina sta proprio quella decisione, che ancor’oggi è operativa. Sul versante israeliano essa ha dato luogo a un ventaglio di leggi − a quella sulla Proprietà Assenteista, a quella sull’Acquisizione della Terra, nonché alle leggi che istituiscono il Fondo Nazionale Ebraico e l’Autorità per la Terra di Israele – mentre sul versante palestinese essa ha prodotto la Nakba, l’espulsione, la spogliazione, la confisca, l’oppressione e l’insopprimibile speranza dei palestinesi di recuperare il diritto al ritorno. Se non ci si tuffa risolutamente nella storia del 1948, rammenta Benn, non si comprende nulla delle relazioni attuali tra ebrei e arabi in Israele, né si comprende nel suo complesso il conflitto israelo-palestinese e i vari velleitari tentativi di risolverlo, e persino la bizzarra inclusione di un partito arabo nella attuale coalizione di governo. ‘La nascita del problema dei rifugiati’, afferma in conclusione Benn, è un tema ‘scolastico’ che in Israele ogni istituto secondario superiore e ogni scuola per allievi ufficiali dovrebbe proporre ai propri studenti. Sta di fatto, però, che la stessa la parola “Nakba” suona ripugnante al cuore del mainstream israeliano, tant’è che di Nakba e di rifugiati palestinesi non si fa cenno né nei corsi liceali di storia né in alcun museo di storia.
Per trovare informazioni utili sull’argomento è consigliabile approcciare l’app ‘Nakba’ dell’organizzazione non governativa Zochrot, fondata nel 2001 da Eitan Bronstein Aparicio. Nato in Argentina 60 anni fa ed emigrato in Israele con la famiglia all’età di 5 anni, Bronstein Aparicio è cresciuto nel Kibbutz Bahan nell’Israele centrale. “Da Claudio, come mi chiamavo, il mio nome è diventato Eitan: porto la rivoluzione sionista dentro di me”, dichiara con tranquillità. Eitan parla di sé come di un “israeliano normale” che ha fatto il servizio militare, alla pari di chiunque altro. Al termine di un percorso personale che definisce la “decolonizzazione della mia identità sionista”, è pervenuto a creare Zochrot (in ebraico “ricordare”): una ong che, mediante un articolato programma di studi storici alternativi, destinato alle classi terminali delle scuole superiori d’Israele, si propone di suscitare e diffondere fra gli israeliani la consapevolezza della Nakba e del diritto dei palestinesi al ritorno. Molto noti nella cerchia degli attivisti di sinistra, Bronstein Aparicio e la sua compagna Eléonore Merza, di 40 anni, hanno scritto a quattro mani un libro proprio sulla Nakba. Eléonore è una cultrice di antropologia politica. Nata in Francia da madre ebrea e da padre circasso, anno dopo anno ha trovato la vita in Israele sempre meno accettabile sotto il profilo ideologico, politico e professionale. E pur avendo ottenuto la residenza permanente, nel dicembre 2019 ha deciso assieme a Eitan e ai figlioli di trasferirsi a Bruxelles, dove le è stato offerto un lavoro particolarmente interessante.
Nelle intenzioni di questa coppia, il trasferimento in Europa è da considerarsi definitivo. Da parte mia esprimo l’auspicio che Eitan ed Eléonore ci ripensino: il Vicino Oriente ha un bisogno enorme di persone come loro.
Bruno Segre
Luciano Belli Paci :
“Ringrazio molto Bruno per le sue pregevoli e stimolanti riflessioni.

Solo su un punto non mi ritrovo.
Il discorso sulla Nakba, a mio modesto parere, è molto più articolato di come emerge dall’articolo.
E’ verissimo che si tratta di una storia non condivisa e che nella narrazione dominante israeliana e filo-israeliana sono prevalse versioni di comodo e rimozioni del problema (mi ricorda molto il modo in cui noi italiani abbiamo considerato per decenni la questione sud-tirolese).
Non mi pare però che sia neppure corretto generalizzare considerando l’esodo palestinese come conseguenza pressoché esclusiva di espulsioni forzate.
Quasi tutte le guerre provocano fughe di una parte della popolazione dalle zone in cui divampa il conflitto e nella sanguinosissima guerra di indipendenza del 1948 – simile per molti aspetti ad una guerra civile – è del tutto verosimile che l’esodo sia stato in gran parte di questa natura. Benny Morris, largamente citato anche nel pezzo di Bruno, spiega bene che l’espulsione violenta riguardò solo un certo numero di villaggi in alcuni scacchieri, in genere dove gli israeliani temevano di non poter tenere le posizioni se avessero lasciato sacche di arabi ostili alle spalle. Lo stesso Morris “rimprovera” Ben Gurion e la dirigenza israeliana dell’epoca per non avere voluto realizzare una pulizia etnica su larga scala, che secondo lui avrebbe prevenuto molti problemi per la vita futura dello Stato.
Ma soprattutto non mi pare che si possa sostenere che “alla radice dell’interminabile conflitto tra Israele e Palestina sta proprio quella decisione” (cioè l’espulsione, la spogliazione, la confisca, l’oppressione e l’insopprimibile speranza dei palestinesi di recuperare il diritto al ritorno).
Nello stesso periodo storico in cui si verificò la Naqba (anni 1945 – 1955) vi furono colossali fenomeni per molti versi affini: spostamenti di confini, nascita di stati, spostamenti di popolazioni, masse di profughi. Circa 12 milioni di tedeschi dopo la disfatta della Germania si spostarono da est a ovest; circa 15 milioni di musulmani e di indù dopo l’indipendenza indiana abbandonarono le proprie case per rifugiarsi i primi in Pakistan e i secondi in India; 300.000 italiani fuggirono dall’Istria e dalla Dalmazia; alcune centinaia di migliaia di ebrei dell’est Europa sopravvissuti allo sterminio non poterono rientrare nelle loro case (vedi pogrom di Kielce) e si ricostruirono una vita altrove; 900.000 ebrei dei paesi Arabi fuggirono andando in Israele e in altri stati, ecc. ecc.
Di tutti questi fenomeni si conserva a malapena la memoria storica, ma i profughi di allora non costituiscono più un problema politico e umano perché sono stati totalmente riassorbiti. Quei profughi e i loro discendenti conservano spesso, come i palestinesi, le chiavi delle case che dovettero abbandonare, ricordi dolorosi, nostalgie, usanze ed elementi identitari. Ma nessuno coltiva più velleità di “ritorno”.
Perché questo unicum palestinese ?
Perché la Naqba non è per nulla la causa, ma è l’effetto del conflitto ed è stata perpetuata insieme ad esso e in funzione di esso.
È l’effetto prima della guerra scatenata dagli arabi nel 1948 – senza la quale quelle povere persone sarebbero rimaste pacificamente nelle loro case – e poi di una politica araba che, anziché riassorbire i profughi di quella guerra, ha voluto a tutti i costi perpetuarne la dolorosa condizione. Quella ferita non solo non doveva in alcun modo cicatrizzarsi, ma doveva proprio rimanere infetta e purulenta, facendo di quegli eterni profughi l’emblema del “crimine” e dello “scandalo” della nascita di Israele, nonché una bomba sempre innescata per produrne un giorno la distruzione.
È giusto e doveroso ricordare la Naqba, un dolore senza fine inflitto al popolo palestinese.
Ma è altrettanto giusto e doveroso ricordare le responsabilità di quel dolore infinito. E distribuirle equamente.
Luciano Belli Paci
Gabriele Eschenazi : “Non fa una grinza. Come sempre non possiamo dimenticare come per il conflitto arabo-palestinese-israeliano si faccia spesso ricorso a parametri «speciali» cuciti addosso a Israele e slegati da precedenti storici.

Non dobbiamo cadere in questa trappola anche se uscire dal mito dell’idealismo sionista è dal punto di vista dell’onestà intellettuale necessario (Benny Morris, però, ormai non ha più nulla da dire). Nessuno, non per caso, ricorda mai l’esodo forzato degli ebrei dei paesi arabi (arrivati anche in Italia), espropriati di tutto e accolti in Israele insieme ai sopravvissuti della Shoà. Ci sono poi gli etiopi e i russi. Israele, terra di rifugio per il popolo ebraico discriminato e perseguitato, non è uno slogan, ma una realtà tangibile. C’è poi un aspetto che mi preme sottolineare come fece una volta Enrico Deaglio dopo una visita in Israele. Deaglio, grande e serissimo giornalista, disse di fronte a me e colleghi del Diario della settimana (cito a memoria): «Vedo Israele e tutto quello di meraviglioso che hanno costruito e prodotto e mi domando. Come potrebbero mai «restituire» e lasciare tutto questo? Hanno portato sviluppo e progresso in una terra desolata e arretrata». Di fatto ignorare questa grande capacità dello stato ebraico di costruire dal nulla in poco tempo agricoltura avanzata, industria, università, centri di ricerca, cultura, musica, sport non può essere cancellata a fronte del dramma dei profughi rifiutati da ogni paese arabo. Persino sotto l’odioso Bibi gli scienziati italiani non hanno fatto in questi mesi che indicare Israele come un esempio da seguire. Per non parlare del mio tema e cioè la dieta a base vegetale che in Israele trova ogni giorno nuove proposte. Non cadiamo nell’errore di farci trascinare a discutere di Israele sempre e solo guardando al problema palestinese. Non lasciamo alla destra ebraica il monopolio delle «buone notizie» su Israele.
Gabriele Eschenazi
Bruno Piperno Beer : Sono d’accordo con quanto scritto da Luciano.

Ho letto recentemente il libro “The war of return” di Adi Schwartz e Einat Wilf (Libro disponibile di amazon) che chiarisce molti aspetti del problema dei profughi palestinesi.
Riesaminando alcuni episodi storici, il libro ribadisce il concetto che i profughi in fuga da situazioni di guerra sono stati accolti dalle popolazioni che erano disposti ad accoglierli.
Mai si è verificata la situazione in cui i profughi sono rientrati in un paese con il quale esistevano situazioni conflittuali.
Questo vale, tra gli altri, per gli episodi citati da Luciano. E questa è una regola che deve valere anche per i profughi palestinesi.
È necessario inoltre riflettere sul ruolo negativo svolta dall’UNRWA (United Nation Relief and Work Agency) che nominalmente è un’emanazione delle Nazioni Unite e come tale dovrebbe favorire il reinserimento dei profughi in terre di accoglienza. Invece si è trasformata negli anni in un’agenzia gestita da gruppi palestinesi che ha come fine quello di perpetuare il problema dei profughi anziché risolverlo.
Al contrario dell’UNRWA, è da evidenziare il comportamento della UNKRA (United Nation Korean Reconstruction Agency), un’agenzia dell’ONU nata negli anni ’50 del secolo scorso per risolvere il problema dei 500.000 profughi della guerra di Corea. Tale Agenzia ha concluso con successo la sua missione di reinserimento dei profughi nel 1958 dopo 3 anni dalla conclusione della guerra tra le due Coree.
Bruno Piperno Beer
Bruno Segre : Caro Luciano e caro Gabriele,
vi sono molto grato per l’attenzione che avete dedicato a questo mio articolo e per le puntuali osservazioni che avete ritenuto necessario formulare: osservazioni di natura storiografica, a mio parere assolutamente corrette e condivisibili.
In realtà, quando mi sono messo a scrivere quelle note non mi proponevo di ‘rifare la storia’ per l’ennesima volta, ma piuttosto di prendere le mosse dall’osservazione del presente − per molti versi caotico, osceno, insopportabile − e tentare di immaginare esiti futuri dotati di un minimo di senso.
Personalmente continuo a essere convinto (a illudermi/pensare/sperare/desiderare, anche se nell’articolo non vi faccio esplicito cenno) che affinché il conflitto in corso tra il Giordano e il Mediterraneo trovi una sensata conclusione − l’unica soluzione capace di rendere comprensibile al resto dell’umanità il progetto sionista − ci vogliono due Stati per due popoli. Due Stati significa uno Stato per gli ebrei e un Stato per i palestinesi. Perché quella soluzione si realizzi, manca drammaticamente all’appello lo Stato per i palestinesi.
Tale constatazione mi ha indotto a scrivere quelle note cercando di non dare a esse la solita curvatura israelocentrica che ritrovo in tutto, o quasi, ciò che ho scritto in passato su questi temi. Ho tentato, insomma, di evitare le strettoie di un discorso ‘parrocchiale’ e di adottare per quanto più potevo ottiche ‘altre’. Con questo approccio ho cercato, fra l’altro, di individuare in alcuni aspetti della partecipazione palestinese ‘dal basso’ ai tragici eventi dello scorso maggio qualche timido segnale di‘ risveglio’. Ritengo, infatti, che se mai riuscirà a nascere, lo Stato dei palestinesi dovranno farselo con le loro lacrime, il loro sudore, il loro sangue gli stessi palestinesi. Con un ritardo di poco meno di un secolo, insomma, dovranno compiere un cammino molto simile a quello battuto dai sionisti quando fecero nascere lo Stato d’Israele.
Ancora vi ringrazio e vi abbraccio con grande amicizia.
Bruno
Luciano Belli Paci : Carissimo Bruno,
concordo in pieno con questo tuo messaggio.
Il sionismo come modello da seguire per i palestinesi mi pare perfetto.
Anche quello palestinese è un popolo che è stato costretto ad inventarsi (come gli ebrei furono costretti a re-inventarsi) come soggetto nazionale sotto i colpi di un destino avverso e per il venire meno di tutte le alternative possibili.
Speriamo che trovino finalmente il loro Ben Gurion J
Un abbraccio.
Luciano

“Sogno una pace che cambi le coscienze”
David Grossman
Mentre israeliani e palestinesi tornano a scontrarsi il grande scrittore auspica un cambiamento “come in 67 anni non ho mai conosciuto”
Quando mi è stato proposto di scrivere qualcosa sul tema “metamorfosi” ho pensato a un cambiamento straordinario descritto nella Bibbia, nel libro di Isaia, che dovrebbe avvenire in futuro, alla fine dei tempi, e prevede un mutamento profondo della coscienza e del comportamento di tutti gli esseri umani.
Dio — profetizza Isaia — giudicherà i popoli ed essi «trasformeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci, un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo e non impareranno più la guerra».
Questa è sostanzialmente la descrizione di un “disarmo” globale, universale, durante il quale gli esseri umani trasformeranno le armi in attrezzi agricoli per lavorare la terra, renderla fertile e produttiva. Isaia profetizza che i vari popoli «non impareranno più la guerra». Ovvero, non solo non si combatteranno a vicenda ma saranno talmente determinati a sradicare i conflitti dalla coscienza umana che cesseranno di insegnare e di imparare la “dottrina bellica”.
Isaia, figlio di Amoz, visse a Gerusalemme circa tremila anni fa, nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. Noi, nel XXI secolo d.C., dovremmo quindi già trovarci nel futuro utopico da lui profetizzato, goderne i frutti e apprezzare l’esistenza pacifica e priva di violenza che ci aveva promesso. Inutile dire che siamo lontani da questa auspicata prospettiva non meno di quanto non lo fosse lui stesso a suo tempo.
Ma scendiamo dalle vette liriche di questa profezia alla prosaica realtà delle nostre esistenze: scrivo queste righe durante un nuovo round di combattimenti particolarmente violenti tra Israele e Hamas, l’organizzazione che controlla la Striscia di Gaza. In questo momento sento suonare l’allarme e missili lanciati da Hamas cadono a poca distanza da me. Al tempo stesso la Striscia di Gaza è sotto un massiccio attacco israeliano. È ancora difficile stabilire chi abbia veramente causato questa esplosione di violenza e di morte ma potremmo pronosticare, sulla base dell’esperienza passata, che presto sarà raggiunto un cessate il fuoco e la situazione si calmerà per qualche mese, o per qualche anno. Entrambe le parti seppelliranno i loro morti, ricostruiranno le case e le città distrutte e torneranno a rifornirsi di armi e munizioni. Nessuno sforzo serio sarà fatto per risolvere veramente e alla radice il problema delle relazioni tra Israele e la Striscia di Gaza e, con ogni probabilità, le cose rimarranno invariate fino al prossimo scontro armato.
Israele si trova in uno stato di guerra da più di un secolo, principalmente con il popolo palestinese, e ormai da cinquantaquattro anni questo popolo è sotto la sua dominazione. Apparentemente non c’è alcuna soluzione a questa situazione distorta e nessuno ne sta cercando una. Da più di un secolo i membri di entrambi i popoli si svegliano ogni mattina con l’annuncio dell’ennesimo omicidio o atto di distruzione, di vendetta o di odio avvenuto durante la notte. «Colui che ride», ha scritto Bertolt Brecht, «probabilmente non ha ancora ricevuto la terribile notizia». Com’è vera questa affermazione per noi israeliani e palestinesi.
Io ho 67 anni e in tutta la mia vita non ho conosciuto un solo giorno di pace. Di pace vera, radicata nei cuori, che cambi la coscienza. Sì, gli accordi firmati da Israele con l’Egitto e la Giordania (e ultimamente con gli Emirati Arabi Uniti) sono importantissimi ma, in fin dei conti, sono stati stipulati tra governi, tra leader, e non si traducono in una pace vera e “naturale” tra popoli. Non creano una situazione in cui le lance si trasformino in falci. I cittadini di questo conflitto non hanno nemmeno mai conosciuto un tipo di pace che esaudisca desideri molto più modesti, che consenta loro di non pensare affatto alla pace ma di abbandonarvisi in maniera semplice e naturale. Una pace che permetta loro di fare respiri profondi, a pieni polmoni, senza avvertire in fondo a ogni respiro una punta di paura, di dolore, di lutto.
Nella realtà delle nostre vite la paura è sempre in agguato. Abbiamo sempre una spada che pende sopra la nostra testa. E anche se di tanto in tanto affiorano momenti di tranquillità e di calma, questi vengono percepiti come una pericolosa illusione, una cospirazione tramata nell’oscurità. Quindi, se allentassimo anche di poco la vigilanza, la tensione, se ci mostrassimo distratti, se concedessimo fiducia ai nostri vicini-nemici, questa illusione potrebbe esplodere all’improvviso e, come al solito, ci ritroveremmo nella realtà della guerra.
Ecco una piccola storia vera: nel 1977 il presidente egiziano Anwar Sadat annunciò di essere pronto a venire in Israele per firmare il trattato di pace con lo stato ebraico, il più grande nemico dell’Egitto. Israele fu travolto da un’enorme ondata di emozione ma il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito avvertì che Sadat stava forse architettando una trappola e, approfittando dell’euforia che regnava in Israele, si accingeva a sferrare un attacco a sorpresa come aveva fatto nella guerra dello Yom Kippur. Questo era ciò che pensava seriamente il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, e non ho dubbi che molti israeliani condividessero i suoi timori.
«Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, e non impareranno più la guerra». Questa frase racchiude un’aspirazione grande e autentica ma anche una certa dose di ingenuità. Un’ingenuità che io però invidio, come invidio il coraggio di esprimere con voce chiara e forte un auspicio tanto ardito, una possibilità tanto anelata.
Un popolo che ha vissuto per innumerevoli anni in uno stato di guerra è condannato a definire se stesso e la situazione in cui si trova in termini bellici, violenti, di sopravvivenza. Un popolo simile, che non conosce una realtà che non sia stata plasmata dalla guerra, farà fatica a credere che esiste la possibilità che non ci siano conflitti. Nell’anno 2000, a Camp David, si tennero colloqui di pace tra israeliani e palestinesi nel tentativo di raggiungere un accordo. I colloqui fallirono. La diffidenza reciproca fu più forte della volontà di pace e innescò una brutale spirale di violenze. A quel tempo, nei giorni della seconda Intifada, molti israeliani si sentirono ingannati, traditi, e non solo dai palestinesi. Vedevano se stessi come traditori, avevano l’impressione di aver tradito la loro impietosa ed eloquente esperienza storica, accumulata nel corso di generazioni, di guerre, di sofferenze. Un’esperienza che avrebbe dovuto metterli in guardia dal non lasciarsi tentare da “illusioni di pace”.
E invece era successo, si erano lasciati “tentare”, avevano tradito il loro istinto guerriero di eterni sopravvissuti, l’amara convinzione che noi ebrei siamo un popolo condannato a vivere e a morire con la spada in mano, per l’eternità. È possibile che israeliani e palestinesi abbiano mai una vita diversa, sicura e pacifica nella loro terra? Che possano godere di rapporti di buon vicinato? Potrà mai avvenire dentro di noi l’agognato cambiamento, la metamorfosi vaticinata dal profeta Isaia?
Come ho già accennato di recente sono stati firmati accordi di pace tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti e tra Israele e Marocco. Questi sono sviluppi importantissimi e positivi. Ma, in fin dei conti, questi accordi hanno sancito una pace tra ricchi mentre quella più vitale, tra israeliani e palestinesi, non è stata ancora firmata. Una pace tra popoli che cambi la coscienza, l’esistenza, la percezione del futuro e l’approccio alla vita, in tutti i suoi substrati. Una pace che al giorno d’oggi non ha molti sostenitori e quasi nemmeno “agenti” che la promuovano. Gli agenti presenti nella nostra regione fomentano infatti più che altro il sospetto, la violenza e la disperazione. Il profeta Isaia visse in un’epoca di guerre tra i regni di Giuda, di Egitto e di Assiria. Se oggi resuscitasse rimarrebbe sicuramente sbalordito nel vedere che i guerrieri sono cambiati ma la guerra c’è sempre. L’auspicata trasformazione da lui pronosticata non è ancora avvenuta.
© David Grossman

Così possiamo trovare la strada del vivere insieme
David Grossman
Migliaia di israeliani, ebrei e arabi, riuniti a Tel Aviv, hanno lanciato un appello alla pace che chiuda il conflitto israelo-palestinese e alla convivenza dentro al Paese. Pubblichiamo il discorso pronunciato sabato sera 22 Maggio 2021 dallo scrittore
Permettetemi di dedicare le mie parole ai bambini che vivono in Israele nelle zone in prossimità di Gaza e ai bambini di Gaza e a tutti i bambini che hanno vissuto sulla pelle e nell’anima l’ultima guerra. La smania di ognuna delle parti in guerra di «incidere nelle coscienze» la sua vittoria ha creato migliaia di piccole sconfitte. Un’intera generazione di bambini, a Gaza e a Ashkelon, presumibilmente crescerà e vivrà con il trauma dei missili, dei bombardamenti e delle sirene. A voi bambini, sulle cui coscienze questo conflitto ha inciso davvero, io sento il bisogno di chiedere scusa, perché non siamo stati capaci di creare per voi la realtà migliore e più sana a cui ogni bambino di questo mondo ha diritto. L’ultima guerra ha dimostrato una volta di più fino a che punto le due parti, Israele e Hamas, sono bloccate, prigioniere del letale circolo vizioso da loro stesse creato. Fino a che punto agiscono ormai da decenni come un meccanismo automatico capace solo di ripetere le stesse azioni, ancora e ancora, con forza sempre crescente. Un’altra pioggia di razzi e un altro bombardamento, e poi pioggia di razzi. E di nuovo lo stesso noto ritmo martellante, sempre più incalzante, che si autoalimenta e offusca la capacità di giudizio.
Poi arriva il momento in cui è evidente che la guerra si è esaurita, e tutti lo sanno, in Israele e a Gaza, ma non sono in grado di smettere, non è possibile smettere, come se la forza fosse diventata il fine stesso invece che il mezzo. Questo gigantesco stantuffo continua a colpire senza sosta, a Be’er Sheva e a Gaza. E può continuare per l’eternità — il meccanismo non è dotato di dispositivo di autospegnimento — a meno che Joe Biden non agiti un dito, e di colpo ci svegliamo dall’incantesimo ipnotico della distruzione, ci guardiamo intorno e chiediamo: cos’è successo qui? Cos’è successo di nuovo? E perché sentiamo che gli elementi più estremisti nel conflitto ci hanno manipolati un’altra volta? Com’è possibile che dopo l’inferno che hanno vissuto milioni di persone, a Gaza e in Israele, ci ritroviamo di fatto vicinissimi al punto di partenza?
E più di tutto chiedo, com’è possibile che Israele, il mio Paese, uno Stato che dimostra forze immense quando si tratta di creatività, di inventiva e di audacia, trascini da ormai più di un secolo le macine di pietra di questo conflitto e non sia in grado di trasformare la sua enorme forza militare in una leva che modifichi la realtà, che ci liberi dalla maledizione delle guerre periodiche? Che ci apra un’altra strada?
È vero, fare la guerra è più facile che fare la pace. Nella realtà in cui viviamo, la guerra si tratta solo di continuarla, mentre la pace costringe a processi psichici difficili ed elaborati, processi che popoli abituati quasi solo a combattere vivono come una minaccia. Noi israeliani ci rifiutiamo ancora di capire che è finito il tempo in cui la nostra forza può determinare una realtà comoda solo per noi, per le nostre necessità e per i nostri interessi. L’ultima guerra ci farà entrare finalmente in testa che da un certo punto in poi la nostra potenza militare non è quasi più rilevante? Che per quanto grande e pesante sia la spada che brandiamo, in fin dei conti qualunque spada è un’arma a doppio taglio?
Questa guerra è finita, ora la domanda bruciante è cosa succederà all’interno di Israele, ai rapporti tra arabi ed ebrei. Quanto è accaduto per le strade delle città israeliane è terribile. Non ha giustificazione. Il linciaggio di persone solo perché sono ebree o arabe rappresenta il livello più infimo di odio e crudeltà. Le vittime sono state uccise, la loro umanità negata. Gli assassini si sono trasformati, in quei momenti, in bestie.
Ma adesso — quando gli spiriti si sono raffreddati e lo Stato di diritto comincia finalmente ad assicurare i criminali alla giustizia — si può parlare di quanto è accaduto, cercare di capire cosa è venuto a galla dalle due parti, e delle radici di quanto è accaduto. Perché è dalla possibilità di comprendere che dipende il futuro di noi tutti, ebrei e arabi. Israele potrebbe trovarsi a breve ad affrontare le quinte elezioni. Gli eventi del mese di maggio e la virulenza dell’odio esploso fra arabi ed ebrei occuperanno un posto centrale nella campagna elettorale.
È facile indovinare che i politici sfrutteranno le angosce e la diffidenza, il razzismo e la brama di vendetta. Gli istinti più bassi che hanno fatto capolino nella realtà israeliana diventeranno il combustibile della prossima campagna elettorale e i sobillatori avranno vita più facile che mai. Tutti, ritengo, sappiamo chi ci guadagnerà. Tutti sappiamo anche che aspetto avrà la realtà in questo Paese se saranno gli estremisti nazionalisti e i razzisti a stabilire le leggi. Perciò la vera lotta oggi non è tra arabi ed ebrei, ma fra quanti — dalle due parti — anelano a vivere in pace, in una convivenza equa e quanti — dalle due parti — si nutrono, psicologicamente e ideologicamente, di odio e violenza.
Magari riuscissimo a ristabilire e irrobustire le forze sane nelle due società, coloro che fra noi si rifiutano di diventare collaborazionisti della disperazione. Così se anche dovesse scoppiare un’altra ondata micidiale come questa — e io temo che scoppierà ogni qualche anno — potremo resisterle in modo lucido e maturo, come sembra stia accadendo già in questi giorni, con un’infinità di incontri e dibattiti e iniziative straordinari. Come dimostriamo noi, che ci ritroviamo qui alla manifestazione, con la nostra risolutezza, con il nostro attaccamento all’idea di pace e uguaglianza, con la cooperazione equa fra i due popoli, e con il nostro «nonostante tutto», la fonte di speranza più grande in questi giorni bui, speranza grazie alla quale rimane possibile ritrovare la strada quasi perduta, la strada tortuosa e ardua per vivere qui insieme, in completa uguaglianza e in pace, arabi, ebrei, esseri umani.

Opinioni : In my name
Stefano Jesurum
In my name (secondo uno dei più profondi insegnamenti dell’ebraismo, ovvero quello della – per me sacra – responsabilità individuale) considero la lettera dell’ormai noto gruppo di giovani ebree e ebrei italiani ( NotInOurNames) innanzittutto una sciocchezza, oltre che un grave errore politico, inopportuna, controproducente, offensiva.
In my name giudico tempi e contenuti della pubblicazione un oggettivo appoggio sia all’antisemitismo mascherato da accusa alle scelte politiche dello Stato di Israele sia una mano tesa a quella parte delle nostre Comunità da anni obnubilate da un acritico osanna a qualsiasi mossa di Gerusalemme.
In my name penso sia una colpevole miopia mischiare fatti e storie che andrebbero invece tenute ben separate se non si vuole regalare una buona carta a chi, sono certo, i firmatari vogliono opporsi. Gli sfratti a Sheikh Jarrah e l’insensata e provocatoria repressione della polizia sulla Spianata delle Moschee pochissimo o nulla c’entrano con gli oltre tremila criminali missili lanciati finora da Hamas e Jihad – fosse solo ché un simile spaventoso arsenale non si prepara e posiziona in pochi giorni.In my name supplico questi giovani di lavorare all’interno della sinistra – a cui palesemente si rifanno – e alle loro Comunità per combattere l’ignoranza e i pregiudizi imperanti e portatori di antisemitismo e islamofobia.
In my name chiedo ancora una volta ai vertici comunitari e ai nostri rabbanìm di fermare le ondate di odio che dalle nostre fila aggrediscono troppo spesso correligionari che non si adeguano al mainstream: un miscuglio, che a me fa paura e orrore, di metodologia squadrista, ignobili insulti legati a dati personali privatissimi, segnali di plebea invidia sociale – tutti ingredienti tipici di identikit intolleranti e illiberali, insomma per nulla democratici.
In my name agisco e prego affinché il maggior numero di noi si convinca che lontano da noi si stanno confrontando da decenni due torti e due ragioni, opposti ma che se non verranno risolti pacificamente porteranno sempre e soltanto morte e dolore, sofferenza e ingiustizie.
In my name affermo con convinzione: è vero, a volte gli ebrei sono (siamo) esasperanti, demenzialmente litigiosi, ottusamente sordi. Però ricordo che Rashì, nel suo commento all’incarico che Mosè fa al suo successore Giosuè, scrive che egli gli disse: «Sappi che loro [il popolo che stai per condurre] sono importuni e contenziosi». Ma gli disse anche: «Tu sei fortunato perché avrai il privilegio di condurre il popolo di Dio in persona». In my name. Un ebreo orgogliosamente di sinistra, sionista, che ama Israele e odia qualunque ingiustizia e sopraffazione.
20 Maggio 2021

DOPO LA TREGUA: LE QUESTIONI APERTE DEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE
Parla con Gariwo Nadav Tamir, l’ex consigliere personale di Shimon Peres
Nadav Tamir, diplomatico israeliano, è il direttore esecutivo di J-Street in Israele: J-Street è un’organizzazione ebraico-americana che lavora per promuovere la politica estera americana pro-Israele e pro-pace. Nadav Tamir è anche serior advisor per gli affari governativi e internazionali al Peres Center for Peace and Innovation, ex consigliere personale di Shimon Peres per gli affari diplomatici, membro del comitato direttivo dell’Iniziativa di Ginevra e del think-tank Mitvim. Ha lavorato all’ambasciata di Israele a Washington e come console generale nel New England. In questa intervista sul conflitto israelo-palestinese, ci parla delle realtà esistenti di collaborazione tra arabi ed ebrei, del ruolo della comunità internazionale, e dell’estremismo e della leadership moderata sia in Israele che in Palestina.
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto un disperato appello di pace da Neve Shalom, un villaggio in Israele dove arabi palestinesi ed ebrei israeliani vivono insieme, praticando la non violenza e la coesistenza pacifica. Può dirci di più sulle realtà esistenti di collaborazione tra ebrei e arabi?
Ci sono tanti progetti di collaborazione tra ebrei e arabi: secondo me questo è l’unico motivo per cui essere ottimisti nel mezzo di questo disastro. La maggior parte della gente vuole vivere in pace, anche se gli estremisti ricevono sempre molta più attenzione. Oggi molte di queste realtà di collaborazione sono ben collegate attraverso i social media, e c’è persino un gruppo Whatsapp con tutte le diverse iniziative che riuniscono arabi ed ebrei. Una delle più interessanti è Women Wage Peace, un’organizzazione guidata da donne, sia arabe che ebree, sia di destra che di sinistra, sia religiose che laiche, che sono unite nella richiesta di un accordo non violento reciprocamente vincolante tra israeliani e palestinesi, e che credono anche che le donne debbano essere più coinvolte nel processo decisionale, un punto di vista che condivido. Ma ci sono tante altre reti professionali e politiche diverse, di diversa provenienza: medici, comuni, ONG e organizzazioni no-profit, artisti: c’è di tutto.
Molti di questi gruppi hanno manifestato molto in questi giorni, chiedendo la cessazione delle violenze. Pensa che queste istanze possano trovare un spazio in politica?
Sì, penso di sì. Uno dei motivi per cui Netanyahu non è riuscito ad ottenere la maggioranza nelle ultime elezioni è stato a causa delle proteste civili, enormi in Israele negli ultimi due anni. La gente vi ha preso parte per motivi diversi. Per me, si trattava soprattutto del conflitto israelo-palestinese; per altri, della corruzione o dell’erosione della democrazia. In generale, comunque, quelle proteste hanno dato voce a un’insoddisfazione diffusa tra gli israeliani riguardo alla politica attuale. Tutto questo ha colpito anche la destra israeliana. New Hope – il recente partito di centro-destra fondato da Gideon Sa’ar – è nato proprio da una grande insoddisfazione per la politica di Netanyahu da parte di persone che credono che si possa essere di destra senza essere populisti, senza mettere se stessi prima del paese, e senza essere corrotti.
Dove sono ora queste voci critiche?
Quando il popolo israeliano è sotto attacco, molti si attaccano alla bandiera e scivolano in un sostegno poco critico del governo, prendendo sul personale ogni critica alle nostre politiche. Per questo stesso motivo mi capita di discutere anche all’interno della mia famiglia: è come se la gente non riuscisse a distinguere tra le politiche del governo e lo stato di Israele. La mettono in questi termini: o sei per Hamas, o sei per Israele. Ma non è questo il punto: per me, Hamas è un’organizzazione terroristica, ma questo non esime Israele dalle sue responsabilità per non aver creato un vero processo di pace e aver fatto uno sforzo reale, anche all’interno di Israele, per trattare con rispetto e uguaglianza gli arabi israeliani. Spero davvero che, ora che è stata concordata una tregua, il popolo israeliano sia più aperto a riflettere sugli errori e sulla mancanza di strategia che ci hanno portato a questa situazione.
In un recente articolo, lei ha detto che la “Legge sullo stato-nazione” – che il governo di Netanyahu ha approvato nel 2018 – ha inviato un chiaro messaggio agli arabi israeliani definendoli cittadini di seconda classe. Potrebbe dirci qualcosa di più su questa legge? Perché Israele ce l’ha e da dove viene?
Prima di tutto, è fondamentale chiarire che Israele non ha una costituzione scritta. Quando Ben Gurion dichiarò l’indipendenza di Israele, pensò che fare i conti con questioni giudiziarie sarebbe stato troppo complicato e avrebbe rappresentato una minaccia esistenziale per Israele. Così, decise di adottare il modello britannico, caratterizzato dall’assenza di una costituzione. Ma la Gran Bretagna e Israele sono molto diversi. La Gran Bretagna ha una lunga tradizione democratica di precedenti che assicurano la protezione e la salvaguardia dei diritti umani, e questo non è il caso di Israele. Nel nostro paese, molti vedono la Dichiarazione d’Indipendenza come una Costituzione. Credono, per esempio, nel principio della Dichiarazione secondo cui Israele è una patria sia per il popolo ebraico che per i suoi cittadini di altre confessioni religiose, un paese basato sulla libertà, la giustizia e la pace, in cui la completa uguaglianza dei diritti sociali e politici è assicurata a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di religione, razza o sesso. Ma altre persone non considerano questi principi come valori fondanti in Israele, e questo è all’origine di un eterno conflitto tra la sinistra e la destra. Molte persone di destra dicono che la nostra corte suprema è troppo universale, troppo liberale, e si lamentano perché manca un carattere distintamente ebraico nelle leggi dello Stato. Per me, queste obiezioni non hanno senso: come ebreo, credo che la democrazia sia di per sé un valore ebraico perché è l’ebraismo che ha portato nel mondo l’idea che siamo tutti uguali. Eppure, la destra israeliana ha alla fine approvato una legge che dà al carattere ebraico dello Stato uno statuto prevalente sul valore liberale della democrazia, promuovendo così ineguaglianza e discriminazione. Questa legge, per esempio, sancisce l’ebraico come lingua ufficiale di Israele, declassando l’arabo – la lingua parlata dagli arabi israeliani – a uno “status speciale”. Ci sono persone nel centro e a sinistra che vogliono aggiungere uguaglianza a questa legge in modo che gli arabi, anch’essi cittadini d’Israele, non siano trattati in modo diverso degli ebrei. Per me, tutto questo è ancora più sorprendente perché noi stessi siamo stati una minoranza in altri paesi. A causa di ciò che abbiamo sofferto, dovremmo essere un modello sul trattamento delle minoranze. L’idea stessa di avere un nostro Stato è stata pensata come un modo per riparare a ciò che abbiamo sofferto.
Oggi potremmo sostenere che Hamas è il vero vincitore di questa guerra, perché, come lei ha scritto, Hamas ha riempito un vuoto creato dal governo israeliano e dall’Autorità Palestinese, presentandosi ora come il vero difensore degli arabi, in Israele come in Palestina.
Sì, assolutamente: Hamas vincerà questa guerra, al di là di quante persone verranno uccise, perché ha dimostrato ai palestinesi in Cisgiordania e ai palestinesi in Israele che è Hamas a prendersi cura degli arabi e dei musulmani. Gli altri vincitori di questa guerra saranno gli israeliani, come Netanyahu e i suoi sostenitori, che si rifiutano di raggiungere un accordo e un compromesso con i palestinesi. Ogni vittoria di Hamas è anche una vittoria anche per loro. I palestinesi moderati, invece, saranno i più colpiti. Anche se hanno le loro colpe, penso che l’unica via d’uscita da questo conflitto sia il rafforzamento dei palestinesi moderati, che non credono nel terrorismo o nella violenza come mezzo per realizzare gli interessi dei palestinesi. Con la sua politica, Israele li sta rendendo sempre più deboli.
In che modo, in particolare, pensa che Netanyahu sia responsabile di aver rafforzato Hamas?
Rifiutandosi di trattare diplomaticamente la questione palestinese e manipolando la paura e i traumi degli ebrei. Mantenere Gaza e la Cisgiordania separate, permettere al denaro del Qatar di sostenere Hamas e, allo stesso tempo, rispondere solo militarmente ai loro attacchi senza alcuna strategia: tutto questo mantiene Hamas in vita non solo fisicamente ma concettualmente. Questo conflitto ne è stato il miglior esempio. Avevamo quasi raggiunto una coalizione di cambiamento che potesse rimuovere Netanyahu dal suo ruolo, ma questa violenza ha provocato molta pressione sui membri di questa coalizione. Nella politica israeliana, la violenza gioca sempre a favore di Netanyahu, che alimenta la paura e fa leva sui traumi che il popolo ebraico ha subito nella storia. È per questo che Netanyahu rende l’Iran molto più grande di quello che è; è per questo che rende il movimento BDS molto più grande di quello che è; è per questo che rende l’antisemitismo molto più grande di quello che è. Per Netanyahu, la paura è l’unico strumento per restare al potere: ma i fondatori di Israele volevano ispirarci con la speranza, un principio che Netanyahu continua a trascurare.
E l’amministrazione americana? Il conflitto israelo-palestinese non era esattamente in cima all’agenda di Biden. Lui ha espresso il suo sostegno a Netanyahu, ma i democratici sono sempre più divisi su questo tema. Cosa pensa che possano fare gli Stati Uniti?
Biden è un amico di Israele. Eppure, nei suoi anni da vicepresidente durante il mandato di Obama ha capito che il conflitto israelo-palestinese è una questione radioattiva nella politica americana. Biden non voleva entrare troppo presto in questa questione: preferiva occuparsi prima di cose che sapeva già come gestire. Sperava che in Israele e il Palestina le cose rimanessero relativamente quiete per un po’, dato il caos politico in cui si trovavano entrambi i paesi. Biden ha bisogno di tempo per invertire alcune delle cose più dannose fatte da Trump. Ma il conflitto israelo-palestinese non è qualcosa che si può trascurare, in un modo o nell’altro alla fine bussa alla porta. Adesso Biden sta usando i vecchi argomenti perché non ha ancora elaborato una sua strategia rispetto a questo problema: non ha neanche nominato un ambasciatore per Israele. Ma ora il conflitto è diventato un fattore ineludibile, e c’è pressione perché lui faccia qualcosa. Spero davvero che Biden affronterà questa questione in modo adeguato, nominando qualcuno che se ne occupi se non ha il tempo di farlo lui stesso.
L’anno scorso, l’ex presidente americano Trump ha promosso i cosiddetti accordi di Abramo tra Israele e quattro stati arabi, descrivendoli come “l’alba di un nuovo Medio Oriente”. In realtà, quegli accordi hanno portato a una perdita di interesse, da parte dei paesi arabi vicini a Israele, nel sostenere la Palestina. Questo ha favorito Netanyahu nel suo ignorare la questione palestinese. Secondo lei come hanno agito e come agiranno questi accordi sul conflitto?
L’intenzione iniziale di Trump e Netanyahu non era di firmare gli accordi di Abramo, ma di promuovere l’annessione di parti significative della Cisgiordania a Israele. Quando hanno saputo che gli arabi non avrebbero mai accettato questo piano, Trump e Netanyahu hanno deciso di ripiegare sul piano B, giocando sugli interessi economici degli arabi e proponendo così gli accordi di Abramo. Penso, comunque, che il processo di normalizzazione potrà aiutare i palestinesi nel lungo periodo. Ma questo è possibile solo se Biden riesce a includere i palestinesi in questo processo, permettendo loro di beneficiare dei suoi vantaggi. In questo caso, la normalizzazione potrebbe trasformarsi in un potente strumento per porre fine a questo conflitto. Anni fa, Shimon Peres parlava di un “nuovo Medio Oriente” perché credeva che un approccio regionale potesse portare benefici anche ai palestinesi. Ma questo accadrà se i palestinesi saranno inclusi, e non solo scavalcati, nel processo di normalizzazione.
Pensa che Biden revocherà questi accordi, allora? E che farà lo stesso con spostamento dell’ambasciata americana a Gerusalemme da parte di Trump?
Non credo che Biden revocherà gli accordi di Abramo, né il trasferimento dell’ambasciata americana a Gerusalemme. È abbastanza chiaro che la capitale di Israele è Gerusalemme: il grande errore è stato ignorare l’aspirazione palestinese a una propria capitale. Quello che Trump avrebbe dovuto fare era, sì, spostare l’ambasciata a Gerusalemme, ma dichiarare che voleva anche un’ambasciata a Gerusalemme Est, nella capitale palestinese. Questo potrebbe farlo Biden.
Alcuni ritengono che le azioni di Hamas siano orchestrate dall’Iran. Altri sostengono che Hamas stia agendo autonomamente, con dinamiche interne più che internazionali. Lei cosa ne pensa?
A molte persone piace spiegare le cose come parte di una grande cospirazione. Le cose sono molto più semplici di così. Prima di tutto, Hamas e l’Iran sono molto diversi. L’Iran, per esempio, è un paese sciita guidato da sciiti che vogliono esportare la rivoluzione sciita iraniana in altri paesi, mentre non ci sono sciiti tra i palestinesi. Naturalmente esistono alcuni interessi comuni: sia l’Iran che Hamas vogliono combattere Israele, entrambi sono antiamericani e antioccidentali. Possono anche verificarsi degli eventi sporadici, come il recente drone iraniano al confine con la Giordania, ma credo che gli ultimi eventi siano stati molto più locali e sicuramente non architettati dall’Iran, che ora è occupato con le elezioni e non è interessato alla questione palestinese.
Uno degli aspetti più sorprendenti di questo conflitto è stata l’esplosione di violenza tra ebrei israeliani e arabi israeliani, anche in zone dove la coesistenza era stata pacifica per molto tempo. Quali conseguenze avranno questi scontri in futuro?
Penso che questo debba essere un campanello d’allarme per Israele rispetto a come trattare le sue minoranze arabe. Israele dovrà trattare la sua popolazione araba in modo più serio ed equo, per non lasciare che gli estremisti si impadroniscano della situazione. Ma questo dipende molto dalla futura leadership israeliana. Se Netanyahu e i suoi amici fascisti guideranno il paese, non ci sarà alcun miglioramento, e le cose potranno solo peggiorare.
Parliamo allora di leadership. Secondo lei cosa comporterà questo conflitto nela leadership israeliana?
È molto difficile prevedere il futuro: ci sono molte nuove dinamiche in atto, e le cose sono molto meno lineari di prima. Lo scenario più probabile è che Israele organizzerà le elezioni per la quinta volta e che la frangia estremista e razzista della politica israeliana guadagnerà molto potere, anche grazie al contributo di partiti di destra che prima erano più collaborativi con la sinistra. Tuttavia, spero anche che la sinistra esca più forte da questa crisi: nel centro-sinistra, per esempio, Yahir Lapid ha guadagnato molta saggezza e ha imparato a fare politica. Spero davvero che riesca a formare una coalizione contro Netanyahu e i partiti ultraortodossi.
E la leadership palestinese?
Il cambiamento arriverà, prima o poi. Spero che le forze moderate riescano a formare una leadership congiunta: finchè saranno divise, questo giocherà a favore di Hamas. Inoltre molto dipende da noi, da Israele, dagli Stati Uniti, dall’Europa, dalla comunità internazionale. Se aiuteremo nelle negoziazioni, se aiuteremo a raggiungere un qualche orizzonte di pace, questo rafforzerà i moderati. Se continuiamo a trascurare questo conflitto, non cambierà nulla. Il conflitto israelo-palestinese è come andare in bicicletta: se non si va avanti, si cade. È fondamentale che la comunità internazionale sostenga gli elementi più moderati della politica palestinese e sia d’aiuto: non dico trovando una soluzione a tutto, ma almeno aiutando nelle negoziazioni.
Come recuperare la prospettiva della soluzione dei due stati? Chi saranno i soggetti del cambiamento? Cosa deve fare Israele? In un recente articolo, lei ha scritto che “il governo israeliano deve dar forma a una politica completa per la questione palestinese, incentrata sulla diplomazia strategica con la leadership palestinese dedicata a trovare una soluzione al conflitto e che ci liberi da schemi futili e ripetitivi”. Ci può dire, più nel dettaglio, in cosa consiste questa politica?
Prima di tutto dobbiamo renderci conto che non esistono soluzioni militari a questo conflitto: anche l’esercito più forte del Medio Oriente – il nostro, che sta diventando sempre più forte – non risolverà nulla. I governi israeliani usano troppo spesso le Forze di Difesa Israeliane, ma questa non è la via d’uscita da questo conflitto. Hamas non scomparirà, anche se continuiamo a bombardarli. L’unico modo per sconfiggere Hamas è cominciare a negoziare con i palestinesi moderati – e non solo per il gusto di negoziare e per ottenere una certa legittimità internazionale, ma con delle negoziazioni che cerchino veramente di raggiungere la soluzione dei due stati. La soluzione esiste: abbiamo bisogno di una leadership moderata da entrambe le parti per attuarla. Shimon Peres diceva che, nel conflitto israelo-palestinese, abbiamo la luce e ci serve il tunnel. L’accordo è abbastanza chiaro, ed è scritto negli accordi dell’iniziativa di Ginevra del 2003:
- tornare ai confini precedenti al 1967
- avere una capitale palestinese a Gerusalemme Est con accordi speciali nella zona dei luoghi sacri, tramite cui tutte le religioni possano essere rispettate e si possa stabilire una forma di sovranità comune
- affrontare la crisi dei rifugiati palestinesi
- avere accordi di sicurezza regionale che coinvolgano altri paesi che vogliono stabilità.
La soluzione è lì, scritta sulla carta. Abbiamo solo bisogno della volontà politica di raggiungerla. E nell’era di Netanyahu, non abbiamo questa volontà politica. La maggioranza della gente sostiene la soluzione dei due stati. Una volta che ci sarà la leadership per andarci, avremo il sostegno del pubblico.
Qual è il ruolo di J-Street in questa fase?
J-Street è stata creata perché molti ebrei liberali e progressisti in America si sentivano poco rappresentati dalle maggiori e più note organizzazioni ebraiche. Da un lato J-Street è nata per accogliere persone pro-Israele e pro-pace. Dall’altro il nostro obiettivo è avere un impatto politico. Siamo un’organizzazione di advocacy e lobbying che cerca di influenzare la politica americana in Medio Oriente con valori di pace e diplomazia. Stiamo cercando di convincere l’amministrazione Biden ad essere più attiva e, nella sezione israeliana, stiamo lavorando per rafforzare la diplomazia israeliana orientata alla pace. J-Street si trova a metà tra la comunità ebraica e il partito democratico. Noi non pensiamo che Israele abbia sempre torto, così come non pensiamo che Israele abbia sempre ragione. Pensiamo che Israele debba imparare dai suoi errori e che l’America debba sostenere la pace e non la violenza. Crediamo che questa sia anche l’intenzione di Biden, ma gli manca lo spazio politico per agire in questo senso. Noi creeremo quello spazio politico.
Vuole mandare un messaggio a chi ci legge?
Il mio messaggio a tutte le persone che leggono questa intervista è: abbandonate lo scaricabarile e cercate un dialogo costruttivo. Abbiamo bisogno di un approccio comune alla soluzione dei problemi, in cui sia gli israeliani che i palestinesi possano unirsi per andare avanti. Per J-Street, questo significa fare pressione sulla politica americana. Per i paesi europei, questo significa rafforzare l’Unione Europea perché possa sostenere e fare pressione su Israele al tempo stesso. Se si fa solamente pressione, Israele si rifugerà – come sempre, purtroppo – nella retorica dell’antisemitismo. Con un incondizionato sostegno, invece Israele vi sarà per scontati. Fare entrambe le cose è la cosa giusta.
21 maggio 2021

Il piccolo partigiano ebreo. Storia di Franco Cesana, nome di battaglia Balilla
Era un ragazzino ebreo in fuga dalle persecuzioni razziali. Scelse la lotta armata, imbracciò uno Sten e fu ucciso dai tedeschi sei giorni prima di compiere 13 anni
Brunella Giovara – Repubblica 24 Aprile2021
Polinago (Modena)
Il ragazzo era su questa scala, e aveva uno Sten a tracolla. Aveva anche un grande segreto, e non l’ha mai detto a nessuno. Ma ogni cosa si polverizzò in un attimo e in un bagliore, era la sera del 14 settembre del 1944, una raffica tedesca lo prese in pieno, nel buio, nelle urla degli uomini sorpresi dall’imboscata, disse poi il suo comandante di aver gridato «tutti a terra!», e «appoggiai la mano sulla spalla destra del ragazzo affinché eseguisse più rapidamente il mio ordine. Ma egli si svincolò di scatto, e col suo corpo mi si buttò addosso».
Si chiamava Franco Cesana, nome di battaglia: Balilla. Nato a Mantova il 20 settembre 1931, sei giorni dopo avrebbe quindi compiuto i tredici anni. Il partigiano più piccolo d’Italia, o uno dei più giovani, medaglia di bronzo al valore militare, «adolescente pieno di slancio e di spirito patriottico…», eccetera.
E volendo tornare nel punto esatto in cui tutto questo è successo, si deve salire al gruppo di case di sasso a Picciniera, che è una borgata di Gombola, che è frazione di Polinago, in provincia di Modena. Appennino, sole e freddo, nei boschi il bianco dei ciliegi selvatici appena fioriti. Da un cortile esce Sandra Veratti, con una vecchia chiave in mano. «Mia mamma era presente al fatto. Si chiamava Maria Rosa Bonvicini, era del ’35».
Quella bambina restò scioccata, mentre guardava i partigiani raccogliere il cadavere di Franco, che stesero in questo oratorio della Beata Vergine del rosario. A fatica, Sandra apre il portone. È una pieve minuscola, con la croce arrugginita sul tetto, l’altare è corroso dall’umido, è tutto come nel 1944. Sei banchi, bastavano giusto per gli abitanti del borgo, costruito tra il 1400 e il 1500 dai conti Cesi, che lo usavano come base per le loro cacce. «Non si può entrare, è pericolante», ma lo stesso si vedono i quadri con le sante e le madonne, la volta è dipinta di azzurro. Il posto giusto per tenerci un morto, nel fresco delle pietre. Il ragazzo Cesana, però, era ebreo.
E questo era il segreto che aveva promesso alla madre di non dire mai. Nell’unica lettera rimasta, le scriveva «ti avverto che non ho detto quella cosa che mi hai fatto giurare». E «ti raccomando, appena ricevuta la mia, bruciala», le nuove regole della clandestinità che stava appena imparando. La madre conservò la lettera, la mise in una bottiglia che poi sotterrò nell’orto.
Anni dopo, Ada Basevi raccontò che di quel suo figlio le erano rimaste due cose: «Una penna, e una lampadina», forse intendendo una piccola torcia per vedere al buio, utile alla nuova vita di partigiano, e quindi fuggiasco. Ma fuggiasco era già un suo destino, e bisogna qui ricordare le migliaia di bambini che la guerra scaraventò su e giù per l’Italia, spesso soli. I genitori li allontanavano per salvarli dalla fame e dai bombardamenti delle città, affidandoli a parenti lontani, in campagna e in montagna, purché lontano. Le famiglie sfollavano e si disperdevano, i pochi telefoni non funzionavano. Vite piccole, sconosciute, randagie. Poi, c’erano bambini e ragazzi con l’aggravante razziale, che cercavano di scampare alle deportazioni, e quindi in fuga perpetua, finché non venivano presi e mandati ad Auschwitz.
I Cesana erano di Mantova, poi trasferiti a Bologna, il padre si chiamava Felice, e i tre figli Vittorio, Lelio e il minore Franco. Nell’unica foto, il bambino ha un piccolo sorriso, un cappottino di tweed, i capelli ricci. Di sicuro all’epoca dello scatto era già stato espulso da scuola, perché era ebreo. Forse era già orfano del papà, per cui la madre lo mandò all’orfanotrofio israelitico di Torino, che accoglieva ragazzi in difficoltà. Ci restò fino al 1941, quando la struttura venne chiusa. Dopo, venne mandato a Roma, come ricorda la cugina Ziva Grazia Modiano Fischer, 87 anni, già presidente nazionale dell’Associazione donne ebree d’Italia, scampata alla deportazione perché rifugiata a Tora, in provincia di Caserta, dove nessuno vendette gli ebrei. «Franco stava all’Istituto Pitigliani, di fronte alla sinagoga, poi chiuso nel ’42. I bambini vennero restituiti alle famiglie», chi l’aveva. La bambina Grazia andava a prendere il cugino Franco la domenica, «lo portavo a casa, così faceva finalmente una bella mangiata. Com’era? Un bambino vivace. Una volta venne punito perché aveva giocato a cuscinate con i compagni».
I Cesana tornano a Bologna, ma la caccia all’ebreo funziona già bene, 5mila lire per ogni cattura. Come tanti, sono ebrei erranti che si fermano qua e là, in una frazione di Serramazzoni, nella stalla di Casa Nuvola, poi a Casa Saldino, nel posto più sperduto della frazione Pescarola, a Prignano sulla Secchia. Qui, ci sono i partigiani. Questo è l’arcangelico regno dei partigiani, Fenoglio chiamava così le Langhe, era così anche la libera repubblica di Montefiorino, che in linea d’aria non è lontano da qui, così come lo è Marzabotto.
Un piccolo libro ha ricostruito la vita breve di Balilla (Dalle leggi razziali al sacrificio di Franco Cesana), fatto prima della pandemia dagli studenti di terza media dell’Istituto Francesco Berti di Prignano, aiutati dai prof Ballesi e Ferrari, dall’Anpi e dalla Comunità ebraica. Nato dalla domanda «ma lo sapete che da queste parti è stato ucciso un ragazzino come voi?», i coetanei di oggi hanno ricostruito le divisioni partigiane, le zone dei comunisti, dei Giustizia e libertà, dei democristiani, chi erano i capi, i rastrellamenti. Uno dei comandanti era “Marcello” Catellani, monarchico, ex ufficiale dell’esercito. Nella guerra contro la Francia era stato ferito a un braccio, che poi gli avevano amputato. In cambio, aveva ricevuto la visita di Mussolini, e poco dopo cambiava idee, riferimenti, saliva in montagna e formava una banda.
Lì arrivò il fratello di Franco, Lelio, e dopo un po’ anche Franco: «Fra gli uomini di Marcello vi è un ragazzetto di circa 12 anni. Si era aggregato alle formazioni azzurre dicendo di non avere famiglia», scrisse poi il partigiano “Roberto”. E il comandante: «Data la sua intelligenza e vivacità poteva essere un ottimo portaordini in momenti delicati. A malincuore, ma tanto era stato il suo entusiasmo, avevo aderito che portasse con sé uno Sten» (le testimonianze sono nel libro La storia mai scritta del Comandante Marcello di Terenzio Succi e Franco Adravanti, editore Youcanprint).
«Franco aveva preso una decisione importante: diventare partigiano», dice Barbara Orlandi, che ha partecipato alla ricerca con i suoi compagni di classe. Era così giovane, «ma aveva fatto una scelta. Era anche uno bravo a scuola», che peraltro gli era proibita. E anche quel soprannome: Balilla. Il balilla non lo aveva mai fatto, proibito anche questo in quanto «appartenente alla religione ebraica».
Quindi, immaginatevi il ragazzo che, un giorno di quel settembre, esce di casa per andare a prendere il latte in una cascina vicina, e invece scappa in montagna. Arrivò alla Picciniera «stanco morto, ma mi feci coraggio e mi presentai. Dopo un po’, l’occasione di entrare a far parte della formazione Marcello. Sei contenta?», scriveva alla mamma. «Fui assunto, e siccome ho studiato, fui dislocato al comando. Non devi impensierirti per me che sto da re. La salute è ottima, solo un po’ precario il dormire».
Gli consegnarono lo Sten, possiamo immaginare l’orgoglio. Era felice? Probabilmente sì. Arrivò quel «crepitio di armi automatiche contro il retro della casa», il gesto istintivo di proteggere il suo comandante, che aveva un braccio solo. Faticarono a seppellirlo. Con tanti preti partigiani nella zona, quello di Pescarola rifiutò di metterlo nel cimitero del paese. Poi lo obbligarono, e solo così Franco andò sotto terra.

Carlo Cammeo, le sue scelte un atto d’amore per la vita
Il 13 aprile del 1921 veniva ucciso a Pisa l’insegnante Carlo Cammeo. Ebreo, militante socialista, fervente antifascista.
Il centesimo anniversario dal suo assassinio è stata l’occasione di una solenne cerimonia svoltasi alla presenza, tra gli altri, del sindaco Michele Conti.
Carlo Cammeo è stato assassinato 100 anni fa nel giardino della scuola dove insegnava, e nonostante sia trascorso un intero secolo il messaggio del suo sacrificio è oggi più che mai attuale e carico di significato.
La sua vita fu improntata ai valori dello studio e sacrificata a quello della libertà, così come testimonia il suo epitaffio: “Per sicaria mano fascista cadeva assassinato il 13 aprile 1921, Carlo Cammeo glorificando con il sangue la santità della scuola e la sua fede nell’idea socialista”.
A sintesi di questo tutt’oggi si possono vedere sulla sua tomba i simboli dei principi che ressero la sua esistenza: un libro aperto, che rappresenta l’amore per lo studio e per la sua professione di maestro, e una falce e martello, a testimonianza della sua fede politica.
Forse, unica testimonianza in Italia di questi simboli, incisi su una pietra tombale.
Pochi sanno che negli anni Trenta la Comunità fu obbligata a cancellare tali simboli perché ritenuti sovversivi, ma nel 1945 la famiglia li fece scolpire nuovamente.
Questo atto porta con sé il messaggio profondo di amore per la vita, per lo studio e per la libertà che oggi viene celebrato insieme alla figura di questo nostro illustre concittadino e correligionario.
Questo assassinio, agli occhi del partito fascista che stava nascendo, rappresentava la giusta “punizione” per chi si era espresso contro la violenza delle camicie nere che, in quella primavera, imperversava in Toscana e in tutta Italia.
Quel fascismo che 17 anni dopo metterà al bando tutti gli ebrei italiani attraverso le infami leggi razziste firmate da re Vittorio Emanuele III proprio a Pisa, nella tenuta di San Rossore.
Maurizio Gabbrielli, presidente Comunità ebraica di Pisa

“Un’ora di dolore per il proletariato pisano”
Il 13 aprile 1921 viene assassinato Carlo Cammeo (1897-1921), segretario provinciale del Partito Socialista e maestro elementare di soli 24 anni, colpevole di aver scritto articoli antifascisti. Quella mattina Mary Rosselli-Nissim e Giulia Lupetti si recano alla scuola dove sta insegnando Cammeo e, con una scusa, lo invitano a uscire dalla classe: nel cortile viene raggiunto da due colpi di pistola, sparati dal fascista Elio Meucci, studente di farmacia. Le due donne non sono figure “anonime”: la Lupetti (per i suoi meriti sarà nominata segretaria del fascio femminile) è figlia del comandante del presidio militare; Mary Rosselli-Nissim è una signora in là con gli anni, erede di una famiglia di sentimenti patriottici, il padre Pellegrino Rossi, di sentimenti mazziniani, e la madre, Janet Nathan, avevano ospitato nella propria casa Giuseppe Mazzini negli ultimi anni della sua vita. I fascisti responsabili della morte di Cammeo, grazie alla complicità delle autorità e all’interessamento del sottosegretario alla giustizia Arnaldo Dello Sbarba, saranno prosciolti dall’accusa di omicidio. In quel periodo, la guerra civile scatenata dai fascisti fu risposta politica e militare alle lotte del “Biennio rosso” (1919-1920). La Toscana nei primi mesi del 1921 fu attraversata da uno scontro violentissimo tra le squadre di fascisti, organizzate dalla direzione fiorentina del movimento, e le forze della sinistra, anarchici, comunisti, socialisti e sindacalisti.

Baltico
Di Stefano Jesurum , pubblicato in Moked il 15/04/2021

Legati al mondo scomparso che gli scrittori yiddish e i fotografi alla Roman Vishniac hanno fatto rivivere e tanto amare, probabilmente non credo si sia sufficientemente razionalizzato, contestualizzato, introiettato un universo certamente meno – poco o per nulla – mistico, religioso, ortodosso, ma non per ciò meno potentemente intriso di ebreitudine. Certo, molti sanno, per dire, che la “scuola di Odessa” ha regalato al mondo alcuni tra i più grandi violinisti di sempre – Heifetz, Milstein, Zimbalist, Elman, Oistrakh e Kogan – oppure, chessò, che Claudio Magris ha riempito pagine indimenticabili descrivendo la simbiotica culla jüdische-mitteleuropea di tanta letteratura. Però è leggendo un libro non recentissimo dell’olandese Jan Brokken che mi si sono aperte finestre finora rimaste chiuse per ignoranza (“Anime baltiche”, traduzione Claudia Cozzi e Claudia Di Palermo, 472 pagine, Iperborea). In realtà l’autore ci guida in uno stupefacente tour attraverso Lettonia, Estonia, Lituania, per le strade e le piazze di Riga, di Vilnius, di Kaliningrad, di Tallinn, nella vita di nuclei familiari, storie nella Storia, tormentate vicissitudini di stati passati dall’indipendenza al dominio russo e poi tedesco per ritornare sotto l’Unione Sovietica, fino alla agognata indipendenza. Ambienti, culture, “sentire”. Anime, appunto, rimaste tali anche nelle fughe oltre confine.
Così Brokken ricostruisce esistenze straordinarie di donne e uomini celebri e di persone comuni attraverso il viaggio in una terra invasa e contesa, dove la violenza del passato è stata combattuta con l’arte, la poesia e la musica. Gidon Kremer e il suo violino, Roman Kacev di Vilnius, per noi Romain Gary, lo scultore Jacques Lipchitz, Hannah Arendt di Kaliningrad, il pittore Mark Rothko (Rothkowitz prima dell’emigrazione), Chaïm Soutine, parecchi altri i cui nomi non sono divenuti famosi. Brevi periodi di fasti, fughe, nascondigli, quartieri rasi al suolo, famiglie cancellate. In gran parte ebrei. Con i loro bambini, la loro privacy, i traumi infantili, le vicende sentimentali, i successi e le sconfitte. Con un legame nascosto ma evidentemente indissolubile con chi era già qui scappato ai pogrom. Si diceva, i mondi scomparsi…
Stefano Jesurum
Jan BROKKEN

Scrittore e viaggiatore olandese, noto per la capacità di raccontare le vite di personaggi fuori dal comune e i grandi protagonisti del mondo letterario e musicale, ha pubblicato numerosi libri che la stampa ha avvicinato a Graham Greene e Bruce Chatwin, come Jungle Rudy, il suo primo successo internazionale. Iperborea ha inoltre pubblicato Nella casa del pianista, sulla vita di Youri Egorov, Il giardino dei cosacchi, sul periodo siberiano di Dostoevskij, il bestseller Anime baltiche, viaggio in un cruciale ma dimenticato pezzo d’Europa, Bagliori a San Pietroburgo, dedicato alla grande città della musica e della poesia russa, e I Giusti, reportage sull’operazione di salvataggio del 1940 che coinvolse più di ottomila ebrei.

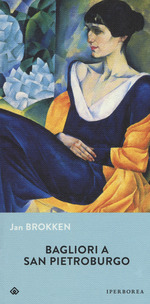

«Ora un governo d’emergenza senza Netanyahu per far ripartire Israele»
Parla a Reset la neo-leader dei laburisti israeliani Merav Michaeli , intervista di Umberto De Giovannangeli
30 marzo 2021
«Israele non può rimanere ostaggio di una sola persona che concepisce la carica di Primo Ministro come una investitura regale che lo pone al di sopra di tutto e di tutti, perfino della Legge. Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo ribadisco oggi: Benjamin Netanyahu è un pericolo per il nostro sistema democratico. E lo è non in quanto uomo di destra ma per la sua concezione autocratica della democrazia e per la praticata volontà di smantellare le fondamenta di uno stato di diritto». Ad affermarlo, in questa intervista esclusiva concessa a Reset è la leader del Partito laburista israeliano, Merav Michaeli.
Nelle elezioni del 23 marzo scorso, le quarte in due anni, il partito che fu di David Ben Gurion, Golda Meir, Yitzhak Rabin e Shimon Peres era a rischio estinzione. Grazie ad una campagna elettorale aggressiva e ad una empatia riconosciutale anche dagli avversari, Michaeli è riuscita a riportare il Labor alla Knesset con 7 seggi. E un buon risultato è stato ottenuto anche dall’altra forza della sinistra israeliana, Meretz (6 seggi). «Considero il risultato che abbiamo ottenuto – rimarca la leader laburista – come una base di partenza per un nuovo inizio della sinistra. Dobbiamo andare avanti sulla strada del rinnovamento sapendo che ci vorrà del tempo perché questa semina dia buoni frutti. Al tempo stesso, però, dobbiamo fare i conti con il presente e con la necessità di dare al Paese un governo stabile, in grado di affrontare la grave crisi pandemica non solo portando a termine la campagna di vaccinazione ma affrontando le drammatiche ricadute sociali che questa crisi ha prodotto. Il nome del premier viene dopo. Basta con i personalismi, è una pratica che abbiamo già pagato a caro prezzo».
Coalizioni a geometria politica variabile. Trattative frenetiche per raggiungere i 61 voti necessari per ottenere una maggioranza di governo alla Knesset. Numeri alla mano né il blocco pro-Netanyahu né quello anti-Bibi hanno quei numeri. E c’è già chi paventa il rischio di nuove elezioni, le quinte in poco più di due anni, un record planetario. Israele è condannato ad elezioni permanenti?
I numeri sono molto in politica. Molto ma non tutto. Se ragioniamo in termini classici, quelli di una divisione destra/sinistra, dovremmo, noi di sinistra, metterci il cuore in pace e dire agli altri: fate voi, vediamo di cosa siete capaci. Ma questo non è fare politica, al più è una mera testimonianza di chi non intende sporcarsi le mani.
Il che significa stringere anche un patto col “diavolo” pur di liberarsi da Benjamin Netanyahu. Anche se quel “diavolo” risponde al nome di Naftali Bennett, il leader di Yamina?
In questa storia, per usare la sua metafora, non vi sono né angeli né demoni. Ma c’è un pericolo superiore a tutti gli altri, questo sì. E questo pericolo si chiama Benjamin Netanyahu. Israele non può rimanere ostaggio di una persona che ha identificato i destini di un Paese con i suoi personali. Un politico che pur di ottenere l’immunità di fronte alla Legge ha promesso mari e monti pur di restare al potere e che non ha esitato neanche un secondo a far cadere il governo di cui era Primo Ministro quando non gli è stata garantita una legge che lo mettesse al riparo dai processi in cui è imputato. Netanyahu ha costretto gli israeliani ad andare al voto in piena pandemia, senza che la Knesset avesse approvato la legge di bilancio necessaria per dare risposte immediate alle drammatiche conseguenze sociali ed economiche determinate dal Covid-19. So bene che in tempi normali un fronte progressista e di sinistra dovrebbe porsi in alternativa alle destre. Dobbiamo ricostruire le condizioni perché questa dialettica democratica possa svolgersi, ma oggi siamo in piena emergenza. Una emergenza democratica, non solo sanitaria. E a determinarla è stato il capo del Likud. Ma il voto ha detto che gli israeliani non l’hanno incoronato re. Netanyahu non è il monarca assoluto d’Israele, anche se lui pensa e agisce come se lo fosse. Voleva conquistare la maggioranza assoluta con i suoi partiti-vassalli, ma non gli è riuscito. Ora le sta provando di tutte. E se non gli riuscirà, è pronto a nuove elezioni. Il suo cinismo non conosce limiti.
La politica non è solo questione di numeri, ma i numeri determinano maggioranze e minoranze. Pur di porre fine all’era Netanyahu fin dove è disposta a spingersi?
Questi sono giorni di trattative e non è ancora tempo di tirare le somme. Di certo, non ci siederemo a discutere con gli eredi di Meir Kahane, il partito del sionismo religioso (6 seggi, ndr). La loro presenza nel Parlamento è una macchia per Israele. Certo, una democrazia deve rispettare il voto popolare, ma il fatto che della Knesset facciano parte personaggi dichiaratamente razzisti, omofobi, che considerano eroi assassini come Yigal Amir (il giovane zelota che uccise il premier laburista Yitzhak Rabin, ndr), questo, lo ribadisco, è un campanello d’allarme che non va sottovalutato. Quanto al resto, in campagna elettorale leader di destra come Bennett, Lieberman (Israel Beitenu, 6 seggi, ndr) e Sa’ar (Tikvà Hadashà, 6 seggi, ndr) si erano espressi, pur con diverse modulazioni, per un governo post-Netanyahu. Noi siamo rimasti dello stesso avviso anche a urne chiuse: coerenza vorrebbe che si ripartisse da questo punto.
I dirigenti del Meretz hanno fatto un endorsement pubblico a favore di Yair Lapid (leader del partito laico centrista Yesh Atid, secondo con i suoi 17 seggi dietro al Likud di Netanyahu con 30) come premier incaricato. Lei non si è pronunciata. Vuole tenersi le mani libere?
Niente di tutto questo. Indicare subito il premier di una coalizione tutta da costruire vuol dire partire con il piede sbagliato. È una storia già vista nelle precedenti elezioni. E non ha portato bene al fronte anti-Netanyahu e, soprattutto, a colui che era stato indicato come premier in pectore (Benny Gantz, leader di Kahol Lavan, che dai 35 seggi delle passate elezioni è tracollato a 8, ndr). Da parte nostra non c’è alcuna preclusione verso Lapid né consideriamo ininfluente il fatto che il suo partito sia il secondo più votato, e che Lapid ha rotto l’alleanza con Gantz quando quest’ultimo scelse di andare al governo con Netanyahu. I tavoli sono aperti, vediamo chi è d’accordo su un programma essenziale, fatto di pochi punti, su cui costruire una maggioranza di governo. E solo dopo indichiamo la persona più adatta a guidare l’esecutivo. A me pare un percorso corretto, lineare, privo di scorciatoie.
Su questioni non secondarie, come la colonizzazione della Cisgiordania, le posizioni di Bennett non sono certo più moderate di quelle di Netanyahu, anzi. Come la mettiamo?
La mettiamo che con Bennett è possibile discutere su come riportare Israele ad essere un Paese normale dove destra e sinistra si sfidano apertamente accettando però un perimetro comune: quello dello stato di diritto. Un perimetro fatto di regole condivise, del rispetto degli altri poteri, a cominciare da quello giudiziario. Un perimetro che Netanyahu ha violato, trasformando le quattro elezioni anticipate in un referendum su se stesso, denunciando inesistenti complotti contro di lui, invocando l’investitura popolare come un salvacondotto per non essere giudicato in un aula di tribunale. Quello a cui penso è un governo di emergenza democratica, nazionale, che duri il tempo necessario per uscire dall’emergenza sanitaria e per dare risposta alle decine di migliaia di famiglie, di lavoratrici e lavoratori, che la pandemia virale ha messo in ginocchio. Affrontiamo questa emergenza e poi ristabiliremo le distanze…
Lei è riuscita a non far scomparire il Labor dalla geografia parlamentare israeliana. Resta il fatto che sommando i seggi del suo partito, quelli del Meretz (6) e quelli della Joint List araba (6), le forze di sinistra raggiungono i 19 seggi. Se a questi sommiamo quelli di formazioni centriste come Kahol Lavan (8) e Yash Aitid (17) arriviamo a 44. Non calcoliamo nel fronte opposto i 4 seggi della Lista araba unita che si è scissa dalla Joint List. Il dato politico che ne esce è però inquietante: 72 dei 120 seggi sono di partiti di destra.
Vede, la cosa peggiore non è sentirsi minoranza ma è agire come se non lo fossi puntando sempre e comunque a stare al governo. Parlo per il mio partito, non intendo impartire lezioni a nessuno. La prima cosa che ho fatto dopo aver vinto le primarie è stata quella di chiedere ai due ministri laburisti che facevano parte del governo Netanyahu, di scegliere tra restare ministri e rimanere nel partito. Tenere i piedi in due staffe avrebbe intaccato ciò che restava della nostra credibilità. Hanno scelto di chiamarsi fuori dal partito, una scelta che ho rispettato e che ha fatto chiarezza. Il Labor è stato ininterrottamente, praticamente da solo, al governo di Israele dalla fondazione dello Stato nel 1948 al 1977, quando per la prima volta a vincere fu il Likud di Menachem Begin. Sappiamo l’importanza di guidare una nazione, lo abbiamo fatto in momenti cruciali per l’esistenza stessa d’Israele. Ma stare all’opposizione non è una condanna a morte. La condanna a morte è quando il sistema democratico è minato dall’interno.
Lei ha conquistato molti consensi tra le donne, promettendo una “rivoluzione rosa”. Manterrà questo impegno?
Assolutamente sì. Perché una democrazia si può dire davvero compiuta quando la parità di genere non è più una conquista ma una premessa. Nell’ultimo decennio le disuguaglianze sociali sono aumentate e le donne ne sono state le principali vittime. Pezzi di welfare sono stati smantellati da politiche iper liberiste che hanno allargato la faglia sociale, in settori cruciali come la sanità, l’istruzione, le opportunità per le giovani coppie, il sostegno alle madri single e agli anziani. La violenza domestica è aumentata e tante donne si sono ritrovate senza protezione. Una situazione intollerabile oltre che profondamente ingiusta.
Per ultimo, una confessione personale: c’è stato un momento in cui ha pensato di non farcela e di essere ricordata negli annali di storia come il primo leader del glorioso Labor estromesso dalla Knesset?
No, neanche nei peggiori incubi. Ma è stata dura, questo sì. Ed ora dobbiamo rimboccarci le maniche perché c’è tanto lavoro da fare. Ma la sinistra c’è, esiste, anche oltre i voti presi. E questo è un bene per Israele.

Le opinioni : i fascisti entrano nel Parlamento israeliano
Gideon Levy – Haaretz
Una coalizione che in Europa sarebbe considerata neonazista è appena riuscita ad entrare nelle knesset, il parlamento israeliano. Non c’è altro modo per descrivere l’alleanza tra i partiti di estrema destra HaTzionut HaDatit (Sionismo religioso), Otzma yehudit (Potere ebraico) e Noam. Xenofobia, omofobia e nazionalismo, uniti a fondamentalismo religioso e violenza: come definirla altrimenti? Nessun paese dell’Europa occidentale avrebbe avuto il coraggio di formare un governo con un partito simile. In Europa questo fascismo sarebbe inaccetabile. In Israele sta per entrare a far parte del prossimo governo.
Ma non è questa la notizia peggiore della notte elettorale del 23 marzo. Il vero problema è che la destra, come al solito ha trionfato. Tutti parlano del risultato del Likud, il partito di Benjamin Netanyahu, ma la vera vincitrice è la destra israeliana. Ancora una volta ha stracciato tutti: più di settanta deputati della prossima legislatura saranno orgogliosi rappresentanti della sua la dura e spietata. Una maggioranza più salda di qualunque possibile coalizione.
Il fatto che qualcuno anche a destra disprezzi Netanyahu non lorende meno di destra. Prima e dopo l’attuale ministro, queste persone rappresentano un Israele violento, arrogante e isolato che ignora il resto del mondo. Anche nel campo contrapposto ci sono persone di destra che si fingono centriste, ma anche escludendole dal conteggio la maggior parte del parlamento è schierato da quella parte. Tra la confusione e i calcoli sui blocchi che potevano essere contro o a favore di Netanyahu si è perso di vista il fatto che Israele si è dimostrato ancora una volta un paese di destra. L’ingressodi Sionismo religioso e degli altri partiti della lista in parlamento e l’identità dei suoi memebri stanno causando un polverone nel campodegli sconfitti, ma è un atteggiamento falso e ipocrita. E’ un bene che l’opposizione si stia svegliando, ma come al solito lo fa troppo tardi. Certo, pensare a persone come Itamat Ben-Gvir,leader di Potere ebraico, eOrit Strock, del partito sionista Casa ebraica,all’interno della Knesset è terrificante. Ma è facile attribuire solo a loro quello che molti altri, considerati molto meno sgradevoli, in realtà pensano,dicono e fanno.
Ben-Gvir dice cose che molti israeliani pensano, anche se non hanno votato per lui. Il governo e l’esercito stanno già realizzando molti degli obiettivi del partito più nazionalista della ventiquattresima legislatura. Perciò l’ingresso in parlamento di Sionismo religioso non è necessariamente una cattiva notizia. Perché renderaà evidenti nella loro forma più crudale intenzioni nascoste, e forse risveglierà finlemnte l’opposizione. E’ facile essere inorriditi da un razzista come Ben-Gvir, condannato per istigazione alla violenza, ma lui ha più biosgno di spaventare nessuno. Quello che fa davvero paura è che Israele già da un bel pò di tempo sta mettendo in pratica le sue idee politiche. Perciò è un ipocrita chi inorridisce per la sua elezione ma non ha battuto ciglio quando l’esercito israeliano sparava in testa ai manifestanti disarmati, come è successo il 19 marzo.
Nessuno rimane sconvolto quando ogni settimana i soldati fanno irruzione nelle case dei palestinesi e trascinano via le prsone dal loro letto; quando ogni giorno i coloni usurpano altre terre e aggrediscono i contadini con catene, quad, droni e armi e nessuno li incrimina; né quando Israele tiene due milioni e mezzo di persone nella prigione di Gaza in condizioni orribili.
Ora i sostenitori di tutte queste atrocià saranno in parlamento. E’ un bene che l’aula possa scoltare quel che hanno da dire, e che ilmondo possa sentire. Non è da queste lezioni che hanno ottenuto legittimità: gli è stata data tempo fa da una maggioranza di israeliani che li approva tacitamente. Sarà alquanto spiacevole sentir discutere in paralamento di “trasferimenti” (cioè della cacciata dalle loro case) dei palestinesi, ma è questo che lo stato fa già nella valle del Giordano, a Silwan e nel sud delle colline di Hebron.
E’ un bene che la lettera ebraica tet, la prma della parola “trasferimenti” e simbolo del partito Sionismo religioso, prenda posto nella knesset accanto alla foto del padre del sionismo Theodor Herzl. E’ proprio questo che lo stato da lui immaginato ha fatto fin dal 1948, a volte lontano da sguardi indiscreti.
Gideon Levy
è un giornalista israeliano. Scrive sul quotidiano Haaretz, dove è uscito questo articolo
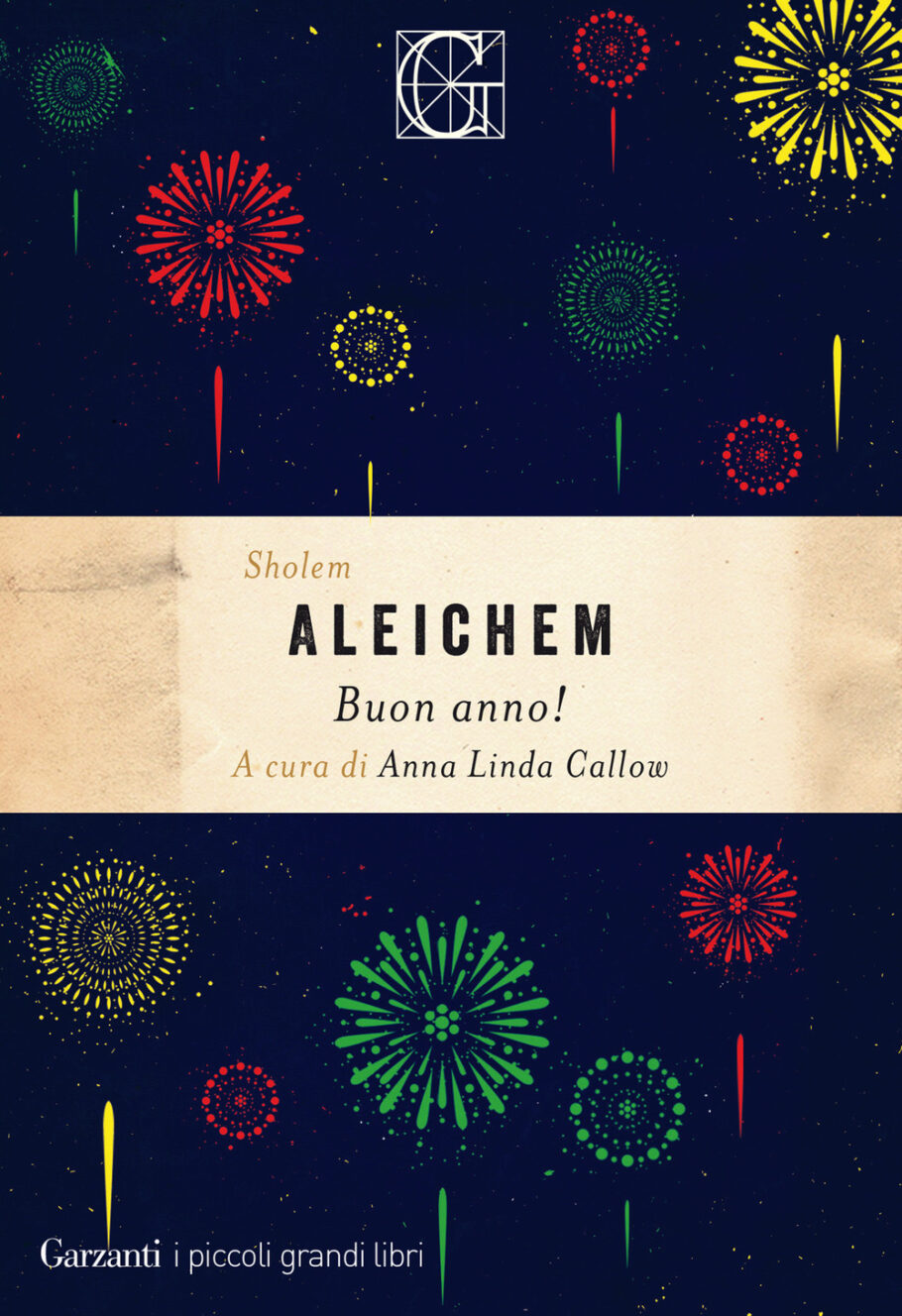
BUON ANNO” DI ALEICHEM, UN TRENO A VAPORE CHE CI PORTA IN UN TEMPO PERDUTO
Stefano Jesurum 21 Febbraio 2021

Sono svariati – non tutti degni di vanto – i motivi per cuida sempre gli amici mi chiamano bonariamente l’orso ebreo, e ben da prima che comparisse il mitico sergente Donny Donowitz di “Inglorious Basterds”. Una delle ragioni di questo simpatico soprannome è l’inveterata tenacia con cui durante un viaggio, lungo o breve che sia, in treno o in aereo, non rivolgo rigorosamente la parola ai casuali vicini di posto, né tanto meno cedo a eventuali loro tentativi di conversazione. Che tuttavia spesso ascolto senza isolarmi nelle cuffie e, anzi, spiando con immensa speranzosa curiosità storie che nella stragrandissima maggioranza delle volte non valgono alcunché. Ed ecco che, bizzarra ironia della sorte, Anna Linda Callow mi regala un libriccino destinato a farmi pentire di un’ormai lunga esistenza così, appunto, orsesca.

Perché “Buon anno!”, quattro racconti brevi di Sholem Aleichem, tradotti e curati per Garzanti dalla suddetta Anna con l’apporto di Franco Bezza e Haim Burstin, ti fa invece accomodare sulla carrozza d’un vecchio treno a vapore che collega alcuni shtetl dell’yiddishland (se ne avete la possibilità, immergetevi nelle parole e nei suoni tenendo sulle ginocchia le meravigliose immagini di “Un mondo scomparso” di Roman Vishniac) e ti rende partecipe delle storie incredibili e folli narrate al suo pubblico ferroviario dal commesso viaggiatore alter ego di Aleichem.

Scrittore di cui – credo – non sia necessario riassumere né la grandezza né la torrenziale vastissima produzione (un titolo per tutti “Tewje il lattaio”).Universi chagalliani e rabbini, personaggi di ogni genere e varietà, riti religiosi, tradizioni familiari, trame tanto fantastiche quanto semplici, reali, sovente ironiche. In questi quattro cammei poi, redatti tra il 1900 e il 1915, protagonisti possono essere perfino una vecchia pendolae una lezione di violino. L’immensa dolcissima nostalgia per un universo irripetibile. Vorrei poi aggiungere che in un breve passaggio de “La pendola” c’è – secondo me –una delle più semplici, profonde raffigurazioni di quel segreto tutto ebraico di concezione del tempo/non tempo che tanto unisce e rinsalda ancor oggi – da sempre – gli ashkenaziti e i sefarditi, i laici e i religiosi, gli osservanti e i poco o nulla credenti… «(su quell’orologio. NdR) quasi mezza città regolava i propri doveri religiosi: la commemorazione della distruzione del Tempio, la sveglia per le preghiere mattutine, il rito del pane del venerdì, la benedizione delle candele, l’accensione del fuoco all’uscita del sabato, la salatura della carne e tante altre cose di questo genere che riguardano la vita ebraica». Insomma quella sorta di appartenenza a un mondo che non c’è più, ma a un popolo che vive.
Stefano Jesurum

Evento 11 febbraio 2021: Israele torna al voto. Tutti gli scenari
L’evento si è svolto via Zoom e ha visto la partecipazione di circa 40 persone collegate da tutta Italia e da Israele.
La serata di approfondimento della politica israeliana era moderata da Gabriele Eschenazi che nella sua introduzione ha dedicato un affettuoso ricordo dei coniugi Rina e Nedo Fiano, scomparsi da poche settimane, che hanno dato tanto all’ebraismo italiano con la loro testimonianza.

Ha quindi introdotto i due relatori: Aldo Baquis, giornalista, e Roberto Della Rocca, esponente del partito Meretz, entrambi collegati da Israele, ed ha posto loro il tema della serata: quali scenari, quali protagonisti, cosa succede a Sinistra in Israele in vista delle prossime elezioni del 23 marzo prossimo.
Aldo Baquis, nel riportare l’atmosfera politica che si respira in Israele in vista delle elezioni, ha sottolineato come il corona virus resti il maggior assillo degli israeliani, nonostante la grande campagna di vaccinazione. Destano preoccupazione le notizie tendenziose sugli effetti dei vaccini diffuse sulle reti sociali che le Autorità sanitarie cercano di contrastare. La partita è ancora in bilico malgrado 3,5 milioni di persone già vaccinate con la prima dose e 2,2 milioni con la seconda dose. Se Netanyahu sperava di utilizzare la carta della vaccinazione di massa e l’uscita dalla crisi primi al mondo come argomenti elettorali, sembra un obiettivo non ancora raggiunto a causa del livello di nuovi contagi ancora elevato, anche per effetto delle nuove varianti, e la situazione degli ospedali pieni di pazienti anche gravi. Il governo è impegnato in una battaglia severa ed in particolare il Ministero della Sanità ha chiesto che l’uscita dal lockdown e la riapertura delle scuole siano molto prudenti e graduali.

In questo contesto di apprensione e di vigilanza nei confronti degli sviluppi della pandemia si innesta un’altra questione in qualche modo legata alle elezioni ed è il comportamento della minoranza araba e degli ebrei ortodossi. In entrambe queste comunità, che hanno dimensioni abbastanza rilevanti, il tasso di vaccinazione non è elevato, si notano infrazioni ed un senso di sospetto verso le autorità. Di conseguenza ci sono tassi di contagio molto elevati in entrambe le comunità e si rilevano comportamenti di indisciplina. Questo è un elemento importante per chi andrà a votare, che ha notato nelle ultime settimane come il governo sia stato latitante nelle zone ortodosse non applicando le stesse misure restrittive che gli israeliani laici hanno dovuto osservare, come le scuole chiuse, mentre le scuole religiose e le sinagoghe restavano aperte. I partiti ortodossi sono alleati importanti di Netanyahu e quindi si è creato un clima antipatico verso la minoranza ortodossa che si sente al di fuori della solidarietà nazionale.
Un altro argomento è il futuro delle relazioni con gli Stati Uniti. Crea qualche apprensione il fatto che Biden non abbia ancora parlato con Netanyahu. L’ex ministro del Likud Gilad Erdan, senza alcuna esperienza diplomatica, è stato nominato nuovo ambasciatore sia a Washington sia all’Onu, fatto inusuale per la diplomazia. C’è il timore che Biden sia più morbido nei confronti dell’Iran, che si teme possa entro due anni disporre della bomba atomica, e Netanyahu spinge su Biden per mantenere le sanzioni ed evitare che recuperi gli accordi di Obama. I programmi nucleari iraniani restano fonte di grande preoccupazione e le Forze Armate hanno avuto ordine di preparare piani di contingenza. E’ possibile che il Capo del Mossad Yossi Cohen venga inviato a Washington a breve per illustrare la situazione alla nuova amministrazione USA.
Inoltre ci sono tensioni al confine con il Libano perché si sta svolgendo una grande manovra militare israeliana.
La situazione sociale resta tesa con migliaia di disoccupati a causa della crisi economica dovuta alla pandemia ma il governo uscente non ha varato la legge finanziaria innescando la rottura dell’alleanza di governo con il partito Bianco Blu di Ganz. Il Likud nega ma è molto atipico che un ministro delle finanze non faccia passare la legge finanziaria. Come conseguenza molti validi funzionari hanno lasciato il ministero.
Parlando delle novità nelle liste dei partiti, sarebbe stato lecito pensare che dall’esplosione di energia generata dalle continue manifestazioni in tutto il paese dei dimostranti di sinistra per richiedere le dimissioni di Netanyahu sarebbe scaturito un forte sbocco per le elezioni di marzo ma così non è stato. Il tentativo di dar vita ad una forza unita di quattro liste (Labour, Meretz, con la nuova Lista di Ofer Shelah (ex Yesh Atid) annunciata a fine dicembre, e quella del sindaco di Tel Aviv Ron Huldai) non è maturato, con la conseguente rinuncia sia di Shelah che di Huldai.
Restano quindi in lizza il Labour e Meretz, oltre alla Lista Araba considerata parte della sinistra.
Il partito laburista emerge da una fase molto difficile perché alle scorse elezioni il leader Amir Perez aveva assicurato che non sarebbe entrato in un governo guidato da Netanyahu. Invece ha poi deciso di entrare con un ruolo marginale insieme ad un altro deputato diventato ministro. Questo pesante voltafaccia ha fatto perdere prestigio al partito laburista e le nuove primarie di gennaio sono state vinte da Merav Michaeli, un’opinionista molto presente nei media, TV, internet, social , che rappresenta una piattaforma progressista e femminista. In realtà la sua linea politica non è molto dissimile da quella del Meretz e un recente sondaggio dà il Labour in ascesa a 7 seggi, però a scapito del Meretz , che rischierebbe di restare fuori dalla Knesset.
A destra c’è un’inflazione di liste di ultradestra, con la novità di Nuovo Sionismo Religioso (Hazionut Hadatit) nata su pressione di Netanyahu e guidata dal leader dei coloni Bezalel Shmotrich e da Itamar Ben Gvir, esponente della scuola di pensiero del rabbino Kahane.
Il Kach del rabbino Kahane – che nel 1990 fu ucciso a New York in un attentato terroristico – era un movimento eversivo, dai toni esasperati e razzisti. Nel 1994, in seguito alla strage alla Tomba dei Patriarchi di Hebron compiuto da uno suo affiliato, Baruch Goldtsein, il Kach fu disciolto in quanto organizzazione terroristica.
Nel 1995 Ben Gvir – allora un militante molto giovane legato ad ambienti ex-Kach e accesamente ostile agli accordi di Oslo – partecipò a manifestazioni aggressive di protesta contro il governo Rabin, arrivando a minacciare il ministro della difesa Benyamin Ben Eliezer. In seguito, da avvocato, Ben Gvir ha difeso numerosi ultrà ebrei protagonisti in Cisgiordania di attacchi a danno dei palestinesi. Da allora sostiene di aver mantenuto un rispetto fondamentale verso la ideologia del rabbino Kahane e anche verso lo stesso Goldstein, ma di aver elaborato una propria ideologia in forma più pragmatica.

Ha poi completato l’analisi della situazione politica Roberto Della Rocca che ritiene che ci sia massima incertezza sull’esito delle elezioni ma è pessimista perché Netanyahu farà sicuramente di tutto per restare al potere per arrivare al processo come Primo Ministro, e cercherà di convincere ad entrare in coalizione Bennet, leader del partito nazionalista Yemina a destra del Likud che i sondaggi danno a 11-12 seggi. In realtà il confronto politico è una specie di referendum tra i partiti pro o contro Netanyahu, non c’è più destra o sinistra. La novità è il partito Tikvà Hadashà (Nuova Speranza) creato due mesi fa per raccogliere i voti di chi è scontento del Likud, trasformato da Netanyahu in un suo partito personale, da Gideon Saar, ex ministro dell’Educazione ed avversario interno di Netanyahu.
Questa lista è stimata in 13 seggi, contro i 28 del Likud e i 18 di Yesh Atid, la lista di Yair Lapid, dato secondo anche nei sondaggi con il 28% come più adatto a fare il Primo Ministro, dietro a Netanyahu al 38% e davanti a Saar sceso all’11%.
La soglia per accedere alla Knesset è 3,25% dei voti validi e garantisce 4 seggi. Se Meretz non dovesse passare, per effetto del recupero dei Laburisti, sarebbe la prima volta dalla sua fondazione quasi trent’anni fa.
Anche la Lista Unica Araba, tradizionalmente considerata parte del centro sinistra perché contro i governi di destra ma in realtà costituita da quattro partiti con molte differenze, si è spaccata con l’uscita del partito islamico del sud, di ultradestra nazionalista e contro la modernità. Si prevede ora che questa lista unica passi da 15 a 9 seggi mentre Netanyahu corteggia gli arabi religiosi del partito Raam.
Un governo anti Netanyahu potrebbe comprendere anche Meretz su punti specifici concordati ma è difficile pensare che Meretz possa stare in una coalizione con Liberman, che rappresenta con Israel Beitenu la destra laica degli ex-sovietici, e Saar, che si colloca più a destra di Netanyahu sia per la politica degli insediamenti sia per l’insegnamento della religione nella scuola. Meretz si trova all’opposizione da 22 anni, l’ultimo governo era stato quello di Barak. Con i Laburisti, a cui manca un leader forte e onesto, ridotti a 6-7 seggi, è chiaro che Israele sta andando sempre più a destra, anche per l’effetto demografico dei religiosi e dei sefarditi che hanno una natalità più alta, anche degli arabi.

Ad una domanda sulla strategia di medio periodo di Meretz, identificato come partito della bolla progressista di Tel Aviv, Roberto Della Rocca ha risposto ricordando che Meretz è il partito che ha il record di leggi e proposte di legge per difendere le classi sociali più deboli, come la legge per permettere l’acquisto delle case popolari da parte degli inquilini, ma non riesce a fare presa nelle cittadine di sviluppo e nelle zone al di fuori di Tel Aviv per un linguaggio non adatto.
Meretz si presenta alle elezioni con la conferma due candidati arabi, di cui una donna, per avvicinarsi alla popolazione araba israeliana che, secondo Aldo Baquis, dovrebbe essere maggiormente coinvolta. A parte gli episodi di indisciplina, in questi mesi gli israeliani hanno scoperto che i medici e gli infermieri arabi sono una forza importate per tenere insieme le istituzioni. Ogni servizio in televisione su strutture ospedaliere ha mostrato il volto umano di medici ed infermieri arabi. Sono processi che richiedono tempo ma che servono a rompere gli stereotipi. Lo stesso Netanyahu, che nel 2015 incitava il suo elettorato ad andare a votare perché gli arabi venivano trasportati ai seggi da organizzazioni di sinistra, ora fa campagna elettorale nelle località arabe, anche per spronarli a vaccinarsi, con un atteggiamento sui social molto diverso grazie all’apertura di una pagina Facebook in arabo. E’ importante che la società israeliana assorba al suo interno la popolazione araba per molti versi emancipata e civile. Due esempi dimostrano il cambiamento in atto: la televisione pubblica ha un corrispondente arabo di Gerusalemme, elevato a giornalista di pieno rispetto, che tratta tutti i temi di attualità con assoluta imparzialità. Anche Haaretz sta assumendo diversi cronisti arabi.
Abu Mazen il mese scorso ha proclamato le elezioni della Autorità Nazionale Palestinese, che si erano svolte l’ultima volta nel 2006. Il 22 maggio si voterà per il Parlamento di Ramallah, il 21 luglio le elezioni presidenziali ed a fine agosto il Consiglio Nazionale Palestinese in esilio. Pochi giorni fa al Cairo si sono conclusi sotto l’egida di Al Sisi i colloqui tra le 14 fazioni palestinesi, di cui Hamas e Al Fatah sono le più importanti, con il raggiungimento di un accordo che dovrebbe assicurare il corretto svolgimento della campagna elettorale e delle elezioni. Anche se i problemi di fondo tra le fazioni non sono superati, va notato un cauto ottimismo tra i palestinesi per effetto della elezione di Biden, che potrebbe portare alla riapertura del consolato USA a Gerusalemme Est e della rappresentanza a Washington della ANP.
Roberto Della Rocca ha confermato che il focus che differenzia Meretz dagli altri partiti sta nella difesa delle minoranze immigrati e arabi. Si dimenticano le leggi sociali, la difesa della donna e degli omosessuali. Ma il problema di fondo per la sinistra resta la soluzione del conflitto palestinese, che condiziona la soluzione di tutti gli altri problemi come la situazione economica, culturale, la democrazia, i rapporti internazionali. Per diventare un paese normale Israele deve avere una soluzione concordata con i Palestinesi e accettata dalla comunità internazionale.
La posizione dei Laburisti di Merav Michaeli sul conflitto palestinese è più blanda, a conferma che questo è un tema sempre meno presente nel dibattito politico israeliano.
Horowitz, leader del Meretz, spinge sul problema palestinese ma bisogna saper parlare agli elettori anche su altri temi più vicini a loro. Nei territori occupati di Giudea e Samaria ci sono 500.000 coloni ma la popolazione araba ha la natalità più alta del mondo. Sommando gli arabi cittadini di Israele agli arabi che vivono a Gaza e in Cisgiordania, si arriva a un totale di 6,5 milioni. Poiché in Israele vivono 6,3 milioni di ebrei, è evidente che in una prospettiva di “Grande Israele” il mantenimento di uno stato ebraico sarebbe incompatibile con uno stato democratico. L’unica soluzione sarebbe rientrare nei confini del 1967.
La democrazia è molto debole per effetto degli attacchi da parte di Netanyahu alla magistratura, alla stampa libera, alla polizia, con una situazione molto preoccupante.
Giorgio Gomel ha commentato che da due anni la democrazia in Israele è limitata dal plebiscito personale su Netanyahu, che dovrebbe essere giudicato dal tribunale e non dagli elettori.
Per la sinistra l’unica possibilità sarebbe un’alleanza con la lista araba, per consentire al 20% della popolazione di essere rappresentato. Ma Meretz è un partito sionista, è difficile pensare ad una lista unica con i partiti arabi.
Secondo Daniele Nahum il fronte anti Netanyahu è molto disomogeneo. Negli ultimi vent’anni lo scontro politico è stato tra Destra e Centro Destra, con la Sinistra assente che non riesce a capire la situazione sociale.
L’incontro si è concluso con la promessa di un nuovo incontro dopo il 23 marzo per l’analisi del voto.

CATTIVA MEMORIA
STORIA, MEMORIA, VERITÀ: RIFLESSIONI SULL’ULTIMO LIBRO DI MARCELLO FLORES

David Bidussa 27 gennaio 2021 Gli Stati Generali

Cattiva memoria di Marcello Flores dà l’opportunità per tornare a riflettere non solo sul rapporto tra memoria e storia, ma soprattutto sui molti modi attraverso i quali oggi si produce discorso sulla storia.
A lungo abbiamo pensato che storia e memoria fossero agli antipodi e dunque che si trattasse di scegliere o di indicare intorno a quale dei due poli lavorare.
Marcello Flores ci dice in prima battuta che esiste una dimensione vischiosa di ciò che conserviamo nella memoria, ma anche che di fronte esiste un cammino impervio di provare a ricostruire fatti, eventi, scelte, opzioni perché al centro della memoria stanno prevalentemente individui, voci. Ovvero figure e che periodicamente tornano a confrontarsi con il passato che raccontano, con quello visto e/o vissuto e ogni volta la sfida è riconoscersi o meno con la versione precedente dei fatti narrati.
In questa dimensione la partita, sottolinea Flores, non è tra memoria e oblio, ma tra cancellazione, conservazione e memoria. La memoria è in breve il risultato di
1) ciò che si ricorda;
ma anche di
2) ciò che si vuole ricordare;
e soprattutto di
3) come si vuol ricordare.
Ogni volta così la narrazione del passato corrisponde non solo alle sfide del tempo presente, ma è in relazione col presente. Un presente che deve fare i conti con le eredità del passato e che spesso affronta quel percorso “controvoglia”.
Un profilo e un disagio che riguardano le memorie dei comunismi e di chi oggi si vuol fare erede di quelle storie; dei fascismi e di chi oggi pensa di aver “pagato pegno” a sufficienza e dunque si ripresenta sul mercato politico offrendo le stesse ricette di a un tempo pensando che il disagio economico e sociale, il malessere esistenziale sia una buona opportunità e una piattaforma per ripresentare ricette che già una volta hanno avuto corso nella storia
Ma soprattutto quel tema delle cattive memorie riguardano alcune questioni dirompenti che stanno nel nostro presente.
Quella che ci riguarda direttamente è l’identità dell’UE e il confronto tra le realtà politiche e culturali dell’Europa occidentale e le realtà politiche dell’ex-impero sovietico. Conflitto che è stato esaltato e in forma plateale della discussione sulla legge 2019, e che oggi rimette in discussione la centralità del 27 gennaio come data della memoria europea.
Un presente segnato dalla rapida parabola delusiva del sogno europeo.
Percorso segnato da molte svolte: prima l’euro, poi il rifiuto dell’approvazione della costituzione nel 2005, poi un allargamento a Est senza un fondamento culturale e politico ma in gran parte segnato dall’ansia di stabilire un confine. Dentro il ritorno dei particolarismi, l’innalzamento delle intolleranze, l’espandersi di un clima di violenze dove progressivamente sono in aumento le zone proibite, i luoghi a rischio della convivenza.
Ma anche conflitto che denuncia oggi una stanchezza di quella data e la necessità di ripensarla pensando anche a una procedura culturale diversa. Se a lungo la scenografia dei “giorni della memoria” (non solo il 27 gennaio) è stata mettere al centro del discorso le vittime, forse occorre iniziare a considerare che quella modalità di ricordo non deve fondarsi sull’etica del risarcimento, bensì su quella della autoriflessione.
Ovvero: in ogni giornata della memoria ciò che deve stare al centro è il “non detto” del discorso collettivo.
“Non detto” che implica mettere al centro non chi è stato escluso, ma l’imbarazzo.
Ne discende che al centro di quel tipo di data deve stare la dinamica di “dire la verità”.
Dire la verità non significa solo dare voce agli esclusi, ma smontare le opinioni e le convinzioni su cui a lungo si è definito il compromesso culturale che ha legittimato gli equilibri di un lungo secondo dopoguerra dove ogni volta il problema era individuare un colpevole.
Dire la verità in questo senso implica decisamente come giustamente sottolinea Marcello Flores dare spazio al discorso della storia e al ruolo dell’indagine storica, ma significa anche riconoscere e vedere i limiti dell’azione culturale degli storici. Ovvero distinguere tra i percorsi della ricerca storica e dei risultati proposti dagli storici, ma poi non tralasciare la costruzione della vulgata cui pure gli stessi storici talvolta contribuiscono.
Processo in cui l’effetto è la banalizzazione della storia cui non sono estranei gli storici allorché si mettono sul piano della divulgazione, della narrazione semplificata, laddove incrociano le loro ipotesi di ricerca con la semplificazione del racconto.
Nella dimensione del ruolo pubblico dello storico non ci sono solo gli effetti di banalizzazione, e non c’è solo la competenza, ma c’è anche la consapevolezza che il racconto di storia e la ricostruzione della scena della storia non è solo il risultato di mettere insieme i fatti o di raccogliere i documenti, come a lungo molti storici hanno ritenuto.
Se quel lavoro è necessario, non è più da solo sufficiente.
Ricostruire la scena della storia, soprattutto in età contemporanea, nel tempo in cui i protagonisti della scena sono ancora vivi, e gli elementi testimoniali sono ancora sul campo, significa sapere che anche altre competenze sono necessarie, spesso non possedute da una sola competenza.
Riguardano (per esempio): una sensibilità semiotica, una sensibilità letteraria, una competenza disciplinare per l’analisi sociologica, per quella antropologica, per le culture scientifiche. Una competenza legata alle forme della comunicazione che non si limita ai dati di fatto, ma come questi vengono confezionati, raccontati, costruiti e “venduti” come pacchetto di spiegazione “convincente”.
Insomma, la scena della storia necessita per affrontare la questione di raccontare il vero, di un concorso di competenze, di una ricerca che è un laboratorio, sia di temi che di figure, che lo storico tradizionale del ‘900 non è in grado di soddisfare da solo. Il che significa anche avere una percezione chiara della crisi del racconto storico, come prodotto della ricerca storica, così come ci è stato consegnato nel Novecento.
David Bidussa è un scrittore, giornalista, storico saggista italiano.
Si è definito storico sociale delle idee, riferendosi a «una disciplina che comprende un mix di competenze culturali tra le quali: storia (contemporanea), storia sociale, semiotica, teoria della letteratura, storia delle dottrine politiche, storia dei partiti e movimenti politici».
Ha scritto saggi sull’ ebraismo, sul sionismo, sul movimento socialista francese e sulla Repubblica di Vichy. Va ricordato “L’ultimo testimone” Einaudi.
Marcello Flores Storico, autore di apprezzate pubblicazioni, si è occupato principalmente della storia del comunismo, del XX secolo, del genocidio degli Armeni durante la Prima Guerra Mondiale, dei diritti umani e delle vittime di guerre.
Ha fatto parte del comitato scientifico-editoriale per la monumentale “Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo”; ha partecipato a diversi programmi televisivi divulgativi sul tema (ad esempio, Il tempo e la storia, Eco della Storia). Fa parte del comitato scientifico per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani sull’Armenia.

Primo Levi, Miti d’oggi
Bruno Osimo – Francesco Brioschi Editore
Prefazione di Bruno Segre
Gli anglismi e gli americanismi che intitolano i capitoli di questo libro non sono da attribuire all’antico vizio italico dell’esterofilia. Alcontrario, proprio con il provocatorio richiamare il selvaggio trapianto nella nostra lingua di terminie costrutti anglofoni, Bruno Osimo ne sottolinea con ironia gli aspetti ridicoli, banali, talvolta volgari, e caso mai fa valere con forza il rifiuto di farsi subordinare, trasformare, denaturare, emarginare.
Per Osimo, fonte inesauribile di ispirazione di tale rifiuto, e di molto altro ancora, è Primo Levi: una guida preziosa alla quale egli si consegna, affascinato dal suo pensiero acuto e lungimirante, dalla sua scrittura cristallina, dalla sua complessa e tragica vicenda umana.
Nel 2012 Osimo aveva dato alle stampe il Dizionario affettivo della lingua ebraica, una prima valida prova narrativa le cui pagine, pur non componendo una vera e propria autobiografia, raccontavano il suo impegno a fare chiarezza nell’intrico delle ascendenze e dei comportamenti famigliari. In quell’opera Osimo, figlio di genitori scampati da giovani (lei a sedici anni, lui a ventitré) alla deportazione verso un Lager, narrava d’essersi trovato iscritto, per iniziativa della yiddishe mame, alla scuola ebraica anche se “papà non voleva che io ci venissi”, e quindi di sentirsi costretto sin da bambino a fare i conti con la sua qualità di “ebreo clandestino”.
Da questa condizione s’era potuto finalmente liberare molto più tardi, andando a visitare a Gerusalemme lo Yad Vashem, il museo-monumento dedicato alle vittime della Shoah. “Quando ho visitato lo Yad Vashem, avevo quasi cinquant’anni. Tanti fili della mia vita mi portavano in quella direzione, ma non lo sapevo, o non lo volevo riconoscere. […] adesso che sono qui dove c’è questa stazione, questo posto dove ci si ferma, dove si fa memoria, […] capisco che quello che mi è stato detto non è nulla a confronto di quello che mi è stato trasmesso senza dirmelo. […] È questo l’unico posto in cui mi sento a mio agio pensandomi ebreo non circonciso e mi sento ebreo completamente, […] È questo l’unico posto in cui paradossalmente mi sento protetto, non nel fisico ma nell’identità, qui sono legittimo, non sono più clandestino, né come ebreo né come cittadino del mondo.”
Dalla composizione di quel favoloso Dizionario è trascorso circa un decennio. E Osimo, entrato ormai in his sixties, ha fatto compiere alla sua inesausta ricerca di chiarezza identitaria un ulteriore tratto di strada, passando dalla lezione dello Yad Vashem − quel memoriale austero che parla della morte, dello sterminio, della cremazione − all’ascolto vigile di Primo Levi: un personaggio capace di vedere ogni cosa con oggettività e distanza, dotato delle qualità morali, culturali, scientifiche, di una resistenza fisica e di una capacità di adattamento tale da permettergli, nel cuore di un’esperienza estrema, di soddisfare una sua pur precaria volontà di sopravvivere; ma in particolare, un testimone in possesso di un’eccezionale capacità di osservare, studiare, giudicare, antivedere, ben palesata dal macrotesto che ha lasciato in eredità ai posteri. «Non sono in grado di giudicare il mio libro − scrive Levi − […] Mi auguro che venga letto comunque: non solo per ambizione, ma anche nella sottile speranza di essere riuscito a far sì che il lettore si accorga che le cose lo riguardano.» “Dire che l’opera di Primo è importante (solo) per la Shoah − commenta Osimo − è grossolanamente riduttivo: è immensa, ed è fondamentale per la nostra vita quotidiana attuale.” E poi, a mo’ di precisazione: “La sua grandezza sta nell’aver ricucito tutto quello che ha visto e vissuto, e ricollegato con la nostra vita quotidiana, ravvisando tracce di Lager nel suo quotidiano e tracce di quotidiano nel Lager. Che è poi quello che cerco di fare io in questo libro con il nostro quotidiano.”
Quanto in profondità Bruno si sia spinto nell’introiettare il pensiero e l’esperienza esistenziale di Primo, lo rivelano le pagine sofferte di questo libro. Perché il lettore incominci a farsene un’idea, do qui qualche esempio.
Sotto la parola chiave SUV (sigla che indica Sport Utility Vehicle), Osimo menziona un episodio di guerra che Primo, in La tregua, descrive così: «[I nazionalsocialisti che, fuggendo dal Lager, non volevano lasciare dietro di sé nulla che potesse favorire i prigionieri] non si erano attardati a recuperarli [gli alimentari in scatola], ma avevano cercato di distruggerli passandoci sopra con i cingoli dei loro mezzi corazzati.» Nel commentare questo passo, Osimo rileva che la violenza – moneta corrente, quale causa di morte e di traumi senza fine, nell’ottica della guerra − può assumere in tempo di pace forme diverse, per esempio negli incidenti stradali, ormai sempre più frequenti. Fa poi notare che per un’automobile normale scontrarsi con un SUV è più pericoloso che scontrarsi con un’automobile normale. Dunque: “Il principio che sta alla base della scelta di girare in SUV [anziché in un’automobile normale] è quello di cercare la propria protezione a scapito di quella altrui. […] Il pensiero, consapevole o inconscio − conclude Osimo −, dei portatori sani di SUV nei confronti del prossimo e dei prossimi, è lo stesso espresso da Primo nel passo citato: «distruggerli passandoci sopra con i cingoli dei loro mezzi corazzati.»
«Siamo stati capaci, noi reduci − si domanda Primo in I sommersi e i salvati − di comprendere e di far comprendere la nostra esperienza? Ciò che comunemente intendiamo per ‘comprendere’ coincide con ‘semplificare’: senza una profonda semplificazione, il mondo intorno a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito […] Siamo insomma costretti a ridurre il conoscibile a schema.» Chiosando queste riflessioni di Levi (in un capitolo intitolato Narrative), Osimo chiarisce che semplificare quando la materia è già, di suo, semplice, è più facile di quando non è semplice affatto. Per poi aggiungere, a parziale spiegazione del clima di indifferenza, apatia, assenza di interesse con cui Primo viene accolto al suo ritorno in famiglia a Torino, che “la vita in Lager è stata programmaticamente costruita in modo da non essere traducibile. I nazionalsocialisti sapevano che, se qualcuno fosse sopravvissuto, nessuno avrebbe creduto ai suoi eventuali racconti. […] I nazionalsocialisti hanno innovato radicalmente le modalità non solo di distruzione fisica, ma anche di detenzione e di condizionamento. Hanno costretto i prigionieri a vivere in modi propriamente indescrivibili, così da impedire loro di raccontare. Per farlo, Primo ha creato non solo un testo, ma un intero linguaggio.”
In un capitolo intitolato No Vax, dopo avere citato un passo da Se questo è un uomo che descrive un quadro epidemiologico rovinoso («Non avevamo che una minima scorta d’acqua, e non coperte né pagliericci di ricambio. E il poveretto, tifoso, era un terribile focolaio di infezione.»), Osimo ci ricorda che, pur non essendo medico, Levi era tuttavia capace di svolgere, nella cornice desolante del Lager, funzioni di rilievo nel prevenire la diffusione delle malattie. La sua cultura gli permetteva infatti “di attenersi ad alcuni princìpi di base, quelli che in teoria vengono insegnati in tutte le scuole nei corsi di igiene.” È vero che oggi le malattie infettive sono diminuite un po’ dovunque. Ma “l’unica epidemia che sta dilagando”, constata Osimo con amarezza, “e che sembra non conoscere antidoti è quella delle informazioni [pseudoscientifiche] in internet”. Chiunque può comunicare ciò che vuole, laddove larga parte del pubblico recettore non ha le basi educative necessarie per filtrare le notizie attendibili e distinguerle dalle panzane. “Apparentemente, internet […] ha dimostrato che la democrazia non funziona, e che nel principio che uno vale uno è racchiuso il pericolo enorme di diffusione di disinformazione.” Siamo ormai scesi, oggi, tanto in basso che sembriamo destinati a ripercorrere senza rimedio gli “errori passati, fino a giungere a nuove infezioni, nuove epidemie, nuove pesti causate da menti labili di persone ignoranti con un enorme potere comunicativo di massa.”
Quanto fossero affamati i Häftlinge ce lo dice Levi in Se questo è un uomo, rammentando che nel campo «si raschiano patate crude con altre bollite e disfatte; la miscela si arrostisce su di una lamiera rovente. Avevano sapore di fuliggine». Nella nostra storia nazionale, la Seconda guerra mondiale fu l’ultimo periodo in cui molti di coloro che la attraversarono ricordano non soltanto di avere sofferto la fame, ma anche di avere assistito a un immane spargimento di sangue umano. Finita la guerra, per alcuni anni − annota Osimo in un capitolo agrodolce intitolato Barbecue − fu avvertito diffusamente il bisogno di compensare il patimento subìto spargendo, per contrasto, sangue non umano, “un lusso prima insperabile”. “Per arrivare alla messa in scena del barbecue […] bisogna avere esorcizzato completamente la fame atavica, di modo da non avere di nuovo voglia di un setting più avventuroso per il proprio rituale di nutrimento. Il maschio inscena, come mezzo milione di anni prima, il ruolo del cacciatore procacciatore di selvaggina, e la femmina − che da copione dovrebbe occuparsi del fuoco − lascia il fuoco al maschio (che altrimenti non avrebbe nulla da fare, dato che non caccia) e si dedica ai servizi di comfort: […] tovaglie, tovaglioli, bicchieri, bevande, posate, recipienti per condimenti et similia. […] nessuno concepirebbe di abbeverarsi al fiume o di pulirsi la bocca con una foglia o di mangiare insipido o di rinunciare al caffè. Nemmeno le patate crude arrostite sulla lamiera rovente fanno di solito parte del nostro menu.”
«Quanto di noi stessi era stato eroso, spento?» si domanda Levi nel finale di La tregua. «Ritornavamo [a casa] più ricchi o più poveri, più forti o più vuoti?» A tali quesiti Osimo risponde in modo indiretto componendo un capitolo intitolato Anti-aging. In esso ci ricorda che tra i dogmi non scritti della nostra cultura figura l’esigenza di fare tante esperienze “perché le esperienze fanno crescere. Un altro [di questi dogmi] è che bisogna apparire giovani. L’ideale, insomma, sarebbe essere dei giovani vissuti. […] Nel 1945 Primo ha ventisei anni, quindi è giovane. Ed è vissuto” grazie al fatto che i trecentoquaranta giorni trascorsi a Monowitz e i duecentosessanta trascorsi nel viaggio di ritorno sono stati estremamente ricchi di esperienze. A quei due dogmi occorre però accostare oggigiorno anche l’equiparazione universalmente accettata tra vecchiaia e negatività, un’equiparazione che mobilita strategie “anti-aging” con effetti collaterali importanti. Grazie infatti ai farmaci che, vergognandocene, assumiamo di continuo, la nostra aspettativa di vita sta aumentando, ma ne deriva anche che “il mondo è sempre più pieno di vecchi, con pròtesi di vario tipo.” “Posso capire − così conclude Bruno − che Primo alla lunga si fosse stufato di vivere in mezzo a una popolazione guidata da queste preoccupazioni. […] In effetti Primo, senza alcun esibizionismo, senza alcuna polemica, senza fare nessun rumore, ha scelto l’unico ‘percorso anti-aging’ (come recita la pubblicità volgare) che funziona davvero.”
Una considerazione decisamente provocatoria ma che, nella sua originalità, trovo del tutto in linea con questo libro, nei termini in cui mi pare che Bruno Osimo l’abbia concepito.
 Bruno Segre
Bruno Segre

Addio Nedo Fiano
E’ morto Nedo Fiano, testimone indimenticabile della tragedia dell’Olocausto
Zita Dazzi – Repubblica 19 Dicembre 2020
L’immagine che gli era rimasta stampata negli occhi e che raccontava sempre era quella di sua madre sulla rampa d’arrivo dei treni per Auschwitz, l’ultima volta che si abbracciarono, prima che lei venisse avviata alla camera a gas. Nedo Fiano è morto questa sera a Milano, nella casa di riposo dove era ricoverato da molti anni, assieme alla moglie Rina Lattes. Suo figlio Lele, deputato Pd, pochi giorni fa aveva scritto su Facebook che l’ultima ora era vicina: “Aspetto notizie, sto sempre col telefono in mano, papà è molto debole, forse è stanco di resistere a 95 anni, forse ha concluso il suo ciclo”. Alle 20 di sabato, il giorno sacro per gli ebrei, quando ormai la vita di Nedo era volata via, Lele Fiano ha scritto un altro post: “Papà ci ha lasciati. Ci rimarranno per sempre le sue parole e il suo insegnamento, il suo ottimismo e la sua voglia di vivere. Non avrò mai io la forza che ebbe lui e che lo fece risalire dall’abisso, ma da lui ho imparato che per le battaglie di vita e contro ogni odio bisogna combattere sempre. Questo ci ha insegnato la memoria che lui ha contribuito a diffondere. Sia lieve a papà la terra che lo accoglie e sempre su di noi la sua mano ci protegga”.
Parole commoventi come tutte quelle che Lele Fiano ha dedicato ai suoi genitori, raccontando gli incontri che avvenivano nella casa di riposo.
Nedo era nato nel 1925 a Firenze e come tanti bambini ebrei alla promulgazione delle leggi razziali, nel ’33, dovette abbandonare la scuola, appena tredicenne, come Liliana Segre, di cui è stato grande amico. Venne poi arrestato con 11 membri della sua famiglia nel ’44 e tutti assieme furono deportati ad Auschwitz, con un terribile viaggio nei vagoni blindati, che Nedo ha raccontato per molti anni a generazioni di ragazzi ed adulti. Sul braccio aveva ancora stampigliato il numero di matricola A5405 e lui fu l’unico della famiglia a fare ritorno, dopo la liberazione l’11 aprile del ’45.
Nedo, che dopo la liberazione si era trasferito a Milano, nella sua vita ha lavorato per l’industria, ma ha dedicato la sua vita a testimoniare la storia dello sterminio degli ebrei durante il nazismo. Ha scritto anche un libro sulla sua storia, ” Il coraggio di Vivere”, e per molti anni ha collaborato con il Centro di documentazione ebraica di Milano raccontando l’Olocausto. E’ stato uno dei primi testimoni della Shoah a vivere la sua esperienza tragica come uno strumento pedagogico per le nuove generazioni.
In una sua testimonianza apparsa sul portale della comunità ebraica milanese Il Mosaico si legge: “Porto con me – da sempre – l’odore, il buio, l’orrore e la ferita di quel tempo lontano. Lotto ancora e recito la parte di un uomo comune, come tanti altri. Ma sento spesso un inferno dentro, anche se cerco di apparire sereno e felice. Amo la mia famiglia sopra ogni altra cosa. In vista ormai della settecentesima conferenza nelle scuole, mi sento ancora là, nel luogo del lutto. Ho una ricca e vivace vita interiore da cui attinguo il mio essere di ogni giorno. Penso, leggo e scrivo, ma sono sempre là, tra i fili spinati e lì resterò fino alla fine della mia vita. Ogni giorno apro gli occhi su un mondo difficile e spesso ostile, ma anche pieno di stimoli e tentazioni. Mi rimbocco le maniche, accetto la sfida e mi batto. Ho tre figli molto più bravi di me, che portano il seme di Birkenau che ho loro trasmesso”.
La senatrice a vita Liliana Segre, commenta la notizia della scomparsa di Fiano, piena di commozione: “C’era tra Nedo e la mia famiglia un legame speciale, più forte delle parentele di sangue. Non potremo mai dimenticarlo. Un grande abbraccio a Lele, Andrea, Enzo e a tutti i familiari”
Fra le molte espressioni di cordoglio che arrivano in queste ore, c’è quella del sindaco di Milano Beppe Sala: “La testimonianza di ciò che ha vissuto durante la deportazione resterà per sempre un grande insegnamento per tutti noi. Un abbraccio ad Emanuele e a tutta la famiglia Fianco”. Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano, fa le condoglianze alla famiglia e alla comunità ebraica milanese e all’Unione delle comunità ebraiche italiane: “E’ un giorno triste per Milano, Nedo Fiano è stato un testimone infaticabile delle nefandezze del nazifascismo, lo ricorderemo sempre con gratidudine, stima e riconoscenza”.
Argomenti
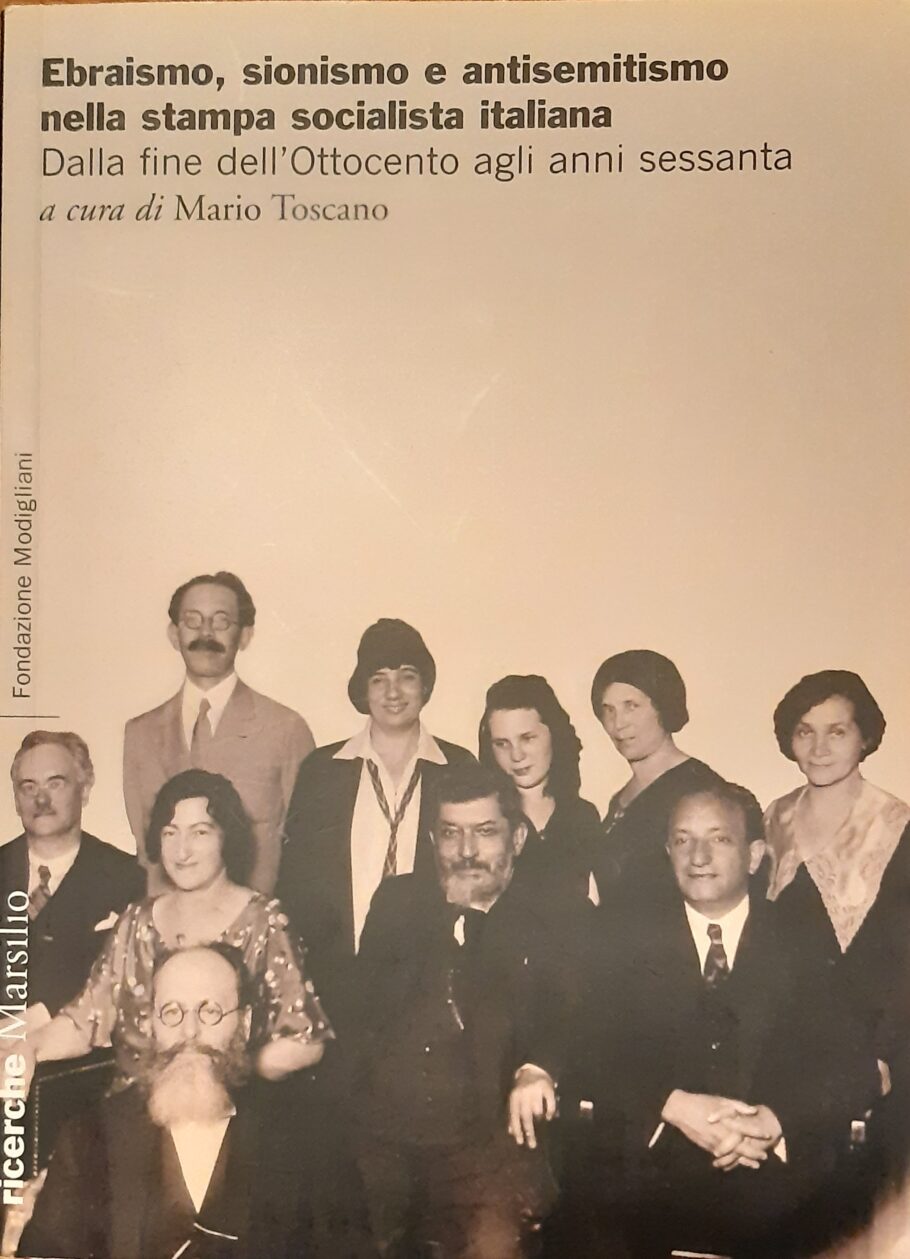
Ebraismo, sionismo e antisemitismo nella stampa socialista italiana
Dalla fine dell’Ottocento agli anni sessanta
A cura di Mario Toscano – Marsilio editore
Nel corso di un secolo il rapporto tra il socialismo italiano e il mondo ebraico è stato molto intenso. I grandi momenti dell’esperienza ebraica dell’età contemporanea hanno costituito materia di riflessione e di analisi della stampa socialista. L’affaire Dreyfus e la nascita dell’antisemitismo politico in Europa, le origini del sionismo e le vicende dello Stato d’Israele, la politica razziale fascista e la shoah, la partecipazione degli ebrei ai movimenti rivoluzionari e l’antisemitismo nell’Unione Sovietica hanno costituito problematiche di grande rilievo per la cultura e la politica del socialismo italiano.
I saggi di M. Gabriella D’Amore, Filomena Del Regno, Luca La Rovere, Alessandra Tarquini, Mario Toscano ricostruiscono le cronache, le immagini, le interpretazioni fornite su questi temi dai principali organi della stampa socialista italiana dalla fine dell’Ottocento agli anni sessanta. Sullo sfondo delle vicende politiche, si delinea il rapporto tra due culture e due identità, emerge il ruolo svolto dal socialismo nella costruzione dell’immagine degli ebrei nella società italiana, si chiarisce il contributo offerto per rendere l’esperienza storica dell’ebraismo contemporaneo una componente essenziale di una società democratica.
L’Introduzione: I confini dell’identità di Mario Toscano definisce i criteri della ricerca che, sia pure limitatamente al caso italiano, si poneva l’obiettivo di collegare l’esperienza storica del socialismo con quella dell’ebraismo in età contemporanea, per cogliere le interazioni verificatesi tra i due “mondi” di fronte a complesse vicende politiche, ideologiche, culturali, economiche e sociali e nel quadro dei processi di integrazione degli ebrei nello Stato nazionale.
L’indagine della stampa è incentrata sullo studio dell’“Avanti”, integrato dall’analisi di “Critica Sociale”, per la funzione storica svolta nel rappresentare la “cultura” del socialismo riformista in Italia e di “Mondo Operaio”, per il ruolo culturale e politico dispiegato nel secondo dopoguerra.
L’indagine mostra il tentativo di sfuggire agli stereotipi e alle descrizioni generiche e impressionistiche per proporre alcuni dati concreti di riflessione. I temi della ricostruzione del contributo dei singoli ebrei alla storia del socialismo in Italia e quello delle presunte o eventuali affinità ideologiche tra ebraismo e socialismo, spesso legati al peso di suggestioni provenienti dall’attualità politica, appaiono intrisi di ambiguità, che devono essere pazientemente dissipate, per evitare il rischio di accedere a interpretazioni storicamente generiche o fuorvianti.
Il saggio di Filomena Del Regno, intitolato L’antisemitismo e il sionismo nelle cronache e nelle analisi dell’”Avanti” (1897-1920), copre un lungo periodo in cui vengono riportati i fatti e i movimenti accaduti in Europa, in particolare in Francia con l’affaire Dreyfus e nell’Impero Russo.
Oltre alla cronaca, l’”Avanti” dedicò grande attenzione alla denuncia e all’analisi dell’antisemitismo, considerato uno strumento nelle mani delle forze reazionarie oltre che in Francia, in Austria, Ungheria, Romania e nella Russia zarista. Ugualmente meritevole di considerazione è lo spazio dedicato alle vicende del proletariato e del movimento operaio ebraico dell’Europa orientale.
L’ebreo per i socialisti italiani è l’ebreo capitalista, emancipato e borghese, ma anche l’ebreo rivoluzionario, il proletario appartenente ad una massa sfruttata. Il significato del movimento antisemita appare ambivalente. In occidente è strumento di lotta per motivi economici, e questa è la spiegazione che l’”Avanti” tentò di fornire, mentre in oriente l’antisemitismo assumeva caratteri medievali di barbara caccia all’untore, al vampiro.
Il quotidiano non si occupava dell’ebraismo italiano, sia per l’esiguità numerica sia per l’integrazione raggiunta dagli ebrei. Il progetto sionista suscitava diffidenza e critica: il fenomeno nazionalista ebraico mal si conciliava con l’ideale socialista internazionalista. Grazie al contributo di alcuni intellettuali ebrei queste diffidenze verranno chiarite.
L’affaire Dreyfus, con tutte le sue implicazioni politiche e mediatiche, venne ampiamente trattato per diversi anni dall’”Avanti”. Il J’accuse di Emile Zola fu secondo Claudio Treves un atto rivoluzionario da parte di un bravo borghese teso all’affermazione della verità e della giustizia contro l’alleanza clerico-militarista. In un articolo apparso nell’agosto del 1899 dal titolo Socialisti e antisemiti si affermava che l’antisemitismo non era un’idea ma il brigantaggio, e gli antisemiti non erano un partito, ma una banda di malfattori e concludeva dicendo che il socialismo avrebbe salvato in Francia la civiltà contro la barbarie gesuitico-antisemita per istaurare la democrazia egualitaria della gente del lavoro. E la borghesia sana e intelligente guardava al proletariato socialista come al salvatore.
Nello stesso periodo altri drammatici fatti di antisemitismo venivano ampiamente documentati dall’”Avanti”, come il caso del sindaco antisemita di Vienna Lueger che nel 1897, appena eletto, si recò in Vaticano, o come la situazione in Algeria. Sul massacro di Kishinev, come pure sui successivi pogrom di Gomel, Odessa, Kiev, Bielostock, il quotidiano socialista assunse una posizione netta di denuncia della ferocia antiebraica nella Russia zarista, con la funzione politica ben definita di deviare lo scontento e la ribellione popolare verso l’ebreo. Il propagarsi della Rivoluzione vedeva secondo l’”Avanti” gli ebrei in prima fila, grazie anche all’attività del Bund.
In occasione dell’appello contro lo zarismo lanciato nel 1906 da Bureau Socialiste International Riccardo Momigliano commentava le vicende russe e spiegava che l’essenza dell’ebraismo era il messianesimo, la tendenza incoercibile all’idealismo; egli sosteneva che accanto agli scaltri ebrei che traevano profitto ovunque, c’erano gli ebrei spiritualmente affini ai grandi idealisti e spettava proprio a loro impedire che alcuni correligionari commettessero l’infamia di sostenere finanziariamente lo zarismo.
Anche i disordini antisemiti in Romania furono oggetto in quegli anni di attente corrispondenze ed analisi dell’”Avanti”. Qui il conflitto era sia economico tra i contadini ed il capitalismo agrario accentratore e sfruttatore dei proprietari ebrei, sia lotta di religione.
Particolarmente pesante era l’antisemitismo in Polonia, dove gli ebrei erano il 40% della popolazione. Iniziata la guerra nel 1914 i polacchi accusavano gli ebrei di essere filoaustriaci e gli antisemiti ricorrevano a leggende medievali. La questione ebraica era vista per la prima volta come un problema di una nazionalità oppressa sotto il regime russo e ugualmente perseguitata sotto il regime tedesco, allo stesso modo del popolo polacco. Questo principio era sostenuto da Raffaele Ottolenghi, che affermava che dalla guerra doveva emergere il principio di cooperazione politica ed economica in ogni Stato tra le varie nazionalità, pur conservando la propria identità spirituale. A favore dell’assimilazione ebraica si era invece espresso Arturo Labriola, in netto contrasto con Ottolenghi.
Il 3 novembre 2016 l’”Avanti” pubblicò un intervento di Massimo Gorki in difesa di tutte le nazionalità presenti in Russia, che avrebbero dovuto unire le proprie forze contro un nemico molto astuto che additava l’ebreo come responsabile di tutte le sciagure del popolo russo.
Nel giugno del 1917 l’”Avanti” annunciava che la rivoluzione aveva abrogato la legislazione eccezionale e aveva restituito a 6 milioni di ebrei il diritto di cittadinanza e l’uguaglianza davanti alla legge e alla società. Nell’articolo gli ebrei erano considerati una classe e la questione dell’autonomia della cultura si risolveva applicando il principio della libertà: “autonomia della nazionalità ebraica nei riguardi delle altre nazionalità ed autonomia del cittadino nei riguardi della sua nazionalità”. Così la rivoluzione garantiva la libertà nazionale e le libertà individuali.
L’ipotesi sionista fu oggetto di intense discussioni tra i socialisti. Importante fu il contributo di alcuni intellettuali ebrei, come Felice Momigliano, che descriveva il sionismo come un fattore di rinnovamento dell’ebraismo e come un movimento del proletariato ebraico oppresso. Momigliano non credeva che il sionismo fosse un rimedio all’antisemitismo e distingueva l’antisemitismo orientale da quello occidentale, che aveva radici economiche.
Col passare degli anni l’inconciliabilità tra l’ideale socialista e il sionismo appariva sempre più netta. Angelo Treves analizzava la questione ebraica nella sua complessità, che la guerra aveva acuito. Non si trattava di dare un’esistenza politica a una delle tante entità geografiche, il popolo ebraico non era un’entità etnica, non aveva comunanza di origine, di lingua e tantomeno di aspirazioni. Nel 1917, in seguito della dichiarazione Balfour, l”Avanti” espresse un giudizio di totale dissenso dei socialisti italiani verso la soluzione sionista della “questione ebraica”. Per Treves la missione del popolo ebraico era ormai conclusa; aveva insegnato il monoteismo e attraverso il cristianesimo aveva diffuso la filosofia della libertà e dell’uguaglianza; dopo la dispersione era stato il protagonista della protesta contro le ingiustizie sociali e del progresso. La storia dei popoli andava avanti, “il regno d’Israele è morto: non si resuscitano i morti!”
All’inizio del 1920 lo scontro tra i sionisti italiani e l’”Avanti”, critico verso la presenza di elementi borghesi tra le file sioniste, portò alla precisazione da parte di Dante Lattes sul ruolo del movimento sionista alla soluzione del problema ebraico senza prendere posizioni politiche.
L’analisi di Luca La Rovere nel saggio Fascismo, “Questione ebraica” e antisemitismo nella stampa socialista, un’analisi di lungo periodo: 1922-1967. affronta un arco temporale ricco di grandi avvenimenti storici e politici.
L’avvento del fascismo ridusse l’”Avanti” ad operare in condizioni sempre più difficili, con la denuncia tenace della violenza antiproletaria e della legislazione liberticida.
La questione ebraica veniva affrontata quasi esclusivamente con lo sguardo rivolto alla situazione degli ebrei nell’Europa orientale, dove il socialismo era visto come l’unica speranza di redenzione ed emancipazione del proletariato ebraico mentre il sionismo era considerato come una perniciosa forma di nazionalismo, incompatibile con l’internazionalismo proletario.
Nel 1923 il leader socialista riformista Claudio Treves sul periodico “La Giustizia” indicava l’antiebraismo fascista come disegno di esclusione sistematica dalla vita nazionale. Nel 1928 “La Libertà” scriveva che il fascismo stava regalando “quell’altra schifosa piaga di cui finora era gloria l’Italia essere stata immune: l’antisemitismo”.
Nel 1931 Filippo Turati, denunciando l’accordo tra lo Stato fascista e la Chiesa, accese una dura polemica con il rabbino Angelo Sacerdoti, che sosteneva la piena soddisfazione dell’ebraismo italiano per la recente legislazione sui culti ammessi. Come Treves, anche Turati collegava la restrizione dell’autonomia ebraica alla logica totalitaria del regime e invitava gli ebrei ad unirsi ai socialisti contro il fascismo e le forze della reazione a difesa dei valori della libertà.
La posizione dei socialisti riformisti sull’antisemitismo non era condivisa dalla frazione massimalista, che continuava a interpretarlo come strumento ideologico utilizzato dalla borghesia per creare conflitti artificiali, sottovalutando antisemitismo fascista.
Nel 1934 l’arresto di alcuni appartenenti al movimento “Giustizia e Libertà”, molti dei quali di origine ebraica, fornì il pretesto alla stampa fascista per lanciare una campagna di stampa contro gli ebrei, assimilati all’antifascismo e quindi all’antinazione.
L’”Avanti” massimalista si chiese se l’iniziativa era un segnale che Mussolini intendeva seguire la strada di Hitler ma in realtà l’antisemitismo improvvisamente agitato dal duce era un “volgarissimo ricatto” contro certa alta banca israelita per ottenere prestiti di cui aveva bisogno.
La posizione massimalista non mutò neppure in occasione della promulgazione delle leggi razziali del 1938; secondo l”Avanti” Mussolini intendeva sfruttare la campagna contro gli ebrei per proclamarsi nemico del capitale e amico del popolo. La persecuzione non meritava attenzione secondo i massimalisti, che consideravano gli ebrei italiano capitalisti e fascisti della prima ora. L’”L’Avanti” scriveva: “Noi pensiamo che l’antisemitismo non aumenterebbe né diminuirebbe i torti del fascismo, per il fatto di estendere ad altri 40 mila italiani (ebrei) le persecuzioni di cui sono vittime 35 milioni di proletari”. L’antisemitismo, estraneo alla popolazione, era considerato un affare interno alla borghesia italiana.
Diversa la posizione riformista, anche grazie alla collaborazione di Guido Lodovico Luzzatto con l’organo del partito socialista unificato, pubblicato prima a Zurigo, poi a Parigi con il titolo de “Il Nuovo Avanti”. Il giovane esule antifascista seppe comprendere, a pochi mesi dall’ascesa al potere di Hitler, la distinzione tra l’antisemitismo ideologico del nazismo e quello fascista. Il nazismo con la persecuzione razziale escludeva per principio dallo Stato quasi due milioni di cittadini sulla base di un odio dichiarato e inconciliabile.
Gli eventi del 1938 portarono Luzzatto a collegare la svolta antisemita in Italia e la campagna razziale avviata dal regime con la guerra in Etiopia, e a rimarcare il cinismo di Mussolini nel tradire i molti ebrei che avevano aderito al fascismo e nel cacciare gli ebrei stranieri che aveva accolto, in spregio a tutti i principi del diritto internazionale. Colpiva la passiva accettazione da parte del paese della svolta antiebraica, in particolare da parte delle sue élite culturali, senza che si levasse alcuna protesta di professori e accademici. Luzzatto commentò: “maturata non è un’antipatia italiana per gli ebrei, ma lo sprofondamento più in basso, delle coscienze nell’avvilimento, nell’abbiezione”.
In più occasioni il giornale espresse la propria solidarietà nei confronti dei perseguitati, dichiarando offensiva per la coscienza d’ogni uomo civile la persecuzione senza una sola giustificazione contro gente per nulla colpevole, se non di essere nata per caso da genitori ebrei.
“Il Nuovo Avanti” definì “leggi del disonore” i provvedimenti che avevano introdotto il razzismo nella legislazione dello Stato, sanzionando di fatto la rottura del principio di eguaglianza dei cittadini. I socialisti presero l’impegno solenne, in quanto rappresentanti “dell’Italia di domani” di abbattere il vergognoso edificio legislativo voluto dal regime. Luzzatto seguì con partecipazione umana e profondità analitica l’inasprirsi della persecuzione, notando l’assenza di odio contro gli ebrei ma anche l’assoluta mancanza di indignazione per l’ingiustizia, che sarebbe diventata opportunismo e indifferenza, anche se il regime richiedeva l’attiva collaborazione dei cittadini nell’applicazione dei provvedimenti antisemiti.
Le pubblicazioni di entrambi i periodici socialisti si interruppero nel 1940 e solo dopo l’8 settembre ’43 le edizioni clandestine dell’”Avanti” diedero notizia delle deportazioni in atto, pur in qualche articolo, con la persistenza dello stereotipo dell’”ebreo ricco” e di vecchi pregiudizi.
Con la Liberazione e la ripresa dell’attività politica l’”Avanti” ritornò come organo ufficiale del Psiup. Il primo articolo dedicato agli ebrei prendeva atto della abolizione della inumana legislazione antiebraica e richiedeva alla nuova Italia la rapida reintegrazione degli ebrei nella società, a partire dagli impieghi statali.

Il tema del coinvolgimento degli italiani nella deportazione venne riportato solo a guerra finita, con una differenza di giudizio sulle efferatezze compiute dai nazisti e le responsabilità dei fascisti, mancando un collegamento tra la deportazione e l’eliminazione fisica di massa ai provvedimenti legislativi del 1938 e alla passività degli italiani.
Fu Pietro Nenni nel 1947 a denunciare la tendenza all’oblio che si registrava intorno la “più colossale delitto della storia umana” che aveva visto come vittime i milioni di sovietici, i milioni di ebrei e di ebree e le centinaia di migliaia di militanti antifascisti, e a chiedere che venisse attuata pienamente l’epurazione in Germania ed il rinnovamento del paese, che le forze di occupazione tendevano a limitare per paura del bolscevismo.
Ancora non si affrontava la connessione tra la fase della “persecuzione dei diritti” a quella della “persecuzione delle vite” ma venivano messi in luce il trauma patito con l’espulsione dalla società italiana nel 1938 e la grande difficoltà per gli ebrei di trovare ascolto nel clima postbellico.
L’alleanza degli ebrei italiani con l’antifascismo fu suggellata dall’episodio dell’assalto da parte dei neofascisti il 14 aprile 1948 e l’”Avanti” dichiarò che il Fronte popolare avrebbe difeso le minoranze religiose e in modo speciale le eroiche comunità ebraiche, che tanto sangue avevano versato per l’Italia e la libertà.
Nel corso degli anni cinquanta il rapporto tra sinistra antifascista e ebraismo si andò consolidando, con un’opera di vigilanza contro ogni reviviscenza di antisemitismo.
Significativa è la negazione assiomatica della presenza di antisionismo nell’Unione Sovietica e nei paesi dell’Europa Orientale, particolarmente evidente nelle cronache del processo Slanski e di quello dei medici nell’Urss del 1953, accompagnata dalla fideistica e acritica ripresa della denuncia dei complotti titoisti e sionisti.
Nel corso degli anni cinquanta e sessanta l’”Avanti” portò avanti una puntuale informazione sulla formazione della memoria dello sterminio, stimolando la comprensione delle ragioni di quella catastrofe e a tramandarne la memoria alle nuove generazioni. A questa azione contribuirono in maniera significativa alcuni intellettuali e uomini politici socialisti. E’ del 1956 la prima Mostra sulla deportazione, organizzata a Torino con il contributo di Primo Levi. Tuttavia a questa azione corrispose una forte reticenza nel riconoscere che l’antisemitismo sopravviveva e, anzi era coltivato a fini politici anche nei paesi del socialismo reale.
All’inizio del 1960 l’”Avanti” riportò con preoccupazione la notizia della profanazione di sinagoghe e latri luoghi simbolici avvenuti a Londra, Parigi, Vienna e diverse città tedesche. Anche in Italia apparvero simboli ed episodi neonazisti in più di venti città ad opera della componente giovanile dell’MSI. L’allarme generato dal riapparire della svastica a soli 15 anni dalla fine della guerra portò l’”Avanti” a dedicare un’intera pagina allo sterminio degli ebrei europei, dedicata soprattutto all’educazione dei giovani. Mario Berti dalle pagine di “Critica Sociale” bollava come “cretinismo” l’antisemitismo degli sparuti gruppi di giovani, che totalmente ignari di quanto avvenuto in Europa solo pochi anni prima, erano manovrati da forze reazionarie.
I fatti di Genova del luglio 1960 rappresentarono il culmine della mobilitazione antifascista contro l’MSI. Il Parlamento, grazie all’impegno dei socialisti, tra cui l’ex deportato Piero Caleffi, ratificò la Convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio.

Con l’avvio nel gennaio del 1961 del processo a Eichmann si riaccese la battaglia per l’affermazione del carattere antifascista della democrazia italiana e l’”Avanti”, in parallelo, lanciò un’inchiesta a puntate dal titolo “I nazisti sono tra noi”, che riportava le infiltrazioni e le connessioni tra ex nazisti e neofascisti in Italia e in Europa.
Il tema dell’antisemitismo sovietico venne sollevato in termini nuovi da Piero Caleffi in un articolo che riassumeva le vicende della nascita dello Stato ebraico e la posizione dell’Unione Sovietica, sia verso Israele sia verso i cittadini ebrei della Federazione. Si coglieva il mutamento intervenuto da parte dei socialisti, ora più autonomi rispetto ai comunisti, nell’affrontare criticamente la questione dell’antisemitismo sovietico.
Dopo qualche anno si sarebbe verificata, con la guerra dei sei giorni, la rottura tra la sinistra comunista e Israele. Questo tema è ampiamente trattato nel saggio di Alessandra Tarquini dal titolo “Il Partito Socialista fra Guerra fredda e Questione ebraica: sionismo, antisemitismo e conflitto arabo-israeliano nella stampa socialista, dalla nascita della Repubblica alla fine degli anni sessanta”.

Il PSI aveva accolto con entusiasmo la nascita dello Stato di Israele e si era schierato decisamente a favore degli ebrei nella guerra del 1948, criticando apertamente la politica inglese, volta a tutelare i propri interessi economici e militari nella regione. La stampa socialista accusava gli inglesi di essere artefici di una politica colonialista e imperialista, augurandosi che il proletariato ebraico potesse allearsi con quello arabo per dar vita a una nazione socialista libera dal colonialismo e dal feudalesimo dei grandi proprietari terrieri. Il PSI chiese al governo di riconoscere immediatamente lo Stato ebraico e esprimere una posizione ufficiale di sostegno.
A questa posizione aveva contribuito Gustavo Sacerdote, spiegando le origini culturali del movimento sionista fondato da Herzl ed il legame tra socialismo e sionismo, nati dalla medesima matrice filosofica della sinistra hegeliana. Per la maggior parte degli intellettuali del PSI gli ebrei avrebbero portato il progresso e la democrazia in Medio Oriente e Sacerdote citò i kibbuz come modello di società alternativa al capitalismo.
La posizione del PSI verso Israele mutò a partire dal 1951, in particolare con una dura campagna contro Ben Gurion e con il dissenso sul ruolo di Israele nella guerra di Suez del 1956. Su “Mondo Operaio” il sionismo veniva considerato da un anonimo inviato come “un ibrido di razzismo e religione” e si sollecitava il popolo di Israele ad imporre al proprio governo una nuova politica fatta di buone relazioni con gli arabi.
Da allora i giudizi sugli israeliani divennero sempre più critici. Nel 1953 veniva pubblicato un articolo che accusava il sionismo di essere diventato uno strumento dell’imperialismo.
Nella diffusione della memoria della Shoah nell’”Avanti” mancò una riflessione sulle ragioni dell’antisemitismo nazista. Un esempio di questa tendenza fu la recensione pubblicata nel 1954 dal giornale socialista al Diario di Anna Frank, in cui non fu citato il fatto che era una giovane ebrea.
Il processo Slansky vide in quegli anni l’”Avanti” schierarsi con il suo corrispondente Carlo Bonetti per la tesi del complotto sionista e quindi per la colpevolezza degli imputati. Bonetti spiegava la distinzione fra antisionismo e antisemitismo, sostenendo che il sionismo era un movimento di classe, nemico della classe operaia, che faceva di Israele un paese pericoloso per il futuro del socialismo. Anche il processo e la condanna dei medici ebrei furono riportati dall’ “Avanti”, rigidamente in una posizione filosovietica, come la giusta conclusione di un tentativo di complotto imperialista.
In questo quadro appare chiaro come l’”Avanti” nel 1956 si schierò a favore di Nasser, che nazionalizzò il canale in risposta al rifiuto della Banca mondiale di finanziare la costruzione della diga di Assuan.
Nel 1959 la rivista “Il Ponte”, fondata da Piero Calamandrei,

dedicò un numero speciale al decennale della nascita dello Stato di Israele. I giudizi dei socialisti all’iniziativa furono discordi tra “Critica Sociale”, che accolse con entusiasmo l’iniziativa, e l”Avanti”, che colse l’occasione per criticare Israele e la sua classe dirigente.
La posizione dei socialisti mutò a partire dagli anni sessanta, con maggior attenzione all’antisemitismo in Unione Sovietica e con la riflessione proposta su Israele e sul mondo ebraico dopo il processo ad Adolf Eichmann. Alla metà degli anni sessanta ormai il PSI si schierava in favore della società israeliana e in difesa dello Stato ebraico, come si vide chiaramente in occasione della guerra dei sei giorni, in aperto contrasto con la posizione del PCI.
Dopo la guerra del giugno 1967, la stampa socialista cambiò ancora una volta la propria posizione, con riflessioni sul conflitto e sulla politica estera israeliana ed in particolare sulla questione palestinese
Gli anni successivi videro un cambiamento del clima politico generale e, soprattutto, della linea di politica interna e internazionale del PSI. In particolare, negli anni della segreteria di Bettino Craxi il partito si impegnò a favore del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. All’interno del partito si svilupparono due orientamenti divergenti che la stampa socialista puntualmente registrò con alternarsi di articoli. La corrente filoisraeliana aveva fra i suoi esponenti più autorevoli Aldo Garosci che il 15 maggio 1968, in occasione del ventennale della nascita di Israele, raccontò ai lettori dell’”Avanti” la nota di angoscia con cui aveva assistito alle celebrazioni di un paese che non aveva ancora ottenuto il diritto di esistere.
In quegli anni l’ebraismo fu definitivamente riconosciuto come una componente fondante dell’identità italiana e socialista. Nel marzo 1987, aprendo il Congresso del partito, Craxi citò l’opera di Carlo Rosselli

e Giorgio Spini, nel quadro di una rivalutazione del pensiero liberal-socialista, citò l’ebraismo del fondatore di “Giustizia e libertà” come un esempio del contributo fornito dagli ebrei alla causa della libertà e del socialismo nella storia italiana. Si trattava di un riconoscimento importante, che portava a conclusione un lungo e complesso processo di evoluzione del rapporto tra l’ebraismo e il socialismo italiano.
Nel complesso il rapporto tra ebraismo e socialismo nella storia dell’Italia contemporanea sembra pienamente in linea con la storia del PSI, segnata da contrasti interni, lacerazioni ideologiche. Gli ebrei guardarono con ottimismo e fiducia al socialismo, cui apportarono un contributo di vitalità ed esperienze, accorgendosi però che veniva più facilmente accettato il singolo mentre più difficile era il riconoscimento come comunità.
Edmondo de’Donato

Esodo moderno, perché la popolazione ebraica europea è diminuita del 60% negli ultimi 50 anni
Simone Benazzo Linkiesta 7 Novembre 2020
Oggi risiede nel Vecchio Continente solo un ebreo su dieci, come nel XII secolo. Una ricerca fotografa il declino demografico di una delle più antiche comunità etnico-religiose
L’Institute for Jewish Policy Research (Jpr) di Londra ha pubblicato uno studio dedicato alla situazione demografica degli ebrei europei, curato dai professori Sergio Della Pergola, nato a Trieste durante l’occupazione tedesca (1942), e Daniel Staetsky.
Il report illustra la costante riduzione del numero di ebrei verificatasi a partire dal secondo dopoguerra in quasi tutti gli Stati europei, includendo nel novero i 27 Ue, i paesi dell’ex Unione sovietica (tre baltici esclusi) e tutti quelli che non rientrano in queste due categorie, come il Regno Unito.
La ricerca inizia sottolineando che, poiché fenomeni come la crescita dell’estremismo di destra e di sinistra e la comparsa della minaccia islamista hanno portato alla diffusione di razzismo e xenofobia, è aumentata in parallelo anche la declinazione di questa ostilità popolare verso le minoranze che colpisce gli ebrei, l’antisemitismo. Osservazione che riecheggia le conclusioni di un approfondito studio sul tema pubblicato nel 2018 dall’Agenzia Ue per i diritti fondamentali.
Anche il futuro di questa longeva comunità europea dipende così dalla tenuta geopolitica dell’Ue e dalla resilienza che essa saprà opporre a estremismi e autoritarismi di sorta. Come sintetizzano le conclusioni, “gli ebrei d’Europa andranno dove andrà l’Europa”.
Gli ebrei, minoranza senza terra, hanno infatti sempre sostenuto storicamente la creazione di strutture multinazionali non esclusive e non vincolanti culturalmente. il genere di entità politico-amministrative dove più hanno potuto prosperare e integrarsi, grazie alla tolleranza de facto garantita dalle autorità. Coerentemente, anche oggi tendono a essere più europeisti dei loro connazionali, soprattutto oltrecortina. Se nei paesi dell’Europa occidentale soltanto una fascia compresa tra l’8% e il 21% si sente “molto attaccata all’Ue”, comunque superiore alle medie nazionali, in Europa centro-orientale – Ungheria e Polonia – questa adesione è invece vistosamente più marcata. Quasi la metà degli ebrei ungheresi e polacchi si definisce “molto attaccata all’Ue”, contro medie nazionali inferiori al 20%.
Si stima che oggi in Europa vivano circa 1,329,400 milioni di ebrei: 788,800 (il 59%) nei 27 paesi Ue, 210,400 (il 16%) in paesi ex sovietici (baltici esclusi) e 330,220 (25%) in paesi terzi – quasi tutti nel Regno Unito (90%).
Tra questi si contano circa 70 mila cittadini israeliani, distribuiti perlopiù tra Regno Unito (18 mila), Germania (10 mila), Francia (9 mila) e Paesi Bassi (6 mila).
Il calcolo è notevolmente influenzato dalla scelta tassonomica, in quanto ci sono vari modi di delimitare il concetto di “ebreo”. Le stime menzionate considerano solo il cosiddetto “nucleo della popolazione ebraica”, cioè le persone che si auto-identificano come ebrei per religione, etnia o cultura. Ma includendo per esempio i possibili beneficiari della Legge del ritorno – la norma che garantisce la cittadinanza israeliana a chiunque possa dimostrare di aver madre ebrea o di essersi convertito all’ebraismo, e non praticare alcun altro culto – il totale arriva a 2,820,800, più del doppio degli ebrei europei identificati tramite la concettualizzazione più riduttiva.
Un divario così cospicuo tra le due cifre si spiega con il fatto che centinaia di migliaia di individui, specialmente in Europa centro-orientale, non si definiscano “ebrei” tout court, verosimilmente perché assimilati o perché timorosi di subire ritorsioni, ma potrebbero rivendicare ascendenze ebraiche.
Un ulteriore problema nomenclaturale, inoltre, riguarda i fondamenti di questa auto-definizione. Nei paesi post-comunisti prevalgono i criteri di etnia e cultura, mentre in Europa occidentale – pur con differenze tra i vari paesi – è la religione il principale tratto distintivo. A Est si è quindi etnicamente o culturalmente ebrei, a ovest lo si è perlopiù per credo.
Conteggiando solo gli individui che compongono il “nucleo della popolazione ebraica”, l’attuale proporzione di ebrei europei (9%) sul totale della popolazione ebraica mondiale è paragonabile a quella (12%) stimata nel 1170 da Beniamino di Tudela, antesignano di Marco Polo. E oggi come allora gli ebrei rappresentano meno dello 0.5% della popolazione europea.
La presenza demografica degli ebrei in Europa, insomma, è tornata ai livelli del XII secolo, dopo aver vissuto una crescita pressoché costante fino al primo Novecento.
Nel 1880 nel Vecchio continente viveva l’88% degli ebrei mondiali, suddivisi tra Europa centro-orientale (75%) e Europa occidentale (13%). Mezzo secolo più tardi (1939), nonostante l’emigrazione in massa verso il Nuovo Mondo, gli ebrei europei costituivano ancora la maggioranza assoluta (58%). Alla vigilia della Seconda guerra mondiale il nostro continente ospitava più di diciassette milioni di ebrei, un numero vicino all’attuale popolazione dei Paesi Bassi.
Nel 1945 saranno undici. La Shoah estirperà quasi interamente le comunità ebraiche di alcuni Stati, principalmente in Europa orientale e nei Balcani. Un trauma collettivo di questa portata renderà impossibile a gran parte dei sopravvissuti e dei loro discendenti sentirsi di nuovo sicuri e accettati nei territori che erano abituati a considerare la propria patria, invogliandoli a emigrare non appena si fosse presentata l’occasione propizia. Che arriverà tre anni e una settimana dopo la resa della Germania nazista. Il 14 maggio del 1948 David Ben-Gurion fonda lo Stato di Israele.
La nascita dello Stato ebraico è stato il primo evento geopolitico post-Seconda guerra mondiale a plasmare radicalmente le traiettorie demografiche degli ebrei europei. Ha agito fin da subito da catalizzatore per gli ebrei di tutto il mondo, ma in particolar modo per quelli europei, traumatizzati dalla Shoah. Tra 1948 e 1968 circa 620 mila ebrei abbandonarono l’Europa orientale; mezzo milione di loro si trasferì in Israele.
Tuttavia, il calo della popolazione ebraica nell’Europa comunista (-22%) venne in parte contemperato dall’aumento di quella in Europa occidentale (8%), principalmente a causa della disgregazione degli imperi coloniali.
La decolonizzazione è stato infatti il secondo degli eventi destinati a stravolgere le vicende umane e collettive degli ebrei del nostro continente.
Il graduale ritiro soprattutto della Francia dai possedimenti coloniali in Africa settentrionale e Asia, ma anche quelli di Regno Unito, Italia, Belgio e Paesi Bassi, fu nefasto per gli ebrei residenti – a volte da secoli – in queste colonie extra-europee. Non solo, avendo sovente svolto la funzione di intermediari sociali ed economici tra potenza occidentale occupante e popolazione locale, gli ebrei furono reputati collusi con gli invasori, ma dopo l’esplosione dei conflitti arabo-israeliani iniziarono a venir sempre più identificati con Israele, il nemico numero uno delle popolazioni arabo-musulmane. Sottoposti a intimidazioni e soprusi continui, molti di loro scelsero di emigrare, spesso nelle metropoli europee, rimpinguando le comunità ebraiche di questi paesi decimate dalla Shoah. A partire dagli anni ‘50 la Francia da sola accolse oltre 250 mila ebrei, provenienti perlopiù dal Maghreb ex-francese.
Un terzo evento è stato però quello più determinante nell’epopea degli ebrei d’Europa: il collasso del sistema comunista nel biennio 1989-91. Già a partire dai tardi anni ‘60, alcuni minimi allentamenti dei divieti imposti dal potere sovietico avevano permesso a molti ebrei di lasciare il paradiso dei lavoratori ed espatriare (solitamente in Israele). Il crollo del Muro di Berlino innescò però un esodo ingente, trascinatosi anche per i tre decenni successivi. Tra 1969 e 2020 più di 1,8 milioni di ebrei hanno lasciato la metà (post)comunista del continente.
In termini percentuali, nell’ultimo mezzo secolo l’Europa ha perso il 59% della propria popolazione ebraica: solo il 9% di quella rimasta in Europa occidentale, ma l’85% di quella dell’Europa orientale.
Se il picco dell’emorragia demografica si è avuto negli anni ‘90, ancora negli ultimi due decenni circa 335 mila ebrei europei sono trasmigrati in Israele, quasi due terzi dei quali dalle sole Russia e Ucraina. Secondo gli autori del report, si sarebbe ora in una fase di assestamento: la stragrande maggioranza (84%-92%) degli ebrei che abitano in Europa ha in programma di rimanerci. Tuttavia, anche qualora l’emigrazione cessasse, le comunità ebraiche europee potrebbero comunque assottigliarsi a causa di altri fattori – aumento dei matrimoni misti, assimilazione, progressivo invecchiamento.
Gli ebrei non sono fuggiti dai paesi del Patto di Varsavia solo per le motivazioni che hanno spinto migliaia di concittadini a compiere la stessa scelta dopo il Crollo del Muro di Berlino: salari più alti e benessere a Ovest, polverizzazione dello Stato sociale e insicurezza generalizzata in patria. Come testimoniano le opere di Vasilij Grossman, l’antisemitismo era molto diffuso anche in Unione sovietica. E non ne soffriva solo il popolino, bensì anche l’intelligentia e le alte sfere, si veda il cosiddetto “complotto dei camici bianchi” scatenato da Stalin poco prima di morire.
Un’interpretazione storiografica grossolana – opposizione dicotomica e irriducibile tra nazisti persecutori degli ebrei e sovietici liberatori dei lager – e le scorie della martellante retorica sovietica dell’amicizia tra i popoli, con cui il regime tentava di negare le tensioni interetniche e la xenofobia latenti nella popolazione, sono tra i fattori che hanno contribuito a occultare questa pagina ingloriosa. Iniziative propagandistiche come la tragicomica vicenda dell’Oblast’autonoma ebraica poco riuscirono a scalfire il radicato antisemitismo cui indulgeva così volentieri anche l’homo sovieticus.

In memoria di Ytzhak Rabin
(Gerusalemme, 1º marzo 1922 – Tel Aviv, 4 novembre 1995)
Nel 25° anniversario dell’assassinio di Rabin, mi piace ricordarlo pubblicando il discorso che egli pronunciò a Washington il 13 settembre 1993, in occasione della firma degli “accordi di Oslo” con l’OLP.
Luciano Belli Paci
DISCORSO DEL PREMIER ISRAELIANO YITZHAK RABIN PRONUNCIATO DOPO LA FIRMA DELL’INTESA ISRAELO-PALESTINESE.

Siamo venuti da Gerusalemme, l’antica ed eterna capitale del popolo ebraico.
Siamo venuti da una terra tormentata e addolorata.
Siamo venuti da un popolo, una casa, una famiglia, che non ha conosciuto un solo anno, un solo mese, in cui le madri non abbiano pianto i loro figli.
Siamo venuti per cercare di mettere fine alle ostilità in modo che i nostri figli, i figli dei nostri figli, non debbano più sperimentare il doloroso costo della guerra, della violenza e del terrore.
Siamo venuti per tutelare le loro vite e alleviare il cordoglio e i ricordi dolorosi del passato, per sperare e pregare per la pace.
Lasciate che dica a voi, palestinesi, che siamo destinati a vivere insieme sullo stesso suolo, sulla stessa terra.
Noi, soldati tornati dalle battaglie macchiate dal sangue; noi, che abbiamo visto i nostri parenti e amici uccisi davanti ai nostri occhi; noi, che abbiamo partecipato ai loro funerali e non possiamo guardare negli occhi i loro familiari; noi, che siamo venuti da una terra dove i genitori seppelliscono i figli; noi, che abbiamo combattuto contro di voi, palestinesi, noi vi diciamo oggi a voce alta e chiara: basta col sangue e le lacrime.
Basta.
Non abbiamo desideri di vendetta… non nutriamo odio nei vostri confronti.
Noi, come voi, siamo gente… gente che vuole costruire una casa, piantare un albero, amare, vivere al vostro fianco con dignità, in affinità, come essere umani, come uomini liberi.
Noi diamo oggi un ‘occasione alla pace, e vi diciamo ancora “basta”.
Preghiamo che arrivi il giorno in cui noi tutti diremo addio alle armi.
La foto : Rabin e il testo della canzone Sir Leshalom che aveva cantato poco prima di essere assassinato

Le parole cambiano il mondo
David Grossman 16 Ottobre 2020
Nell’era della pandemia il potere della scrittura può essere salvifico anche ricordandoci chi eravamo. Con questo intervento il grande scrittore israeliano ha inaugurato l’edizione virtuale della Buchmesse di Francoforte
Capita che, a metà giornata, io alzi la testa dalla tastiera e pensi a uno o due scrittori miei amici.
Li immagino seduti al computer come me, alla ricerca di un vocabolo o di un tratto elusivo del carattere di un personaggio. Li immagino tamburellare con le dita, prepararsi l’ennesimo caffè. Camminare su e giù per la stanza perché la frase che hanno appena scritto non suona come dovrebbe. Li immagino a casa loro. La pandemia infuria, magari ha già bussato alla loro porta, eppure loro sono completamente assorti, quasi accordassero uno strumento musicale. Immagino una sorta di rete invisibile, sottile ma forte, tessuta da migliaia di scrittori e poeti che vivono in ogni parte del mondo. Alcuni hanno già pubblicato libri, altri sono alla loro prima esperienza. Gran parte di loro non è nemmeno consapevole dell’esistenza degli altri, ma insieme fanno qualcosa di importante: correggono un poco la dissonanza generale. Creano un’opera d’arte.
Qui, oggi, noi scrittori, poeti, traduttori, redattori, editori, agenti ma soprattutto lettori, paragoniamo tristemente le circostanze odierne a quelle degli anni passati e ci chiediamo quale sia il nostro compito nell’attuale realtà. Potremmo dare un qualche contributo? Creare una sorta di “anticorpo” o di “vaccino spirituale” al virus? Contrapporre qualcosa di significativo al senso di restrizione e di annientamento generato dalla pandemia?
Credo che questo “qualcosa” sia la nostra capacità di osservare. Il modo in cui guardiamo il mondo e descriviamo ciò che vediamo. L’osservazione è il fulcro della nostra arte. Ciò che fa di noi degli scrittori, e forse le persone che siamo. E c’è molto da osservare. E da raccontare. In quasi tutti gli ambiti della vita avvengono, e avverranno, cambiamenti. Sistemi economici, politici, sociali, culturali collasseranno o assumeranno nuove fisionomie. Probabilmente anche i rapporti tra le persone, tra famigliari, tra amici, tra coppie muteranno.
Forse la prossimità alla morte farà sì che donne e uomini, dopo la pandemia, vedano la loro vita in una luce diversa e non vogliano più accettare compromessi. E forse scopriranno quanto siano significativi e importanti i rapporti di amicizia e d’amore. Ma fino a quel momento il coronavirus continuerà a imperversare e, come sempre, man mano che le fondamenta della società verranno minate e la sicurezza personale e nazionale diminuirà, probabilmente assisteremo a un aumento degli episodi di nazionalismo, di fondamentalismo religioso, di xenofobia, di razzismo e a gravi violazioni della democrazia e dei diritti civili. E noi scrittori osserveremo, scriveremo, documenteremo e metteremo in guardia da chiunque cerchi di attuare manipolazioni linguistiche e cognitive. Da chiunque minacci i nostri diritti civili e umani. Un evento come l’attuale pandemia di coronavirus avviene forse una volta in un secolo. Il destino ha voluto che accadesse a noi. È una malattia orribile, letale, che ci fa sentire impotenti. Osservarla, osservarne le conseguenze, è come fissare il sole. Ma gli scrittori hanno sempre fissato questo o quel sole e raccontato ciò che hanno visto. È la natura di questa strana professione. Vogliamo osservare quest’epoca e ricordare com’eravamo. In che modo abbiamo resistito o non resistito. Dove si sono rivelate le nostre debolezze – individuali e sociali – e in quali momenti abbiamo scoperto di essere più deboli di quanto pensassimo e più forti di quanto credessimo.
Saremo testimoni attivi, curiosi, acuti. Scrivere, non necessariamente della pandemia, è anche il nostro modo di resistere ai cliché, a vuoti slogan, ad affermazioni indiscriminate che spianano la strada all’istigazione, al pregiudizio e al razzismo. Ciò che facciamo riuscirà a indebolire anche minimamente lo slancio del coronavirus? Ovviamente no. Però ci permetterà di rafforzare un poco il nostro sistema immunitario. Di ricordare a noi stessi chi eravamo prima della pandemia. E di quanto potrebbe essere bello e luminoso il mondo dopo che saremo usciti da questo incubo.
Prima di concludere vorrei raccontarvi una storia così come mi fu riferita da Abraham Sutzkever, uno dei più grandi poeti yiddish, vissuto nel ghetto di Vilnius durante la seconda guerra mondiale.
Così Sutzkever mi narrò della notte in cui scappò dal ghetto: “Mi convinsi del potere racchiuso nella poesia nel marzo del 1944, quando dovetti attraversare un campo minato. Nessuno sapeva dove fossero le mine. Vidi persone fatte a pezzi. Vidi uno stupido uccello che si era avvicinato troppo. Qualunque direzione prendessi, qualunque passo facessi, avrebbe potuto significare la morte. Ma fra me e me ripetevo una melodia” (e per “melodia” lui intendeva una poesia). “E al ritmo di quella melodia camminai per un chilometro nel campo minato, e ne uscii”. Poi disse la seguente, sorprendente, frase: “Potresti ricordarmi che melodia era? Io non ricordo…”. E io posso immaginarlo con un sorrisetto, quasi a dirci che la melodia la si dimentica sempre. Sta a noi reinventarla, con parole nostre, per non sentirci impotenti, sconfitti, persino nel mezzo di un campo minato. Per avere ancora speranza.
Traduzione di Alessandra Shomroni

ISRAELE, EMIRATI ARABI E BAHREIN: LA PACE PUÒ DIVENTARE CONTAGIOSA
di Gabriele Eschenazi Gariwo 12 Ottobre 2020

Nessun ballo per le strade ha accompagnato in Israele l’annuncio dell’accordo di pace con Emirati Arabi e Bahrain. Nelle piazze gli israeliani c’erano e ci sono, ma per un altro motivo: manifestare contro un governo non solo capeggiato da un primo ministro sotto processo per corruzione, ma assolutamente incapace di gestire l’emergenza sanitaria ed economica legata alla diffusione del Covid-19. Questa pace per i comuni cittadini non sembra al momento contare nulla. Eppure è da sempre il loro sogno, tema di canzoni celebri, preghiere e opere artistiche. Leader che hanno concluso accordi di pace come Begin o Rabin sono entrati nel mito quasi quanto David Ben Gurion. Succederà anche con Benjamin Netanyahu e la sua pace con Emirati Arabi e Bahrein? Da dieci anni al potere aspetta invano di entrare anche lui nel pantheon dei primi ministri che hanno fatto la storia dello Stato ebraico. Pensava di farlo con l’annessione dei territori, ha scelto di farlo con questi accordi, ai quali dovrebbero seguirne altri. Finora, però, questa mossa non ha pagato. Migliaia d’israeliani radunati in massa sotto casa sua continuano a chiedergli di andarsene. E anche i suoi sostenitori di destra non hanno apprezzato. Per loro l’annessione ora “congelata” era più importante di qualsiasi pace, che in un primo momento ha più che altro entusiasmato uomini di affari e tour operator, pronti a proporre ai loro concittadini trasferte da sogno in Paesi dal consumismo e dal lusso sfrenato.
Gli arabi israeliani da parte loro si sono domandati quando un governo israeliano firmerà una pace anche con loro. Netanyahu negli ultimi anni ha fatto di tutto per delegittimarli come cittadini di pari diritti. Ha fatto approvare la Legge della Nazione, durante le campagne elettorali gli ha additati come pericolo per la democrazia. “Votano in massa”,”Ci odiano, ci vogliono uccidere”, i suoi messaggi diffusi a ripetizione sui social media con l’aiuto di suo figlio Yair, “odiatore” di professione. Gli arabi locali, i palestinesi, sarebbero gli arabi cattivi e quelli della penisola arabica gli arabi buoni, educati, civili e filoebrei. Ma cosa succederà quando pellegrini degli Emirati, Bahrein e poi Arabia Saudita verranno in visita a Gerusalemme per pregare nei luoghi santi? Saranno più liberi di muoversi dei loro fratelli palestinesi? Potrebbero essere decine di migliaia i nuovi visitatori del Monte del Tempio e della moschea di al-Aqsa. Ma non si può dimenticare che questo è un luogo di preghiera rivendicato anche dagli ebrei ortodossi più oltranzisti che sognano il “terzo tempio”. Palestinesi, turisti-pellegrini dal mondo arabo, ebrei ortodossi: un insieme di comunità diverse da gestire in pochi chilometri quadrati. Interessante, tra l’altro notare, come Netanyahu non abbia richiesto di inserire nell’accordo il riconoscimento d’Israele come “Stato del popolo ebraico”, clausola da lui definita irrinunciabile per ogni accordo con i palestinesi, ma di fatto pretestuosa e senza senso.
La destra annessionista si preoccupa del destino del suo disegno della Grande Israele. Gli accordi su questo tema sono volutamente ambigui. In un passaggio parlano di “una soluzione che tenga conto delle esigenze e delle aspirazioni di entrambi i popoli” senza però menzionare il termine “diritti” che c’era negli accordi di Camp David. In un altro, invece, facendo riferimento al piano Trump parlano di “una soluzione giusta, completa, realistica e duratura al conflitto israelo-palestinese”. Il termine “realistica” potrebbe lasciar intendere una soluzione alla Trump, che tenga cioè conto della realtà attuale sul territorio con colonie e Gerusalemme annesse a Israele, ma anche delle esigenze dei palestinesi privati di risorse e spazio vitale da 43 anni di occupazione.
Rimane il fatto che questi accordi pace sono stati raggiunti ancora una volta come in passato senza proporre un soluzione definitiva al problema palestinese. Era già successo al tempo degli accordi di pace con Egitto e Giordania, ma c’è una differenza. Nei casi precedenti questi due Paesi furono aspramente criticati dal mondo arabo per aver abbandonato la causa palestinese, mentre questa volta a curare la regia degli accordi è un paese come l’Arabia Saudita, custode dei luoghi santi dell’Islam sul suo territorio, ma che potrebbe aspirare a mettere sotto la sua tutela anche Gerusalemme che Israele rivendica come sua capitale unica e indivisibile. Come saranno regolati i rapporti del mondo musulmano con la Città Santa? La questione è in sospeso, ma intanto Emirati Arabi e Bahrein si sono aperti una porta per il controllo della Gerusalemme araba.
Ma questo non è il loro unico successo politico. Hanno ottenuto dagli Usa senza veto israeliano di poter acquistare gli aerei da combattimento F-35, ora richiesti anche dal Qatar. L’accordo inoltre prevede che eventuali operazioni militari israeliane nella regione avvengano in coordinamento con gli Usa e con i suoi alleati arabi. Un vincolo alla libertà di manovra militare da sempre rivendicata da tutti i governi israeliani. Le alleanze come sempre aiutano chi le stringe, ma legano anche le mani.
Timori per le conseguenze dell’accordo investono l’Egitto, buon alleato degli Emirati, dai quali riceve come peraltro anche la Giordania copiosi finanziamenti al suo sviluppo dell’ordine di miliardi dollari. Il regime di al-Sisi si è giovato dei rapporti di pace con Israele per ritagliarsi spesso un ruolo di mediazione con Hamas, l’amministrazione palestinese e altri Paesi musulmani come il Sudan. L’allargamento della cerchia dei Paesi alleati d’Israele inevitabilmente diminuirà il peso diplomatico dell’Egitto sullo scacchiere mediorientale.
Guardando alla politica interna dello Stato ebraico ad essere sconfitta da questo accordo sembrerebbe essere anche la sinistra israeliana, o ciò che ne rimane dopo la quasi ormai certificata scomparsa del partito laburista. In realtà potrebbe essere un’occasione da cogliere. Il mantra che la pace col mondo arabo non si risolverà senza una soluzione del problema palestinese si è improvvisamente capovolto diventando “il problema palestinese non si risolverà senza che il mondo arabo non sia in pace con Israele”. L’iniziativa di pace promossa nel 2002 dalla Lega Araba su ispirazione saudita è ormai superata dagli eventi. Emirati e Bahrein con i sauditi sullo sfondo hanno deciso di rompere un tabù per convenienza strategica, ma anche guardando al futuro. E in questo modo sono venuti in effetti in soccorso del movimento della pace israeliano. Hanno bloccato la progettata annessione dei territori e ne hanno impedito la strumentalizzazione a Turchia e Iran. Hanno indebolito Hamas e Hezbollah, sempre più debole in Libano. Il concetto caro alla destra “tutti sono contro di noi” si sta ora sgretolando e anche i palestinesi si trovano ora di fronte a una realtà che non hanno mai voluto ammettere e che ha impedito loro in passato di accettare i vari piani di pace a loro proposti. Gli accordi di pace con Emirati e Bahrain, che “minacciano” di essere più caldi di quelli con Egitto e Giordania, parlano di cooperazione economica, tecnologica, scientifica e ambientale. Riconoscono in Israele una risorsa della regione e non un corpo estraneo. Ai palestinesi non rimarrà che prendere atto che il loro nemico non sarà mai sconfitto né con razzi, né con palloncini incendiari, né con missili, né con attentati, né con nuove Intifada.
Sarà sconfitto con la pace, rinunciando all’irrealistico “diritto al ritorno dei profughi”, chiedendo invece di abbattere muri e posti di blocco, cancellare le discriminazioni e restituire territori e risorse vitali alla creazione dello Stato palestinese. Sembra che una parte importante del mondo arabo abbia appreso la lezione di Nelson Mandela quando disse:”Se vuoi fare la pace col tuo nemico, devi lavorare col tuo nemico. Così lui diventerà tuo alleato”.
Lo stato di guerra e la violenza hanno da sempre aiutato la destra israeliana e Netanyahu, maestro nell’usare la paura per ergersi di fronte agli elettori come unico e insostituibile scudo. Oggi che il primo ministro vende falsamente alla sua opinione pubblica “una pace ottenuta in cambio di pace e non di territori”, sta alla sinistra israeliana sbugiardarlo e ribadire che per completare l’opera serve sedersi al tavolo con i palestinesi soprattutto se questi ultimi adotteranno una linea più realistica con il sostegno dei Paesi arabi moderati.
Analisi di Gabriele Eschenazi, giornalista

Israele: la crisi della sinistra
Giorgio Gomel – La Stampa Giovedì 24 Settembre 2020
Dopo una campagna virulenta e segnata, come nelle precedenti elezioni dell’aprile e settembre 2019, dall’isterismo ossessivo agitato dai partiti di destra contro gli arabi israeliani – circa il 20% dell’elettorato – i risultati del voto del 2 marzo scorso confermano il senso di un paese fortemente diviso, polarizzato sugli estremi. Netanyahu, giunto alla sua ottava campagna elettorale come leader del Likud e premier con ininterrotta continuità da undici anni, ha improntato la campagna a un plebiscito sul suo conto nell’imminenza del processo che lo attende per casi di corruzione, frode e abuso d’ufficio. Il processo, che sarebbe dovuto iniziare il 17 marzo, è stato rinviato, su decisione del ministro della Giustizia uscente da lui stesso recentemente nominato, prima alla seconda metà di maggio, poi a luglio, infine a dicembre prossimo, in ragione del diffondersi anche in Israele dell’epidemia da Coronavirus. I temi dirimenti per il futuro del paese – un accordo di pace con i palestinesi e il mondo arabo, il rispetto dello Stato di diritto e delle prassi democratiche, il legame controverso fra religione e politica, il monopolio del rabbinato ortodosso in materia di diritto civile e di famiglia, l’acuirsi delle diseguaglianze socioeconomiche – sono stati largamente elusi.
Il premier uscente ha colorato il confronto elettorale di una forte impronta ideologica: da un lato rilanciando la campagna d’opinione rivolta a delegittimare le istituzioni indipendenti e subordinare il potere giudiziario, in particolare la Corte suprema, a Parlamento e governo; dall’altro invocando l’annessione della Valle del Giordano e l’estensione anche formale della sovranità di Israele sugli insediamenti nei Territori palestinesi, rifacendosi al piano di pace dell’Amministrazione Trump. La coalizione uscente – composta dal Likud come centro di gravità e da altri partiti religiosi e della destra nazionalista – è rimasta però al di sotto della soglia maggioritaria (59 seggi contro 61). All’opposizione la sinistra ebraica, unitasi con l’alleanza fra il Partito laburista, più attento alle istanze socioeconomiche – il degrado del welfare state, l’acuirsi delle disparità di reddito – e il Meretz, unico a sostenere con forza il diritto dei palestinesi a uno Stato e a difendere la democrazia incompiuta del paese, ha subito un’ulteriore flessione al 5% circa dei suffragi, soffrendo in parte dello slittamento del voto “utile” verso il partito di centro Blu e bianco. Solo la sinistra, con i partiti arabi, ha sollevato con forza il dilemma del futuro democratico del paese. Una democrazia limitata a causa: a) della legge sullo “Stato-nazione ebraico” che codifica una condizione di diseguaglianza fra ebrei e arabi cittadini di Israele; i secondi godono di pari diritti individuali, civili e politici, ma non dei diritti collettivi di minoranza nazionale; b) del clima ossessivo volto non solo a delegittimare il potere giudiziario, ma anche a demonizzare l’accademia, la stampa, le ONG attive nella difesa dei diritti umani, avvicinando Israele a paesi retti da partiti nazional-populisti.
La Lista araba unita ha ottenuto un ulteriore corposo successo giungendo a 15 seggi: vi hanno influito la crescente partecipazione al voto dei cittadini arabi di Israele; la loro volontà di incidere in misura maggiore sul corso politico del paese in parallelo al processo di integrazione economica e civile nella società israeliana; infine, la stessa disponibilità manifestata dalla leadership dei partiti unitisi nella Lista a sostenere un governo di centrosinistra qualora fosse annullata la legge dello “Stato-nazione ebraico”, ripresi i negoziati con l’Autorità palestinese e promosso con più vigore il progresso delle comunità arabe di Israele, che soffrono di arretratezza, povertà e crimine. Alcuni analisti dei flussi elettorali hanno sottolineato che circa 20.000 elettori ebrei hanno spostato il loro voto dai partiti classici della sinistra ebraica alla Lista araba.
La novità dirimente post elezioni sarebbe stata l’ipotesi di un appoggio esterno in Parlamento da parte della Lista araba a un governo guidato da Benny Gantz, il leader del partito centrista. Lo stesso Gantz aveva rigettato in verità come provocatoria l’offerta di appoggio della Lista araba nel corso della campagna elettorale, volendosi “coprire a destra” e cedendo alle seduzioni dell’isteria antiaraba. Uno sviluppo siffatto avrebbe rappresentato la rimozione di un tabù paralizzante per il sistema politico del paese sin dalle origini: soltanto il governo guidato da Yitzhak Rabin fra il 1992 e il 1995 si avvalse infatti del sostegno dei partiti arabi, che fu rilevante nelle trattative che condussero agli accordi di pace di Oslo fra israeliani e palestinesi.
Ciò non è avvenuto. La coalizione sarebbe stata in verità assai eterogenea, composta, oltreché dal suo partito, dalla sinistra ebraica e dal partito Yisrael Beiteinu, guidato da Lieberman, alfiere degli ebrei russi immigrati in Israele, nazionalista di destra e di impronta fortemente laica, oppositore accanito del peso coercitivo delle autorità e dei partiti religiosi sulla vita civile del paese. Il governo di unità nazionale che si è poi formato dopo una lunga crisi istituzionale raggruppa intorno al Likud e ai partiti religiosi una parte del partito di Gantz che ha subito una scissione e i residui del Partito laburista, ridottosi a 3 seggi.
Al di là dei fatti contingenti, è in atto da tempo uno spostamento profondo e permanente della società israeliana verso posizioni etno-nazionaliste. Nelle inchieste d’opinione oltre il 50% degli intervistati si dichiara di destra, contro il 25% di centro e meno del 15% di sinistra, un orientamento prevalente soprattutto fra i giovani. Fenomeno dovuto alle trasformazioni sociali e demografiche del paese: la grande immigrazione dalla Russia postsovietica dei primi anni Novanta (circa 800.000 persone); il prevalere di una visione del mondo etnocentrica, che combina in molti casi rigorismo religioso e chiusura nazionalista, fra molti dei 600.000 immigrati giunti in Israele negli ultimi venti anni da Russia, Ucraina, Francia, Stati Uniti; il crescere del peso demografico ed elettorale dei religiosi, circa il 15% del paese.
Vi è qualcosa di paradossale, quasi una scissione fra preferenze dei cittadini e comportamenti nel voto. Nelle inchieste d’opinione gli israeliani mostrano di condividere le posizioni della sinistra non solo in materia di diritti civili e sociali o di ruolo dello Stato in settori quali la sanità e l’istruzione, ma anche sul conflitto israelo-palestinese. Tuttavia le preferenze “rivelate” nel voto premiano la destra, in modo coerente e continuo ormai dal 2009, quando con le dimissioni di Olmert, imputato di corruzione, il suo partito centrista Kadima capeggiato dalla Livni, pur vittorioso nelle elezioni, non riuscì a formare una coalizione di governo. Da allora la premiership è nelle mani di Netanyahu. La debolezza della sinistra è anche una conseguenza nefasta della strada nichilista imboccata dai palestinesi: l’esplodere della violenza terroristica contro civili israeliani negli anni 2001-05, la guerra di guerriglia mossa da Hamas dalla Striscia di Gaza, il rigetto da parte di Abu Mazen delle offerte positive del governo Olmert-Livni nei negoziati del 2008.
La sconfitta della sinistra ebraica è eclatante anche nella retrospettiva storica. Quella sinistra socialdemocratica fondatrice dello Stato, anzi delle prime istituzioni pre-Stato (la Histadrut, il sindacato operaio, i kibbutzim), che ha retto il paese nei suoi primi trenta anni fino alla vittoria del Likud di Begin nel 1977 e che ancora nel 1992, guidata da Rabin, ottenne il 47% dei suffragi (56 seggi su 120), è oggi ridotta al 5% (7 seggi).

La divisione fra destra e sinistra nella storia politica di Israele concerneva tipicamente tre questioni: a) il welfare state e l’intervento pubblico nella sfera economica; b) il rapporto fra religione e Stato; c) il conflitto con i palestinesi. La frattura fra i due schieramenti negli ultimi dieci anni ha investito anche il tema del rispetto dello Stato di diritto e delle norme di una democrazia liberale minacciata dalle pulsioni autoritarie dei partiti di destra.
Due gli elementi determinanti del regresso dei partiti di sinistra. Il primo, forse preminente, attiene all’identità affermatasi via via dagli anni Novanta fra la sinistra e il “campo della pace” – partiti, movimenti, organizzazioni della società civile attivi nel promuovere prima la trattativa fra Israele e l’OLP, poi l’attuazione degli accordi di Oslo e una composizione negoziata del conflitto basata sul principio di “due Stati per due popoli”. Il fallimento di questo disegno nei negoziati di Camp David (2000) e Annapolis (2008), lo scetticismo circa la fattibilità della soluzione “a due Stati” – ritenuta ancora con favore dal maggior numero di israeliani, ma percepita come non più possibile – si è riflesso pesantemente sulle sorti politiche della sinistra, vista come incapace di guidare il paese, garantirne la sicurezza e gestire, se non risolvere, il conflitto. Meglio allora conservare lo status quo, un regime di occupazione di parti rilevanti della Cisgiordania e il blocco rigido della Striscia di Gaza: un’occupazione che persiste da oltre cinquant’anni, corrompe occupanti e occupati, ma protegge gli israeliani dal rischio di una pace vissuta come qualcosa di distante, velleitario o utopico. Non sono solo infatti gli oltre 400.000 israeliani che vivono negli insediamenti in Cisgiordania a rendere la soluzione di “due Stati per due popoli”, con uno Stato palestinese indipendente che riconosca la legittima esistenza di Israele e stabilisca con esso rapporti di buon vicinato, sempre più difficile sul terreno. Una vasta parte della società israeliana preferisce i palestinesi “invisibili” dietro il muro di separazione eretto lungo la Linea verde e per lunghi tratti assai più a est in Cisgiordania.
Su tale esito ha agito la retorica scatenata da partiti, opinion makers e media vicini alla destra e dediti a dipingere il movimento per la pace come visionario, utopista o, peggio, traditore. Smolanit, in ebraico “di sinistra”, è diventato nel lessico politico-popolare in Israele quasi un insulto, l’immagine di gente antipatriottica disposta a sacrificare le ragioni della sicurezza dello Stato per rincorrere astratti ideali.
Il secondo elemento attiene al tema delle identità in senso etnico e socioculturale. Il Likud, già dalla vittoria elettorale del 1977, ha teso a rappresentare la sinistra come espressione dell’élite di origine europea – ashkenazita più specificamente – che ha dato vita al paese e alle sue istituzioni, lo ha dominato per anni sul piano economico, sociale e politico e tuttora esclude gli ebrei di origine “orientale” dal potere effettivo. Di qui un sentimento di frustrazione rabbiosa di molti elettori di quella parte del paese che si riversa contro la sinistra. Nonostante il tentativo del Partito laburista in anni recenti di ritornare alle sue fondamenta socialdemocratiche, enfatizzando la questione delle diseguaglianze di reddito e coltivando gli interessi degli strati emarginati della società e delle aree arretrate del paese dove sono più numerosi ebrei immigrati dai paesi arabo-islamici, l’esito sul piano elettorale è stato deludente.
L’unico modo per una riscossa del centrosinistra è forse un’intesa con la minoranza araba nel paese, un’alleanza anche politica per costruire una società fondata su principi di eguaglianza e democrazia, in base alla quale i partiti ebraici si battano per modificare la legge dello Stato-nazione e includere gli arabi nel body politico del paese alla pari e gli arabi accettino Israele come Stato democratico a maggioranza ebraica.

L’altra Israele contro Netanyahu
DAVID GROSSMAN

REPUBBLICA 17 SETTEMBRE 2020
Nel Libro di Osea leggiamo: “Poiché costoro seminano vento, e mieteranno tempesta“. Per quasi dodici anni Benjamin Netanyahu ha seminato vento. Un vento malvagio, aberrante. Ora, nei giorni della pandemia, i risultati sono chiari: Israele è un Paese diviso e disorientato, sfiduciato nei confronti della sua leadership e di se stesso e facile preda del turbine del coronavirus.
Tiro a indovinare: se gli israeliani dovessero rispondere onestamente alla domanda “cosa vi augurate per il nuovo anno?”. A parte, ovviamente, la salute, immagino che molti di loro, inclusi i sostenitori di Netanyahu, risponderebbero semplicemente: una vita stabile, tranquilla, sicura, in cui non vi sia corruzione e si percepisca la presenza di un governo, della legge. Immagino inoltre che molti si augurerebbero anche un primo ministro (uomo o donna) che anziché essere un “mago” (come spesso viene definito Netanyahu), si occupi di questioni di stato e cerchi con tutte le sue forze di curarne le ferite.
Questo è ciò che augurerei io a tutti noi: una vita cristallina. La augurerei anche a Benjamin Netanyahu, da uomo a uomo. A volte mi chiedo se lui ricordi ancora la sensazione di una vita simile. Se ci sia ancora un posto nella sua esistenza in cui non finga, in cui sia cristallino, libero. Da anni ci ha abituati al fatto che quasi tutto ciò che tocca, in qualche modo, si intorbidisce, si aggroviglia in interessi celati, tortuosi, o ha un doppio fondo. L’ho guardato circa due settimane fa quando, riferendosi all’assassinio di Yaakub Abu Al-Kyan, ha gridato: “I cittadini di Israele pretendono di sapere la verità!” e ho pensato alle taglienti parole del profeta Isaia: “Guai a quelli che chiamano bene il male, e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro!”
Indubbiamente Netanyahu è un oratore fantastico, un arringatore straordinario. Questa settimana ha pure conseguito un grande e importantissimo risultato politico che potrebbe influire sulle posizioni di altri Paesi della regione. E allora perché così tanti israeliani si sentono stranieri ed esiliati nel proprio Paese? Perché così tanti di noi avvertono un continuo senso di soffocamento, faticano a respirare? Forse perché oggi siamo sedati e ventilati. Siamo un’ottima materia prima atta a qualsiasi manipolazione, un materiale morbido e flessibile con cui modellare la dittatura “pseudo democratica” che Netanyahu sta instaurando. Per questo motivo il movimento di protesta contro di lui è un’incoraggiante – ed essenziale – ventata di aria fresca. A un tratto echeggiano parole chiare, assertive, che trafiggono il rimbombo capzioso di quell’-Io-Io-Io che ci sommerge da anni. La protesta fa rinascere in noi un senso di benessere e, dopo anni di bugie ed esagerazioni, risuonano finalmente parole di verità.
È vero, i manifestanti appartengono a gruppi diversi e talvolta slegati fra loro, hanno una leadership frazionata e ancora arrancano alla ricerca di una direzione. Ma proprio in questo sta la loro forza, in questa goffaggine, nelle energie di chi deve scrollarsi di dosso il senso di soffocamento, nel ringhio che, corroborato da argomentazioni razionali, efficaci e ben formulate, sale prepotentemente di tono. Netanyahu accusa i manifestanti (e la sinistra e i media e la procura e l’opposizione e chi no…), di essere ossessionati dallo slogan “Chiunque, ma non Bibi”. In realtà lui stesso si è trasformato in una specie di ossessionato, di “posseduto” che stringe in una morsa un intero Paese impotente e quasi apatico dinanzi al suo egoismo aggressivo, alla sua corruzione. Un Paese che per anni, risucchiato nel vortice di Bibi, si è occupato di lui, della sua famiglia, dei suoi capi d’imputazione. È come se, intorno a noi, ci fossero mille specchi e tutti riflettessero l’immagine di Netanyahu e, quando li guardiamo, vediamo lui, non noi. Ma poiché vorremmo tornare a rivedere il nostro riflesso, poiché siamo preoccupati per Israele e abbiamo la sensazione che il miracolo che lo ha creato e la solidarietà che lo ha mantenuto saldo stiano svanendo, manifestiamo ogni settimana davanti alla residenza ufficiale del premier a Gerusalemme, davanti alla sua casa a Cesarea e su 315 ponti e crocevia in tutto il Paese.
E continueremo a farlo. Continueremo a gridare, a urlare: Bibi vattene! Esci dalle nostre vite, vai per la tua strada e lasciaci ricostruire sulle macerie che ti lasci alle spalle. L’intera società israeliana ha bisogno di riprendersi da un lungo periodo in cui ha smarrito il buonsenso. Vorrei potessimo tornare ad apprendere alcuni principi fondamentali: l’essere diversi gli uni dagli altri senza odiarci, l’avere opinioni contrastanti senza manifestare malignità, l’essere capaci di spegnere l’ostilità e il sospetto che si accendono nei nostri occhi quando guardiamo chi (i nostri fratelli, sangue del nostro sangue) la pensa diversamente da noi.
Sarà un processo lungo e complicato perché il guasto è già filtrato nelle pieghe più recondite di Israele. Ma una cosa è chiara: non potremo iniziare questo processo di guarigione fintanto che Netanyahu rimarrà al potere. Lui non porrà rimedio a nulla. Anzi. Un’eventuale prosecuzione del suo governo pregiudicherebbe la possibilità di un risanamento e condannerebbe Israele a un ulteriore deterioramento. Anche l’ipotesi di un provvedimento di interdizione temporanea dalla carica di primo ministro evoca un tipo di interdizione più profondo intrinseco in Netanyahu: lui non è in grado di risanare laddove Israele ne ha più bisogno. Semplicemente non lo è. Chi gli è stato vicino testimonia che non presta mai ascolto. È distaccato dalla realtà e vive, a tutti gli effetti, in uno spazio in cui esistono soltanto lui e i suoi interessi. Esternamente può mostrare – od ostentare con fantastica abilità – potere, aggressività, sicurezza di sé e una sorta di compassionevole e paterna preoccupazione per i suoi sudditi. Senza dubbio gli piace considerarsi un “padre della nazione”. Ma è un padre manipolatore, cinico, sfruttatore e utilitarista.
No, nonostante tutti i suoi sforzi è impossibile percepire in Netanyahu qualità taumaturgiche, terapeutiche. A dire il vero non è nemmeno possibile percepire in lui un sentimento di autentica compassione per i bistrattati israeliani che lui stesso, con il suo operato e i suoi fallimenti, ha fatto precipitare nella situazione in cui si trovano. Perciò, ormai da tempo, non è più questione di “Sì Bibi” o “No Bibi”. È una lotta contro il disfacimento, a favore di una riparazione. Contro la malattia, a favore di un risanamento. Contro la disperazione, a favore della speranza. E in questa lotta ognuno deciderà quale posizione prendere. Buon anno nuovo.
Traduzione di Alessandra Shomroni
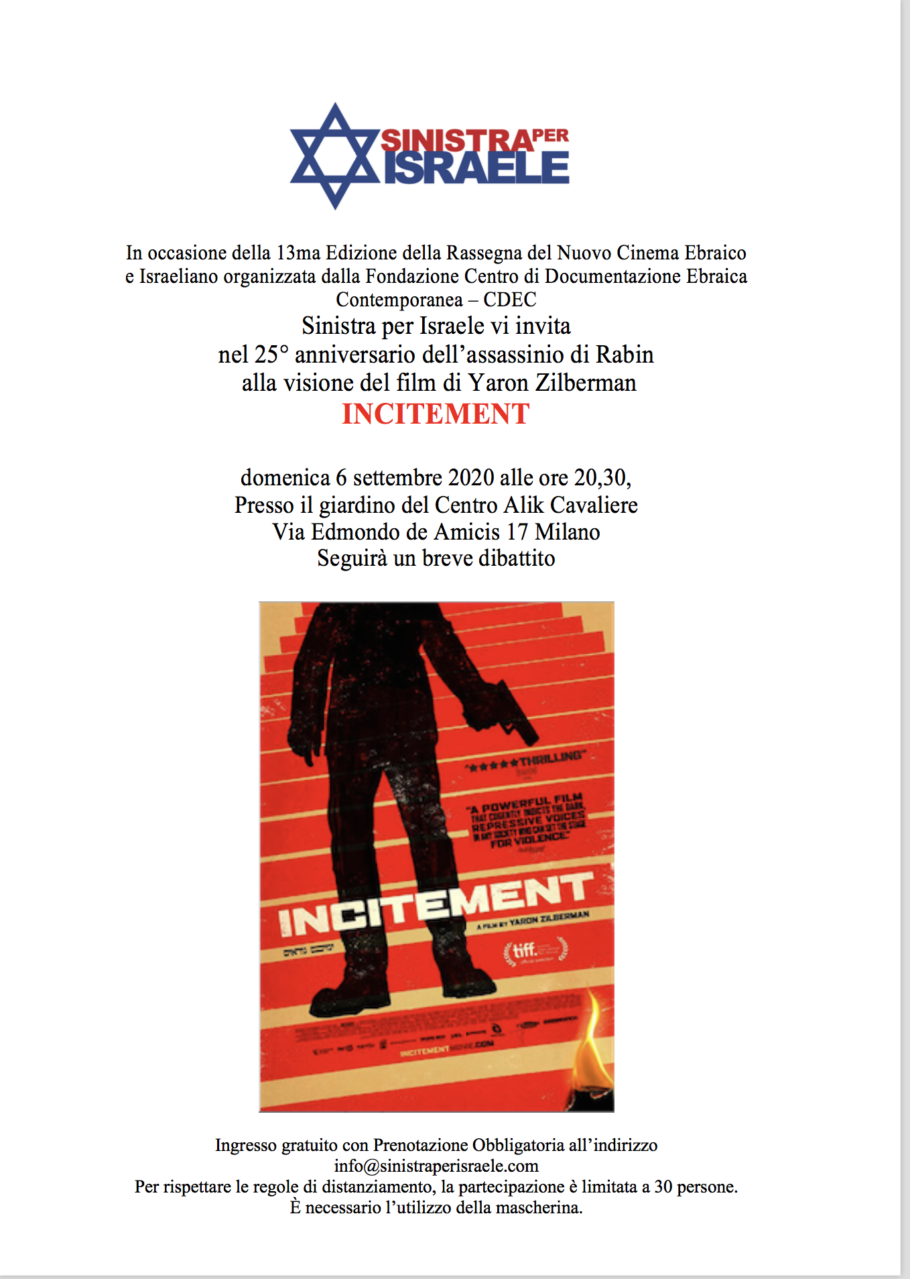
“Incitement”, il film sull’assassino di Rabin
Chi era Yigal Amir? Il suo ritratto in una storia che indaga l’animo umano. E che in ebraico è intitolata Yamim Noraim, in riferimento ai giorni dell’introspezione che separano Rosh Hashanà e Kippur
Si dice che in Israele non si può mai stare da soli e in un certo senso questo è molto vero. Ai tassisti bastano poche informazioni generiche sul passeggero per elargire consigli di vita, uno sconosciuto sul treno ti spiegherà perché non capisci niente di politica dopo aver adocchiato il giornale che stai leggendo, il cassiere del supermercato commenterà i prodotti che compri e ti chiederà se sei proprio convinto perché lui ne avrebbe scelti altri. Naturalmente, questi sono esempi caratteristici di una società particolare, ma è vero a tutte le latitudini che non siamo mai soli. Le nostre azioni, le nostre decisioni, i nostri pensieri, difficilmente sono il frutto di un processo compiuto nell’isolamento, sono di solito il risultato di interazioni, suggerimenti, impulsi che in modo attivo o passivo accogliamo e facciamo nostri. Fino a dove si può spingere questa dinamica?
Sembra essere questo il nodo di Incitement, l’ultimo film di Yaron Zilberman che il 22 settembre si è aggiudicato il premio Ophir (il cosiddetto “Oscar israeliano” assegnato dall’Accademia Israeliana del Cinema e della TV) ed è perciò stato selezionato per rappresentare Israele nella sezione Miglior Film Straniero alla prossima notte degli Oscar. Presentato per la prima volta in agosto al Festival Internazionale del Cinema di Toronto, il film racconta il processo che culminò nell’assassinio del premier Yizhak Rabin (4 novembre 1995)

dalla prospettiva di chi lo commise, lo studente venticinquenne Yigal Amir.
La prima cosa interessante del film è il doppio titolo. Perché se in inglese è Incitement, in ebraico è Yamim Noraim, proprio come il periodo di dieci giorni tra Rosh Hashanà e Yom Kippur. Un periodo che chiama all’introspezione, all’indagine dell’anima, proprio come quella – spiega il regista in questa intervista – che Israele non ha mai fatto completamente riguardo quegli accadimenti. Zilberman chiarisce le ragioni del doppio titolo. Yamim Noraim in inglese non avrebbe funzionato: non sarebbe stato possibile conservare questo riferimento così forte alla tradizione ebraica, tanto più che nessuna traduzione rende giustizia all’espressione. Quella letterale, “Giorni Terribili” smarrisce il senso di solennità del periodo che di per sé non ha una connotazione unicamente negativa. E così si è pensato a Incitement: una scelta, precisa il regista, appropriata e contemporanea, perché interroga anche e soprattutto le nostre società.
Il film – arricchito da materiale filmico originale sugli accordi di Oslo – è ambientato nell’anno che precede l’assassinio e segue il processo di radicalizzazione di Amir. È la sua storia, ma anche la storia di molti altri. Degli ambienti, delle amicizie, degli esempi di vita all’interno dei quali i suoi propositi sono maturati. Dei poster che ritraevano Rabin con la svastica e del pensiero che ucciderlo fosse un compito religioso, una via per onorare la Torah. Una storia sulle divisioni della società, sul ruolo degli influencer su una personalità fragile e alla ricerca di un’opportunità di riscatto: famiglia yemenita, nella vita nulla di regalato, una fidanzata, Nava, che lo lascia dopo pochi mesi per uno dei suoi amici (e lo invita pure al matrimonio) a causa del suo non essere ashkenazita.
L’epifania di Amir (interpretato da Yehuda Nahari Halevi) ha luogo, racconta il regista, nella scena in cui assiste al funerale di Baruch Goldstein, l’estremista che il 25 febbraio 1994 aprì il fuoco sui musulmani raccolti in preghiera Alla Tomba dei Patriarchi a Hebron, uccidendone 29 e ferendone 150. Nel momento in cui il feretro viene sollevato, Amir pensa che anche lui, forse, potrebbe essere un eroe, anche per lui può esserci la possibilità di contare, di liberarsi del peso dell’insignificanza. Un’operazione non priva di rischi, quella compiuta da Zilberman. Raccontare la storia dal punto di vista dell’assassino inevitabilmente apre se non una porta, almeno uno spiraglio all’empatia. E forse proprio qui sta la questione: nessuna chiamata all’indulgenza o alla giustificazione, ma una “indagine dell’anima” collettiva, seria e profonda come il periodo degli Yamim Noraim richiede: come si diventa Yigal Amir?


Il programma e l’approccio di Joe Biden verso Israele
Claudio Vercelli -Joimag 23 Agosto 2020
Il candidato Dem richiama il suo costante sostegno ad Israele, l’opposizione al movimento di boicottaggio e il sostegno agli aiuti militari. Una approfondita analisi e un confronto con l’approccio di Donald Trump nei confronti di Gerusalemme
Per certuni, sarebbe un coltello da infilare in un pano di burro, tanto è facile l’obiettivo; per altri, molti altri – invece – rimane qualcosa a cui aggrapparsi, a rischio di negare la medesima evidenza. Si dirà che sono opinioni e, come tali, discutibili a prescindere. Ma ci sono opinioni che si sorreggono sulle mere credenze (le “speranze”, tali poiché prescindono dalla realtà, rivelando infine la loro natura illusoria); così come ci sono opinioni, che tali rimangono, tuttavia ancorate ad un qualche dato di fatto.
Veniamo al dunque. Nei giorni trascorsi, per meglio intenderci durante un comizio in Wisconsin, Donald Trump, dinanzi alla platea degli astanti, ha candidamente affermato che lo spostamento dell’ambasciata americana a Gerusalemme è il risultato non solo di un intendimento suo proprio ma soprattutto della risposta alle pressioni derivanti da una parte del suo elettorato, quello di origine e radice cristiano evangelica. Non ebraica, beninteso. E neanche «sionista», per ciò che tale aggettivazione possa a tutt’oggi significare. Per inciso, il Jerusalem Embassy Act (JEA) – una legge approvata dal Congresso statunitense nell’ottobre del 1995, a grande maggioranza (93 voti su 100 a favore al Senato; 317 su 435 alla Camera), divenuta poi atto con valore esecutivo nel mese di novembre dello stesso anno, con la quale si riconosce Gerusalemme come città indivisa e capitale d’Israele – andrebbe quindi riletto, nella sua applicazione, alla luce di una tale concessione. Non ad Israele bensì ad un segmento di elettori statunitensi. Quello che più fa chiasso e rumore. Ancora una volta: non gli ebrei, ma i militanti dei gruppi di «rinascita» evangelicale, i «rebirth» che sono parte dell’ossatura ideologica di un’America non tanto conservatrice quanto suprematista.
Per essere chiari, ricapitolando, poiché la premessa è nota ai più, va rammentato che Gerusalemme è la capitale d’Israele ma, per una significativa parte della comunità internazionale, non è riconosciuta come tale. Quanto meno, non prima di un’adeguata negoziazione del «final status» del conflitto tra israeliani e palestinesi. Che è tutta a venire. La questione, quindi, rimane aperta, altrimenti essendo ritenuta «scelta unilaterale». Di fatto, le presidenze Clinton, Bush ed Obama, di volta in volta hanno richiamato ed applicato l’opzione del rinvio dell’adempimento alla norma in ragione degli interessi di «sicurezza nazionale». Solo con Donald Trump, nell’estate del 2017, si è iniziato a procedere nei fatti, arrivando al riconoscimento definitivo, il 6 dicembre di quell’anno, di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico e, quindi, come legittima sede della maggiore rappresentanza diplomatica di Washington. Peraltro, anche a questa ultima manifestazione di volontà, sono seguiti passi non del tutto certi e incontrovertibili. Sta di fatto che, all’interno di questa cornice, è risaputo e riconosciuto il vivido sostegno dei cristiani evangelici rispetto ad una tale soluzione. In tutta plausibilità, maggiore di quella degli stessi ebrei americani. Poiché i primi ritengono che la cristianità possa pienamente realizzarsi solo se gli ebrei torneranno alla loro terra di origine.
Cosa c’entra tutto ciò con le elezioni presidenziali a venire? La convention democratica di Milwakee (qualcuno ricorda forse «Happy Days?») ha tributato a JosephRobinette Biden Jr, detto «Joe», la nomination per sfidare, alle elezioni di novembre, Donald John Trump. Non è stata un’incoronazione, beninteso, bensì un’investitura meditata. Biden, benché conosca a fondo i meccanismi del potere federale americano, partecipandovi da circa cinquant’anni, non è il candidato ideale per i democratici. Si tratta, per diversi aspetti, di una figura di retrofila, anche se non di retroguardia. Semplicemente, ad oggi è il meno peggio. Il problema non è neanche il suo modesto profilo (il quale, non è detto che, alla fine, non giochi a suo favore), la sua mancanza di appeal, il suo essere da sempre nelle “seconde linee” del suo partito, ma la drammatica mancanza di idee innovative tra i democratici.
Non è un suo esclusivo problema, trattandosi semmai di una condizione che è letteralmente trasversale all’intero sistema politico. In America come nel resto del pianeta. Vale quindi anche per i repubblicani ed – immediato riflesso – per i cosiddetti «indipendenti» così, come tanto più, per le ali radicali. Le quali, rifacendosi alla nozione di «identità» come indice esclusivo dell’agire politico, tanto involontariamente quanto paradossalmente, rendono omaggio (e quindi rafforzano) i sovranismi e i populismi di varia risma. Poiché questi ultimi si alimentano del declino delle società intese come cornici di una cittadinanza diffusa, sostituendo ad esse – invece – le appartenenze di gruppo. Non quelle repubblicane, costituzionali e così via bensì le dimensioni particolariste. In politica, non si vince facendo la sommatoria delle identità, come se esse da sé costituissero, infine, una maggioranza, ma cercando di dare di volta in volta corpo e forma a quest’ultima. Che va ricreata daccapo, poiché il fuoco della grande trasformazione che stiamo vivendo è proprio la disarticolazione della Middle Class. Oltreoceano come nel «vecchio Continente».
Dopo di che, conviene tornare alle elezioni americane. Biden ha ricevuto il sostegno convinto della Obama Family, che ha sostituito, negli equilibri dei democratici, quella più aristocratica e autoreferenziale dei Clinton. Non è un caso. In quanto Biden da sempre è visto come il “vice”. Non solo da quando tale carica occupò per davvero nei fatti, in ben due mandati, tra la fine del 2009 e il 20 gennaio 2017. Ma a tutt’oggi. In quanto Obama ha una chiara intenzione, ossia di tornare alla presidenza per la successiva tornata, nel 2024. Per suo diretto tramite o per quello della moglie Michelle. Da tempo, infatti, si adopera sia per allargare la sua base di consenso tra democratici in crisi di identità (tra i repubblicani, forse, le cose sono ancora peggio messe), sia per rettificare unba parte degli errori commessi durante il suo mandato: la fallimentare politica di concessioni nei confronti dell’Iran e di una parte del mondo islamico, che si disinteressa, oramai, di Washington, confidando semmai su Mosca e quant’altri; la deludente applicazione della grande riforma sanitaria, che è pesata soprattutto su un ceto medio in recessione, premiando di meno gli ipotetici destinatari e molto di più il vorace circuito assicurativo; l’attenzione per le issues legate alle identità civili (“ciò che io ritengo di essere”) ma non alla complessa trama dell’integrazione sociale (“ciò che io ritengo di potere effettivamente possedere”, ovvero le risorse materiali), hanno consegnato al suo bizzarro ed eclettico avversario Trump un vantaggio competitivo. Obama, che da tempo – dopo il pit stop di quattro anni – si è candidato a rappresentare nei tempi a venire la metà della grande mela elettorale statunitense, quella per l’appunto democratica, ci sta pensando e si allena ai bordi. Auspicabilmente, per non commettere gli errori del passato. Per il momento, tuttavia, tocca a quello che è stato a lungo il suo vice. Nel ticket Biden-Harris, adesso alla ribalta, se non avverrà una catastrofe elettorale, tuttavia molto di più dipenderà dalla seconda. Biden, infatti, non è un Mosè che divide le acque, giocando contro di sé, tra le altre cose, l’età. Ma non solo. Kamala Harris, invece, morde i freni, avendo assestato un uppercut alla potente Elisabeth Warren e silenziosamente pensando a liquidare quel pezzo di aristocrazia democratica che ruota intorno alla generazione degli ottuagenari, a partire dalla speaker della Camera Nancy Pelosy. Il tempo dirà se tali prospettive abbiano un qualche legittimo fondamento o siano solo illusioni di una tarda estate. Non per questo Biden, va ripetuto, è un “pupazzo” oppure un candidato privo di autonomia. Più semplicemente, se non esprimerà un profilo autonomo (qualora dovesse essere eletto, quando avrà terminato il suo mandato – lo ripetiamo – sarà ultraottantenne), verrà letteralmente risucchiato da un mondo che sta cambiando.
Detto questo, qual è l’atteggiamento – e con esso il programma – dei democratici riguardo ad Israele? Lo riprendiamo nei suoi passaggi di fondo. Il primo punto è cheil presidente Trump ha reso Israele meno sicuro e ha indebolito le relazioni USA-Israele». Ad egli, infatti, oltre ad una retorica denunciata come non solo inconcludente ma anche deleteria, si contesta la volontà di non volere arrivare ad una reale soluzione del conflitto con i palestinesi sulla base del principio «due Stati per due popoli». Mentre i democratici, con Obama, si sono impegnati per un sostegno economico e militare di sostanza (valutato in 38 miliardi di dollari, a partire dai programmi missilistici di difesa, a partire dal 2016, per dieci anni complessivi di investimenti), Trump si sarebbe limitato a gesti di forma, retoricamente enfatici, più di immagine che non di sostanza. In altre parole, tale condotta avrebbe risposto maggiormante a calcoli di circostanza che non di reale intenzione. Risultando infine controproducente. A tale riguardo, l’amministrazione Trump, ritirando il contingente americano dalla Siria alla fine del 2019, non solo avrebbe abbandonato i curdi al loro destino ma, lasciando un vuoto di potere a favore dell’Iran, ne avrebbe favorito le manovre al confine settentrionale di Israele.</pre>
Il piano di pace Kushner, lanciato dall’attuale Amministrazione con grande enfasi nei mesi scorsi, sarebbe da sempre una sorta di lettera morta, incoraggiando piuttosto l’annessione unilaterale di una parte dei territori della Cisgiordania (con un grave nocumento per le future trattative, altrimenti sostenute dalle precedenti presidenze, a prescindere dal colore politico). A fronte di ciò, Biden richiama, tra gli altri, il suo costante sostegno ad Israele (Paese nel quale si recò, per la prima volta, nel 1973); il suo ruolo chiave, quand’era vicepresidente, nel garantire ad Israele la necessaria sicurezza; la sua opposizione al movimento di boicottaggio, disinvestimento e a favore delle sanzioni (BDS) nonché il sostegno agli aiuti militari al Paese (a partire dal programma Iron Dome e dai programmi antimissilistici); il rifiuto nel dare corso ad atti unilaterali, destinati altrimenti a pregiudicare le trattative di pace; il sostegno alla ripresa degli aiuti statunitensi all’Autorità nazionale palestinese, tuttavia in linea rigorosa con il Taylor Force Act (che vincola gli aiuti americani alle autorità palestinesi in base al loro esplicito rifiuto del terrorismo e del ricorso alla violenza contro i civili israeliani); l’azione anti-iraniana, aprendo al piano d’azione globale congiunto (JCPOA, il Joint Comprehensive Plan of Action) contro la nuclearizzazione di Teheran. A ciò si aggiunge l’accusa, sempre rivolta a Trump, di avere vellicato, quanto meno implicitamente, l’antisemitismo presente negli ambienti suprematisti, che non hanno mai disdegnato di manifestare un qualche sostegno all’Amministrazione uscente.
Il programma di Biden, al netto dei prevedibili auspici su una proficua collaborazione bilaterale tra Washington e Gerusalemme («Israele manterrà sempre il suo vantaggio militare qualitativo»; «sostenere il fondamentale partenariato economico e tecnologico tra gli Stati Uniti e Israele, espandere ulteriormente la collaborazione scientifica e aumentare le opportunità commerciali ed alimentare la cooperazione sull’innovazione in tutta la regione»), auspica la ripresa di contatti e, in prospettiva, di negoziazioni, tra quest’ultima e Ramallah. Una tale prospettiva, scarsamente accreditata dal governo Netanyahu-Gantz, è la premessa per esercitare un lungo affondo contro il «taglio distruttivo dei rapporti diplomatici con l’Autorità nazionale plestinese» attribuito a Trump. Poiché, aggiunge il programma democratico, gli Stati Uniti non possono derogare dal loro ruolo di mediazione.
Ciò che l’attuale presidente andrebbe facendo, quindi, non è nell’interesse di Gerusalemme ma per esclusivo calcolo di parte. La propria. Al riguardo, viene ribadito che: «le azioni di Trump hanno ostacolato le prospettive di una soluzione a due Stati. Il piano di pace era morto in origine, nonostante fosse stato pubblicizzato dalla Casa Bianca come “l’accordo del secolo”, ovvero una soluzione alle sfide di Israele. L’Amministrazione ha proposto un piano che è stato concepito senza alcun contributo da parte dei palestinesi ed è stato respinto all’unanimità dalla Lega araba. Il piano di Trump ha reso [quindi] più sfuggente una soluzione negoziata a due Stati del conflitto israelo-palestinese, codificando misure estreme come l’annessione e il trasferimento della cittadinanza araba. Se Israele annettesse unilateralmente ampie aree della Cisgiordania, come previsto nel piano di Trump, metterebbe definitivamente in discussione il suo futuro come Stato sia democratico che ebraico». A tale riguardo, «la proposta di Trump ha scatenato grandi proteste in Giordania, mettendo a repentaglio la stabilità di un alleato regionale già fragile ma cruciale. L’annuncio di Netanyahu che avrebbe annesso la Cisgiordania e la Valle del Giordano ha anche messo a rischio un accordo di pace di lunga data tra Israele e Giordania, vitale per la sicurezza di Israele». In buona sostanza, «il fallimento dell’amministrazione Trump nell’opporsi all’annessione mette in discussione il suo impegno per la sopravvivenza di Israele come stato ebraico e democratico». Un altro punto è quello per cui «le politiche di Trump stanno rendendo il Medio Oriente più pericoloso per Israele». La vocazione “isolazionista” sta lasciando varchi aperti all’Iran, ad Hezbollah, ai gruppi sovversivi e terroristici presenti in Siria. Bisognerà quindi considerare ogni passo in base alla geopolitica russa, turca e iraniana. In quest’ultimo caso, «il ritiro di Trump dall’accordo con l’Iran, mentre quest’ultimo era ancora in regola, ha danneggiato la credibilità degli Stati Uniti, ci ha alienati dai nostri alleati, ha aumentato la probabilità che l’Iran stesso potesse acquisire armi nucleari e ci ha lasciato con meno strumenti per contrastare Teheran. La cosiddetta pressione che l’Amministrazione ha esercitato sull’Iran non ha quindi cambiato in meglio il comportamento delle sue classi dirigenti».
A fronte di ciò, «Trump ha alimentato l’ascesa dell’antisemitismo e del nazionalismo bianco». Seguono una serie di affermazioni per cui<b> «</b>l’81% degli ebrei americani è maggiormente preoccupato per l’antisemitismo da quando Donald Trump è diventato presidente. Secondo un altro sondaggio, il 68% degli elettori ebrei si sentirebbe meno sicuro di due anni fa e il 71% degli ebrei disapproverebbe il modo in cui il presidente ha gestito la questione dell’antisemitismo». A rinforzo di ciò, «Trump ha ripetutamente fatto osservazioni antisemite nei confronti degli ebrei americani, tra cui l’accusarli di essere “sleali” nei confronti di Israele votando per i democratici, dicendo [inoltre] che “non amano abbastanza Israele” e suggerendo che i suoi sostenitori ebrei votino per lui solo per proteggere la loro ricchezza. La campagna presidenziale di Trump ha adottato stereotipi antisemiti […]. Nell’ottobre del 2018, Trump ha promosso una teoria del complotto antisemita su Twitter. Trump ha accusato gli ebrei di doppia lealtà al White House Hanukkah Party del 2018 e nell’aprile 2019 a Las Vegas. Trump ha affermato, nell’agosto 2019, che gli ebrei americani che votano democratico […] sono ignoranti o “sleali”. Quando gli è stato chiesto di chiarire, ha detto che intendeva “sleali verso Israele”. Nel dicembre 2019 Trump ha nuovamente invocato paradigmi antisemiti sulla doppia lealtà e l’avarizia, ebraica che i gruppi ebraici hanno [poi] denunciato. Trump ha emesso un ordine esecutivo sull’antisemitismo quattro giorni dopo aver formulato osservazioni antisemite che molti gruppi ebraici hanno denunciato in quanto tali». In ultimo, «i nazionalisti bianchi e i neonazisti sostengono e sono incoraggiati da Trump, [mentre] lui peggiora le cose rifiutandosi di condannarli chiaramente». La dura sequela di condanne prosegue, seguendo quattro binari principali: la politica democratica contro l’Iran; la necessità di trovare, in campo palestinese, un interlocutore credibile, anche nell’interesse di Gerusalemme; la condanna dell’antisemitismo e del razzismo («Trump non unisce, semmai divide»); la rivendicazione, nella tradizione democratica, di una netta e prevalente posizione a favore degli ebrei.</pre>
Non è plausibile che l’esito del confronto tra Biden e Trump si giochi solo su questi piani. L’elettore americano, infatti, è preoccupato soprattutto dagli effetti economici della pandemia. Si intende poco, se non nulla, delle questioni internazionali. Il Medio Oriente, per molte famiglie, è soprattutto il luogo in cui uno dei loro figli è andato a fare una corvée militare. Così come la considerazione nei confronti degli ebrei segue spesso andamenti molto differenziati a seconda delle contee e degli Stati presi in considerazione. L’antisemitismo, non a caso, è maggiormente diffuso in ambito rurale, a tratti appartenendo quasi ad una sorta di “deep tradition”. Il punto è che per Trump una parte non secondaria dei consensi arriva proprio da quell’America profonda, ancora perlopiù Wasp (White Anglo-Saxon Protestant), ma non solo, che fatica sempre di più a stare dietro al vortice dei cambiamenti in atto. Su come una tale carta verrà giocata dai democratici, fortemente ancorati anche al voto metropolitano, ce lo dirà a breve, tra le altre cose, la tornata elettorale che si sta approssimando.
Claudio Vercelli


Israele-Emirati Arabi Uniti: a chi giova l’accordo
di Claudio Vercelli Joimag 16 agosto 2020
Tutti ruoli delle parti in gioco in un’approfondita analisi di Claudio Vercelli

Non si sono fatti la guerra direttamente ma da sempre condividevano un’ostile separazione. Sputi a distanza, per intendersi. Israele ed Emirati Arabi Uniti, con la mediazione di Washington, stanno invece ora per firmare un accordo di pace che porterà, a breve, all’auspicata normalizzazione dei rapporti diplomatici e politici. Per chi conosce le dinamiche del Medio Oriente non è per nulla una sorpresa poiché già da alcuni anni era in corso un lento ma inesorabile processo di avvicinamento tra i paesi sunniti del Golfo e Gerusalemme.
Rimane il fatto che nel momento in cui verrà definitivamente siglato un trattato che si lascerà alle spalle quello che è stato (così anche quello che non è stato, benché avrebbe potuto essere, nel qual caso a beneficio di tutti), senza scomodare enfatiche espressioni come «svolta epocale», tuttavia si potrà dire che si è voltata una importante pagina in un libro che altrimenti continua ad essere scritto con un inchiostro incolore su pagine oramai incollate tra di loro. I
Termini enfatici, dettati anche dal calcolo politico interno alle proprie amministrazioni, non difettano. «L’inizio di una nuova era», ha dichiarato il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che, in tutta probabilità, si prepara ad un orizzonte di inedite conflittualità politiche interne ad Israele e, forse anche, ad un nuovo passaggio elettorale, a partire dal tardo autunno. Un primo passo verso nuovi accordi con altri paesi arabi, ha evidenziato il Presidente Usa Donald Trump, definendo l’intesa come un «enorme successo». Suo, si intende. È buona cosa lasciare sedimentare gli entusiasmi per poi, a cose maturate, capire fino a quale punto ci si possa spingere nel dire qualcosa piuttosto che altro. Afferma il brogliaccio diplomatico dell’amministrazione Trump, e viene ripetuto dalle prime dichiarazioni congiunte, che «le delegazioni di Israele e degli Emirati Arabi Uniti si incontreranno nelle prossime settimane per firmare accordi bilaterali riguardanti gli investimenti, il turismo, i voli diretti, la sicurezza, le telecomunicazioni, la tecnologia, l’energia, l’assistenza sanitaria, la cultura, l’ambiente, la creazione di ambasciate e altre aree di reciproco vantaggio».
Verosimilmente, se nulla di catastrofico nel mentre interverrà, le cose dovrebbero andare in una direzione destinata ad essere irreversibile. In cambio della formalizzazione dei rapporti diplomatici, economici e commerciali, Israele si è impegnata a sospendere il piano di annessione di parte della Cisgiordania, annunciato – tra molti distinguo e critiche anche in casa propria – qualche settimana fa dal Premier israeliano Benjamin Netanyahu. Quest’ultima notizia, invero, è accreditata soprattutto da parte araba, poiché sul versante israeliano non si può dire la medesima cosa. Ciò che probabilmente ne deriverà è invece un’anestetizzazione del processo di omologazione e incorporazione di una parte della Cisgiordania allo Stato d’Israele. Difficile comunque pensare che una volpe come Netanyahu non ci avesse già pensato, al netto delle propagande incrociate. Il premier, nonché leader del Likud, non crede alla necessità storica di incrementare le dimensioni geografiche del suo Paese come precondizione per garantirne un futuro prospero.
Mentre sa che esso sempre più spesso sarà giocato sul versante della capacità di giocare la parte dell’ago della bilancia nei conflitti in corso nel Medio Oriente e nel Mediterraneo: l’escalation tra Grecia e Turchia sul controllo dei giganteschi depositi di gas naturale e metano; il destino dei territori frammentati e feudalizzati della Siria, dell’Iraq e della Libia (aree di influenza, all’interno di società nelle quali la statualità novecentesca è tramontata per sempre); la feroce contrapposizione tra «asse sunnita» del Golfo e componenti sciite. Netanyahu, per parte sua, ha una carta fondamentale da giocarsi: non ha mai creduto, contrariamente ai suoi oppositori interni, che si debba esistere in quanto “amati” bensì poiché temuti. Anche per questo, in tutta plausibilità, potrebbe incassare da sé l’assegno in bianco che gli deriverà da un tale accordo: dopo l’Egitto (1979) di Begin e la Giordania (1994) di Rabin, adesso potrebbero arrivare i «principi», gli «sceriffi», le dinastie – in una parola i maggiorenti – sunniti. Per una controparte apparentemente non così importante, non almeno per lui, ossia quegli insediamenti ebraici invisi non solo a buona parte della politica internazionale ma anche da significativi segmenti dell’elettorato nazionale israeliano. Netanyahu non li odia e neanche li ama. Semplicemente, si chiede quanto possano servirgli. Per preservare se stesso. Non è cinico: è un politico formatosi alla scuola degli Stati Uniti.
Peraltro, l’interesse comune di Israele e degli Emirati è il doppio fronte sia anti-sciita che avverso al radicalismo sunnita, laddove quest’ultimo si manifesti. Entrambi vogliono contenere l’espansionismo degli odiosi ayatollah iraniani e, allo stesso tempo, fermare il virus islamista dei Fratelli musulmani diffuso da Qatar e Turchia in tutto il Medio Oriente, dal Golfo fino a Gaza con Hamas ed anche in Egitto. Senza contare Hezbollah, protagonista ma anche subalterno al declino libanese. Insomma, la scena si è troppo movimentata per non entrare in gioco. Il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti Mohammed Bin Zayad ha non a caso affermato che «nel corso di una conversazione telefonica con il presidente Trump e il premier Netanyahu è stato raggiunto un accordo per fermare ulteriori annessioni di territorio palestinese. Gli Emirati e Israele hanno convenuto di cooperare e di stabilire una road map per l’istituzione di relazioni bilaterali». Sembra una foglia di fico. In franchezza, risulta difficile pensare che per gli emiratini il destino dei palestinesi stia alla sommità delle loro preoccupazioni. Anche perché la progressiva normalizzazione delle relazioni con il mondo sunnita – ci vorranno comunque molti anni – potrebbe suonare come una campana a morto per Ramallah.
Semmai, per meglio intendere il quadro corrente, bisogna chiedersi quali siano i veri interessi della monarchie del Golfo. Giacché, proprio ciò ci dice che, oltre all’avversione rispetto al pericoloso interventismo di Teheran, entra in gioco la contesa con la Turchia e il Qatar per l’egemonia sul fronte sunnita. Forse il fuoco odierno delle tensioni si alimenta nella Libia divisa tra fazioni, dove la leva residua per gli americani (e gli Emirati) è il generale Haftar (di contro al premier Serraj, sostenuto anche dall’Italia). Ma è solo un frammento di scenario, beninteso. Non di meno, Netanyahu, che conosce benissimo l’area composita dei suoi sostenitori, non ha alcun interesse ad accreditare, secondare e vidimare le posizioni più radicali, quelle che vorrebbero cancellare, con un tratto di penna e un’azione di forza, la controparte palestinese. Non avrebbe nulla da guadagnarci, beninteso. Poiché «Re Bibi» domina la politica israeliana da almeno venticinque anni in quanto capace di dosare l’identitarismo e il sovranismo della destra più radicalizzata con le istanze di mediazione che qualsivoglia azione politica necessariamente implica. Sempre e comunque. A meno che non si cerchi la miccia di una nuova Sarajevo, come nel 1914. Cosa del tutto estranea a Washington al pari di Gerusalemme. Poiché ciò che Donald e Bibi condividono è la consapevolezza che la guerra si farà comunque, ma non come di prassi, usando l’esercito di terra e di aria, bensì l’economia digitale e tutto ciò che si trascina con essa. Si tratta di un differenziale profondo, nonché nettamente marcato, rispetto alla precedente presidenza interventista di George W. Bush (giudicata severamente da Trump, ricambiato in ciò dall’ostilità di buona parte degli ambienti dei cosiddetti «neocons», contrastati a loro volta dall’alt-right populista). Netanyahu, per parte sua, ha capito che la vecchia destra likudista e nazionalista non solo è sfiancata bensì anacronistica. Le reazioni secche di molti likudnikim, a partire dal presidente Reuven Rivlin, rivelano di un tale divorzio da tempo. Da almeno due anni in qua.
Non è questione, quindi, di tessere le lodi del primo ministro israeliano o di descriverlo come un manipolatore. Semmai, è necessario capire per quale ragione la sua leadership esprima una così lunga durata, ovvero su quali binari riesca comunque a rigenerarsi, spesso al pari di un’araba fenice. Il premier israeliano, che da sempre può gettare sul tavolo della discussione la carta di «mister sicurezza», oltre a rassicurare i suoi connazionali, si rivela capace di coalizzare contro il nemico di sempre (ossia, dal 1979, con la rovinosa caduta dello Scià, l’Iran teocratico, quello che parla della politica mondiale come di una sorta di continua Armageddon), un connubio tra risorse economiche del Golfo (meridionale nonché sunnita), interventismo (residuo) statunitense ed eccellenza tecno-securitaria nazionaledi Gerusalemme.
Inutile aggiungere che un Trump, altrimenti affaticato dalla pandemia e dalle difficoltà economiche in casa, si giochi questo risultato, peraltro silenziosamente perseguito da tempo, al netto dello stesso piano di Jared Kushner su un definitivo accordo tra Gerusalemme e Ramallah, per accreditarsi rispetto ad una parte dell’elettorato nelle elezioni presidenziali di novembre. Il codice che il presidente uscente userà, per convincere i suoi potenziali elettori, non sarà quello del nuovo interventismo americano (che aborre, al pari di quanti credono in lui) ma della sua “persuasività” così come dell’arrendevolezza altrui (qualcosa del tipo: «Politics as a business», la melodia che molti dei suoi elettori meglio intendono). Tradotto in parole povere: “noi, americani, garantiamo ai nostri interlocutori le migliori condizioni di accordo; sta poi a loro usarle a proprio beneficio”. Plausibile, quindi, che la firma di un qualche trattato formale tra Gerusalemme e Abu Dhabi possa verificarsi prima della data delle presidenziali americane. Trump ha stracciato la politica di appeasement di Obama (e in parte dell’Unione Europea) con l’Iran. Guarda con belluina determinazione ad Erdogan, Putin e alla Cina di XI Jinping. Anche per questo continua a piacere a certuni. Fuori di Washington, si intende.
Quanto ai palestinesi, per l’ennesima volta emerge la scarsa rilevanza del loro futuro rispetto ai pur precari equilibri che sono venuti definendosi dal 2000 ad oggi. Il fatto che una parte della loro bulimica e inamovibile leadership abbia reagito denunciando un «tradimento dei nostri fratelli arabi», semmai conferma questo stato di cose. Lo stesso Egitto di al Sisi non nasconde la sua mitigata soddisfazione per la configurazione che si va definendo del quadro regionale. Il Cairo ha bisogno del sostegno di Gerusalemme. Non si tratta di un destino «cinico e baro» ma, più semplicemente, della differenza tra il fare politica e il pensare che basti dichiarare di volerla fare per ottenere un qualche risultato premiante.
Claudio Vercelli

Dove inizia la notte
Stefano Jesurum , Setirot, pubblicato in Attualità il 20/08/2020

Nello speciale dell’ultimo numero di Pagine Ebraiche Daniela Gross segnala la mostra “Hannah Arendt and the Twentieth Century” (curata dalla filosofa Monica Boll; fino al 18 ottobre al Deutsches Historisches Museum di Berlino). Punto focale è il poco conosciuto talento fotografico della grande intellettuale, e la conseguente raccolta di scatti che documentano sentimenti, quotidianità, volti più o meno noti, frammenti di vita che scorrono per decenni, attimi felici, ritratti rubati, album estemporanei. Icona del ‘900, lei e le sue riflessioni sul totalitarismo, sul razzismo, e la fuga negli anni della persecuzione nazista, la complicata vita sentimentale, le amicizie con i Grandi…
… e così sono andato a rileggere un libriccino che consiglio a chi ad Hannah Arendt abbia voglia di sentirsi un po’ più vicino. Eichmann. Dove inizia la notte, atto unico teatrale di Stefano Massini (Fandango Libri).

La rappresentazione di vittima e carnefice. Centoquattordici pagine dirompenti, fredde, viscerali, profondissime, razionali, emotive, piene e vuote di passione. Massini, un cantastorie che mi piace molto, con quegli occhi che sprigionano la durezza della bontà e la follia della ragionevolezza. Sul palcoscenico delle pagine ci sono solamente loro due, come li ricordiamo dai filmati del processo o dalle immagini di archivio. E le loro parole, incessanti, attanaglianti. «Il linguaggio, Herr Eichmann. Il linguaggio è lo specchio, sempre, di cosa sentiamo davvero. Ci pensi: la chiamavate “Soluzione Finale”. Non avevate il coraggio di dire “Massacro”. E il gas di Globočnik? Era un “Trattamento Speciale”». Ma poi, dice Hannah, «le grandi masse fanno così: scordano tutto, velocemente, in un attimo. E non per distrazione, no. Lo fanno perché condannare gli altri – condannarli davvero – è pericoloso: corriamo il rischio, prima o poi, di sbagliare tutti. E nessuno vuol essere fatto a pezzi». Ci vuole coraggio. Anzi, no, non il coraggio, la dignità. «Il coraggio in fondo è una cosa di un attimo», vero Herr Eichmann?, il coraggio «fa rumore, abbaglia. Ci senti sotto l’orchestra. Ecco, sì, il coraggio è cinema. Perfino un vigliacco può avere un attimo di coraggio, nella vita, e non cambia il fatto che era e resta un vigliacco. No. Più del coraggio è la dignità. Molto di più. Perché la dignità, se ce l’hai, ti resta incollata addosso, è parte di te».
«Ognuno ha la sua idea di dignità: per lei, Hannah, è ribellarsi. Per me era rispettare gli ordini. Stiamo su due fronti opposti». Già, due fronti opposti. Ieri, oggi, domani. Così il dialogo immaginario tra l’SS-Obersturmbannführer Eichmann, esperto di questioni ebraiche, responsabile operativo della soluzione finale, organizzatore del traffico ferroviario per il trasporto dei deportati ai campi di sterminio (sfuggito al processo di Norimberga, scappato in Argentina, individuato e rapito dal Mossad, processato in Israele, condannato a morte per genocidio e crimini contro l’umanità) e la giornalista politologa filosofa Hannah Arendt (suo il resoconto del processo ad Eichmann per il New Yorker, poi diventato il saggio La banalità del male), ci interroga senza un attimo di tregua. Si è appena concluso il processo. Siamo nel 1961. E oggi con la Arendt noi cerchiamo, grazie a Massini, dove comincia e perché comincia il male. «Ci sarà un momento, preciso, in cui prende forma. O no? Deve esserci. Tutto ha un inizio. Quell’attimo impercettibile in cui si passa dal nulla al qualcosa. È questo che cerco io, da lei». Anche oggi, no? C’è qualcosa di talmente… stupido nel male. «Sì: stupido. E guardi che non parlo delle coincidenze. Dico che il male si nutre di paura. Ne ha bisogno. Voi eravate fieri che la gente tremasse, anche solo a vedere una divisa. Portavate i teschi coi coltelli incisi nei distintivi. La paura, certo, la paura. Eppure, a sentirvi parlare, è così chiaro che ad avere paura eravate per primi voi».
La paura. Non ci dice qualcosa? Herr Eichmann si indigna: «Non mi pagavano». «Oh sì. La pagavano con un verbo essere: “Sono un SS”. Dare a qualcuno un verbo essere è una buona forma di stipendio».
Stefano Jesurum

Il vantaggio di essere una nazione
Il nodo dell’identità. Corriere della sera 2 agosto 2020
Lorenzo Cremonesi intervista Yael Tamir

“Appartengo alla generazione cresciuta con le canzoni di John Lennon. Avevo 17 anni nel ’71 quando ascoltai per la prima volta Imagine e come tanti giovani occidentali m’innamorai subito del sogno, anzi dell’utopia, di un mondo aperto e pacifico. Lennon e Yoko Ono forgiarono il nostro immaginario con la loro Nutopia, uno Stato senza confini. Bene, oggi non esito a sostenere che fu un’utopia sbagliata, una fantasia pericolosa. Un mondo senza frontiere non è affatto un mondo ideale: non può essere né democratico, né giusto. E comunque quell’utopia è stata cancellata in pochissimo tempo dopo l’esplodere della pandemia del Coronavirus. In un pugno di giorni sono stati chiusi i confini, è stato sospeso il trattato di Schengen. Per garantire la vita dei loro cittadini anche le democrazie hanno sbarrato le frontiere». Attivista della sinistra israeliana da quando era liceale, paladina dei diritti civili e della nascita di uno Stato palestinese, fondatrice nel 1978 con un pugno di compagni del movimento Pace Adesso contro l’occupazione di Cisgiordania e Gaza, quindi deputata e ministra laburista sino al 2020, oggi docente universitaria, Yael Tamir non smentisce nulla del suo passato. «Rimango una convinta laburista, anche se non esisto a definirmi una liberale nazionalista. Credo che le élite della sinistra illuminata e cosmopolita abbiano commesso gravi errori e nei miei lavori accademici studio le radici e gli sviluppi del nazionalismo», spiega a «la Lettura», presentando il suo Le ragioni del nazionalismo (Bocconi).

Tra gli argomenti che cita per criticare l’illusione cosmopolita, ci ricorda che solo il 3,3 per cento della popolazione mondiale vive in un Paese diverso da quello di nascita. Ma come replica a chi ci ammonisce in Europa sui disastri provocati dal nazionalismo, responsabile di due terribili guerre mondiali? «Certo, temo gli estremismi e il nazionalismo xenofobo. Amo sempre ricordare gli insegnamenti di Isaiah Berlin, mio tutor al dottorato di Oxford tanti anni fa ormai, che spesso parlava della necessità di relativizzare le proprie convinzioni. Il modo in cui le si sostiene differenzia il civilizzato dal barbaro. Una volta sottolineati i pericoli del nazionalismo estremo, io miro a porre l’accento su quelli altrettanto gravi del distacco tra le classi dirigenti illuminate ma sradicate, individualiste, prive del senso di solidarietà sociale per i propri concittadini, e invece gli strati meno abbienti della popolazione, che si sentono traditi, abbandonati e tendono a votare per i partiti populisti. Theresa May, quando era premier britannica, parlava non a torto di “cittadini del mondo che in realtà sono cittadini di nessun luogo”. Individui che vanno a sciare a Cortina, al mare alle Maldive e per i weekend a Parigi. Sono coloro che mandano i figli nelle grandi scuole internazionali, dispongono delle ricchezze per farlo, e non sono toccati dai problemi delle periferie urbane, dove i genitori non vogliono avere i bambini dei migranti in classe con i loro figli. Tanto dove studiano i figli dei cosmopoliti abbienti i migranti non ci sono. Un moderato nazionalismo trasforma invece lo Stato in patria, dà forza e sostanza al Welfare State, crea la solidarietà comunitaria, ci fa sentire tutti parte di una stessa casa. II problema delle sinistre è che spesso non comprendono il bisogno dell’elettorato popolare di vivere in una società dai confini chiari e sicuri. Ancora, lo ha dimostrato il virus: solo nei nostri confini possiamo aiutarci gli uni con gli altri nell’emergenza, sappiamo a chi dare e a chi prendere. La verità è che non esiste un welfare globale».
Concorda con chi vorrebbe bloccare i migranti? «Non ho detto questo. Dico che occorre una chiara politica sulle migrazioni. Lo Stato deve controllare i flussi. La scelta della composizione demografica di un Paese non può essere lasciata alle organizzazioni non governative. La popolazione in genere teme le migrazioni non controllate. I meno abbienti hanno paura degli stranieri, li vedono come concorrenti in casa loro. Il dramma dei progressisti in Italia è stato che, accecati dall’ideologia globalista, non hanno capito i bisogni e le paure più elementari degli elettori».
I suoi argomenti non fanno il gioco delle destre israeliane e dei coloni, che vorrebbero espellere i palestinesi? In queste settimane il premier Benjamin Netanyahu cerca di mettere a punto l’annessione di larga parte della Cisgiordania. Che ne pensa? «Contesto Netanyahu e chi lo sostiene. Non ho mai cambiato idea dai tempi di Pace Adesso: sono per la soluzione dei due Stati, uno accanto all’altro. E ciò non contrasta con le tesi dei miei libri. Noi israeliani abbiamo bisogno di uno Stato sicuro e socialmente solidale e di altrettanto necessitano i palestinesi. La pace sta nella divisione della terra, assolutamente non nell’annessione. La considero un disastro per entrambi i popoli».
Ma non crede sia troppo tardi? Di fatto l’espanslone delle colonie ebraiche negli ultimi decenni ha reso impossibile la spartizione. «Certo, ogni giorno che passa rende le cose sempre più difficili. Ma la situazione è reversibile, penosa, eppure la terra può ancora venire divisa. Non ci sono altre vie che abbiano senso e non comportino tragedie. L’alternativa sarebbe comunque peggio: uno stato continuo di tensione, guerriglia e addirittura guerra a bassa intensità, con picchi di violenza molto gravi. Sarebbe come la ex Jugoslavia negli anni Novanta».
Nel libro cita la famosa frase di Massimo D’Azeglio, per cui, fatta l’Italia, bisognava fare gli Italiani. Una dinamica del nostro Risorgimento a cui guardava anche il movimento sionista delle origini e poi alla nascita di Israele nel 1948. Che cosa altro individua di positivo nel nazionalismo moderato? «I due Risorgimenti hanno avuto dinamiche simili e i sionisti guardavano con ammirazione all’esempio italiano. Nel nazionalismo si trovano l’amore per la storia e per la natura del luogo in cui si vive, il senso di appartenenza individuale che coincide con quello collettivo. Ogni volta che vengo in Italia resto stupefatta da come voi valorizzate il vostro passato: si vede nelle statue, nelle piazze, nei palazzi, nelle targhe delle vie, di fronte alle fontane, nelle basiliche. Il vostro rispetto reciproco è stato encomiabile durante la fase di massima crisi del virus. Oltretutto, il nazionalismo aiuta a dare un senso alla propria esistenza in un mondo secolarizzato. Prevale l’idea che, dopo la nostra morte, la patria, la collettività a cui siamo appartenuti, continuerà a vivere. La nostra esistenza non sarà stata vana».

A proposito del film Nabka 72
Pubblichiamo una serie di interventi originati dalla segnalazione di Vittorio Pavoncello in merito al film Nabka 72 , trovato per caso sulla cineteca del movimento operaio e che si può vedere sul link https://www.aamod.it/2020/05/13/nakba-72/
Da Vittorio Pavoncello con il contributo di Gabriele Eschenazi e Luciano Belli Paci
Al Direttore Vincenzo Maria Vita
Ci sono molti modi di vedere il conflitto israelo-palestinese, questi modi possono essere neutrali, o di parte e per parte dobbiamo intendere una visione del problema più orientata verso Israele o più orientata verso i palestinesi. Tutto ciò è giusto oltre che legittimo. Diverso è il caso dove una visione di parte viene supportata da menzogne, non da fake news che sono altra cosa, ma da menzogne vere e proprie, ed è questo il caso del film NAKBA 72 di Monica Maurer regista e documentarista tedesca, membro del consiglio direttivo dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio di Roma.
Monica Maurer può rielaborare tutto ciò che vuole e sembra che questa sia una sua tecnica costante se dobbiamo far fede ad una intervista che ha rilasciato a Invicta Palestina dove narra dei suoi esordi da Film Maker: “Lavoravo nell’archivio, usando i vecchi film per creare dei fillers, montavo nuovi filmati utilizzando materiale d’epoca”. Questa tecnica di rielaborazione libera in termini estetici può essere un modo per creare, ma se si è un artista di regime le proprie opere diventano pura propaganda. Ed è quanto accade con il suo film NAKBA 72 “riempito” di propaganda antisemita e non di storia del conflitto israelo-palestinese e che ricorda molto da vicino il film nazista Der Ewige jude (L’ebreo eterno).
Nel filmato si descrive inopinatamente l’immigrazione ebraica come un progetto di “pulizia etnica” facendo in questo caso davvero “pulizia della storia” così come è stata raccontata da diversi libri sull’argomento redatti da ricercatori anche critici, ma capaci di suffragare le proprie tesi con fatti reali e mantenendo equilibrio di giudizio. Si parla dell’accoglienza dei profughi ebrei espulsi dai paesi arabi e depredati di tutto come “importazione” quasi si trattasse di merci.
La prima guerra del 1948 è raccontata in modo fantasioso omettendo che ben 5 Stati (Egitto, Siria, Libano, Transgiordania e Iraq) attaccarono l’appena proclamato Stato d’Israele proponendo, loro sì, una totale pulizia etnica (“buttiamo a mare gli ebrei” era la loro parola d’ordine) e realizzandola di fatto in tutti i territori sotto il loro controllo. Quel progetto di sterminio non si realizzò solo perché furono sconfitti. Lo stato di Palestina non poté nascere perché il territorio assegnato dall’ONU ai palestinesi e rimasto in mani arabe venne annesso, parte dalla Giordania e parte dall’Egitto.
Il video nell’ipotizzare un complotto ebraico/sionista ai danni dei palestinesi rimanda direttamente ai Protocolli dei savi di Sion.
Come militanti dell’associazione Sinistra per Israele, da sempre paladina della soluzione “Due popoli per due stati” ci meravigliamo di come questo filmato possa essere proposto nell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio di Roma lasciando intendere che l’Archivio sposi le tesi esposte nel video. Non possiamo pensare che sia questo l’intento dell’Archivio, che certamente ha ben presente quale sia il valore dell’esistenza di uno stato ebraico riconosciuto dalle Nazioni Unite.
Il conflitto israelo-arabo-palestinese ha una storia lunga e complessa dove torti e ragioni si sovrappongono e confondono. Una soluzione fino ad oggi non è arrivata nonostante a volte sia sembrata anche piuttosto vicina. Estremisti da una parte e dall’altra hanno impedito che avvenisse una riconciliazione e la fine degli spargimenti di sangue. Non possiamo cessare di sperare e lottare affinché una soluzione alla fine si trovi. Ma questo non potrà avvenire seminando odio, risentimento e demonizzazioni nei mezzi di comunicazione. Nelle società israeliana e palestinese non mancano forze che operano per il dialogo e il rispetto reciproco. Noi le sosteniamo e così dovrebbe fare anche l’Archivio del Movimento Operaio di Roma evitando di proporre ai suoi visitatori video come NAKBA72.
Riportiamo qui l’importante contributo di Bruno Segre al nostro dibattito

Sono uscito d’ospedale cinque giorni fa, il 15 luglio, dopo sei settimane di degenza, per ritrovarmi subito immerso nel mondo della comunicazione pubblica e nel clima pesante del Kulturkampf che Donald Trump sta da anni spargendo ovunque.
Nel particolare, ho preso visione del film Nakba 72 – Aamod e ho letto il testo scritto da Vittorio e poi rielaborato da Gabriele. Di quest’ultimo condivido tutto, comprese le virgole e gli spazi vuoti. Faccio invece più fatica a consentire con Vittorio che, “capitato per caso” nel catalogo dell’archivio del movimento operaio e dell’audiovisivo, vi trova “con sorpresa” il manufatto antisemita realizzato nel 2018 da Monica Maurer.
Sull’intera vicenda e sul seguito SpI che poi ne è nato, desidero proporre qualche considerazione.
– Nel corso dei miei novant’anni non ricordo d’avere mai visionato un documento di propaganda “filopalestinese” altrettanto sgangherato, controproducente, poco credibile sino al limite dell’imbarazzante. Persino nella scelta del materiale iconografico la sedicente “documentarista” tedesca ne ha combinata una più del diavolo: secondo lei, quando nel maggio 1948 Israele “scatenò la sua premeditata aggressione” contro l’Egitto, il Libano , la Transgiordania eccetera, gli aerei “degli ebrei” − guardateli bene − erano degli Stukas! Ma nel confezionare il suo capolavoro, da chi si è mai fatta ispirare la Maurer? dal Mossad?
– Gli unici “utenti” ai quali un documento di questo tipo può dare soddisfazione sono coloro che criticano Israele perché già animati da inguaribile giudeofobia (non tutti i critici di Israele, dunque), e più in generale gli antisemiti tout court.
– L’antisemitismo è una malattia dalle radici antichissime, che purtroppo l’universo cristianizzato si porta dentro sin dai tempi degli imperatori Costantino e Teodosio, e che in forma palese e/o sotterranea continuerà, temo, a circolare ancora fra i nipoti dei nostri nipoti. Per cancellare gli effetti di quasi duemila anni di demonizzazione non sono sufficienti una Shoah o un Concilio Vaticano II. Gli antisemiti sono ancora abbondantemente presenti fra di noi: antisemiti di destra, di centro e di sinistra. In vita mia ne ho incontrati molti e, personalmente, ho imparato a farmene una ragione.
– Mentre non credo, in buona sostanza, che la visione di Nakba 72 – Aamod possa portare a un significativo aumento del numero degli antisemiti già normalmente circolanti, temo che neppure l’eccellente testo di Gabriele abbia la virtù di convincere qualche antisemita a lasciar cadere il pregiudizio e a cambiare idea.
– Che cos’è e che cosa rappresenta questa cineteca del movimento operaio nel cui archivio giace Nakba 72 – Aamod? È vero, noi di SpI siamo piccoli, abbiamo scarsa visibilità e poca voce, ma ho la netta sensazione che la citata cineteca sia ancora meno visibile di noi. Insomma, mi domando se valga la pena che spendiamo preziose energie per segnalare al nostro modestissimo pubblico l’esistenza di una simile inesistenza.
– Infine, sul tema “Sinistra-Israele” propongo un’ultima considerazione, o meglio, sollevo un’ultima pesante domanda. Qualcuno di voi riesce ancora a vedere “qualcosa di sinistra” in ciò che si muove nel complesso garbuglio vicino-orientale? L’intero Israele, come ben sappiamo, è in mano a un ampio ventaglio di destre, secolari e religiose, ma altrettanto può dirsi dei palestinesi (Olp e Hamas) e dei diversi Stati arabi e musulmani con i quali i governanti di Israele stanno facendo affari e stanno progettando le future carte geopolitiche della regione. Qui, allora, la questione di fondo non sarà più quella di “difendere Israele dagli antisemiti di sinistra”, come nei decenni scorsi, ma sarà quella di spingere la sinistra − in Israele, nel Vicino Oriente e nel più grande mondo − a ritrovare se stessa. Non sarà che, per caso, dovremo cambiare denominazione e chiamarci “Sinistra per la Sinistra”?
Bruno Segre
Riportiamo infine l’interessante contributo di Enrico Fink
Mi permetto di intervenire anche se sono da sempre quasi del tutto assente dalla vita attiva di questo gruppo; più un “lurker”, come si dice, che altro, ma un lurker che segue e legge sempre avidamente tutto quanto.
La polemica che vedo fiorire in questi giorni un po’ mi rincuora perché mostra ancora una volta quanto questi temi siano urgenti per molti di noi, ma anche ovviamente mi preoccupa. Ho avuto qualche settimana fa anche una brutta esperienza sul sito facebook “progressisti per israele” che colgo l’occasione per chiedere, è gestito da SPI? Non ci entro, ma anche lì ho notato un astio e un modo di relazionarsi che mi inquieta.
Trovo interessanti e costruttivi tutti gli interventi e le varie bozze proposte, ma manca ancora secondo me l’espressione chiara di ciò che ci distingue da i vari IC tanto presenti sul web. Ed è importante forse dirselo oggi, che ci ritroviamo spaccati e rancorosi, importante ricordarsi chi siamo, anche al di là dell’intervento nei confronti dell’archivio in questione.
Mi spiego. Non basta dire, come pur bene scrive Gabriele, che stare dalla parte dei palestinesi o di Israele sono entrambi posizioni giuste e legittime. Bisogna dire che se abbracciate correttamente e onestamente, le due cause sono una. Nella mia esperienza di discussione pubblica sui nostri temi, ho sempre trovato vincente far capire alla parte “avversa” che, in questo caso, avevano di fronte qualcuno di non nemico, ma potenzialmente alleato. Quello che ci caratterizza come “sinistra per Israele”, al di là delle amare considerazioni che qui abbiamo tutti letto, è che tutti quanti crediamo che – praticabilli i due popoli due stati o meno, per adesso – non ci sia comunque prospettiva positiva possibile per una parte se non anche per l’altra, contemporaneamente. Che, per quanto faccia sorridere oggi dirlo, non si possa veramente e onestamente essere filopalestinesi senza al contempo essere anche filoisraeliani, e viceversa. Nel vero senso di quelle parole. È chiaro che è un discorso utopistico, ma è ciò che ci motiva e ci rende non solo diversi, ma necessari. Se ci rivolgiamo a un ente di sinistra, io do per scontato che gli ideali che lo animano sono, potenzialmente, anche i nostri; ma stanno sbagliando metodo, visione politica, strategia. Questo gli dovremmo spiegare. Caro archivio del mondo operaio, siamo ANCHE NOI dalla parte dei palestinesi, oltre che degli israeliani. Ma voi, siete sicuri che perdurare in una critica violenta becera e “sgangherata”, per citare Bruno, sia una strada che porta da qualche parte? Non vedete che condannate voi stessi e chi vi segue all’abbraccio mortale con chi in realtà desidera l’annientamento dell’altro? Con la destra, alla fin fine? Da voi, che siete sensibili alla causa dei palestinesi, pretendiamo intelligenza politica, onestà intellettuale, perché la vostra causa lo merita. Ne abbiamo bisogno tutti. Falsità come quelle della Maurer sono un contributo negativo a qualunque prospettiva di pace. Venite dalla nostra parte, compagni, e abbracciate la complessità del tema Israele/Palestina. Se chi come voi appoggia il movimento palestinese non farà questo sforzo, sarete complici di chi mantiene da decenni la situazione così com’è, e specula sulla pelle dei palestinesi ai quali vi rivolgete. Noi già da tempo siamo fra quelli che, fra chi ama Israele, rifiutano soluzioni unilaterali e aggressive. Siamo piccoli, quasi inesistenti, ma ancora oggi non si vede una soluzione di pace che non passi per una visione come la nostra. Abbiamo bisogno di voi.
Questo secondo me il messaggio che dovremmo cercare di portare in situazioni come queste. Questo il senso del nostro agire. Non ci spacchiamo lungo linee di polemica e divisione personale.
Enrico Fink
From Peace to Separation
Shaul Arieli Expert on the Israeli-Palestinian conflict

“We are not seeking a happy marriage with the Palestinians, but a fair divorce – And this is what the TwoStates solution is about”
Amos Oz on J-Street Convention in 2012
Amos Oz speaks on the opening night of J Street 2012: Making History [Conference]
The Israeli Peace Camp was never homogeneous; rather, it was an ecosystem of countless organizations and initiatives that focused on different issues and forms of action, bound by their shared ambition to promote a peace agreement between Israelis and Palestinians including the establishment of a Palestinian state alongside Israel. With the Peace Camp’s retreat from politics back to the realm of civil society, the controversies and divisions between the various actors resurfaced, making it difficult for them to speak in a united voice and collaborate effectively. In his essay “Give Separation A Chance,” Dr. Shaul Arieli describes how the dissolution of the peace paradigm of the 1990s led to the disintegration of the peace camp into groups that pull in different, and at times, contradictory directions. According to Arieli, there is, however, one thread uniting most of the different actors, namely a shift in their objective from promoting peace to advocating for physical separation from the Palestinians in the West Bank. Arieli writes:
“Mutual distrust, the stalled negotiations, Europe’s weakness in the face of a growing right wing, civil wars in the Arab world and Trump’s leadership have combined to drive an ideological shift in the Israeli “peace camp”: from seeking a peace agreement, to bilateral or unilateral separation from the Palestinians in the West Bank”
Thus, despite the ostensible continuity in the declared objectives of the civil society organizations that have worked to advocate for the two-states solution over the past decades, a profound shift has occurred. While in the 1990s the promotion of the two-state solution was framed as part of a utopian, or at least positive vision that included transforming a negative situation of ongoing violent conflict into a positive situation of peace, today, the main messages are mainly negative in nature and draw on the necessity of preventing a dystopian scenario, e.g. potential escalation of the conflict, the undermining of Israeli democracy, losing the Jewish majority in the country as a result of annexing territories, or international pressure (in the pre-Trump era). Psychologically, the difference between the two framings is huge, if to follow Amos Oz’s metaphor, comparable to the difference between reaching into ones pockets when getting married versus spending money on a divorce lawyer. It is understandably less complex to rally support for the former than for the latter.
While in the 1990s the promotion of the two-state solution was framed as part of a Utopian vision, today, the key messages are negative and draw on the necessity of preventing a dystopian scenario
In his essay “Do Good Fences Make Good Neighbors?” Meron Rapoport argues that the promotion of the alarmist discourse in which the Palestinians are often depicted as a “monolithic threat” that needs to be put
behind a fence, has only served to further undermine the Israeli left and to consolidate the right-wing narrative. Rapoport writes:
“A fundamental tenet of the separation philosophy is that Israel cannot trust the Palestinians and must rely on itself. Therefore, the argument goes, Israel must strive to separate from the Palestinians as soon as possible, before they become a majority. […] Peddling this urgency has reinforced the belief among JewishIsraelis that, as the Palestinians cannot be trusted, there is no partner for an agreement. If indeed there is no partner for an agreement, maintaining the status quo appears to be the best alternative“
The negative discourse that portrays the Palestinians as a threat that must be disposed of not only harmed the cause of the two-state advocates, according to Rapoport, but also fueled the right-wing demonization campaign against the Palestinian population within Israel. The Zionist left’s doomsday scenario, according to Rapoport, in which equal rights might be granted to Palestinians who are branded as the ultimate “other” plays to the hands of the right and their intimidation-based discourse, while also dividing the Israeli centerleft camp around the question of the very legitimacy of cooperating with the Arab Joint List (and effectively impeding the option of forming a center-left government).
Controversial ‘Divorce the Palestinians’ Israeli Media Campaign Explained
The subsiding of the public debate around the conflict over the past decade has made room for the issue of Jewish-Arab relations within Israel to emerge as the new dividing line between left and right. This issue figured prominently in the series of election campaigns held during the past year. The rise of the Joint Arab List as a prominent political actor has transformed the Israeli Palestinians into a significant player in the parliamentary arena whereby it is practically impossible to establish an alternative government to that of Netanyahu without it. The right-wing slogan: “Bibi or Tibi” (referring to Arab-Muslim MK Ahmad Tibi) aimed precisely at the “Achilles’ heel” of the center parties, which were inundated with challenges from the press questioning the authenticity and viability of their pledge to pose an alternative to Netanyahu without collaborating with the Joint Arab List.
The leadership of the Israeli-Palestinian public is currently at a crossroads between investing in Jewish-Arab partnership, or the independent promotion of sectoral interests
The reluctance to support a partnership between the Arab parties and the Zionist center-left parties is, however, not only the legacy of the latter. As Ravit Hecht points out in her essay, many Palestinian Israelis who now choose to define themselves through their Palestinian identity, prefer right-wing rule in Israel over the Zionist left, which they believe wronged their ancestors more severely than the Israeli right.
In his essay “(Im)possible Alliance,” the poet Marzouk Alhalabi reviews the key developments in the relationship between the Zionist left and the Palestinian public in Israel and concludes that the latter, which was subjected to intensive de-legitimization in the two decades since the events of October 2000 will not be waiting for the Zionist left parties’ stamp of approval, especially given their waning influence in Israeli politics. According to Alhalabi, the leadership of the Israeli-Palestinian public is currently at a crossroads between investing in Jewish-Arab partnership, or the independent promotion of sectoral interests, after the fashion of other parties in the Israeli parliament, while renouncing their automatic affiliation with the Zionist left.

The Crisis of the Zionist Left
Oz Aruch

Head of the German-Israeli Dialog Program at the Heinrich Böll Stiftung
Over a period of one and a half years, extending over all of 2019 and half of 2020, the Israeli political system underwent unprecedented turmoil. It took a grand total of three consecutive election campaigns and one global health crisis to bring about the formation of a national government. Electoral trench warfare was waged between the Likud party, led by longstanding Prime Minister Netanyahu, and the “Blue and White” list, headed by former general and political novice Benny Ganz, both of whom had failed to rally the parliamentary majority needed to form a government on their own. Eventually, the Covid-19 epidemic and the ensuing economic crisis offered the necessary boost and cover for the formation of a broad government joining Netanyahu’s right-wing bloc (comprising Likud and the Ultra-Orthodox parties) with the Blue-andWhite and Labor parties.
Acceding to collaboration with Netanyahu despite having vowed against it for three consecutive election campaigns, Blue-and-White and Labor justified the concession by depicting the new government as an “emergency unity government,” the merging of two rival political camps in the country, willing to put aside their ideological differences to tackle the spiraling health, economic and political crises ailing the country.
In his statement of intent as he led the Labor Party into the newly formed unity government despite having publicly shaved his iconic moustache (so that the viewers can “read his lips”) in a dramatic oath never to again join a Netanyahu-led government, Amir Peretz proclaimed:
“We are joining a unity government as equal members; the Labor Party is returning to the national leadership. In a national, health and economic emergency, we have decided again to be on the side that acts to fulfil our social-democratic worldview, to stand again at the center of the political stage, and to restore the Labor Party to an important, significant and influential position of influence on Israeli government policy.”
The Labor Party chair’s reference to the “equal membership” in the new government, might create the impression that it was formed by the two rival ideological camps in Israel, i.e. between the right-wing and left-wing camps, and that the Labor Party, which for decades following the establishment of the state led the Israeli left-wing camp, played a significant role in the process, as was the case in all previous unity governments in Israel. However, this depiction could not be further from the truth. The 18-month long election campaign, as well as the various coalition talks and the establishment of the alleged “unity and emergency” government were not part of a process that took place between the Israeli right-wing and leftwing camps, but between Netanyahu’s right-wing bloc on the one hand, and a mix of parties that consider themselves center-right, and whose leaders made sure to declare at every opportunity that they did not belong to the left-wing and/or represent leftist ideas.
For the first time since the establishment of the State of Israel, the declared parties of the Zionist left, namely Labor and Meretz have been swinging at the electoral threshold, viewing the political goings-on from the sidelines, devoid of political support and influence. These two parties, which in the 1992 elections won 44 seats (Labor) and 12 seats (Meretz), together representing 47% of Israeli voters, during the last round of elections scraped by with a mere six seats, representing roughly 5% of the vote. By leading his small party, represented by just three seats, into the right-center “unity” government (in turn also precipitating a split from the Meretz Party), Labor Party Chairman Amir Peretz might have very well signed the death warrant for the main political platform of the Zionist left.
For the first time since the establishment of the State of Israel, the declared parties of the Zionist left have been swinging at the electoral threshold, viewing the political goings-on from the sidelines
The virtual absence of the Zionist leftist parties from one of the most dramatic and polarized political campaigns in the history of the country was not a function of some refreshing ideological breeze offered by Blue-and-White, or a more accurate representation of a conceptual alternative to the decade-long right-wing rule under Netanyahu. Rather, Blue-and-White, which rose to prominence thanks to left-wing voters and alleged to offer the only alternative to Netanyahu and Likud, announced day and night that it was not leftwing and refrained from conveying any messages that could be construed as “leftist” or even as an ideological break from the right-wing agenda of the past years effectively leading to the erasure of the Zionist left’s traditional positions from the public discourse.
Instead of offering a clear alternative to the right-wing, Blue-and-White seemed rather to communicate to their potential voters that they had no significant ideological disagreements with the governing Likud, only that contrary to the latter, their representatives were not tainted with corruption. Thus, on a range of key political issues that have tended to delineate the divide between the right-wing and left-wing camps in the country in recent decades, especially on issues of foreign and security policy and the future of the IsraeliPalestinian conflict, it was difficult to identify any significant differences between the agendas of Likud and Blue-and-White. Furthermore, the political platform that purported to represent an alternative to the Israeli right also featured prominent right-wingers who had defected to Blue-and-White from Likud (for various reasons, ideological differences or disillusionment of the right-wing agenda not among them) who supported the expansion of Jewish settlements in the West Bank.
Blue-and-White seemed to communicate that they had no significant ideological disagreements with the governing Likud, only that contrary to the latter, their representatives were not tainted with corruption
Finally, the fact that Blue-and-White and Labor, that for three consecutive election campaigns claimed to present a political alternative to the right, agreed to include a clause in the coalition agreement that sanctioned the annexation of parts of the West Bank to Israel as of July 2020, exemplifies the fundamental change in the composition of the Israeli parliament. For the first time in decades, the Knesset is no longer divided between a left-wing camp that supports the advancement of the peace process and the right, which objects to it. The decision of the Labor Party, once at the helm of the Zionist left and the peace camp, to join this government, even signing a waiver relinquishing the right to object to any legislation relating to the annexation of parts of the West Bank, is tantamount to an admission of guilt and a concession of defeat.
How did the Israeli Zionist left parties, and most notably the Labor Party, which established the state and ruled it unchallenged until 1977, reach the brink of extinction? And how can one account for the fact that the nearly complete departure of the Zionist-left parties from the political stage took place, of all times, at one of the most critical junctures in Israeli history, when the status quo regarding some of the most fundamental tenets defining Israeli public life, including the rule of law, Israel’s character as a Jewish and democratic state, and the future of the Israeli-Palestinian conflict, was being called into question?

Ogni cosa è più illuminata
Esther Safran Foer ha continuato il viaggio del libro del figlio Jonathan. Alla ricerca di un altro pezzo di memoria per non dimenticare l’orrore nazista: “Il nostro non è un ricordare un fatto accaduto tempo fa, ma riviverlo come un inizio rivolto al domani”
Susanna Nirenstein, La Repubblica , 29 Maggio 2020
«Zachor», Ricorda! Le ingiunzioni della Bibbia ebraica sono incondizionate: il verbo zakhar, ribadiva il grande Yosef Haym Yerushalmi, ricorre 169 volte nella Torah, un baluardo contro l’inesorabile erosione della memoria per un popolo disperso e sottoposto a miriadi di persecuzioni e massacri.
La famiglia Safran Foer è un monumento alla lotta contro l’oblio: se Jonathan ha scritto Ogni cosa è illuminata, tradotto in 36 lingue dopo essere andato a ricercare le tracce dello shtetl di Trochenbrod nell’Ucraina occidentale dove la famiglia di suo padre fu sterminata dai nazisti, adesso anche la madre Esther, figlia di genitori miracolosamente sopravvissuti allo sterminio degli ebrei, ha dato alle stampe un libro, Voglio sappiate che ci siamo ancora (Guanda).
È un memoir sulla sua vita iniziata nel 1946 nell’ex ghetto di Lodz, proseguita per più di due anni in un campo profughi in Germania (dove arrivò nel doppiofondo di un camion per sfuggire alle guardie russe di frontiera), approdata infine in America. Ed è un libro sulle infinite ricerche fatte per ricostruire il passato di sua madre e suo padre e sull’assassinio dei loro congiunti.
Esther Safran Foer colleziona fotografie, lettere, documenti, ricerche, mappe, genealogie, dati dello Yad vaShem (il museo della Shoah di Gerusalemme), dell’Holocaust Memorial di Washington, pareri di investigatori, di agenti dell’Fbi, vasetti di terra raccolta in posti significativi, così come suo figlio Jonathan attaccava alla parete di camera sacchettini di plastica contenenti tessere di oggetti, fatti, ricordi relativi ai suoi famigliari.
Cresciuta tra i silenzi di sua madre e il suicidio – quando aveva otto anni – di suo padre, ha dovuto ricomporre un sensibilissimo puzzle. Nel 2016 ha rotto ogni indugio, ed è andata insieme al figlio Frank in Ucraina, a individuare la famiglia che aveva salvato suo padre, a scovare finalmente i nomi della prima moglie del babbo, Tzipora, e della loro figlia, Asya ambedue falcidiate dalle Einsatzgruppen. La contattiamo per skype.
Mrs Foer, lei riempie la casa di scaglie di ricordi sensibili. La memoria è una sua parte fondante, perché?
«Ho ereditato tutto il passato di due sopravvissuti, dovevo passarlo ai miei tre figli e sei nipoti, perché sappiano da dove veniamo».
Perché nell’ebraismo la memoria è così importante?
«Il nostro modo di ricordare, quando ogni anno leggiamo l’Hagaddah di Pasqua sulla fine della schiavitù in Egitto, non è imparare un fatto accaduto tanto tempo fa ma riviverlo come se a uscire dalle mani del faraone fossimo noi stessi, per la nostra libertà. La nostra memoria è un inizio rivolto al domani».
Sua madre non raccontava molto. Si è data una spiegazione di quei silenzi?
«Un po’ parlava. Per esempio raccontava sempre del giorno in cui, con i tedeschi alle porte, aveva lasciato il villaggio, senza nemmeno salutare sua mamma. Rammentava come sua sorella l’aveva inseguita portandole un paio di scarpe, e di come lei ne avesse quasi subito persa una. Io non volevo porre tante domande, sapevo che il mio ruolo era di portare gioia. Raccoglievo i suoi frammenti: schegge di memoria. Persone incontrate in Israele, Brasile, Usa mi raccontarono come lei e l’amica con cui fuggì in Russia, Uzbekistan, Kazakistan avessero vissuto dormendo nei cascinali, nascondendo le patate nelle mutande, risparmiando anche pochi chicchi di riso per il giorno dopo. Lei invece cercava di non volgersi troppo indietro, verso i suoi sensi di colpa. Poi mio figlio Frank per l’esame finale del college le fece un’intervista, lì cominciammo a ricomporre il quadro. Ma c’è voluta una vita intera per saperne di più».
Quando aveva quarant’anni sua madre le disse che suo padre nello shtetl aveva avuto una prima moglie e una figlia uccise dai nazisti. Cosa cambiò in lei?
«Fu uno shock. C’era stata un’altra famiglia. C’era stato un altro bambino, mia sorella. Ho fatto mille ricerche, non riuscivo a trovare nulla. È stato un miracolo che poi in Ucraina, a Kolki, abbia incontrato dei testimoni ancora vivi che rammentavano molto».
Come si sono salvati i suoi genitori?
«La mamma, con l’avvicinarsi dei tedeschi ebbe l’istinto di scappare. Era giugno, ma prese un cappotto e un paio di forbici, se le cacciò in borsa e seguì con altre cinque amiche l’esercito russo che si ritirava. Si dovettero separare ma sopravvissero tutte. Mio padre invece è morto suicida quando avevo otto anni, non ho potuto chiedergli nulla. Sapevo che viveva nel ghetto e che i tedeschi lo usavano come operaio: il giorno dell’Aktion che eliminò tutti gli abitanti, lui era stato mandato fuori a riparare qualcosa. Quando tornò voleva togliersi la vita. Qualcuno lo convinse a nascondersi. Ho una foto della famiglia che l’ha salvato, è la stessa fotografia che prima Jonathan, poi io, abbiamo portato con noi in Ucraina per saperne di più».
Pensa che il viaggio di suo figlio Jonathan a Trochenbrod le abbia aperto una strada, o di averlo spinto lei in Ucraina con la sua fame di notizie. Chi ha influenzato chi?
«C’erano cose che non ero pronta a fare e sulle quali indirizzavo i miei figli. Frank a intervistare la nonna, Jonathan ad andare a Trochenbrod. Ne nacque il romanzo, il film. Capii che il viaggio che desideravo era possibile».
Come ha commentato Jonathan il suo libro?
«Non gliel’ho fatto vedere finché non era quasi finito. Poi mi ha ringraziato per come ho perpetuato i nomi della nostra famiglia, per come stavo passando tutto quello che era successo alla generazione futura».
Quando si è trovata davanti alle due fosse comuni dove erano stati uccisi i suoi parenti in Ucraina, lei e suo figlio Frank avete lasciato sotto terra e infilata tra i sassi una fotografia della sua famiglia al completo, figli, nuore, nipoti. Perché?
«Volevo dirgli “sappiate che ci siamo ancora”, restiamo qui con voi, e voi con noi, non vi dimenticheremo».
Il libro
Voglio sappiate che ci siamo ancora di Esther Safran Foer (Guanda, pagg. 288, euro 17,10)

ISRAELE: UN NUOVO GOVERNO PER TUTTE LE EMERGENZE
La crisi politica più lunga della storia d’Israele si è risolta con l’insediamento di un nuovo governo di emergenza nazionale. Ma oltre al coronavirus, quali sono gli altri obiettivi del nuovo esecutivo?
ISPI 18 Maggio 2020
Comincia con un ritardo di tre giorni sul previsto, la staffetta di governo tra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. Il nuovo governo israeliano di emergenza nazionale – il primo dopo oltre un anno di stallo e tre elezioni andate a vuoto – sarà guidato per i primi 18 mesi dall’ex premier e per i secondi 18 dall’ex capo di stato maggiore, oggi leader di quel che resta dell’alleanza Blu e Bianco. Si tratta dell’esecutivo più numeroso della storia del paese: 36 ministri e 16 vice che hanno giurato ieri davanti alla Knesset dopo un ritardo causato dalla sollevazione di alcuni membri ‘anziani’ del Likud, il partito di centro-destra di Netanyahu, che non avevano ricevuto incarichi di governo. In base all’intesa, Netanyahu assumerà la guida del paese per un anno e mezzo, mentre l’ex rivale Gantz, che ora assume la poltrona di ministro della Difesa e di vicepremier, gli succederà nel novembre 2021.

| Staffetta contro il coronavirus? |
| Dopo oltre 500 giorni di impasse e tre tornate elettorali, i 120 deputati della Knesset hanno approvato un governo per i prossimi 3 anni, guidato ‘a staffetta’ da Netanyahu e Gantz. Il parlamento ha approvato l’esecutivo con 73 voti a favore e 49 contrari dopo oltre due mesi di consultazioni. Ad allungare i tempi è stata la volontà di Netanyahu, primo ministro più longevo della storia d’Israele, nel rifiutarsi di fare un passo indietro malgrado sia imputato per corruzione. Gantz ha sempre detto di non voler governare con lui, ma quando ha accettato di farlo – anche a causa dell’emergenza coronavirus – ha perso la metà dei deputati del suo partito. L’ex numero due di Blu e Bianco, Yair Lapid, è ora all’opposizione e ha più volte attaccato il nuovo governo affermando che gli israeliani “meritano di meglio”. L’attuale esecutivo sarà chiamato a far fronte alla crisi economica determinata dall’epidemia di coronavirus, che in Israele ha contagiato almeno 16.500 persone e ne ha uccise 268. |
| …o contro la magistratura? |
| Il processo contro Netanyahu, imputato per corruzione, si apre il prossimo 24 maggio. La Corte Suprema israeliana ha stabilito che ciò non gli impedisce legalmente di governare. Sebbene esista una legge che impedisce ai ministri israeliani di rimanere in carica se imputati, tale dispositivo non esiste nel caso del primo ministro. Netanyahu è inquisito per frode e corruzione in tre diversi procedimenti a suo carico. La prima udienza era prevista per il 17 marzo, ma è stata rinviata alla prossima settimana a causa dell’emergenza coronavirus. Il rischio di una condanna in tribunale non è cancellato, ma fortemente indebolito: in base all’accordo di governo infatti, il Likud – e nella fattispecie Netanyahu – può nominare tutti o buona parte dei rappresentanti della Commissione delle nomine giudiziarie. Questo fungerebbe da garanzia politica anche per il futuro, visto che nel maggio 2021 il mandato di Rivlin scadrà e non è impensabile ipotizzare che l’interesse di Netanyahu verta proprio sulla carica presidenziale. Benché rivesta un ruolo cerimoniale e simbolico, il presidente della Repubblica gode dell’immunità dai processi. |
| Pronti all’annessione? |
| Oltre a rispondere agli effetti della pandemia e allontanare dal premier dal lungo braccio della giustizia, il nuovo governo ha anche un terzo obiettivo immediato: l’annessione delle colonie e, successivamente, di migliaia di chilometri quadrati nella Valle del Giordano, il confine orientale della Cisgiordania, che dovrebbe un giorno costituire la base territoriale per un futuro stato palestinese. L’accordo di coalizione di Netanyahu con Gantz fissa al 1° luglio la data per iniziare il processo di annessione unilaterale delle colonie. Non è del tutto chiaro quante colonie il governo è intenzionato ad annettere. La Cisgiordania è sotto il controllo israeliano dalla guerra dei sei giorni del 1967, e sul suo territorio vivono oggi oltre 400.000 coloni israeliani in 128 insediamenti. Quello che è certo è che questi territori, illegali in base al diritto internazionale e il cui status giuridico è regolato dalle Convenzioni e dal diritto internazionali diventerebbero parte integrante di Israele e soggetti alle sue leggi. |
| Dagli Usa semaforo verde o giallo? |
| Il piano, uno dei cavalli di battaglia di Netanyahu, in linea con il ‘Piano di pace del Secolo’ presentato a fine gennaio da Donald Trump, contemplerebbe nel medio periodo – un’annessione unilaterale della Valle del Giordano da parte di Israele. Se l’Unione Europea ha già messo le mani avanti, indicando che un’azione simile “non è in linea con il diritto internazionale”, e che ci sarebbero delle “conseguenze sul piano diplomatico”, Egitto e Giordania hanno formalmente protestato contro un’azione che, di fatto, sancirebbe la fine della soluzione dei due Stati. In un’intervista a Der Spiegel, re Abdullah II di Giordania ha avvertito che se Israele procederà con il suo piano, entrerà in un conflitto politico e diplomatico con il regno e causerà “un terremoto politico” che potrebbe causare una nuova esplosione di violenza in tutta la regione. Ma inaspettatamente, un ritardo nei progetti di annessione di Tel Aviv potrebbe arrivare proprio da Washington: pochi giorni fa il segretario di Stato americano Mike Pompeo si è recato in visita in Israele e al termine dei colloqui con i vertici istituzionali ha usato parole caute per riferirsi alla questione. La cosa non è passata inosservata, e il New York Times ipotizza che il semaforo verde dell’amministrazione Trump potrebbe essere diventato giallo. Sulla questione pesano le incognite della scadenza elettorale di novembre negli Stati Uniti e il sostegno del presidente ad un’annessione de facto, a cui lo sfidante Joe Biden si è detto contrario, potrebbe non essere scontata. Già una volta, Washington aveva messo il freno a Netanyahu, quando a febbraio voleva procedere all’annessione della Valle del Giordano. Succederà di nuovo? |
| IL COMMENTO di Giuseppe Dentice, ISPI Associate Research Fellow “Il nuovo governo israeliano nasce tra poche luci e diverse ombre. La principale certezza è data dalla formazione di un esecutivo di emergenza nei primi sei mesi (ufficialmente mirati a combattere la questione Covid-19) e nei successivi 30 atti a portare stabilità ad un paese che per oltre 500 giorni non ha avuto un governo. Quindi, comunque vada, Israele avrà un governo. Tuttavia questo capitolo apre una sequela lunghissima di incognite legate alle iniziative dei singoli leader e alla loro capacità di agire effettivamente per il bene del paese. In sostanza sono in tanti, anche all’interno del Likud, a pensare che un esecutivo come questo, nato più da un compromesso che non da volontà politiche condivise, possa presto cadere dietro alla scelta di Netanyahu – che di fatto gestisce tutto l’iter, uscendo più rafforzato che mai rispetto a Gantz – di disattendere gli accordi e rimanere al potere anche oltre il 2021. Solo i dossier legati ai problemi processuali del premier uscente e alla possibile annessione della Cisgiordania tout-court (le colonie ebraiche e, soprattutto, l’area riguardante la Valle del Giordano, la quale potrebbe essere annessa non prima del voto americano di novembre) potrebbero effettivamente produrre un quadro completamente stravolto che, almeno ad oggi, non si intravede, facendo piuttosto presagire una sensazione di saldezza di Netanyahu come di rado avuta nel recente passato”. |

La pandemia dell’antisemitismo, le mutazioni dell’antisionismo
Gabriele Eschenazi Gariwo 12 maggio 2020
Cartelli con svastiche, accuse agli ebrei di essere i portatori del corona virus. L’estrema destra americana è scesa in piazza a fine aprile negli stati americani governati dai democratici per manifestare contro le restrizioni adottate per fermare la pandemia. E ancora una volta hanno trovato negli ebrei il loro principale bersaglio. È successo in Minnesota e in Illinois con attacchi frontali alla governatrice Gretchen Whitmar e al governatore J.B. Pritzker di origini ebraiche. Ma situazioni analoghe si sonno verificate anche in Wisconsin, Pennsylvania e Virginia.

Organizzazioni ebraiche come la JCPA (Jewish Council for Public Affairs) o l’Anti-Defamation League hanno subito fatto sentire la loro protesta, ma la prima reazione di Trump con uno dei suoi soliti tweet non è stata incoraggiante: “Questa è bravissima gente, ma sono arrabbiati. Li vedremo, gli parleremo, faremo un patto”. Poi a correggere il tiro ci ha pensato Elan Carr, inviato speciale del Dipartimento di Stato per la lotta all’antisemitismo: “Il mio ufficio sta rilevando nel mondo, soprattutto nei social media, uno tsunami di antisemitismo legato alla pandemia e alla crisi economica” ha detto.
Contro il virus delle teorie cospirative non è mai stato trovato un vero e proprio vaccino. E anche oggi al tempo del Covid-19 questo virus ha cominciato a diffondersi rimettendo nel mirino gli ebrei come da tradizione e non solo negli Usa. Ne parla il Centro Wiesenthal con un saggio specifico curato da Harold Brackman. Agli ebrei e Israele vengono attribuiti sia la colpa di aver creato il Covid-19, sia quella di volerlo sfruttare per propri fini o economici o politici. Le fonti delle accuse sono gli ambienti dell’estrema destra e del fanatismo islamico. Diversi sono gli episodi enumerati dal Centro Wiesenthal. Tra questi: l’Iran che accusa Usa e Israele di voler lanciare una guerra mondiale batteriologica, la tv irachena Al-Ayam che attribuisce ai Rothschild la responsabilità del virus così come lo sarebbero stati delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, il gruppo di ricerca Louis Farrakhan che ipotizza che Israele abbia inventato il virus per poi fare i soldi con il vaccino. Non mancano, come riporta la CNN, le inevitabili accuse a Soros lanciate da Michael Caputo, attuale portavoce del Dipartimento della Salute americano, che prima della sua nomina aveva affermato che l’agenda politica di Soros richiede una pandemia. Anche il professor Yehuda Bauer sulle colonne del quotidiano Haaretz ha lanciato l’allarme per un antisemitismo che si nutre sempre degli stessi stereotipi e fa l’esempio di Assad al-Azzouni, un noto scrittore giordano, secondo il quale il Corona virus può essere solo il prodotto dell’odio che gli ebrei spargono nel mondo e una ricompensa a Trump per aiutarlo a farsi rieleggere. Le calunnie antisemite non fanno alcuna differenza tra comunità ebraiche della diaspora e Stato d’Israele. In questo contesto antisemitismo, antisionismo e anti-israelianismo si sovrappongono e affondano le loro radici in un odio millenario mai sopito. Tuttavia nella vasta casistica del fenomeno dell’antisemitismo c’è chi fa dei netti distinguo tra l’odio verso l’ebreo e quello verso il sionista. La definizione di quest’ultimo termine si presta a diverse interpretazioni soprattutto se disgiunte dal suo autentico significato storico.
Per chiarire i termini della questione non rimane che analizzarla su due piani differenti: quello storico e quello legato invece all’attualità dello Stato d’Israele, vittima di una crisi politico-ideologica senza precedenti nella sua pur breve e intensa storia.
Sappiamo quanto sia ancora forte oggi in Europa la memoria della Shoah e quanto questa susciti sentimenti positivi e negativi nello stesso tempo e quanto spessa essa si leghi a Israele. Così se una svastica accompagna su un muro il termine Juden e invece in un altro il termine Israele non possiamo fare a meno di pensare che si tratti di manifestazioni di antisemitismo in entrambi i casi e che le radici di questi episodi siano di fatto le stesse: un odio profondo verso gli ebrei come individui e come comunità collettiva.
Per sfuggire a questo odio non sono bastate nella storia assimilazione, isolamento, emigrazione, integrazione. Poi alla fine del ‘900 in seno agli ebrei europei si è fatta strada l’idea di dare una definizione nazionale dell’ebraismo, che superasse la tradizione e la religione, collanti secolari dell’identità ebraica. Quest’idea ispirata anche dal Risorgimento Italiano prese il nome di sionismo e si concretizzò in un movimento politico sancito dal primo congresso sionista convocato a Basilea dal 29 al 31 agosto del 1897. Il progetto di uno Stato ebraico era la possibilità di offrire agli ebrei, religiosi e atei, un contesto nel quale poter essere padroni del proprio destino. Alla domanda sul significato del sionismo il filosofo Yeshayau Leibowitz soleva sempre rispondere: “Gli ebrei hanno costituito lo stato d’Israele perché stufi di essere governati da altri”. Questa legittima aspirazione nazionale, riconosciuta sul piano internazionale prima dalla Dichiarazione Balfour del 1917 e poi trent’anni dopo da una risoluzione dell’ONU, è diventata bersaglio di una nuova forma di antisemitismo: l’antisionismo, cioè la negazione al popolo ebraico del diritto di autodeterminarsi. E si è trattato di uno sviluppo simultaneo. Il “complotto sionista” è diventato sinonimo di “complotto giudaico”: uno Stato ebraico pensato non per autodeterminarsi, ma per governare il mondo come avevano raccontato nel 1903 I Protocolli dei Savi di Sion e successivamente anche Hitler nel Mein Kampf, che attribuì agli ebrei anche la colpa del bolscevismo.
Successivamente i regimi comunisti dell’Est europeo nel dopoguerra perseguitarono i propri cittadini ebrei accusandoli di sionismo per emarginarli non solo quando manifestavano la volontà di emigrare in Israele. Definire un ebreo sionista bastava per poterlo perseguitare pensando di neutralizzare così l’accusa di antisemitismo.
Ai denigratori del sionismo si aggiunse pure l’ONU, che pure aveva fatto nascere lo Stato d’Israele. Avvenne il 10 novembre 1975 con la risoluzione ONU che definì il sionismo «una forma di razzismo e di discriminazione razziale»: un tentativo per delegittimare lo stato d’Israele. Questa risoluzione fu poi ritirata nel 1991 prima della conferenza di Madrid sul Medio Oriente.
Antisionista per principio è stato a lungo anche il mondo cattolico, tanto che solo nel dicembre 1993 il Vaticano riconobbe lo Stato d’Israele.
Nel tempo, e oggi sempre di più, l’esercitazione del diritto di autodeterminazione è diventato la garanzia della continuità dell’esistenza ebraica. Oggi, infatti, nel mondo quasi il 50% degli ebrei, che si riconoscono come tali, risiede in Israele. Il suo sviluppo economico e demografico è stato tale che oggi pare davvero un’assurdità che esista ancora chi ne metta in dubbio l’esistenza. Come afferma lo storico ebreo francese Georges Bensoussan (Una città 11/2004): “Il sionismo è una rivoluzione intellettuale e chi afferma che lo Stato d’Israele, oggigiorno, nell’Europa democratica e dei diritti dell’uomo, non ha più alcuna giustificazione, non ha capito nulla del sionismo. Non è la Shoah l’origine della nascita dello Stato d’Israele. Anche senza Shoah oggi esisterebbe lo stato israeliano. Anche in questo caso si parte da un’idea falsa degli ebrei, considerati tali solo dal punto di vista strettamente religioso. Si continua a non rendersi conto che gli ebrei, oltre a essere una religione, sono anche un popolo”.
Gli antisionisti vedono nella nascita d’Israele una sorta di “peccato originale”, la causa prima del conflitto arabo/palestinese/israeliano. Questa è stata a lungo la posizione anche di tutto il mondo arabo, che a lungo ha considerato Israele, uno stato coloniale fondato da europei estranei al Medio Oriente. L’odio verso Israele e il sionismo è stato traslato nelle moschee e ha assunto connotati religiosi sempre più estremi. I trattati di pace con Egitto e Giordania e gli accordi di Oslo non hanno contribuito, come ci si sarebbe potuto aspettare, a cambiare presso le popolazioni arabe la percezione negativa di Israele, del sionismo e degli ebrei in generale fatte salve alcune eccezioni come, per esempio, il Marocco e gli Emirati Arabi.
Che gli antisionisti non siano semplicemente coloro che criticano la politica dei governi israeliani ha cercato di spiegarlo sul quotidiano Haaretz Dan Miron, professore emerito di letteratura ebraica all’Università di Gerusalemme. Secondo Miron negli Usa chi dichiarandosi antisionista si oppone solo alla politica dei governi israeliani è definito con disprezzo “rosa”. “Alla base dell’antisionismo intellettuale al quale mi riferisco c’è, molto semplicemente, la richiesta di annullare l’esistenza dello Stato d’Israele”, dice il professore, che approva senza riserve la decisione del Parlamento Francese. “Macron e anche altri parlamenti europei hanno capito che l’antisionismo per principio non è semplicemente anti-israelianismo, ma è una delle forme dell’antisemitismo contemporaneo”.
La presa di posizione francese mira a togliere terreno sotto i piedi del movimento BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) così come ha già fatto il parlamento tedesco e si è proposto di fare quello austriaco. I fautori del boicottaggio generalizzato d’Israele e dei suo cittadini non potranno più essere equiparati nei finanziamenti a organizzazioni no profit.
Se da una parte sembra inevitabile constatare che esista una sovrapposizione tra antisionismo e antisemitismo nell’opinione pubblica mondiale, dall’altra non si può ignorare come nello stesso mondo ebraico e israeliano il sionismo sia oggetto di negazione e strumentalizzazione. Ancora oggi i partiti religiosi ortodossi, Shas e Yaadut Hatorà, si considerano “non sionisti” così come ovviamente i partiti arabi uniti nella Reshimà Hameshutefet, orientata però ultimamente più verso la condivisione che non la contrapposizione. Di fatto oltre il 20% della Knesset (parlamento israeliano) è composto da non sionisti, da coloro cioè che non si riconoscono nel sionismo l’ideologia fondante dello Stato, che d’altra parte è fortemente strumentalizzata dal Likud e dalla galassia dei partiti di destra. Un esempio su tutti è la “Legge della Nazione”, che ribadisce l’esclusività ebraica nell’identità dello Stato d’Israele, peraltro già definita dalla Dichiarazione d’Indipendenza. Il testo di quest’ultima sancisce da una parte che “Lo Stato d’Israele sarà aperto all’immigrazione di ebrei da tutti i Paesi della loro dispersione” e dall’altra che “Lo Stato promuoverà lo sviluppo del Paese per il bene di tutti i suoi abitanti; si baserà sui precetti della libertà, della giustizia e della pace insegnata dal Profeti ebraici; rispetterà la piena uguaglianza sociale e politica di tutti i suoi cittadini, senza distinzione di razza, credo o sesso”. Uno Stato ebraico e democratico come ha sempre cercato di essere dalla sua fondazione. Ma oggi sembra che “ebraico e democratico” siano due definizioni sempre più difficili da tenere insieme tanto che invece di essere complementari stanno diventando sempre più alternative – e questo lo si deve soprattutto alla persistente occupazione dei territori conquistati dall’esercito israeliano nel 1967 e dove vivono tre milioni di palestinesi e 700mila ebrei israeliani. La soluzione due Stati per due popoli, oggi lontana, prevede uno Stato ebraico e uno Stato palestinese, ma se lo Stato diventasse definitivamente unico non potrebbe che essere democratico ed ebraico/palestinese. Il disegno del sionismo originario sarebbe stravolto e a condurre a questo risultato sarebbe proprio la destra nazionalista israeliana. Oggi dunque essere sionista o filosionista significa sempre più schierarsi contro la politica di Netanyahu e contro l’annessione dei territori, che potrebbe a breve diventare in parte realtà con l’appoggio di Donald Trump e del nuovo alleato Benny Ganz.
Schierarsi contro il populismo e il nazionalismo israeliano non significa essere antisionisti né tanto meno antisemiti, ma esattamente il contrario. E non è un caso che la destra nazionalista israeliana con Netanyahu in prima fila abbia interesse a definire antisemita chiunque critichi la loro ideologia e contemporaneamente chiuda gli occhi di fronte al risorgente antisemitismo di regimi populisti come quello di Viktor Orban in Ungheria o Jair Bolsonaro in Brasile.
Essere filoisraeliani e antisemiti nello stesso tempo è la loro paradossale strategia. E ad assecondarla c’è proprio Netanyahu anch’esso populista e nemico del sistema democratico.
Eppure se c’è una strategia perdente per il popolo ebraico è proprio quella di allontanarsi dall’idea che l’antisemitismo potrà essere limitato solo da chi rimane fedele ai valori democratici universali che difendono la libertà e l’identità di tutti allo stesso modo.
Analisi di Gabriele Eschenazi, giornalista

David Grossman: “Non scrivo più da maschio” La lezione di un grande autore: “Soltanto l’empatia può salvarci”
Wlodek Goldkorn 25 Ottobre 2019 Repubblica
È come se fossi incinto: una sensazione di felicità che si ha quando ci si accorge che una nuova vita alberga in te e che questa vita sta per venire al mondo”. David Grossman inizia così, con una confessione al femminile, questa conversazione: per dire di essere pronto a scrivere un nuovo libro. E forse non è un caso. Intanto, perché nei romanzi dello scrittore israeliano le donne hanno un ruolo chiave. Sono madri che rifiutano la notizia della morte del figlio militare (A un cerbiatto somiglia il mio amore), cercano addirittura di cambiare il passato (Che tu sia per per me il coltello), riescono a riportare l’amore nel cuore di un uomo che del rancore ha fatto la ragione della sua vita (Applausi a scena vuota). A tutto questo torneremo nel corso di questa intervista, concessa in occasione dell’uscita in Italia (con Mondadori) di La vita gioca con me. Un libro, tradotto da Alessandra Shomroni, che racconta tre generazioni di donne: una nonna, una figlia, una nipote. Ma poi, parlare con la voce femminile riflette l’immaginario e i sogni degli israeliani oggi. Grossman, nato a Gerusalemme nel 1954, sei anni dopo la fondazione dello Stato degli ebrei quindi, è come una specie di barometro che indica il tempo e la qualità dell’aria che si respira. Guardandolo dritto negli occhi (che con molta rapidità alternano espressioni di gioia con altre di una profonda tristezza, ma prevale la gioia), ma anche leggendo i suoi romanzi e libri per bambini, si percepiscono i desideri nascosti, le paure non dette, l’inconscio collettivo di Israele. Oggi fra Tel Aviv e Gerusalemme c’è un’atmosfera di grande incertezza: dopo due elezioni politiche in pochi mesi non si riesce a costituire un governo, mentre l’intera regione attorno sta diventando un luogo più pericoloso che mai, tra guerre vere e minacciate.

Così si assiste a una specie di ritorno o forse al bisogno di recuperare gli inizi della saga di un Paese. Una saga dove si mescolano il racconto della volontà dei pionieri, forti e sicuri di sé, con la narrazione dei sopravvissuti alla Shoah, timorosi perfino di sognare perché la notte portava indicibili incubi. In questa riscoperta delle fonti, mitiche e mitologiche, le donne hanno un ruolo centrale. Sono forti, talvolta soldatesse, ragazze che parlano e ridono a voce alta, non sempre hanno i bisogni dei maschi, e quando occorre, sparano. Si sente perfino la nostalgia di Golda Meir, a capo del governo nei primi Settanta, per anni considerata un pessimo politico e oggi rivalutata, se non nella storiografia, nei sentimenti della gente. In questo ritorno alle origini c’è anche l’immagine delle donne distrutte nel corpo e anima nella catastrofe europea e che una volta approdate qui, hanno tentato una guarigione. Ecco, le tre donne dell’ultimo romanzo di David Grossman sono forti, seppure siano reduci di esperienze estreme in Europa. Hanno sfiorato, direttamente o attraverso il racconto famigliare, la morte, conosciuto il sapore del tradimento e dell’abbandono. Ma alla fine vince la vita. La vicenda si basa su una storia vera. La nonna di La vita gioca con me è stata partigiana con Tito in Jugoslavia, poi prigioniera a Goli Otok, un’isola che fu una specie di gulag nell’Adriatico, infine membro di un kibbutz in Galilea e militante di Donne in nero, un movimento di israeliane e palestinesi che si oppongono all’occupazione. Ed è anche una donna che dopo aver perso la famiglia nella tragedia del Vecchio Continente, nel kibbutz ne crea un’altra e ne diventa il capo, matriarca indiscussa e leader inflessibile.
Lei, Grossman, è entrato nei panni femminili. Racconta i sentimenti più intimi di tre donne. Non ha avuto paura?
“Scrivere come se fossi tre donne, una 90enne, una 65enne e la terza 40enne è stata una sfida. Uno degli sforzi più grandi era introiettare il linguaggio di ciascuna delle tre. E non solo la lingua ma le loro emozioni. Ho voluto fare l’esperimento di far vivere dentro di me donne sofisticate, forti, intelligenti. Io scrivo perché voglio dare la voce a qualcosa dentro di me che non riesco a esprimere in nessun altro modo. Dentro ognuno di noi ci sono tante opzioni che non mettiamo in atto nella nostra vita quotidiana. Potrei forse da un giorno all’altro cominciare a comportarmi da donna? Penso di no. Mi guarderebbero male. E poi sono convinto che ognuno di noi porti dentro tante identità per così dire pietrificate, congelate. Talvolta più che uno scrittore mi sento un massaggiatore. Massaggio e accarezzo certe parti per scongelarle”.
Diciamolo, lei è un maestro di empatia. Tanto che anche quando parla di sé lo fa attraverso i protagonisti dei suoi romanzi. Lei abita davvero i corpi e le anime delle persone cui dà la voce e immagine. Ma poi queste persone del tutto inventate quella voce gliela restituiscono, come se fosse vera. Già in “A un cerbiatto somiglia il mio amore” lei entra nella testa e nella pancia di Ora, una donna ribelle, che rifiutando una notizia cerca di rifiutare il linguaggio e il sistema.
“Ci ho messo due anni e mezzo per capirla. Non riuscivo a raccontarla. Poi, all’improvviso ho compreso. Il mio errore era un errore da maschio, volevo che Ora si concedesse a me. E invece dovevo essere io ad aprirmi a lei. Il personaggio di Ora ha qualcosa di unico. Non è classificabile. In una società polarizzata come è quella israeliana, lei è una donna che talvolta parla come se fosse di destra, altre come una militante della sinistra. Forse questa capacità di vivere la contraddizione nella propria carne è una caratteristica femminile. Non saprei”.
Lo è. E infatti lei è così bravo a vivere nei personaggi che inventa e crea, perché è conscio come pochi altri che il mondo non è bianco o nero. Ma vorrei insistere. In fondo, da maschio, non ha paura di questa intimità femminile?
“Paura? No. Guardi, in tutti gli ambiti della vita si può essere un po’ codardi, ad eccezione della letteratura. Se sei vigliacco non sarai mai capace di scoprire qualcosa di nuovo, di darti a qualcosa o qualcuno che non conosci ancora, o diventare appunto persona di un genere diverso del tuo. Faccio un esempio: Nina”.
Aiutiamo i lettori. Nina è la figlia di Vera, la nonna di “La vita gioca con me”. Vera l’ha abbandonata quando era bambina, per restare fedele alla memoria del marito accusato, sempre in Jugoslavia, di essere un traditore. Vera è una donna che ha scelto di andare in prigione, di finire ai lavori forzati, incurante delle conseguenze sulla figlia. E così Nina, traumatizzata, una volta diventata adulta non riesce a trovare da nessuna parte un suo posto. E finisce per fuggire verso l’estremo Nord dell’Europa.
“Finisce oltre il circolo polare, a Svalbard, il luogo più estremo sulla faccia della Terra. Ci sono andato due volte. Ero in un paesino abitato da duemila persone e, attorno, tremila orsi polari affamati, che qualche volta attaccano gli umani, per cui per strada devi camminare armato o accompagnato da qualcuno con il fucile. Una notte, ho camminato solo e disarmato dal bar dove avevo cercato la compagnia di qualche persona fino alla pensione dove abitavo. Volevo sentire la paura. Volevo provare le emozioni di Nina. E giuro, ho avvertito gli artigli dell’orso sulla mia schiena, nella mia carne. Lei mi ha chiesto se ho mai temuto a causa delle cose che racconto: non mi è concesso aver paura, anche perché parlo di donne in rivolta e che si rifiutano di dare allo Stato il diritto di gestire la morte dei loro cari”.
Viene in mente la vicenda di suo figlio Uri, morto da soldato nella guerra in Libano nel 2006.
“Sì, sono un padre che ha perso il figlio. E da quel giorno, il mio cognome è lutto (lo scrittore usa il termine ebraico riservato ai genitori che hanno perso figli, shkol, ndr), ma dentro quel cognome “shkol”, congelato, generico, quasi da cliché, posso rivendicare il mio diritto a un nome che non sia il cognome. Posso muovermi liberamente e non in ubbidienza alle definizioni che mi dà il governo, il lessico militare, l’esercito. Io posso continuare a scrivere le mie storie”.
Lei come le donne dei suoi romanzi si rifiuta di essere una vittima ma rivendica allo stesso tempo il diritto al dolore. Dice, nella vita e nei libri, che il lutto non esclude il desiderio.
“In questo romanzo racconto le protagoniste che si rifiutano di essere vittime e che cercano di guarire la ferita che passa di generazione in generazione. E forse alla fine sono capaci di provare un sentimento che assomiglia al perdono e alla pietas. Smettono di incolpare l’una l’altra”.
Questo nel romanzo. E nella vita vera?
“Sono sempre stato affascinato dalla questione di colpevolezza. Per me la scrittura è un modo per capire una colpa primaria, una colpa di cui qualche volta ero complice”.
Sta dicendo una cosa che aveva intuito Primo Levi, la vergogna è anche quella del testimone.
“La colpa e la vergogna del testimone non è la stessa del carnefice. Però spesso siamo colpevoli perché non abbiamo impedito che qualcosa succedesse, anche se potevamo farlo. In Applausi a scena vuota c’è la storia di Dovale e di come il suo amico ha girato lo sguardo altrove, mentre a lui stava succedendo una cosa terribile. Così, noi qui in Israele. Io vivo in un luogo dove da 52 anni c’è l’occupazione e uno dei sintomi della malattia di cui soffriamo è che ci siamo abituati a girare lo sguardo altrove. Dobbiamo invece costringerci a guardare. Aggiungo un’altra cosa riguardo al ruolo del testimone. Io, nella vita, cerco un testimone empatico e penso che ognuno abbia il diritto a un testimone appunto che lo guardi con benevolenza”.
La benevolenza può guarire la ferita?
“Sotto la cicatrice la ferita resta. Ma parlando – e questo fanno le donne, in fattispecie quelle che io racconto – la carne sotto la cicatrice si fa più flessibile, meno rigida”.
Un’altra donna che lei racconta è Miriam del “Che tu sia per me il coltello”. Il titolo richiama le lettere che Franz Kafka ha scritto a Milena Jesenska. Miriam si mette nei panni di Milena e dice: “Fossi in lei, sarei andata a casa di Franz, lo avrei costretto a guardarmi dritto negli occhi”. Sembra che Miriam voglia cambiare perfino il passato. È una follia la sua, una volta si sarebbe detto una follia tutta femminile. Per noi maschi il passato è passato, si va oltre. Miriam invece pensa di riaprire il rapporto fra Milena e Franz. Ma leggendo quelle righe, ho pensato che in fondo quella è anche una sua follia, Grossman.
“Forse sì (ride)”.
Per lei cosa sono le donne nella vita, non nei romanzi?
“Posso dire che ho imparato molto dalle donne, dalle amiche, e tantissimo da mia moglie. I miei due grandi amici sono maschi, ma vedere il mondo solo con gli occhi del genere cui appartengo è limitativo e stupido. Non tutte le donne sono coraggiose e ricche d’animo. Ma io ho avuto la fortuna di aver incontrato nella vita donne sensibili, sagge, dotate di senso critico che mi hanno insegnato cose su me stesso. Grazie a loro capisco di più chi sono. Le mie lettrici migliori sono donne. E poi, le donne hanno il coraggio di esporsi al testo, anche a un testo estremo. I maschi invece vogliono solo vincere, o superare se stessi: e del resto in ebraico vincere, superare se stessi e maschio sono parole che hanno la medesima radice”.
Ancora una domanda. La nipote della Vera del romanzo è cineasta. Ma alla fine (e non facciamo spoiler) lei suggerisce che la parola è più importante dell’immagine, che in fondo la parola resta, l’immagine invece è provvisoria e volatile.
“Ne sono convinto. Ma vorrei aggiungere poche frasi su come è nato il libro”.
Prego.
“Un giorno, mi chiamò al telefono Eva Nahir-Panic, questo è il vero nome di Vera, per criticare un mio articolo che secondo lei non era sufficientemente duro con i coloni nei Territori occupati. E cominciò a raccontarmi la sua vita. La sua storia era quella di una ragazza ebrea borghese in Jugoslavia, che sposò un ufficiale serbo di origini contadine e si unì assieme al marito ai partigiani. Ma poi il suo uomo venne arrestato e morì in una prigione di Tito e lei finì ai lavori forzati a Goli Otok. Ogni settimana mi chiamava. Mi chiedeva se avrei scritto la sua storia. Dicevo che forse sì, ma che la sua storia sarebbe dovuta passare per il filtro della mia immaginazione. Un giorno sono andato a trovarla nel suo kibbutz. Lei raccontava e io, per una notte, un giorno e una notte ancora, scrivevo su un quaderno con la penna. Mi ha regalato la sua storia perché sapeva che avrei ascoltato anche quello che lei non ha detto. È morta quando aveva 97 anni. E mi manca”.
Wlodek Goldkorn

La sinistra italiana e gli ebrei. Ma anche gli altri
David Bidussa commenta il libro di Alessandra Tarquini la sinistra Italiana e gli ebrei , 21 marzo 2020 Gli Stati Generali
La conclusione di Alessandra Tarquini nel suo libro su sinistra italiana e gli ebrei (il Mulino) consiste nel fatto che gran parte della sinistra quando si è confrontata con la propria memoria, ma anche si potrebbe dire con le linee essenziali e storiche della costruzione della propria identità politica e culturale, si è spesso preoccupata e confrontata con il timore del venir meno dell’antifascismo “senza chiedersi come mai la cultura della quale sono espressione ha fatto così fatica a occuparsi degli ebrei” [p.286].

È una domanda corretta e, a mio avviso, centrata. Se ne potrebbe fare anche un’altra (che non smentisce questa, ma che forse aiuta comprendere un processo, tanto da contribuire a rafforzarla) ma lo accennerò solo in conclusione. Prima vale la pena raccontare il libro di Alessandra Tarquini.
Dunque, il tema è proporre un lungo excursus che parte con le premesse della nascista culturale della sinistra in Europa intorno alla Rivoluzione francese e poi ai molti nodi irrisolti della costruzione del pensiero socialista(Marx, ma soprattutto Blanqui, Toussenel, Proudhon, senza tralasciare i riformisti come Malon, una figura che ha un peso consistente nella costruzione culturale del socialismo italiano negli anni tra Comune di Parigi e fondazione del PSI – o gli operaisti come Guesde, una ricca famiglia di ritratti dove il linguaggio antisemita è spesso più forte tra i riformisti che non tra i rivoluzionari) per attraversare il profilo culturale delle molte famiglie politiche della sinistra in Italia più o meno dagli anni della fondazione del Psi (1892) fino al suo scioglimento e, in contemporanea, l’autoscioglimento del Pci per avviare la nuova avventura del PDS.
In quell’excursus la sensibilità (politica, culturale, emozionale, per certi aspetti anche genericamente umana) dimostrata dalle molte famiglie della sinistra in Italia prima alle condizioni delle diverse minoranze ebraiche in Europa è alquanto scarsa.
Prima è un discorso tra dispotismo e democrazia, per cui nella riflessione socialista la questione dell’antisemitismo è il marchio dei sistemi non democratici (Russia zarista in testa) anche se l’Affaire Dreyfus segna un campanello d’allarme sulla permeabilità traversale dell’antisemitismo disegnando schieramenti traversali tra destre e sinistre in cui l’elemento della “Nazione” ha un ruolo non indifferente (è un elemento che sistematicamente tornerà in tutte le svolte culturali delle sinistre quando manifestano il proprio antisemitismo ed è il punto di incontro di tutte le parabole culturali e politiche – individuali e di gruppo – che da sinistra vanno verso destra nel corso del ‘900).
L’antisemitismo dunque per il movimento socialista (non solo in Italia, ma più generalmente nel linguaggio della II Internazionale) è un fenomeno che riguarda solo i propri avversari, non il proprio campo (nelle culture, ma anche nelle emozioni; per esempio questo è un aspetto che sarebbe utile scavare per capire come si forma il linguaggio anche antisemita della sinistra inglese, per molti aspetti diverso, ma non opposto a quello del conservatorismo inglese).
Questo tratto si conferma non solo negli anni tra le due guerre, ma anche nella lunga stagione del dopoguerra (la parte più consistente della monografia di Tarquini è concentrata sul secondo dopoguerra).
In quel secondo dopoguerra Tarquini individua varie stagioni ma anche non si limita a una sola agenzia, ma tiene conto di uno spettro ampio di figure, di gruppi dirigenti politici: dai socialdemocratici di Saragat, alle molte anime del Psi, ai comunisti, alla nuova sinistra. E inoltre non solo i partiti, ma anche i gruppi intellettuali o le riviste che hanno definito l’identità culturale delle sinistre italiane nel secondo dopoguerra (“Rinascita”, “Mondoperaio”, “Nuovi Argomenti”, “Il Ponte”, “Astroloabio”, “Tempo presente”; “il Manifesto” (in questa unga scorribanda non sarebbe stato improprio, mi sembra di non averla mai incontrata, anche un breve cenno intravedere cosa accada quando compare una rivista come “MicroMega” o con gli effetti di una riflessione anche sulla questione dell’antisemitismo una volta che si apre il laboratorio della discussione sul dissenso all’Est negli anni ’80: penso per esempio auna rivista come “L’Ottavo giorno”, ma anche a cosa significa confrontarsi con le società civili dell’ex blocco sovietico, un tema che parla di oggi)).
In questo tratto due sono i temi della questione:
Il primo riguarda i temi del confronto e della riflessione del lascito culturale, politico, emozionale,..) dell’antisemitismo razzista del fascismo italiano (un tema che solo con gli anni’90 diventa una discussione sul paradigma culturale dell’identità italiana, e allora il tema da indagare è perché occorrano cinquant’anni per aprire un serio ragionamento sulle culture del razzismo italiano che, è bene ricordare, non significano solo antisemitismo) e, insieme, quelli dell’analisi di ciò che era entrato – e spesso non era entrato nella cultura fondativa dell’esperienza dell’antifascismo italiano, sostanzialmente poco sensibile al tema dell’antisemitismo).
Il secondo riguarda come la sinistra italiana a partire già dall’immediato dopoguerra riflette intorno al processo della nascita dello Stato di Israele e, più in generale, che immagine ha della questione israelo-palestinese (sullo sfondo si potrebbe anche dire che immagine ha della questione mediorientale più in generale).
Il primo riguarda come lentamente le culture sociali e politiche dell’antifascismo nell’Italia repubblicana siano state capaci di mettersi in gioco di fronte al fenomeno e all’analisi dell’antisemitismo – non solo nel fascismo – ma anche in ciò che era rimasto “attaccato” alle loro culture. In questo senso si trattava di fare i conti non solo col proprio passato generico, ma con il proprio passato autobiografico (la storia di Franco Fortini è esemplare da molti punti di vista e su questo Tarquini giustamente insiste).
Contemporaneamente si trattava di riflettere sull’idea di Italia mediterranea – altro elemento che pesca nella cultura lunga italiana, almeno dal nazionalismo dei primi anni del ‘900 – e su un suo possibile ruolo nel momento della ridiscussione della geografia della “Guerra fredda” nel corso degli anni’80. Lì mi sembra risiedere una delle matrici del fascino che quell’«antico mito» gioca nella riflessione di Bettino Craxi, e su cui ci sarebbe da scavare per individuare un tratto culturale sottotraccia dell’identità della cultura del socialismo in Italia nel corso del’900.E parallelamente lì sta una delle idee di “politica regionale” che muovono la riflessione politica negli anni del Pci di Enrico Berlinguer e poi nel Pds di Massimo d’Alema. Ma anche si potrebbe osservare nello scarso peso che ha la cultura – economica, politica, sociale- di pensare Europa a partire dagli anni ’70 in tutte le agenzie della sinistra (riformista, radicale, rivoluzionaria, “nuova”,….).
Un tratto che, significativamente romperanno solo alcune figure che hanno vissuto da marginali o da “esuli in patria” la riflessione per un rinnovamento del paradigma culturale della sinistra almeno dalla fine del “mito dell’Urss” o meglio che non hanno mai avuto il mito dell’Urss che hanno dovuto conviverci con estrema difficoltà
Ma anche riguarda una cultura del terzomondismo italiano, in cui ritorna un elemento di fascino del “primitivo” dell’antindustriale, di una visione eroicizzata del primitivo, nei cui confronti Furio Jesi già negli anni’70 metteva in guardia senza successo, né allora, né ora. Quel paradigma è ancora molto forte nella cultura e nel linguaggio di noi italiani (di sinistra, e di destra).
Gran parte del fascino – e qui mi immetto nel secondo tema della questione – che le sinistre italiane (spesso con un linguaggio non molto diverse da quello delle destre nazionaliste e rifondative dell’idea di Europa che guardano con entusiasmo al codice culturale dell’Italia degli anni ’10 del Novecento) hanno nei confronti della realtà politica, culturale, dei palestinesi e dei movimenti ha la sua origine nell’anti-industrialismo e, ancora di più, nel proprio antiamericanismo. Ma anche in quella cultura orientalista avrebbe detto Said, che nasce laddove proprio costruisce un paradigma vittimario di e steso e allo stesso tempo ha bisogno di santificare vittime per ché ha una visione della politica manichea, fondata sull’ansia di individuare il “portatore di bene”, di solito identificato con l’aver “subito la storia “ (in questo dimenticando che nella storia ciascuno ha una parte di responsabilità nella propria condizione, compresa la condizione di sconfitto, e che una possibilità di riscatto sta nell’affrontare preliminarmente le proprie responsabilità).
Tarquini ha il merito in questo libro sia di tener distinti questi due piani, sia di farli interagire, non confondendo, i piani di analisi.
Non è poco. Un’ultima questione che forse come scrivevo all’inizio che non smentisce l’impianto del libro, ma che forse aiuta comprendere un processo, tanto da contribuire a rafforzarlo.
Nella storia della cultura politica in Italia – lungo tutto l’arco dello schieramento politico e delle aree culturali – un peso rilevante lo ha la cultura della Chiesa.
Sul tema in questione quella cultura non è stata assente, anzi è stata molto spesso determinate e lo è stata, significativamente, nelle culture che nel secondo dopoguerra si sono confrontate con la questione medio-orientale a partire dal destino dei «luoghi Santi» perché in gioco, in chi detiene quei luoghi sta, anche, un segmento rilevante della propria identità, prima ancora che un segmento rilevante della propria storia.
Il linguaggio della Chiesa in Italia non ha avuto un peso rilevante solo nelle realtà dell’associazionismo cattolico direttamente espressione della Chiesa, ma lo ha avuto nella formazione dei quadri dirigenti di tutte le formazioni politiche italiane (nuova sinistra e nuova destra incluse) lo ha avuto nella formazione di ciò che si chiama rapporto tra “primo mondo” e “Terzo (o quarto) Mondo” nel secondo dopoguerra.
E lo ha avuto nel modo in cui si è discusso (più spesso non discusso) di antisemitismo.
Mi piacerebbe, un giorno, con la stessa acribia, trovarmi tra le mani un libro che provasse a connettere queste diverse storie in una storia che per molti aspetti non può non essere raccontata che “tutta intera “ e “a parte intera”
Alessandra Tarquini ci ha messo un pezzo. Non è poco. È importante. È anche importante, senza pretendere che ce lo consegni Alessandra Tarquini, sapere che cosa manca.
David Bidussa

Antisionismo, una versione dell’antisemitismo
Michael Walzer da Vita e Pensiero 1-2020
(grazie a Giorgio Gomel della segnalazione)
Storicamente l’antisionismo si è manifestato all’interno dello stesso ebraismo, con le sue numerose varianti. Da tempo però coinvolge il mondo della sinistra, in Europa e negli Stati Uniti. Un antisionismo pericoloso come quello di destra
In un certo numero di campus universitari e in vasti settori della sinistra, l’antisionismo è una politica oggi di moda. Le organizzazioni ebraiche e di gran parte degli ebrei che conosco concordano nel dire che si tratta della versione più recente dell’antisemitismo.
Ma l’antisionismo è un problema a sé,e possiede molteplici varianti.Nelle pagine che seguono mi piacerebbe esplorare la sua variante antisemita. Ritengo che il “sionismo” rimandi all’idea dell’esistenza legittima di uno Stato ebraico, niente di più, e che l’antisionismo contesti tale legittimità. La mia preoccupazione, qui, concerne l’antisionismo di sinistra negli Stati Uniti e in Europa.
L’antisionismo ebraico
La maggior parte delle varianti dell’antisionismo si è dapprima manifestata fra gli stessi ebrei.La variante probabilmente più antica vede nel sionismo un’eresia ebraica.Secondo la dottrina ortodossa, il ritorno degli ebrei a Sion e la creazione di uno Stato sono opera del Messia e avranno luogo nei tempi a venire. Nell’attesa, agli ebrei viene ingiunto di accettare l’esilio, di obbedire ai governanti dei gentili e di attendere la liberazione divina. Ogni azione politica mirante ad affrettare il suo avvento è considerata un’usurpazione delle prerogative di Dio. Gli autori sionisti si opponevano alla passività prodotta da questa dottrina con tale passione che gli ebrei ortodossi li bollavano come antisemiti, benché essi non avessero mai chiamato così il proprio rifiuto del progetto sionista.
Attendere il Messia ha la sua versione di sinistra che potremmo chiamare attendere la Rivoluzione. Si è spesso detto agli ebrei (e alle altre minoranze) che tutti i loro problemi si sarebbero risolti solo con il trionfo del proletariato; molti ebrei hanno visto in una simile posizione una manifestazione di ostilità, un rifiuto di riconoscere l’urgenza della situazione in cui si trovavano. Da parte mia, non la ritengo tanto l’espressione di un antisemitismo, quanto una forma di rigidità ideologica e un’assenza di sensibilità morale.
La seconda versione ebraica dell’antisionismo è nata nella Germania del XIX secolo, tra i fondatori dell’ebraismo riformato. Non esiste un popolo ebraico, dicevano, esiste soltanto una comunità di fede – uomini e donne di obbedienza mosaica. Gli ebrei potevano essere buoni tedeschi (o buoni cittadini di un qualunque Stato), perché non erano una nazione come le altre e non aspiravano a fondare un proprio Stato.
Il sionismo era avvertito come una minaccia da parte dei buoni tedeschi perché suggeriva che gli ebrei fossero fedeli a un’altra alleanza.
Questo ha permesso da allora in poi a una corrente importante della sinistra di affermare che uno Stato ebraico è necessariamente uno Stato religioso, paragonabile a uno Stato cattolico, luterano o musulmano; in altri termini: una formazione politica inaccettabile per la sinistra. Tale posizione venne adottata dagli ebrei riformati, seppur consapevoli che gran parte dei loro correligionari non la condivideva.
Se la nazione è davvero un plebiscito giornaliero, come ha scritto Ernest Renan, possiamo dire che gli ebrei dell’Europa dell’Est, in grande maggioranza, votavano quotidianamente per il popolo ebraico. Non tutti erano in cerca di una patria in terra d’Israele, ma gli stessi membri del Bund, che speravano nell’autonomia degli ebrei nell’impero zarista, erano dei nazionalisti ebrei.
I primi riformatori volevano cambiare il corso e la natura della storia ebraica, ma non ignoravano la propria storia. Non vale lo stesso per i gauchisti, che si oppongono all’esistenza del popolo ebraico ma sono in gran parte ignoranti. Non sono vittime di ciò che i teologi cattolici chiamano «l’invincibile ignoranza»: in realtà quel che non sanno non vogliono saperlo; è questo che dovrebbe inquietarci.
Se cercassero di interessarsene, potrebbero istruirsi sulle ragioni dell’intreccio radicale tra religione e nazione nella storia ebraica. Non
si può separare la religione dal politico; se non possedete uno Stato non potete costruire un muro fra la Chiesa – o la Sinagoga – e lo Stato.
Fin dalle sue origini, il sionismo si è sforzato di mettere in moto il processo per districare quell’intreccio ed edificare uno Stato dove in cui prevalesse la laicità. Lo Stato di Israele ha oggi i suoi fanatici che contrastano tale sforzo, così come vi sono nazionalisti indù e zeloti musulmani che si oppongono ad analoghi sforzi nei propri Stati.
Affinché la sinistra, come potremmo attenderci, difenda ovunque la laicità, bisognerebbe che essa prendesse in considerazione il valore del progetto sionista originario.
Non direi che il pigro preconcetto secondo il quale l’ebraicità è un’identità puramente religiosa rientri nell’antisemitismo. Ma il rifiuto di riconoscere che un gran numero di ebrei, identificati in quanto tali, non sono religiosi, è un po’ strano. Non diciamo che sono “ebrei non praticanti” (come di un cattolico non religioso diremmo che non è praticante); sono semplicemente ebrei. Questo postulato secondo il quale non ci sarebbe un popolo ebraico che includa a un tempo i fedeli e i non-fedeli deve ben avere una ragion d’essere. Esso consente ai gauchisti, che hanno sostenuto tanti movimenti di liberazione nazionale, di affermare che il sionismo non è paragonabile poiché non esiste una nazione ebraica. È un argomento comodo, ma questa caratteristica non è un valido motivo per avanzarlo.
La terza versione dell’antisionismo ebraico è al tempo stesso politica e religiosa. L’argomento religioso serve anche a spiegare il lungo periodo di diaspora. Secondo i suoi difensori, gli ebrei sono troppo buoni per la forma Stato. Una politica di sovranità esige una fermezza e una brutalità che s’intona meglio alle nazioni dei gentili. Segnati dall’alleanza del Sinai e da una lunga storia di spoliazione e di persecuzione, gli ebrei non possono, e non dovrebbero, tentare di imitare i gentili. Questa dottrina può apparire fi losemita, con la differenza, rispetto ad altre, che non possiede alcun fondamento empirico. Anche prima del 1948, gli ebrei sono sopravvissuti come nazione in ambienti per la maggioranza ostili utilizzando tutti i mezzi politici necessari, spesso con un’arte degna di nota.
La versione politica di questo argomento antisionista non è affatto più convincente: essa afferma che gli anni in cui sono stati privi di uno Stato hanno fatto degli ebrei i primi cosmopoliti. Gli ebrei sono sì un popolo, ma un popolo post-westfaliano. In anticipo sul resto del mondo, hanno trasceso lo Stato-nazione. Il sionismo rappresenterebbe dunque una regressione rispetto all’universalismo della diaspora.
La realizzazione sionista, lo Stato d’Israele, è una confutazione definitiva di questa definizione del popolo ebraico. Essa mostra che, se anche il cosmopolitismo è il programma di alcuni ebrei, non definisce tutti gli ebrei. Del resto, perché il cosmopolitismo dovrebbe essere un programma in primo luogo o soltanto per gli ebrei? Anche se certi ebrei si augurano di essere cosmopoliti, di rappresentare la luce delle nazioni o viceversa una luce contro le nazioni, perché tante persone di sinistra, non-ebree, non assumono il ruolo che riservano agli ebrei?
Conosco candidati migliori per una politica post-westfaliana. Che i francesi superino lo Stato-nazione! Sono loro, dopo tutto, a essere all’origine di questo intero affare, con la leva in massa del 1793, La marsigliese, il primo inno nazionale, la bandiera tricolore, la prima bandiera nazionale, e tutti i sermoni rivoluzionari. O i tedeschi, i danesi, i polacchi, i cinesi…
L’odio per lo Stato-nazione
Ed è questo il punto cruciale. La forma di sinistra più comune dell’antisionismo nasce, dicono i suoi difensori, dall’opposizione al nazionalismo e allo Stato-nazione. Questo fu, agli inizi della storia della sinistra, un argomento convincente e diffuso, sostenuto dagli ebrei stessi.
Rosa Luxemburg, ad esempio, parla con eguale disprezzo dei polacchi,degli ucraini, dei cechi, degli ebrei e delle «nazioni e delle mininazioni si annunciano da ogni parte e affermano il loro diritto a costituire degli Stati. Cadaveri putrefatti escono da tombe centenarie, animate da un nuovo vigore primaverile, e popoli “senza storia” che non hanno mai costituito entità statali autonome avvertono il bisogno violento di erigersi in Stati» (Tra guerra e rivoluzione [1918], trad. it. Milano, Jaca Book, 2019). La sola cosa che ammiro nel disprezzo della Luxemburg è il suo universalismo. Ebbene, è proprio questo che manca nel gauchismo contemporaneo dove il disprezzo è ben più circoscritto.
L’argomento della Luxemburg può applicarsi a una gran quantità di situazioni. La seconda metà del XX secolo ha visto la caduta degli imperi britannico, francese, sovietico e la creazione di più Stati-nazione di quanti la storia ne avesse conosciuti fino ad allora.
Alcuni gauchisti sognavano di trasformare i vecchi imperi in nuove federazioni democratiche, ma la maggior parte di loro ha semplicemente
approvato le creazioni post-imperiali – nel caso sovietico senza dubbio con un po’ meno entusiasmo –, a eccezione di una sola. Pensate a tutte le opportunità mancate di opporsi allo Statonazione! Perché sostenere il nazionalismo vietnamita, ad esempio, quandola giusta posizione rispetto al Vietnam, al Laos e alla Cambogia (i tremembri dell’Indocina francese) sarebbe stata in tutta evidenza la creazionedi uno Stato multinazionale? Perché la sinistra non ha difeso l’idea di un’Algeria che, all’interno della Francia, avrebbe dato a tutti i cittadini i diritti proclamati dalla Rivoluzione francese? Non lo ha fatto, e ha sostenuto il Fronte di liberazione nazionale (Fln) che ha creato uno Stato-nazione e ha pietosamente fallito nel garantire quei diritti. Mi ricordo l’entusiasmo della gente di sinistra per la Birmania di U Nu – oggi Myanmar –, esempio paradigmatico dello scacco del nazionalismo. La Birmania avrebbe dovuto costituire una provincia dell’India e riunire i buddhisti, gli indù e i musulmani all’interno di un solo Stato, ma nessuno, a sinistra, ha patrocinato questa soluzione.
I britannici hanno amministrato il Sudan “anglo-egiziano” prima che fosse liberato dal giogo imperiale; i due Paesi africani avrebbero allora dovuto essere uniti all’interno di un unico Stato. Perché i gauchisti non si sono opposti alla liberazione del Sudan? O alla scissione fra l’Eritrea e l’Etiopia? Perché non si sono appellati alla formazione di un solo Stato baltico invece della triade nazionalista formata da Lituania, Estonia e Lettonia?
Potrei prolungare l’elenco delle mie domande, ma la risposta è sempre la stessa. In tutti i casi, i popoli hanno scelto lo Stato-nazione: era questa l’opzione democratica, anche se non ha sempre condotto alla democrazia. La sinistra aveva dunque ragione di sostenere i vietnamiti, gli algerini e tutti gli altri. Ma allora, perché non gli ebrei? E perché, adesso che lo Stato ebraico esiste e che assomiglia più o meno a tutti gli altri Stati, è il bersaglio di una così singolare variante del disprezzo luxemburghiano?
Governo e Stato: Israele ieri e oggi
Le risposte più comuni all’ultima domanda sono le seguenti. In primo luogo, la creazione dello Stato d’Israele ha richiesto lo spostamento di 700 mila palestinesi. Israele è uno Stato di “occupazione coloniale”– come pressappoco tutti gli Stati, se risaliamo sufficientemente lontano nel passato; ma lasciamo da parte questo ragionamento, la storia recente è più istruttiva. Non c’è stato spostamento di arabi palestinesi negli anni Venti e Trenta del Novecento: malgrado la colonizzazione sionista, la popolazione araba è aumentata grazie alla natalità ma anche grazie all’immigrazione, essenzialmente dalla Siria (nel 1922, il primo censimento britannico contava 660.267 arabi; erano 1.068.433 nel 1940). E neppure vi è stato spostamento durante la Seconda guerra mondiale, in un momento in cui l’immigrazione ebraica era menoforte. La creazione dello Stato di Israele è stata proclamata nel 1947dapprima dall’Onu, in seguito a Tel Aviv nel 1948, prima dell’inizio dello spostamento su grande scala: l’idea secondo cui lo Stato “richiedeva”uno spostamento non può dunque essere corretta. È l’invasione del nuovo Stato da parte di cinque eserciti arabi che ha costretto
alla fuga un gran numero di arabi palestinesi (gli ebrei non fuggivano,non avevano un luogo dove andare) da un lato, all’espulsione di molti altri abitanti (gli ebrei non sono stati espulsi perché gli eserciti arabi hanno perso la guerra) dall’altro. Il dibattito sul rapporto tra coloro che sono fuggiti e coloro che sono stati espulsi è ancora vivo; le cifre sono importanti in entrambi i casi. Resta il fatto che il dibattito non esisterebbe se la guerra non fosse avvenuta, e vi sarebbero ben pochi rifugiati oggi nei campi. La Nakba [l’esodo palestinese del 1948, NdR]è una tragedia provocata da due attori, da due movimenti politici, e dai soldati delle due parti.
Cosa ne è delle fughe e delle espulsioni che avvennero altrove – in
particolare nel corso della creazione degli Stati moderni turco o pakistano?
È curioso che gli autori di sinistra non contestino la legittimità di questi Stati, anche quando criticano, come è giusto, le politiche dei loro governi (si contesta spesso la potenza del whataboutism [neologismo inglese più o meno equivalente a ciò che in italiano viene indicato come “benaltrismo”, NdR], ma io penso che costituisca una critica potente della cecità di uomini e donne che si indignano degli eventi che avvengono qui, dovunque si collochi questo qui, ma non manifestano interesse particolare per analoghi eventi che avvengono altrove. Mi sembra che si debba insistere su questo fenomeno.
Il secondo elemento spesso invocato per giustificare l’antisionismo è questo: Israele opprime i palestinesi, in Israele e nella Cisgiordania occupata. Questo è vero e i miei amici sionisti, in Israele, si mobilitano da anni per l’uguaglianza di tutti nello Stato e contro l’occupazione e il trasferimento dei coloni. Ogni critica severa del governo attuale mi sembra giustificata, e più è severa meglio è. Elenco qui sotto ciò che mi sembra importante dire a questo proposito, perché voglio essere riconosciuto come un difensore del sionismo e non come l’apologeta di ciò che viene compiuto in Israele oggi, o di ciò che si è fatto ieri, in nome del sionismo (i difensori del nazionalismo palestinese avrebbero interesse a fornire un elenco analogo delle patologie della politica palestinese).
– Gli arabi israeliani, cittadini di Israele, devono far fronte a numerose discriminazioni nella vita quotidiana, in particolare nell’ambito dell’alloggio e delle richieste di finanziamento per l’educazione e le infrastrutture.
– Adottando la legge «Israele, Stato-nazione del popolo ebraico»(19 luglio 2018), la Knesset ha alzato il dito medio verso i suoi cittadini arabi.Benché la legge non abbia conseguenze legali, prefigura una cittadinanza di seconda classe.
– La Cisgiordania è il teatro di una colonizzazione invasiva, di un’appropriazione di terre e di sorgenti, e di un governo militare senza
legge.
– I coloni si comportano da delinquenti violenti nei riguardi dei palestinesi,
senza subire effettive sanzioni da parte della polizia o dell’esercito israeliano.
– Il governo attuale incoraggia l’ostilità nei confronti degli arabi e ne fa una regola di governo; ha di mira la creazione di un solo Stato dominato da quella che sarà ben presto una minoranza ebraica.
Potrei proseguire l’elenco, ma quello che ho scritto basta a far comprendere il mio pensiero: le critiche di questo tipo non hanno niente a che vedere con l’antisionismo o l’antisemitismo. Si tratta di politiche governative, e i governi non fanno altro che governare gli Stati, non li incarnano. I governi vanno e vengono – almeno è quel che speriamo – mentre gli Stati si iscrivono nella durata per proteggere la vita comune dei loro cittadini, degli uomini e delle donne. Di conseguenza, criticare il governo d’Israele non dovrebbe comportare un’opposizione alla sua esistenza. È stato necessario opporsi con fermezza alla brutalità dei francesi in Algeria, ma non ricordo nessuna voce che mettesse in discussione l’esistenza dello Stato francese. Il trattamento brutale dei musulmani nell’ovest della Cina invoca la stessa fermezza, ma nessuno chiede l’abolizione dello Stato cinese (anche se, in pratica se non in teoria, la Cina è uno Stato-nazione dell’etnia han).
Alcuni, a sinistra, affermano che i lunghi anni di occupazione e il nazionalismo di destra del governo Netanyahu rivelano l’“essenza stessa” dello Stato ebraico. Questo argomento dovrebbe suonare strano alle orecchie di tutte quelle persone di sinistra che hanno imparato, molto tempo fa, dalle autrici femministe in particolare, che bisogna rinunciare agli argomenti “essenzialisti”. La lunga storia dell’interventismo degli Stati Uniti in America Centrale rivela l’“essenza stessa” degli Stati Uniti? Forse sono gli oppositori all’intervento e all’occupazione a essere più “essenziali”. Comunque sia, uno Stato ha davvero un’“essenza”?
Oggi molti a sinistra approvano il nazionalismo palestinese senza preoccuparsi del suo carattere “essenziale” e senza riflettere sul programma dei nazionalismi che chiedono, spesso esplicitamente, il grande
tutto: «Dal fiume al mare». Vi sono oggi, al governo d’Israele, ebrei sionisti che chiedono il grande tutto con analogo fervore. La sinistra dovrebbe dunque opporsi a entrambe le rivendicazioni con la stessa determinazione. Quanti, a sinistra, reclamano “uno Stato”, con pari diritti per gli ebrei e i palestinesi, direbbero senza dubbio che fanno esattamente questo, perché il loro programma sembra tradurre un disprezzo fermo del nazionalismo e dello Stato-nazione – fermo, sì, ma applicato a un solo caso.
In realtà, “uno Stato” significa l’eliminazione di uno Stato: lo Stato ebraico esistente. In che modo i partigiani di “uno Stato” hanno in mente di realizzare questo programma? Qual è il loro piano per distruggere lo Stato ebraico e il movimento nazionale che gli ha dato nascita?
E come vedono la disfatta del nazionalismo palestinese? A cosa assomiglierebbe questo nuovo Stato? Chi deciderebbe le politiche d’immigrazione (è la questione che ha fatto fallire il bi-nazionalismo immediatamente prima e dopo la Seconda guerra mondiale)? Infine, ed è l’esito più probabile, cosa accadrebbe se il nuovo Stato somigliasse al Libano di oggi? La storia recente del Medio Oriente e quelle di Israele e della Palestina mostrano che la coesistenza pacifica è una pia illusione. Anzi, nemmeno un’illusione.
Se si vuole permettere ai due movimenti nazionali di ottenere (o di mantenere) la sovranità cui aspirano, è sicuramente opportuno aggiungere uno Stato piuttosto che sottrarne uno all’equazione. La soluzione dei due Stati è forse anch’essa un’illusione – esiste in effetti dai due lati uno schieramento significativo di forze che vi si oppongono – ma l’idea è più realistica. Sappiamo, infatti, come creare degli Stati-nazione; abbiamo una lunga esperienza in materia. Non sappiamo come creare la comunità politica ideale che i partigiani dello Stato unico dicono di desiderare, ma non vogliamo – e non dovremmo volere – il genere di Stato che essi creerebbero, se lo potessero.
Edificare Stati-nazione, questa è la politica che la sinistra ha difeso nel periodo post-coloniale. La Jugoslavia è l’eccezione degna di nota: la maggioranza delle persone di sinistra si sono opposte alla creazione di sette nuovi Stati-nazione, preferendo a essi il regime tirannico che li aveva un tempo mantenuti uniti. E questa è un’ulteriore incoerenza:
se l’alternativa alla liberazione nazionale è la tirannia, la sinistra dovrebbe optare, e in genere ha optato, per la liberazione. È la scelta giusta, perché sappiamo che le nazioni hanno bisogno di Stati, non fosse altro che per proteggerle dall’oppressione straniera. Ne è prova la storia degli ebrei, o degli armeni, dei curdi, dei kossovari e dei palestinesi. Le inchieste mostrano che, in ognuna di queste nazioni, larghe maggioranze desiderano uno Stato per se stesse. E se gli altri lo vogliono, perché non gli ebrei?
L’antisionismo è una cattiva politica
Perché non il sionismo? Perché gli ebrei non sono un popolo; perché dovrebbero essere più cosmopoliti degli altri; perché lo Stato sionista ha avuto la sua quota di cattivi governi; perché nessuno dovrebbe avere uno Stato (anche se, in pratica, quasi tutti ne possiedono uno).
Possiamo trovare delle ragioni, ammissibili, a ognuna di queste affermazioni, ma il modo in cui sono avanzate oggi non manca di suscitare
sospetto. È possibile, talvolta probabile, che quanti le avanzano credano anche che gli ebrei siano stati responsabili della tratta degli schiavi, che le lobby sioniste controllino la politica estera americana (come ha sostenuto la deputata Ilhan Omar) e che i banchieri ebrei governino il sistema finanziario internazionale. Troppe donne e troppi uomini credono queste cose, a sinistra come a destra. Sono antisemiti o compagni di strada degli antisemiti, e il loro antisionismo è probabilmente strettamente legato al loro antisemitismo – anche se esistono ormai antisemiti pro-israeliani, ad esempio fra gli evangelici americani o fra i nazionalisti di destra in Europa dell’Est.
Gli uomini e le donne di sinistra devono essere vivamente critici, particolarmente nei confronti degli altri membri della sinistra che adottano queste vedute. È evidentemente più facile condannare gli antisemiti di destra e pretendere che l’antisemitismo non esista a sinistra.
Ma l’antisemitismo esiste a sinistra. Forse è vero che l’antisemitismo di destra è una minaccia più grande per il benessere ebraico, ma non bisognerebbe comunque sottovalutare la sua versione di sinistra. Detto questo, sono convinto che gran parte degli antisionisti e anche numerosi antisionisti di sinistra non credono alle favole antisemite.
Forse ignorano volontariamente cos’è il popolo ebraico, forse sono particolarmente preoccupati dallo Stato ebraico, forse alla fin fine non amano semplicemente gli ebrei (è quel che ha detto George Carey, l’ex arcivescovo di Canterbury, a proposito di Jeremy Corbyn).
Forse. Ma quando si parla di Israele nei dibattiti di sinistra, il vero problema è il sionismo, ed è dunque del sionismo che bisogna parlare. Per tutte le ragioni che ho fornito, quel che non va nell’antisionismo è l’antisionismo stesso. Che voi siate antisemiti, filosemiti o indifferenti al semitismo, l’antisionismo è una cattiva politica.
(Traduzione di Mario Porro)
Michael Walzer è uno dei più importanti teorici della politica viventi. Ha insegnato a lungo all’Institute for Advanced Study di Princeton, di cui è professore emerito di Scienze sociali. È considerato uno degli esponenti di spicco della corrente “comunitaria” del pensiero politico contemporaneo, assieme ad Alasdair MacIntyre e Michael Sandel. È autore dei fondamentali saggi Sfere di giustizia (1983) e Esodo e rivoluzione (1985) e di molti altri contributi sul pensiero politico moderno e contemporaneo. È anche condirettore della rivista «Dissent».

Di laicità, ebraismo e identità
Micol De Pas su JoIMag 3/03/2020 : Recensione al libro “Il funerale negato. Ovvero, l’ombra lunga dei Patti Lateranensi”, un’intervista a Bruno Segre di Alberto Saibene
“Non riesco a considerare la laicità come una “condizione”, come qualcosa che tu possa concretamente “conquistare” e che, una volta l’abbia conquistata, tu possa conservare quasi fosse un tesoro. La laicità, così come io la intendo, è la scelta di un metodo, di una prospettiva aperta, pluralistica, di una concezione polifonica della vita e della cultura. (…) è improntato a laicità il comportamento di chi rifiuta di lasciarsi imporre, e anche di imporre, un “pensiero unico”. Quella laica è una scelta di metodo della quale il mondo in cui oggi viviamo ha un profondo bisogno, pena la sua distruzone”. Sono le parole di Bruno Segre nel suo ultimo libro Il funerale negato. Ovvero, l’ombra lunga dei Patti Laternanensi, un’intervista con Alberto Saibene pubblicata per l’editore una città.

Un piccolo volume che, nelle ultime pagine in particolare, si trasforma in un manifesto per la libertà. Quella di espressione, quella identitaria, quella individuale. Che Segre declina con molta attenzione rispetto alla religione. Laicità non è il risvolto positivo di religione che ne sarebbe il negativo, bensì un modo aperto, inclusivo, libero di intenderla. “Mi resi conto di essere ebreo quando, all’età di otto anni, i fascisti mi intimarono che ero di razza ebraica e mi bandirono da tutte le scuole del regno. Da allora, cioè da oltre 80 anni, combatto con impegno laico la mia battaglia identitaria“, spiega Segre. Che poi aggiunge: “Quanto alla mia ebraicità, l’ho sempre vissuta in chiave libertaria; non ho mai smesso di considerarmi un liberto poiché l’Eterno ci ha tratto con mano potente dall’Egitto, dalla casa di schiavitù“. Non solo: “l’ebraismo laico è presa d’atto che la vita e la cultura degli ebrei hanno una dimensione plurale” e tale pluralità è sinonimo di ricchezza (e arricchimento futuro).
Lo spirito laico dell’autore analizza dunque i patti laternanensi e tutte quelle norme collaterali che dal 1930 al 1987 erano rimasti invariati, superando indenni la Shoah e decenni di post-fascismo.
Leggi anche: Pio XII e il silenzio sulla Shoah: si aprono gli archivi vaticani
Tra queste norme, anche quell che regolavano i rapporti tra le comunità ebraiche e lo Stato con la legge Falco, che imponeva agli ebrei di essere iscritti alla comunità ebraica della provincia di pertinenza, a meno di rinunciare all’ebraismo tramite abiura. Poi, con la revisione del Concordato, nel 1984, emerse la necessità di rivedere anche la legge Falco e nel 1987 Tullia Zevi e Bettino Craxi firmarono l’Intesa ebraica, cui seguì l’approvazione dello Statuto dell’ebraismo italiano da parte dell’Ucei. L’8 marzo 1989 entra così in vigore come legge l’Intesa ebraica che abroga la legge Falco. “E ciò facendo”, spiega Segre, “apre la strada a un’importante novità (…): l’obbligo vessatorio per tutti gli ebrei residenti in una determinata circoscrizone di aderire alla comunità di pertinenza territoriale (salvo atto di abiutìra) e la sostituzione di quel regime con il principio liberale dell’adesione volontaria“.
Cos’altro c’è di liberale nell’Intesa ebraica?, chiede Alberto Saibene. “Ben poco! Il documento conserva la tradizionale cornice giuridica e sociale unitaria e (…) salvaguarda la tradizionale struttura unitaria dell’ebraismo italiano mantenendola all’interno dell’ortodossia rabbinica. In generale i diritti per i quali l’Intesa domanda che lo Stato eserciti la sua tutela, marcano separatezza, indicano differenza specifica: una differrenza che per lo più si qualifica di matrice religiosa“, risponde Segre, che poi prosegue con il suo punto di vista: l’Intesa serve a proteggere questo aspetto dell’ebraismo, ortodosso e rabbinico, probabilmente in crisi d’identità e di autorevolezza. Impossibile fare appello al pensiero laico, a quel pensiero che ammette una pluralità di voci, rispettandole tutte, forse proprio perché, come dice il titolo di questo piccolo libro, siamo ancora coperti dall’ombra lunga dei Patti Lateranensi.
A questi fa riferimento poi una storia personale dell’autore, che su JoiMag abbiamo raccontato pubblicando una lunga lettera dell’autore: l’impossibilità di dare sepoltura alla moglie nel cimitero ebraico di Monticelli d’Ongina, e che è richiamata nell prima parte del titolo di questo libro, Il funerale negato.
Leggi anche: Noi, marrani di Monticelli d’Ongina
Questioni halakhiche, forse però incapaci di comprendere la lettura della storia, perché in quel cimitero riposano coniugi di matrimoni misti celebrati in tutte le epoche… Ecco, il pensiero laico di Bruno Segre è una forma di pluralismo che significa anche conoscere il passato per capire il presente.

Sinistra diffidente verso gli ebrei anche quando Israele non c’era
di PIERLUIGI BATTISTA Corriere della Sera 11 Gennaio 2020
Il saggio di Alessandra Tarquini (il Mulino) mette in luce pregiudizi di lunga durata ricostruendo il rapporto tra la sinistra italiana e il mondo ebraico nell’arco di un secolo
Nel 1974, quando un famoso sceneggiato televisivo su Mosè, interpretato da Burt Lancaster, fu trasmesso dalla Rai, un giornale di estrema sinistra, il «Quotidiano dei lavoratori» organo di Avanguardia operaia, protestò perché la tv di Stato si era prestata, a suo parere, a un’apologia della «supremazia del popolo ebraico» così spudorata da giustificare in modo obliquo «l’aggressività di Israele contro il popolo palestinese». La notizia sconcertante, però, non era la pubblicazione di un commento così smaccatamente antisemita che oggi muoverebbe a giusta indignazione, ma l’assoluta mancanza di reazioni a un argomento che, allora, sembrava normale che circolasse non solo nel recinto infetto del neonazismo, ma in quello delle forze che pure si ispiravano ai valori della Resistenza antifascista.
-kbkE-U3160890998995a5D-140x180@Corriere-Web-Sezioni.JPG?v=202001112050)
Del resto, racconta Alessandra Tarquini in un saggio molto documentato come La sinistra e gli ebrei. Socialismo, sionismo e antisemitismo dal 1892 al 1992 (Il Mulino), fa pure un po’ impressione che nel 1972 non sia apparsa sui giornali di sinistra nemmeno una recensione dedicata alla ripubblicazione del 16 ottobre 1943 di Giacomo Debenedetti o di, anche se la cosa può apparire incredibile, Se questo è un uomo di Primo Levi. Era normale, o comunque veniva accettato come argomento in sé non raccapricciante, la continua, insistita, maniacale comparazione tra le azioni dello Stato di Israele e il nazismo. Durante la guerra dei Sei giorni, nel 1967, si arrivò a sostenere che la stella di Davide del popolo di Anna Frank aveva macchiato il suo significato facendosi arbitrariamente simbolo della prepotenza militare di Moshe Dayan e di Israele, Stato, si disse, letteralmente anche nei decenni successivi, «teocratico e razziale». Si disse che le operazioni militari israeliane erano identiche alla guerra lampo hitleriana. Si accostò, con analogia mostruosa, la svastica alla stella di Davide. Si disse impunemente, con un luogo comune destinato a molta e immeritata fortuna negli anni a venire, che le vittime di ieri, gli ebrei, fossero diventati i carnefici di oggi e che oggi i «nuovi ebrei» erano oramai i palestinesi.
Scrive Alessandra Tarquini che nella stampa di sinistra «i termini israeliano, sionista, ebreo vennero a sovrapporsi». Con la guerra del Libano del 1982, mentre le reazioni a una bara davanti alla Sinagoga deposta durante un corteo sindacale furono molto blande, riaffiorò nella stampa di sinistra il vecchio pregiudizio antisemita sulla contrapposizione tra il Dio dei cristiani del Nuovo Testamento, pieno di amore, e il «vendicativo» e crudele Dio degli ebrei del Vecchio Testamento. Sulla rivista «Il Ponte» il direttore Enzo Enriques Agnoletti non si risparmiò persino un paragone spericolato tra l’invasione israeliana e le Fosse Ardeatine: «Confronto odioso? Purtroppo no». In tutti questi casi, è la presenza ebraica in quanto tale a suggerire immagini, suggestioni e comparazioni che oggi, per fortuna, non sarebbero più pensabili.
Ma se con l’ostilità nei confronti dello Stato di Israele è rintracciabile ancora un elemento politico, la minimizzazione dell’antisemitismo appare, scorrendo le pagine del libro della Tarquini, una costante, sin dal primo Novecento, della cultura della sinistra italiana (e non solo italiana, basta vedere le considerazioni dell’autrice sui libri di Adorno e di Sartre, scritti a ridosso della Shoah, ma dove l’elemento specifico dello sterminio ebraico viene menzionato quasi di sfuggita).
Nelle ondate antisemite, o nell’offensiva dell’antigiudaismo cattolico che oltraggiava il sindaco ebreo di Roma Ernesto Nathan come «un volgare insultatore della nostra fede», ancora si contrapponevano stereotipi come quello di Alceste De Ambris sull’equivalenza tra «lo sfruttatore battezzato e il banchiere circonciso nelle carni». Esercitava molto fascino la definizione di Marx della «questione ebraica» destinata a risolversi con l’auspicata fine del capitalismo. La completa assimilazione, cioè la fine di ogni identità ebraica, era vista come unico antidoto alle persecuzioni antisemite, come a dire che per non essere perseguitato come ebreo occorresse perdere ogni tratto distintivo proprio in quanto ebreo.
Quando il fascismo si macchiò con l’orrore delle leggi razziali, ancora una volta, nella cultura democratica e liberale, si minimizzò l’aspetto specificamente antiebraico per spostare l’attenzione sulla mossa propagandistica di Mussolini per presentare gli ebrei come i padroni della finanza. La stessa Shoah venne equiparata per anni a una forma di generica e certamente orribile «disumanizzazione», in cui però gli ebrei furono solo una parte, sia pur cospicua, delle vittime della sopraffazione nazista.
Anche nella rappresentazione cinematografica, sia pur con le migliori intenzioni di denuncia della barbarie nazista, e in film come L’ebreo errante di Goffredo Alessandrini, tratto da un romanzo di Eugène Sue, e Kapò di Gillo Pontecorvo che «non si soffermava sull’identità delle vittime, confinate all’interno della contrapposizione tra i nazisti e i loro avversari, e ignorava l’antisemitismo».
Del resto persino Carlo Levi parlò del lager come «il permanente sacrificio umano sull’altare degli idoli di Stato», «il rifiuto dell’uomo da parte dell’uomo», definizioni dove, nota Alessandra Tarquini, «non emerge alcuna considerazione sugli ebrei».

ISRAELI ELECTIONS TRYING TO ESCAPE FROM THE DEADLOCK, AGAIN
The March 2 general elections in Israel – the third in 11 months – remain contested and uncertain, crossed by scandals, fake news and harsh propaganda. The country is facing an unprecedented political situation, with a heavy toll on governance and policymaking. According to the latest polls, neither Benjamin Netanyahu nor Benny Gantz will cobble together a majority: the scenario of a fourth election is increasingly likely. Trump’s Peace Plan and its still unpredictable outcomes for Israel, the Palestinians and the region have added even more uncertainty to this situation. What is it at stake? How will Washington’s Middle East plan impact the Israeli vote? Has Netanyahu’s time in power come to an end?
The “Netanyahu Factor” Driving Israelis to the Polls Nimrod Goren | 28 febbraio 2020
Israelis have gotten used over the years to governments that do not complete their full terms. But, they never experienced repeat elections prior to 2019. The current political deadlock is leading Israelis to the polls for the third time in one year. In the final days of the campaign, leading candidates are even referring to the option of a fourth round. Israelis are facing an unprecedented political situation that takes a heavy toll on governance and policymaking. They are also experiencing a reality that runs counter-intuitive to the Israeli state of mind of the past decade, which used to perceive Prime Minister Benjamin Netanyahu as being bound to lead on and on.
Since 2009, Israeli politics has been largely shaped by one man. By winning consecutive elections and forming consecutive coalitions of various sorts, Netanyahu managed to dominate Israeli politics, prevent potential contenders from standing a chance against him, and be regarded by most Israelis (and by many in the international community) as invincible. It is not by chance that the term “King Bibi” was used on the covers of both Time and Newsweek, and was the title chosen for a documentary film that explored Netanyahu’s rise to power.
For years, Netanyahu had almost total control of his party, successfully maneuvered leaders and voters of other right-wing parties, effectively disempowered opposition from the center and left, shaped the public discourse to his advantage, delegitimized political rivals while polarizing the society, and overall – stirred Israel’s reality to his direction of interest. Time and time again, Israelis went to the polls with no real hope of leadership change. The main open question used to be which type of coalition will Netanyahu form after results are announced.
And then things changed. Corruption investigations that were initially dismissed and brushed off by Netanyahu, picked up pace. From one legal phase to the other, it became evident to Israelis that a major issue is brewing. Netanyahu’s repeated and increasingly harsh attacks on key personnel in the legal establishment, which were aimed at mobilizing his political base and rally his supporters, exemplified just how problematic his situation is. It was anti-corruption slogans that played a leading role in the downfall of the Likud government in 1992 and the victory of Yitzhak Rabin, and Netanyahu seems to have understood the political danger that his legal issues pose to him.
To try and counter that, Netanyahu hastened into early elections (April 2019). His goal was to quickly form a new coalition that will advance legislation protecting him from being indicted while in office. Election results initially indicated that he has succeeded in paving the way for that. His traditional right-wing bloc had the required majority. But a surprise was in the waiting. Former Minister of Defence, Avigdor Lieberman, a nationalist right-wing politician who has been part of Netanyahu’s camp since the 1990s (although episodes of political rivalry), broke ranks. Without Lieberman’s party, Yisrael Beiteinu, Netanyahu did not have a coalition. His efforts to attract centrist/leftist parties to join a “unity government” or even to bring on board a single defector from another party who will give him the necessary majority in parliament – all failed.
In the past, Netanyahu used to carry out such political moves easily. But, due to his corruption allegation, he became a persona non grata among his opponents. They were not willing to enable him to become prime minister again, given his potential downfall and the legislative reforms he sought to advance. Netanyahu was losing ground. As he failed to form a government and went to repeat elections, his image as invincible and as a “political magician” was shattered. Moreover, his image in Israel as “Mr Security” was now effectively challenged by the Blue and White Party leader, Benny Gantz, which featured three ex-IDF Chiefs of Staff on the top of its list.
Netanyahu sought remedy in diplomatic activism. He saw the realm of foreign policy as one in which he has an added value over his contenders. Billboards of him shaking hands with Donald Trump and Vladimir Putin appeared all over Israel, portraying him as a mega-diplomat. International visits and meetings were orchestrated for him, and world leaders were willing to grant Netanyahu new diplomatic achievements that he can present as part of his campaign. However, this – like other elements of his campaign – did not prove to be effective. The September 2019 elections showed a decline in votes for the Likud party, and Netanyahu failed again in forming a government, despite the loyalty of his party and ideological bloc (excluding Lieberman).
Towards the March 2019 elections, that tone of the opposition was already more confident. “He just can’t” was the slogan of Blue and White against Netanyahu, referring to his inability to form a coalition. “Netanyahu only cares about himself”, their campaign said, referring to the court case against Netanyahu that will begin just two weeks after the elections, on March 17th. Even the announcement of the so-called Trump Plan, which was supposed to be the ultimate political gift to Netanyahu towards the elections, was handled by the opposition in a way that did not increase Netanyahu’s popularity in the polls.
It is still not clear which direction the upcoming elections will go. But, Netanyahu’s time in power should be up. His long tenure led him to develop a sense of entitlement to the position, that prevented him from doing – at least until now – what a prime minister accused of bribe should do: announce resignation. The damage to Israeli democracy, state institutions and governance caused by his political and personal conduct is mounting. Israel is paying a heavy price for this. It is a price that drives voters to the polls time and time again. It is also a price that drives many of them to seek a new prime minister.
Netanyahu vs Gantz: How to Defeat Each Other Peter Lintl | 28 febbraio 2020

The starting point and the sole reason that Israel faces a third election within a year is Prime Minister Benjamin Netanyahu’s looming (and now happening) indictment due to several corruption cases. Since Netanyahu seems to put all his hopes on a law granting him legal immunity he is bound to coalesce only with right winged parties – all others parties from the center-left-Arab bloc have ruled this possibility out. And since secular nationalist Avigdor Lieberman with his Yisrael Beitenu party has dropped out of the right-winged block supporting Netanyahu, we see a stalemate since April 2019. It is clear that any other Likud leader would be able to form a coalition with the centre, as the indictment is the only reason hindering that. Yet so far, no one was able to form a coalition without Netanyahu nor oust him as Likud leader.
Nevertheless his challenger Benny Gantz has managed to establish himself as a formidable opponent: as the first challenger since long, he achieves similar support in polls regarding the ability of leading the country. Secondly, his party alliance, Kahol-Lavan (“Blue and White”), has become the strongest party in the Knesset.
Political constellations
The two candidates operate within very small margins. As the recent elections as well as current polls show: the overwhelming majority of voters will not change their political opinion and switch sides to the other blocks. The right-wing and the center-left-Arab blocs are rather stable. Thus, in the last weeks before the election, the respective campaigns focus on two aspects: first, to mobilize their core electorate and to counter a potential election fatigue among the voters. This seems to be the case especially with the Likud electorate. Sources from within the Likud speak of up to 300,000 potential Likud voters who did not vote for the party in the last elections. Secondly, there is a slim group, the so-called “soft right”, which is, according to polls, the only group of voters to potentially switch between the blocks from right to center-left.
Benny Gantz: appealing to the soft right
Benny Gantz and his party are bound to convince the small margin of moderate, soft right wing voters, who are critical of Netanyahu due to his corruption indictment. For Gantz tactics this translates on focussing on notions related Netanyahu’s looming trial: fighting corruption, re-establishing trust in state institutions, and general depicting himself as statesmanlike-leader (mamlachti) working for the whole of society, whereas Netanyahu is portrayed as utilizing the premiership for his own interests. Generally speaking, Gantz counters those voices that want to transform Israel into a more illiberal, majoritarian democracy.
As a further consequence, Gantz tries to avoid political stances which are associated with the left which could deter those soft right-wingers. He categorically rejects the possibility to include the Arab Joint List into any future coalition, since it is a party that is largely made up by Arab-Israelis. Furthermore, especially in this last election campaign, Gantz maintains moderate right-wing positions regarding the Palestinian Territories: e.g. that he would never return the Jordan Valley or that he would even annex the Jordan Valley – albeit in coordination with the international community (which effectively means not annexing it). Later on, he also stated that he would implement the “Trump Plan” after the election and thus implicitly annex all settlements. Nevertheless, over the last year Gantz was sending mixed signals regarding the West Bank and potential process with the Palestinians. Especially during the first election campaign in 2019 he also spoke of renewing the peace process.
Bottom line, Gantz positions himself as a moderately right wing politician, in a way not unsimilar to the pre-Oslo Labour party. Yet, since he is compelled to win this margin of soft-right Likud voters, it is hard to tell where he really stands on those issues. In addition, his party is extremely split: the bandwidth ranges from clear left-wingers like former Meretz member, Yael German, to outspoken pro-settlement activists as Zvi Hauser. Generally speaking, as many pundits observe, neither Gantz nor his party really formulate a concise vision of a future Israel. The main message and common denominator is to replace Netanyahu.
Netanyahu: acting prime minister in the ropes
Netanyahu’s election campaign relied much on the aspects it emphasized in the previous two campaigns, with a few updates in the respective fields. It featured Israel’s excellent economy (highlighting that Israel is a gas exporter), Netanyahu’s good relations with important foreign leaders and former foes (Netanyahu just attained overflight rights for Israeli planes over Sudan) and his capacity in keeping the enemies at bay, while at the same time portraying Gantz as a left-winger with whom the country would be endangered in all those fields.
Yet what certainly stood out in recent weeks and dominated the media was the so-called Trump Peace Plan – which was, not incidentally, published on the very day on which Netanyahu’s bid for immunity was scheduled to be discussed in the Knesset. The publishing of the plan is without any doubt a major political and PR achievement of Netanyahu. The plan is very close to Netanyahu’s own political positions (some ideas seem to be strikingly similar to those presented in Netanyahu’s “A Durable Peace”).
In addition, the impression of the strong bond between Netanyahu and US President Donald Trump was further strengthened by the image of the two, presenting the Peace Plan together to the public. Thus one of the successes was certainly to highlight during the election campaign Netanyahu’s potency and somewhat overshadowing the indictment.
Yet while it is generally welcomed in the Israeli society up, also by many who would see themselves as political centrist – the plan did, according to latest polls, not help to win any voters from the centre.
One of the consequences of that was that Netanyahu started a last minute effort and rolled out an economic vision for the next decade, promising cheaper housing, tax reductions and lowering the food prices.
Constellations and outlook
Thus, by the time of writing, the political constellation as well as the polls look very similar to the results of the September elections, which produced the stalemate between the right-wing and center-left-Arab bloc. The outcome of the election will be crucially influenced by the extent the parties can mobilize their electorates – of special importance will the turnout of the volatile Arab-Israeli vote. Additionally those soft right voters will also play an important role.
There are three principles scenarios for potential coalitions after the election: 1) Gantz can form a coalition without Netanyahu; 2) Netanyahu can form a coalition to pass an immunity law for him; or 3) leaders find some other creative way to allow Netanyahu protection from law enforcement. Some stipulated something like a “Nixon Law”, granting Netanyahu a pardon in exchange for him to step down. Albeit all of those possibilities seem unlikely. Yet, if this issues will not be solved, stalemate will prevail.
In this case, several factors will be worth watching: first, it needs to be seen to what extend the start of the trial against Netanyahu on March 17th will affect coalition negotiations and the standing of Netanyahu. Linked to this is, secondly, the question for how long the Likud will not rebel against Netanyahu as party leader. And thirdly, it is important to see if the minor parties will eventually switch blocks or put pressure on Gantz or Netanyahu to compromise. Especially the ultra-orthodox parties are worth watching here: their societies are heavily dependent on state subsidies for religious schools. They are in urgent need of the passing of a new budget – something a caretaker government without a Knesset majority, as is in office since 2019, cannot do.
For Netanyahu, on the other hand, the stalemate – or potentially a forth election, as some already speculate – seems to be a good option.
What Palestinians Should Expect from Israeli Elections Hugh Lovatt | 28 febbraio 2020

President Donald Trump’s peace plan has been met with wall-to-wall opposition from Palestinians who see it as a denial of their aspirations for sovereign statehood. Many feel that it instead formalises a one state reality of open-ended occupation and unequal rights that they are currently living. Beyond the considerable anger and frustration that US actions have produced, it still seems like business as usual for Palestinians. Ultimately, what may produce a more significant reaction will be the more practical manifestations of the US plan, most particularly any steps towards de jure annexation of the West Bank. With this in mind, many Palestinians are awaiting the result of Israel’s latest round of elections.
For now, the reactions of the Palestinian leadership in Ramallah is limited to tinkering with the current Oslo peace process model, rather than ushering in a strategic rethink. There is still be no seriousness to enforce Palestinian threats to sever security cooperation with Israel or dismantle the Palestinian Authority (PA). President Mahmoud Abbas also remains unwavering in his belief in a two-state solution based on internationally agreed parameters.
Many in the PA and Palestine Liberation Organization (PLO) leadership are still hoping that the potential formation of an Israeli government led by Benny Gantz’ centrist Kahol Lavan (“Blue and White”) party would minimise the chances of annexation and allow both sides to re-right the ship. PA leaders hopes that the formation of a centre-left Israeli government could create a path towards this. They also hope that a Gantz government would allow Palestinian residents of East Jerusalem to participate in Palestinian national elections – a condition that President Abbas has set before issuing a presidential decree that would formally set in motion the electoral process.
The problem is not just that there is no plan B should Gantz lose. The other problem is that the Palestinian leadership in Ramallah is banking on an extremely optimistic reading of Israeli political dynamics. In reality, it is difficult to see how the next round of Israeli elections will produce anything more positive for Palestinians.
Whether Netanyahu stays or goes, there is unlikely to be a substantial break in Israel’s future foreign policy trajectory on the Palestinian issue. Any changes will be mostly cosmetic. Neither Gantz or Netanyahu support a return to status quo ante two-state position. Both have endorsed the US plan. Gantz was also quick to claim that Netanyahu stole his idea when he promised to extend Israeli sovereignty to the Jordan Valley.
Moreover, given current electoral dynamics, it is very unlikely that Gantz could, or would, seek a centre-left government with the Arab-Palestinian Joint Jist. Much more likely will be a centre-right government dominated by Gantz’ Kahol Lavan, Avigdor Lieberman’s Yisreal Beiteinu and a selection of other right-wing or ultra-orthodox parties, perhaps even a Likud without Netanyahu. Ironically, a Netanyahu win could actually suit the Palestinian cause better. Netanyahu’s removal would improve Israel’s relation with the EU, particularly western European governments who have grown frustrated with his behaviour, further reducing the EU’s willingness to criticise Israeli actions towards the Palestinians.
But it is perhaps in Gaza where a change of government would be most felt. Gantz and his erstwhile coalition ally, Lieberman, have criticised Netanyahu for being too soft and having squandered Israel’s deterrence capacity against Hamas. In response, they have openly called for the resumption of targeted assassination of Hamas leaders. While there is obviously a degree of electioneering behind such rhetoric, a Gantz government could very well end up taking a more confrontational position towards Gaza.
Palestinian reactions to the US plan, and what might follow, once again reveal the deep limitations and weaknesses of the Palestinian liberation movement in its current form. This is driving home an acknowledgement at all levels of Palestinian society that there needs to be a new strategy, and for this to happen, there needs to be new leadership.
Senior PA/PLO officials prefer a new leadership to emerge from within their ranks as a result of internal deal-making to succeed Abbas. While they publicly support elections, it is a safe bet that most see this as too unpredictable and potentially destructive to their ambitions given the unpopularity of both Fatah and the PLO, and their own public ratings. Hamas’s popularity, while marginally better, is also suffering, despite its continued dominance in student politics.
This generation of Palestinian leaders – whether from Fatah or Hamas – undoubtedly has the most intrinsic desire for continuity and stability, and is therefore the least likely to radically break from the current strategy, even if some changes cannot be discounted.
But many Palestinians, including a majority of the youth population, have become alienated from established political parties, and the Oslo-configured middle east process, and are desperate for new leadership and liberation strategies.
There is a new alternative, and younger, leadership emerging in the West Bank, East Jerusalem, Gaza, and the diaspora, that could potentially meet such criteria. These younger leaders and activist see the Trump plan as highlighting both the demise of the Oslo-configured two state paradigm and the need for alternative liberation strategies.
For many younger Palestinians, a new strategy will have to include the demand for equal rights within the existing one state reality (potentially without taking a collective position on two states or one state as the final goal). Along with this comes an emphasis on reviving the Palestinian national movement and promoting new forms of popular representation (at home and abroad). In parallel, there is another, equally as young, portion of Palestinian society that may gravitate towards a more confrontation approach, whether targeting Israel, its settlers, or the PA.
While a new generation of Palestinian leaders are playing increasingly important roles in grassroots mobilisation and international representation, the restrictive and exclusionary policies pursued by the main Palestinian parties, combined with Israeli detentions, are hampering their ability to compete at the national level. While this weighs against them over the short term, their age in comparison to the current generation of Palestinian leaders means that they may still prevail over the longer term. As such, the ideas which they are now discussing are perhaps more representative of where the Palestinian national movement is going.
Religious Parties: A Crucial Needle in the Israeli Vote Davide Assael | 28 febbraio 2020

To understand the extent of the upcoming Israeli elections on March 2, I think we have to start a little further back. At least since the last decade of the last century.
The 1990s were defined as the period of Israeli “Constitutional reform”, as they were characterized by an unprecedented activism of the Supreme Court. Since the birth of the state until then, the court had limited itself to promulgating fundamental laws (in Israel they replace the constitution) concerning the state’s power structure. In the Nineties the tone of the measures began to change. In 1992 the law on human dignity and freedom was promulgated, two years later the law on freedom of occupation (considering the context, it should be underlined that occupation meant jobs). The legislators were moved by the intent to fix what was expressed in the charter of ’48, which defined Israel as a “Jewish and democratic state”. However, in the conservative and religious circles of Israeli society the turning point was perceived as an unacceptable shift of the balance needle in a liberal direction to the detriment of the Jewishness of the nation. Following the old pendulum rule, what followed was a reaction in the sense of identity. This reaction had several consequences. The most striking was the birth of a new nationalist right wing, whose two most prominent figures were Naftali Bennet (founder of the Habayt Hayeudi, “The Jewish House”, party) and Ayelet Shaked.
For twenty years the most skilled in taking advantage of the new scenario has been Prime Minister Benjamin Netanyahu, who worked hard to become the leader of this new identity front. But in the Middle East, it is known, identity and religion are hardly divisible concepts. The space has therefore been created for Israeli religious parties to play their own game, with the aim of influencing the country’s politics. When we refer to religious parties in Israel we have to underline the large differences among them and remember that two Jews usually have three opinions. Since the origin of the state (and perhaps even earlier) two fronts had been established: one religious-Zionist, in favour of a conciliation between the religious and national spheres, the other composed of the haredim (literally, the feared), always skeptical of the state of Israel, considered culpable of being the result of secular-modern culture instead of being constituted on a messianic basis. In Western language this second group is called “ultra-Orthodox”. But, as we said, two Jews have three opinions, so even here it was impossible to create a common container. The haredim parties are divided into: Yahadut HaTorah (“Judaism of the Torah”) and Shas. The first, a de facto continuator of a party founded in Poland in 1912, is the result of the union of Agudat Israel (“Union of Israel”) and Deghel Israel (“Flag of Israel”). If the first one represents the Hasidic current (a mystical current today more than anything else devoted to Jewish proselytism), the second is an expression of Lithuanian Judaism, which has had so much weight in the interpretation of the Scriptures. Shas, founded in 1983, is instead an expression of Sephardic and Misrachi Judaism. Its charismatic leader was Rav Ovadia Yosef, Chief Rabbi of Israel from 1973 to 1983, who died in 2013.
In recent years these parties have been increasingly decisive for maintaining the coalition led by Netanyahu, which, with its peculiar unscrupulousness (you don’t have to be an expert on Machiavelli to recognize how much unscrupulousness in politics is a virtue), did not hesitate to make alliances with a world that does not belong even to a small extent to his human and political biography. Showing a remarkable ability in political bargaining, these parties managed to orient Israeli politics, obtaining a series of successes. First of all, confirming the rabbinic monopoly on conversions (here the conflict is with reformed Judaism) and on marriages, as on other areas of public life. Then, on the so-called “Law of the Wall”, where Netanyahu bowed to the most extreme demands, repeatedly contradicting himself. No mixed prayer area, where women and men can pray together. Third, with the Military Service Law[1]. This deserves a separate chapter. It is sufficient to say that the haredim communities benefit from special exemptions from the early years of the state. Exemptions which have gradually extended to anyone who pronounces the formula “The study of the Torah is my occupation”.
The rest is recent history: Avigor Liberman, founder of Israel Beitenu (“Israel our home”), an expression of the secular right, did not accept the rejection of ultra-Orthodox parties to revise the military service law, condemning Netanyahu’s government to fall. The center-left coalition reorganized around the figure of Benny Gantz, founder of Kahol-Lavan (“Blue and White”), forcing Bibi into a draw. A majority was not found and – which is unprecedented for Israel – citizens returned to the polls a second time. Another stalemate. The third election will take place on March 2. The country is exhausted. The disaffection towards politics grows, even if the voting percentages remain high, but driven by the extreme wings, which are involved in the game. The polls show an absorption of the smaller parties by the larger ones, but the balance between the two sides does not seem to have changed. Liberman has already said that this time he will guarantee the country a government. Going in which direction? The responsibility on his shoulders is enormous. First, to represent a bridge in an increasingly polarized country, one therefore more vulnerable to the enormous external pressure to which it is subjected. Second, to indicate the way for the future of Israeli identity. In what sense should the dialectic established by the founding fathers between Jewish and democratic values be redefined? Where to set the new limit? Because Israel is facing the same problems as all democracies around the world, where we are witnessing identity reactions following decades of openness and naive dreams of breaking down all limits. Except that in these parts the balance between universal and particular is called Zionism. The question is then legitimate: will Israel still be a Zionist state?
]Instead, we could be surprised by the skeptical reaction of the haredi world to the Law of the Nation enacted in 2018, which was due to the belief that it implied further secularization of the state.
Will Israeli Arabs Tip the Balance in the Elections? Claudia De Martino | 28 febbraio 2020

At a time when the political debate about state identity rages, the Palestinians of Israel, the biggest non-Jewish minority of the country (21% of the population), represent both the greatest electoral challenger and one of the few contradictory voices in an otherwise predominantly right-wing domestic electoral debate.
Despite running again in the next elections as a single slate – the Arab Joint List –, the Palestinians of Israel are a heterogenous group made up of four different parties (Hadash or the Democratic Front, Ra’am or the Southern Islamic Movement, Ta’al or the secular party and Balad or the national-secular party) divided along religious and political lines. From the group – despite their living in the “complete and united capital of Israel” (Basic Law 5740/1980) – are excluded the 350,000 Palestinians of Jerusalem enjoying a separate status, that of “non-citizen permanent residents of the State of Israel”, yet not entitled to vote in national elections: their condition is still pending and increasingly critical given the fact that East Jerusalem, according to the “Deal of the Century”, could never be returned to a Palestinian state, an accidental outcome eventually leading to their mass application for Israeli citizenship.
Notwithstanding all their internal cleavages, the single fact that all the Arab parties had been able to toss aside their respective differences and merge together in a single list is already a major achievement. The decision to run united once again, as in 2015 and September 2019, is the proof they had understood their political potential as the third major Knesset bloc, likely to be assigned key roles in both parliamentary committees and state institutions either way, whether supporting the government from outside or from the opposition ranks. In fact, the largest party outside the government coalition appoints the opposition leader, a key figure involved in all security briefings, consulting monthly with the prime minister and entitled to rebuttal speeches at the Knesset: thus the Joint List is anyhow predicted to play a major role in the forthcoming 23rd Knesset.
Given the current political stalemate between the two major political parties (Kahol Lavan and the Likud, competing in a head-to-head race – 36 to 34 seats – to build a coalition government) and the desperate attempt of both blocs to win 2 to 3 extra seats, the Joint List is able to pull the strings even tighter. By boosting an already increasing Arab turnout (rising from 49.2% in April 2019 to 59.2% in September 2019) even by a little, the Arab vote could potentially translate into two additional seats allocated either to the Joint List (for which 81.8% of the Arab preferences are cast) or to Kahol Lavan, the centre-right party, already chosen among the Jewish parties by the most Arab voters in the last round of elections. Either way, a higher Arab turnout would contribute to paving the way for the ousting of incumbent Prime Minister Benjamin Netanyahu, rightly or wrongly identified as the first enemy of the Arab minority. This in spite of the acknowledged success of his economic endeavours, among which stands the “Five Years Plan 2015-2020” investing 20 billion shekels in the so-called “Arab sector” by assigning funds to local authorities to build infrastructures and boost education. The plan achieved concrete results, such as the roll-out of the first public transportation in Arab cities, a net increase in communities’ employment rates and in attainment of a sensitive increase in those with higher education (70% of Arab students enrolled in colleges and universities), though the Likud government underperformed in housing, crime and poverty reduction. However, the most serious responsibilities ascribed to Netanyahu relate to his relentless support for settlement construction and open disregard for Arab voters shown by installing cameras in polling stations in September 2019 and labelling them an “internal enemy” aimed at overturning the Israeli democracy from within. Consequently, Bibi’s current hopeless bid to regain some Arab voters by promising to launch direct flights to Mecca at discount rates for Muslim pilgrims appears to be an empty and belated gesture, likely to fall on deaf ears.
The Arab Joint List has also gained experience throughout the last four years. After the bold move to support a prospective Gantz government in the post-September 2019 coalition talks, it has not been disheartened by the Kahol Lavan leadership’s decision to corner it out of the political game, pledging not to include it in any government. It knows that appearances are deceptive and, notwithstanding Benjamin Gantz’s firm tone of rejection, his party is opening up to Arabs and reaching out to them, reassuring the Palestinians of Israel living in the so-called “Triangle” (the eastern side of the Sharon plain in the Galilee with the highest concentration of Arabs, 92% of all residents) against the potential “relocation” to a future Palestinian State envisaged in the “Deal of the Century” and promising to fight crime and further close educational and income gaps. In addition, public opinion is sensibly shifting in its favour, as proved by a recent Channel 13 survey showing that 44% of Jews would consider “legitimate” a government supported by Arab parties against 33% totally opposed to the idea. Furthermore, some Jews ditched by their progressive left-wing party (Meretz, merged with more centrist forces) are willing to break ranks and consider voting for the first time for an Arab List: a swing vote that could potentially translate into two more seats brought about by those disheartened Jews.
All things considered, the mounting tide of forthcoming change at the helm is working in their favour and makes the Arab List even more ambitious. Currently projected in the polls to win between 13 to 14 seats, it has set its sights on 16, considering itself able to raise the stakes if able to win the preferences of both the sceptical and quitter Arab voters and those of the Jews at the fringes. Unsurprisingly, the List had launched a campaign dedicated to each Jewish minority, targeting the ultra-Orthodox under the banner of the common fight against the “military draft”, the Ethiopians by the catchword of “combatting police brutality” and the Russians by way of promoting equality against the ultra-Orthodox religious establishment.
The main goal is twofold: gaining credit both as a true national force with a progressive and comprehensive platform open to Jews and Arabs alike and changing the overall narrative, no longer portraying the Arabs as a problem but rather as an asset for the state of Israel. It does so by running campaign slogans in the interest of the many under the pioneering and enlightened leadership of its chairman Ayman Odeh. By advocating equality, the List claims to work to preserve the democratic character of the Jewish state, so far threatened by many Jewish groups and right-wing parties, by demanding equality, by cross-sectionally catering to the rights of other minorities too, and by repealing the Nation-State law, rejecting the Law of Return and calling for the “recognition of the rights of displaced persons” (a key point in the Joint List’s platform) to lay the foundation for a just peace that would imply the return of some Palestinians into what is currently Israel. In sum, the Arab Joint List places itself to the left of the Israeli political spectrum, filling a staggering void but also relying on the strength of numbers, being perfectly aware that, whatever the bombastic attacks coming from the Jewish parties, the 21% of Israelis the Arabs represent are there to stay, cannot be permanently ignored and will be increasingly vocal in politics too.

Il “pagamento” di Eichmann, poter dire “sono una SS”
Stefano Jesurum 26 gennaio 2020

Hannah Arendt: «Nessun giudizio, Vostro Onore: eravamo in tanti».
Adolf Eichmann: «……..».
A: «Nessun giudizio, Vostro Onore: eravamo in tanti».
E: «……..».
A: «Nessun giudizio, Vostro Onore: eravamo in tanti».
E: «……..».
A: «Nessun giudizio, Vostro Onore: eravamo in tanti».
E: «……..».
Eichmann. Dove inizia la notte, atto unico di Stefano Massini, Fandango Libri. La rappresentazione teatrale di vittima e carnefice. Centoquattordici pagine dirompenti, fredde, viscerali, profondissime, razionali, emotive, piene e vuote di passione. Avete in mente gli occhi di Stefano Massini quando fa i suoi pezzi a Piazza pulita? Occhi che sprigionano la durezza della bontà e la follia della ragionevolezza.
L’inciampo del Giorno della Memoria è, appunto, un “inciampo”, una ricorrenza, tra qualche giorno, ieri, chissà. Qui, ora, sul palcoscenico delle pagine, ci sono solamente loro due, come ce li ricordiamo dai filmati del processo in Israele o dalle immagini di archivio. E le loro parole, incessanti, attanaglianti. «Il linguaggio, Herr Eichmann. Il linguaggio è lo specchio, sempre, di cosa sentiamo davvero. Ci pensi: la chiamavate “Soluzione Finale”. Non avevate il coraggio di dire “Massacro”. E il gas di Globočnik? Era un “Trattamento Speciale”».

Ma poi, dice Hannah, «le grandi masse fanno così: scordano tutto, velocemente, in un attimo. E non per distrazione, no. Lo fanno perché condannare gli altri – condannarli davvero – è pericoloso: corriamo il rischio, prima o poi, di sbagliare tutti. E nessuno vuol essere fatto a pezzi».
Ci vuole coraggio. Da sempre, e ancora. Anzi, no, non il coraggio, la dignità. «Il coraggio in fondo è una cosa di un attimo», vero Herr Eichmann?, il coraggio «fa rumore, abbaglia. Ci senti sotto l’orchestra come nei film, trombe, violini. Ecco, sì, il coraggio è cinema. Perfino un vigliacco può avere un attimo di coraggio, nella vita, e non cambia il fatto che era e resta un vigliacco. No. Più del coraggio è la dignità. Molto di più. Perché la dignità, se ce l’hai, ti resta incollata addosso, è parte di te». «Ognuno ha la sua idea di dignità: per Hannah Arendt e Sophie Scholl è ribellarsi. Per me era rispettare gli ordini. Stiamo su due fronti opposti».

Già, due fronti opposti. Ieri, oggi, domani. (Sophia Magdalena Scholl, Forchtenberg 9 maggio 1921 – Monaco di Baviera, 22 febbraio 1943) è stata un’attivista tedesca legata alla resistenza d’ispirazione cristiana, appartenente alla Rosa Bianca. Scelse la ribellione non violenta al regime.
È considerata martire dalla Chiesa cattolica e uno dei simboli della lotta alla dittatura nazista).
Con la Arendt noi cerchiamo, grazie a Massini, dove comincia e perché comincia il male. «Ci sarà un momento, preciso, in cui prende forma. O no? Deve esserci. Tutto ha un inizio. Quell’attimo impercettibile in cui si passa dal nulla al qualcosa. È questo che cerco io, da lei.”
Perché poi, come non essere d’accordo con Hannah?, c’è qualcosa di talmente… stupido nel male. «Sì: stupido. E guardi che non parlo delle coincidenze. Dico che il male si nutre di paura. Ne ha bisogno. Voi eravate fieri che la gente tremasse, anche solo a vedere una divisa. Portavate i teschi coi coltelli incisi nei distintivi. La paura, certo, la paura. Eppure, a sentirvi parlare, è così chiaro che ad avere paura eravate per primi voi». La paura. Non ci dice qualcosa anche oggi?
Herr Eichmann si indigna: «Non mi pagavano». «Oh sì. La pagavano con un verbo essere: “Sono un SS”. Dare a qualcuno un verbo essere è una buona forma di stipendio». C’è chi lo preferisce ai soldi.

L’antisemitismo di sinistra che la sinistra non sa riconoscere
di Matteo Gemolo – MicroMega 1/2020
È evidente che la lotta all’antisemitismo sia utilizzata da Salvini in chiave strumentale e giustissimo è stigmatizzare l’ipocrisia del leader leghista. Ma la sinistra, per essere credibile su questo terreno, dovrebbe iniziare a riconoscere e combattere l’antisemitismo che serpeggia silenzioso nelle sue stesse file.
Per capire il perché Matteo Salvini si sia ritrovato settimana scorsa a dibattere pubblicamente di antisemitismo nell’inusuale contesto istituzionale della sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, affiancato da intellettuali conservatori stranieri, ricercatori ed ambasciatori dobbiamo fare un passo indietro e guardare all’Europa degli ultimi anni.
Allo stato attuale, 70 membri del moribondo partito Laburista inglese sono indagati dalla Commissione per l’Uguaglianza e Diritti Umani per antisemitismo. A discorsi politicamente legittimi e di critica al governo israeliano si intrecciano affermazioni dal sapore sovversivo e apertamente intollerante come “vorrei tanto essere il presidente dello Stato di Israele. Hanno un bottone per autodistruggersi, vero?” pronunciate da Ali Milani, ex-candidato laburista nel collegio di Uxbridge e South Ruislip e proposte quanto meno imbarazzanti come quelle di “ricollocare Israele negli Stati Uniti” per risolvere “il conflitto arabo-israeliano”, rivendicate da Naz Shaha, altra parlamentare Corbynista.
Nel luglio del 2019, la BBC si fa autrice di un documentario dal titolo incendiario “Il partito laburista è antisemita?” in cui vengono raccolte le testimonianze di otto ex-dirigenti e impiegati Labour che denunciano l’“insopportabile” atmosfera negazionista all’interno del proprio partito in merito a questioni legate all’antisemitismo e a presunti legami tra la cerchia di Corbyn, Hamas, Hezbollah e la fratellanza musulmana. Sempre nello stesso periodo, viene pubblicata una lettera aperta su The Guardian a firma di una sessantina di deputati laburisti che denunciano il proprio leader con argomentazioni simili. Un parricidio?

La convergenza tra sinistra anti-capitalista/anti-imperialista à la Corbyn e nuove forme di antisemitismo subdolo e silenzioso sembra non arrestarsi ai confini naturali della Manica.
Nell’analizzare la débâcle laburista
nelle elezioni nazionali del 2019, Jean-Luc Mélanchon, leader francese de La
France Insoumise ricicla l’argomento delle Epistole di San Girolamo del dum
excusare credis, accusas (mentre credi di scusarti, ti accusi) incolpando Corbyn
di aver dimostrato “debolezza” e generato “allarme tra le fasce più deboli del
proprio elettorato” per il solo fatto di essersi confrontato e poi “scusato”
con chi accusava il suo partito di non aver vigilato a sufficienza in merito a
ripetuti episodi di antisemitismo: ci sono numerosi testimoni che riportano
quanto fosse frequente sentire alle riunioni di partito espressioni come: “Zio
scum” (feccia di sionista), “l’unica ragione per cui abbiamo prostitute a Seven
Sisters è perché ci vivono degli ebrei” e “Hitler was right.” Per Mélanchon,
meglio avrebbe fatto il leader laburista ad ignorare completamente il grido
d’allarme lanciato dal capo rabbino inglese Ephraim Mirvis dalle colonne del
Times alla vigilia delle elezioni nazionali britanniche e passare all’incasso
elettorale.
Come spiegarsi dunque la sconfitta di Corbyn? Semplice: una macchinazione messa in atto da una fitta rete di lobby politico-mediatiche legate a Likud, il partito nazionalista liberale del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Quest’interpretazione, promossa da Mélanchon e sposata da tanti altri a sinistra, sembra fare pericolosamente da specchio alle teorie complottistiche demo-pluto-giudaico-massoniche (e chi più ne ha più ne metta…) di stampo fascista del secolo scorso. La cosa più grave è che questo approccio esclude aprioristicamente la possibilità che anche a sinistra si possano infiltrare forme occulte e subdole di antisemitismo.
Ma non è di certo una novità. In
molti ambienti pseudo-progressisti questo genere di convinzione si salda alla
perfezione con un’altra apodittica certezza: quelli pericolosi ed illiberali
sono e saranno sempre dall’altra parte. Ce lo confermano quelli de Il Manifesto
che scrivono con fervore: “i conservatori (inglesi) hanno sì il razzismo iscritto
razzisticamente nel proprio Dna politico e sguazzano nell’islamofobia come
tutte le destre fasciste…”, aggiungendo con deferenza religiosa: “Corbyn, un
leader politico la cui militanza antirazzista nessun altro deputato di
Westminster può vagamente pareggiare.”
E tornando all’Italia, ecco che ci ritroviamo in queste settimane al cospetto di un Matteo Salvini inedito che discute con opportunismo e fiuto politico eccezionale di antisemitismo, di fatto monopolizzando la conversazione su questioni che fino all’altro ieri sembravano del tutto ininfluenti: esiste un qualche legame tra sinistra ed antisemitismo? Quali sono le differenze sostanziali tra antisionismo ed antisemitismo? Esistono forme di antisemitismo diverse da quelle fascistoidi del secolo scorso? Questioni serie e che sono ormai da decenni dibattute in Europa da intellettuali, accademici e giornalisti provenienti da tutte le culture politiche.
E di fronte a questi interrogativi
come reagisce parte della stampa italiana? Semplice: facendo la solita
deleteria e controproducente (ormai la storia recente lo ha dimostrato)
caricatura al cazzaro verde. “Salvini: l’antisemitismo in Italia? Colpa degli
immigrati” si legge con incredibile spirito di sintesi su La Stampa; oppure
“Salvini organizza un convegno sull’antisemitismo per prendersela coi migranti”
titola Linkiesta.it.
Intendiamoci: fare la parodia al discorso del leader della Lega è facile. Troppo facile. Il suo linguaggio volutamente semplicistico e strumentale si autodenuncia da solo per quel che è: un tentativo prevedibilissimo di allinearsi alle destre conservatrici occidentali – quelle che riescono a vincere le elezioni e a governare paesi ben più complessi e dal peso internazionale ben più rilevante del nostro, come Regno Unito e Stati Uniti d’America.
Ma l’elemento di novità di queste settimane è un altro: Salvini ha finalmente capito che per trasformare il Carroccio da partito populista di protesta – abituato a tessere relazioni ambigue e controproducenti con movimentucoli neofascisti locali dallo scarso impatto elettorale – a forza di governo, deve circondarsi di “menti” esterne che contribuiscano con “argomenti” spendibili dal punto di vista intellettuale a realizzare quella mutazione genetica a cui il suo partito aspira da tempo e che gli garantirebbe un posto di tutto “rispetto” sul piano internazionale. Ed è così che tra un rigurgito al Mojito, i “bacioni” alla sinistra e i “bacini” al rosario, Salvini si ritrova per la prima volta supportato da intellettuali e pensatori appartenenti ad una destra conservatrice moderata, tutti provenienti da fuori Italia, pronti a dibattere in un contesto altamente istituzionale argomenti sui quali tra le file della sinistra italiana purtroppo sono ancora in molti a tacere. “Le nuove forme dell’antisemitismo” del 16 gennaio scorso segna il via a questo percorso di lifting intellettuale a cui si vuole sottoporre il Carroccio, a cui seguirà a breve un’altra conferenza intitolata “National Conservatism. God, Honor, Country: Presitdent Ronald Reagan, Pope John Paul II, and the Freedom of Nations”, che si terrà al Grand Hotel Plaza di Roma il 4 febbraio prossimo e che vedrà come ospiti anche il primo ministro ungherese Vicktor Orban.
Cosa ribattere dunque ad un discorso articolato come quello di Douglas Murray (autore tra i vari del best-seller “La strana morte dell’Europa: immigrazione, identità e Islam”) che da anni parla di antisemitismo di matrice religiosa? Come reagire di fronte a chi come Ramy Aziz (ricercatore egiziano copto e analista politico del Middle Eastern Affairs Journal) e Dore Gold (presidente del Jerusalem Center for Public Affairs) porta avanti una perorazione che tende ad erodere la già precaria e sottile linea di confine che vi è tra una legittima critica alle politiche governative israeliane e la negazione del diritto al popolo ebraico all’autodeterminazione?
Al di là dell’evidente uso strumentale che Salvini fa di questi argomenti, mescolando con una certa abilità la proposta di vietare per legge il Bds (boicottaggio dei prodotti provenienti da Israele) con il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d’Isreale (seguendo la lezione di Trump), cos’altro hanno da dire gli intellettuali di sinistra di fronte all’emergere di effettive nuove forme di antisemitismo? Basterà affermare che non esistono perché a parlarne è Matteo Salvini?
Chiunque sia genuinamente interessato a comprendere le cause dell’aumento esponenziale degli attacchi antisemiti degli ultimi decenni in Occidente dovrebbe compiere prima di tutto un gesto di onestà intellettuale: spogliarsi per un istante della propria casacca ideologica, allontanarsi dallo specchio su cui le stesse idee trite e ritrite si riflettono narcisisticamente da decenni e confrontarsi con i dati che provengono dal mondo reale.
L’Alto commissario delle Nazioni Unite (UNHCHR) riporta che gli atti antisemitici in Francia nel 2018 sono aumentati del 74% rispetto al 2015. Il numero delle minacce antisemite sono anch’esse in crescita del 67% e fanno riferimento a 358 incidenti registrati nel 2019 (comprendenti insulti orali e scritti, email di minaccia, graffiti, svastiche ecc.) rispetto ai 214 riportati del 2017. Sul suolo francese sono ancora 824 gli istituti ebraici sotto sorveglianza militare e poliziesca. Ancora più preoccupante appare la situazione in Francia se prendiamo in considerazione un ulteriore dato: rispetto alla tendenza generale che vede diminuire gli attacchi a sfondo raziale (scesi del 4,2% secondo DILCRACH, la Delegazione interministeriale alla lotta contro razzismo, antisemitismo e omofobia) e quelli di matrice anti-musulmana (il 2018 registra il livello più basso di attacchi contro cittadini di fede islamica dal 2010), gli atti antisemiti rappresentano più della metà, il 55%, di tutti gli atti violenti a sfondo razzista registrati nel 2018, a discapito del fatto che la comunità ebraica francese costituisca meno dell’1% della popolazione totale.

In Germania la situazione è altrettanto allarmante. Secondo l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) gli attacchi antisemiti hanno raggiunto un totale di 1.799 unità rispetto alle 1.239 del 2011. Le statistiche della polizia attribuiscono l’89% di tutti i crimini antisemiti tedeschi agli estremisti di destra, ma i membri della comunità giudaica descrivono un’altra realtà: secondo un’indagine dell’Unione Europea, il 41 % degli intervistati afferma che gli attacchi degli ultimi anni siano fondamentalmente di matrice islamica. Un’indagine della Anti-Defamation League sembra confermarlo, riportando un’inquietante dato: il 56 % dei musulmani in Germania nutre atteggiamenti apertamente antisemiti, rispetto al 16 percento della popolazione complessiva.
Individuare le diverse radici ideologiche, politiche e religiose di questo sentimento crescente d’odio e pregiudizio nei confronti dei nostri concittadini ebrei è tanto fondamentale quanto urgente. Molti osservatori, non tra gli ultimi l’Agenzia tedesca per la sicurezza interna, hanno iniziato ad allargare il proprio campo d’indagine anche a fette della popolazione di confessione musulmana, dando risposta concreta al timore largamente diffuso all’interno della comunità ebraica rispetto a quel fenomeno noto come “antisemitismo d’importazione” che si affianca a quello del tutto locale d’origine neonazista. Dal 2015 in avanti, la crescente presenza di rifugiati provenienti dalla Siria e dall’Iraq ha allarmato molti ebrei in Germania che già si percepivano minacciati su due fronti opposti: da un lato, dall’avanzata della destra nazionalista dell’Afd, dall’altro da una più generale atmosfera d’intolleranza alimentata a distanza dal conflitto israelo-palestinese, soprattutto a partire dalla Seconda Intifada di inizio anni 2000.
Un episodio su tutti: nell’Aprile del 2018, nel distretto di Prenzlauer Berg a Berlino un ragazzo israeliano di nome Adam Armoush, viene aggredito da un 19enne siriano di origine palestinese mentre passeggia con un amico indossando uno yarmulke; il siriano prende la propria cintura e frusta il ragazzo israeliano al grido di “yehudi” (“ebreo” in arabo). La scena è filmata da un testimone ed il video, diffuso sui social media, genera una tale indignazione nell’opinione pubblica internazionale che Angela Merkel si ritrova costretta pubblicamente a parlare per la prima volta di “matrice islamica” in riferimento ad un episodio di violenza antisemita.
Anche in Svezia, il numero di crimini a sfondo antisemita registrati nel 2018 ha raggiunto il record più alto degli ultimi decenni, aumentando del 53% rispetto ai dati forniti dal governo nel 2016. Nei Paesi Bassi la polizia parla di casi raddoppiati tra il 2008 e il 2018, da 141 a 284 (dati Poldis). La comunità ebraica del Belgio, che conta circa 40.000 abitanti e si divide principalmente tra la capitale ed Anversa, ha subito un numero crescente di minacce ed intimidazioni negli ultimi anni a partire dall’attentato al Museo Ebraico di Bruxelles del 2014 per mano dell’ex miliziano dell’ISIS Mehdi Nemmouch, costato la vita a quattro persone. Il rabbino capo Albert Guigui non indossa più la kippah dal 2001, a seguito di un assalto antisemita alla sua persona per mano di un gruppo di giovani magrebini. L’esibizione del copricapo tradizionale ebraico viene percepito come pericoloso da un numero crescente di ebrei europei. Nel 2014, in Danimarca una scuola ebraica di Copenaghen ha invitato i suoi studenti ad indossare cappellini da baseball sopra i loro yarmulke. Nel 2016 Tzvi Amar, presidente del concistoro israelita di Marsiglia, ha consigliato agli ebrei della sua città di adottare una simile forma precauzionale. Anche in Italia gli incidenti antisemiti si sono quasi quadruplicati passando da 16 episodi nel 2010 a 56 nel 2018 (DIGOS).
Questi dati ci insegnano tre cose. Primo: il problema dell’antisemitismo è reale, vasto e radicato. Secondo: sottovalutare l’antisemitismo per pigrizia intellettuale o presunta superiorità morale, pensandolo come un problema che non ci affligge, significa solo rendersi complici della sua diffusione. Terzo: lasciare alle destre sole il monopolio su di un argomento che è molto più complesso di quello che ci fa comodo credere, è da irresponsabili.
E per concludere, si stia certi di una cosa: la comunità ebraica se ne fa molto poco delle nostre critiche nei confronti di Matteo Salvini, se a nostra volta non dimostriamo di esser capaci di riconoscere e combattere l’antisemitismo che serpeggia silenzioso tra le nostre stesse file.
Mattia Gemolo (24 gennaio 2020)

Matteo Gemolo è un musicologo e flautista italiano. Laureato in Filosofia all’Università di Padova, in Musicologia all’Università Ca’ Foscari di Venezia e in flauto traversiere al Conservatorio Reale di Bruxelles. In qualità di interprete e ricercatore il suo lavoro si situa in prima linea nella ricerca, studio ed esecuzione del repertorio contemporaneo per il traversiere. Di origini veneziane, vive da 8 anni a Bruxelles (Belgio). Suona regolarmente con orchestre barocche di fama internazionale e si esisisce nei principali teatri e festival in tutta Europa. Ha inciso per Warner Classics & Erato e per Arcana (Outhere Music). Ha collaborato con varie riviste tra cui FaLaUt (IT), The Flutist Quarterly (US) e come conferenziere per il Royal Northen College of Music di Mancheste (UK), l’Università di Cardiff (UK) e l’Università di Aveiro (PO). E’ attualmente titolare di una borsa di studio di dottorato in Music Performance all’Università di Cardiff (Galles). Appassionato di filosofia, politica, storia dell’arte, cinema e giornalismo. Scrive e parla fluentemente in Inglese e Francese.

L’odio senza tempo
Dialogo su antisemitismo e antisionismo in crescita in Italia e in Europa
Giovedì 16 gennaio 2020 Sinistra per Israele ha incontrato a Milano i circoli PD 15 Martiri e Marcona 101 per un dialogo su antisemitismo e antisionismo, di nuovo in crescita in Italia ed in Europa.

I partecipanti sono stati accolti con un buffet di assaggi a “tema” con falafel, hummus, melanzane ed altre specialità.
Dopo una breve presentazione dei circoli da parte di Massimo Griffini e Margherita Scalfi e l’introduzione di Edmondo de’Donato sul tema della serata, Lia Quartapelle ha parlato, in collegamento da Roma, della recente indagine di Euromedia Research, pubblicata dalla Stampa, che riporta dati allarmanti sul fenomeno del crescente odio verso gli ebrei, con addirittura il 6,1 % degli interpellati che si dichiara apertamente antisemita.
Le motivazioni dell’inimicizia nei confronti dei cittadini di origine ebraica indicano come “colpe” per il 14% la responsabilità di un “genocidio” palestinese da parte di Israele, per l’11,6% che gli ebrei dispongano di un preponderante potere economico-finanziario internazionale, per il 10,7% che si prendano cura solo della propria comunità religiosa e non della società in cui vivono, per 8,4% che si sentano superiori agli altri, per il 5,8% che abbiano responsabilità dirette nei conflitti nel mondo.

Nega la Shoah l’1,3% degli intervistati. Molto più diffuso è l’antisemitismo “inconsapevole”.
Lia ha poi ricordato la Conferenza Internazionale Interparlamentare per la lotta contro l’antisemitismo, che già nel 2016 aveva rilevato un peggioramento del fenomeno in Europa, anche a causa di Internet. Lia ha citato l’intervento della professoressa Monika Schwarz Friesl, che aveva rilevato come il fenomeno dell’antisemitismo sia presente in tutti i livelli della società, come risulta dagli oltre 200.00 messaggi ostili analizzati.
Lia ha ricordato che è stato chiesto al governo ad applicare la definizione di antisemitismo introdotta dall’IHRA (International Holocaust Rimembrance Alliance), che ne allarga il concetto e coglie anche le sfumature più striscianti, tra cui, appunto, l’odio verso Israele:
“L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso le persone ebree, o non ebree, e/o la loro proprietà, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto.”
Inoltre tali manifestazioni possono anche avere come bersaglio Israele, percepito come una collettività di ebrei. L’antisemitismo accusa frequentemente gli ebrei di cospirare ai danni del resto dell’umanità, ed è spesso utilizzato per incolpare gli ebrei di uno o più problemi politici, sociali ed economici. Trova espressione orale, scritta e impiega stereotipi sinistri e tratti caratteriali negativi». La definizione è stata accolta il governo italiano proprio il giorno successivo l’incontro.

Si è aperto quindi il dibattito partendo dalla necessità di fare chiarezza in una situazione di ignoranza, intesa come mancanza di consapevolezza, che annulla la memoria del passato e non aiuta a costruire il futuro. Come scrisse Primo Levi “chi non impara dal passato è condannato a riviverlo”. Dato il paradosso attuale di una Destra che difende Israele, il primo punto è stato chiarire che, pur se il termine “antisemitismo” potrebbe essere riferito anche agli arabi, esso è riferito generalmente solo agli ebrei come d’altra parte intese fare Wilhelm Marr, che lo coniò nel 1879.
Gli interventi in particolare di Luciano Belli Paci, Bruno Segre, Gabriele Eschenazi Giorgio Albertini e Stefano Jesurum hanno fornito un esauriente quadro storico politico dalla creazione dello Stato di Israele, delle vicende del conflitto israelo-palestinese e delle varie fasi del processo di pace. E’ stata ricordata la matrice socialista del sionismo politico, frutto di uno sforzo di conciliazione tra marxismo ortodosso e nazionalismo ebraico. Interessanti contributi alla discussione sono stati portati dall’ambasciatore Giuseppe Cassini, che ha ricordato i suoi incontri sia con Rabin che con i leader arabi in Giordania, e da Michele Sarfatti, che ha citato una ricerca del 2017 dell’Osservatorio antisemitismo del Cdec di Milano che constatò che l’11 per cento degli italiani «rispondeva con giudizi negativi a domande sugli ebrei». E’ stata evidenziata la distinzione tra antisionismo, inteso come negazione del diritto all’autodeterminazione del popolo ebraico, e la legittima critica al governo di destra di Israele, che non va assimilata quindi all’antisemitismo.

E’ stato fatta notare il progressivo indebolimento della sinistra in Israele, con il risultato che i principali competitori nella la terza tornata elettorale in un anno sono sostanzialmente un partito di destra, Likud, e uno di centro, Blu e Bianco. Paradossale che uno dei migliori alleati di Israele sia oggi l’Arabia Saudita, in quanto avversaria dell’Iran. In questo quadro spicca l’irrilevanza, ormai da anni, dell’ Unione Europea nel quadro mediorientale.
Le varie domande ed interventi delle altre persone presenti hanno alimentato la discussione, confermando l’interesse per il tema.
Ennio Galante ha chiesto se ci sono rapporti con l’unione delle comunità palestinesi ed il loro presidente Khaled Tamimi, e ha citato il GRMOC e Guido Valabrega, noto per le sue prese di posizione contro Israele all’interno del PCI.
Particolarmente interessante l’intervento di Alberto Pontara, che ha fatto notare come il fatto che il 6% della popolazione italiana si dichiari antisemita in modo aperto ci deve far preoccupare. Ma ancora di più ci deve allarmare il dato, che non conosciamo, di quanti lo sono ma non lo ammettono. Siamo di fronte a diversi tipi di antisemitismo: quello di destra (non solo estrema), quello populista (incarnato perfettamente dai deliri sui “Savi di Sion” di qualche esponente cinque stelle), quello di tipo islamista e infine dobbiamo anche constatare un antisemitismo di sinistra. In Francia il problema è ancora più sentito: molti ebrei francesi hanno scelto di andare in Israele, c’è una paura che si pensava debellata e che invece torna in modo preoccupante. La domanda è: c’è questa consapevolezza a sinistra? La sinistra sta facendo abbastanza per contrastare ogni forma di antisemitismo, anche al suo interno? Ma soprattutto, cosa dobbiamo e possiamo fare di più su questo tema? Da qui si è concordata la necessità di diffondere, all’interno del PD e della Sinistra, una maggiore conoscenza e consapevolezza, per scardinare le pregiudiziali antiisraeliane tuttora presenti nella sinistra italiana, con la proposta di tenere incontri come questo anche in altri circoli PD di Milano.

L’odio senza tempo
Antisemitismo e antisionismo sono fenomeni di nuovo in crescita, come dimostra l’ultimo l’attacco sanguinario di Monsey negli Stati Uniti e gli ignobili episodi sempre più frequenti in Europa. Anche in Italia si registra un crescendo inquietante di manifestazioni di odio.
I Circoli PD di Milano M101 e 15 Martiri con Lia Quartapelle ne parlano con Sinistra per Israele, da sempre impegnata a contrastare i pregiudizi antiisraeliani e antisionisti anche nella sinistra italiana, sempre con Israele, sempre contro i governi di destra (anche in Israele).
Sarà l’occasione per promuovere, sopratutto nei giovani, la corretta informazione ed analisi di questi fenomeni, per combatterli, riproponendo lo scardinamento della pregiudiziale antiisraeliana, l’antisemitismo a sinistra, e riaffermando il sionismo storico come “oggetto” di sinistra.
Vi aspettiamo Giovedì 16 Gennaio ore 21 in via Marcona 101
Amos Oz scolpiva le fiamme Ma sempre con delicatezza
Ad una annodalla scomparsa invitiamo a rileggere la rievocazione dello scrittore Eshkol Nevo del suo maestro all’Università Ben Gurion: «Spero che avremo il suo stesso coraggio»
Amos Oz era il mio maestro. Alla prima lezione del corso di scrittura all’Università Ben Gurion ha esordito con questa frase: «Non posso insegnarvi a scrivere. Però vi posso insegnare a cancellare». Hanno fatto seguito esercizi stimolanti. E riscontri incisivi. Ma più di tutto mi sono rimasti impressi il basilare rispetto con cui si rivolgeva a tutti i presenti e la serietà con cui si dedicava a qualunque testo gli venisse presentato. Anche il più acerbo. A fine seminario mi sono reso conto che da Amos non avevo imparato soltanto come scrivere, avevo imparato anche come insegnare: con riverenza, con dedizione assoluta, con la consapevolezza che il potere nelle mani di un maestro va usato soltanto per giovare.
Eshkol Nevo
Il secondo corso che ho seguito con lui era dedicato ai racconti brevi di Shai Agnon. Amos non insegnava Agnon come lo insegnano al liceo, con lo scopo di cavarne interpretazioni, ma da autore che cerca di individuare in che modo la lettura di un grande narratore può diventare motore per la scrittura. Ci leggeva Agnon, riga dopo riga. Delucidava e illuminava. Collegava e spiegava. Più di tutto, ci contagiava con il suo amore per Agnon.
Al termine di una lezione mi sono avvicinato al podio dove si trovava. Volevo raccontargli una cosa. Ho aspettato in fila. C’era sempre una fila di persone che volevano intrattenersi con lui. E a ciascuna dedicava un’attenzione indivisa. Quando è arrivato il mio turno, mi ha chiesto di accompagnarlo all’aula successiva in cui doveva entrare. Mi sono pavoneggiato con lui, mi ero licenziato dal lavoro e adesso «scrivevo e basta». Lui si è fermato, mi ha guardato con il suo sguardo penetrante e ha detto: «Io non ho mai “scritto e basta”». E ha aggiunto: «Non son certo che sia cosa buona, per un uomo, “scrivere e basta”».
Adesso ripenso a quella frase. Contiene un nocciolo di saggezza universale: l’anima dell’uomo ha bisogno di un contatto con il mondo concreto, altrimenti languisce nella sua solitudine. Ma racchiude anche un’ideologia. Non basta scrivere belle storie. O romanzi ben costruiti. Certo, ci si può accontentare di questo, ma un vero intellettuale non può non essere coinvolto nella società in cui vive. Esprimere la sua opinione, anche quando non è popolare. Illuminare con le sue parole gli angoli bui, anche quando nessuno li vuol vedere.
La verità va detta: Amos ha pagato un prezzo alto per il suo coinvolgimento politico e sociale. Mentre per molti riusciva a formulare in modo incisivo quel che provavano, molti altri sentivano che rappresentava tutto quello che avversavano.
«Non ho bisogno che tutti mi amino tutto il tempo» ha detto una volta Amos. Eppure, serve coraggio per rinunciare a questo amore, e serve coraggio per andare controcorrente, e serve coraggio per essere leale solo ed esclusivamente a te stesso e alla tua bussola interiore.
Spero che io e la mia generazione avremo il coraggio che ha
avuto Amos: di non tacere al nostro Paese, quando cambia faccia.
Amos è rimasto il mio maestro anche quando ho smesso di studiare con lui.
Dopo ogni nuovo romanzo, ricevevo la sua telefonata. O una lettera. A volte entrambe. Oltre alle cose che del libro gli piacevano, segnalava sempre — con delicatezza, con voce gentile — ciò a cui a suo avviso era possibile aspirare. Anche dopo l’ultimo libro, ha telefonato. Questa volta, per scusarsi. Stava leggendo il mio nuovo romanzo più lentamente del solito, per via delle chemioterapie che lo indebolivano. Perciò non l’aveva ancora terminato. Sperava solo che io non la prendessi male.
Lui sperava che io non la prendessi male? Mentre lo scrivo, sento un brivido. Ma non solo io ricevevo quelle telefonate, e le lettere stilate in una scrittura incredibilmente fitta.
Chiunque abbia avuto il privilegio di avere rapporti con Amos Oz conosceva il segreto: il più grande degli scrittori in lingua ebraica, l’oratore che scolpiva le fiamme, lo stregone della tribù, nella vita privata era una persona di straordinaria delicatezza. E di straordinaria generosità.
Alcuni anni fa, dopo la pubblicazione del suo libro Giuda,
l’ho intervistato. Il giornale me l’ha proposto e ho pensato che fosse
un’ottima scusa per incontrarci. Ci siamo seduti nel suo studio. Abbiamo bevuto
un tè. Poi un altro tè. Si è arrampicato sulla scala per prendere un libro
dallo scaffale più alto della sua biblioteca.
Adesso torno a rileggere quell’intervista. E scopro che verso la fine gli avevo
chiesto della fine: della prospettiva di cui godiamo quando ci avviciniamo
all’ultima parte della nostra vita.
Ecco come ha risposto: «Nella mia vita, ho ottenuto più di
quanto sperassi. Ci sono persone che alla mia età sono amareggiate, si
comportano come se stessero per essere cacciate fuori da una festa in pieno
svolgimento. Io provo gratitudine. Sono grato per un bel libro. Per una buona
conversazione. Per i miei figli e nipoti. Per le amicizie».
E ha aggiunto: «Trascorro molto tempo con i morti, ripenso alle persone che ho
conosciuto e amato nel corso della vita, ci sono più persone che ho amato e
oggi non sono con noi, che non persone che ho amato e sono con noi. Mi mancano.
Vivo come fossi gravido. Con i morti nella pancia. Di tanto in tanto converso
con loro. Pongo domande, e ricevo risposte».
Alcune settimane fa ci siamo nuovamente incontrati in casa
sua. Non immaginavo che sarebbe stato l’ultimo incontro. Amos era malato. Ma
come sempre sprizzava acume e racconti. E come sempre lui e sua moglie Nilli
non mi hanno permesso di andarmene prima di rifornirmi di provviste letterarie
per la strada.
Avessi saputo che era il nostro ultimo incontro, sarei forse stato più generoso
nelle parole di congedo.
Forse gli avrei detto che il maestro giusto, al momento giusto, può cambiare la
vita a una persona.
Adesso converso con lui nel mio cuore, pongo domande e ricevo risposte, leggo e rileggo i suoi libri. Raccolgo frasi belle con cui consolarmi: «In cuor suo sapeva che la maggior parte delle persone ha bisogno di più amore di quanto ne possa ricevere»; «La mia maestra Zelda… riteneva opportuno richiamarmi garbatamente, se qualche volta smetti di parlare, le cose qualche volta potranno parlare a te»; «Un uomo deve agire per gli altri e non distogliere lo sguardo; se vede un incendio, ha il dovere di cercare di spegnerlo; se non ha un secchio d’acqua, può usare un bicchiere; se non ha il bicchiere, avrà un cucchiaino, l’importante è continuare a provare».
Amos Oz, amato maestro, il tuo ricordo sia di benedizione.
(traduzione di Raffaella Scardi)
L’autore del ricordo
La scomparsa dello scrittore Amos Oz, che era nato a Gerusalemme il 4 maggio 1939 e si è spento il 28 dicembre 2018 a Tel Aviv a causa di un tumore, ha segnato un lutto grave per la letteratura israeliana e mondiale. Tra gli allievi di Oz, la cui opera ha segnato una stagione fondamentale nella vicenda culturale del suo Paese, spicca il romanziere israeliano Eshkol Nevo (nato nel 1971), che a suo tempo frequentò le sue lezioni all’Università Ben Gurion. A Nevo, autore di libri importanti come il romanzo Nostalgia (edito in Italia da Mondadori nel 2007 e poi riproposto da Neri Pozza nel 2014) si deve questo ricordo di Oz, che unisce la commozione personale a riflessioni acute sul ruolo svolto dal maestro nella vita sociale dello Stato ebraico.
ESHKOL NEVO
3 gennaio 2019 | 21:08

Amos Oz
A un anno dalla scomparsa
Di Wlodek Goldkorn
È morto a 79 anni il grande scrittore israeliano. Una vita al servizio della sua terra dal kibbutz alle battaglie civili, non ha mai smesso di denunciare l’escalation militare verso i palestinesi e di promuovere la soluzione dei due Stati
Sia perdonato il tono personale ma la storia che segue, per certi versi, riassume il modo di stare al mondo e con gli altri di Amos Oz, scomparso ieri all’età di 79 anni. Eravamo a Novara a presentare il suo romanzo Giuda, l’ultimo che ha scritto e dove, attraverso vari protagonisti lo scrittore israeliano fa i conti con gli ideali cui ha creduto e con l’idealismo che talvolta porta al tradimento e può provocare la morte altrui; un romanzo quindi sulla responsabilità. In una sala piena di gente avevo fatto cenno, coerentemente con il libro e con la vita dell’autore, al dovere di soccorrere i naufraghi e i profughi. A tavola, dopo la presentazione, Oz mi guardò dritto negli occhi e mi domando: «Ti sei sentito contento quando hai fatto quella domanda e hai avuto l’applauso del pubblico?». Amos Oz, proprio perché era un grande scrittore sapeva che per fare “il Bene” non bastano le belle parole. E da gigante della letteratura era conscio dei limiti della stessa letteratura.
Un giorno, a casa sua, a Tel Aviv, parlando di Louis-Ferdinand Céline, disse: «Scriveva benissimo, meglio di tutti gli altri francesi del Novecento, ma non era un grande scrittore». Per Oz erano fondamentali l’etica nella letteratura e il dovere di narrare bene la tragedia insita nell’esistenza di noi umani, ma senza astio. Amava ripetere che un ideale per rimanere ideale non può essere realizzato; che il sogno quando diventa realtà è delusione; che l’amore non è solo altruismo ma ha un lato egoistico; e che nel predicare il Bene, appunto c’è del narcisismo. E ciò nonostante, tutto questo non deve portarci al cinismo, alla rinuncia agli ideali, ai sogni e all’amore. Il compromesso, diceva, era la parola più cara del suo vocabolario e con una certa ironia, faceva un esempio: «Da decenni sono sposato con la stessa donna; quindi so cosa vuol dire compromesso». Per quella donna, Nili, provava, ricambiato, un amore senza limiti.
Amos Oz era nato a Gerusalemme come Amos Klausner, figlio di un intellettuale originario dei territori dell’ex impero zarista, e che lui stesso considerava fallito. Lo ha descritto in modo magistrale in Una storia d’amore e di tenebra, un romanzo e un memoir tenero e crudele al tempo stesso, in cui racconta le vicende della sua famiglia. La madre Fania si era tolta la vita quando Amos era giovanissimo e da quel lutto non è mai riuscito a guarire. A quindici anni lasciò la casa del padre e l’ambiente di destra in cui era cresciuto e andò a vivere in un kibbutz. Cambiò il cognome in Oz, che vuol dire forza e coraggio. Voleva essere pioniere, agricoltore, e con i piedi nudi toccare la terra. E invece diventò scrittore.
Negli ultimi anni, nel saggio Gli ebrei e le parole, scritto assieme alla figlia Fania Oz-Salzberger, rivaluta l’idea di un’identità ebraica legata al testo, alla memoria delle parole e non alla terra. Un ritorno alle origini diasporiche, un ripensamento del messaggio sionista? No: per Oz, l’esistenza di uno Stato degli ebrei era di primissima importanza, questione di vita e di morte. Ma ripeteva spesso: «Sono disposto a dare la vita per la libertà, non per le pietre e i luoghi sacri». Non sopportava i fondamentalismi, li considerava un morbo dei nostri tempi; e intendeva tutti i fondamentalisti: islamici, ebraici, cristiani. Pensava che per curare quella malattia occorreva il senso dell’ironia, quella distanza da se stessi che permette di accettare la rinuncia a qualche diritto, per non ledere quelli altrui. Ecco perché per lui la pace con i palestinesi voleva dire fine dell’occupazione e due Stati, quindi un divorzio ragionevole, senza pretese di amore tra ex nemici. E a proposito dell’occupazione, un giorno mentre lo accompagnavo all’aeroporto mi ha detto con orgoglio: «Sono stato il primo a dire pubblicamente, nel 1967, subito dopo la Guerra dei sei giorni che occorreva ritirarsi dai Territori che erano stati appena occupati». Nello stesso anno si mise a girare i kibbutz per raccogliere le testimonianze dei soldati, racconti duri e crudeli, per niente edificanti né celebrativi della vittoria. Il tutto uscì in un libro e recentemente, in un documentario, Censored Voices. «Volevo raccontare quanto la guerra sia sangue e merda e non solo trionfi», disse. Eppure considerava quella una guerra giusta.
Scrittore instancabile (22 tra i romanzi e le raccolte di storie brevi e 11 i libri saggistici, pubblicati in ebraico), il suo capolavoro assoluto resta un romanzo scritto all’età di 27 anni, pubblicato nel 1968, Michael mio in cui racconta la storia di una donna afflitta da una sorta di mal dell’anima, depressa, instabile, insoddisfatta della vita, con sullo sfondo un marito buono ma incapace di far fronte alla situazione, in una Gerusalemme divisa tra Israele e Giordania. Era contento quando sentiva dire che quello era il suo libro migliore; perché il più profondo nella ricerca della verità interiore. Della Gerusalemme degli anni Cinquanta e primi Sessanta, città degli intellettuali, laica, un po’ sonnolenta, ha avuto sempre nostalgia, mentre dal kibbutz si trasferiva ad Arad nel deserto del Negev e poi a Tel Aviv, per stare vicino ai nipoti. Quando abitava ad Arad, ogni mattina, prestissimo (si alzava alle cinque) andava a camminare, fuori dalla cittadina. Diceva che guardare il deserto con le sue pietre e i suoi spazi, un’immagine che racchiude l’eternità, gli faceva capire quanto fossero ridicole le espressioni “per sempre” o “mai” in bocca ai politici. E ad Arad (cambiando il nome del luogo in Tel Ilan) ambientò un delizioso romanzo, Scene della vita di un villaggio, in cui descrive le piccole vite di piccoli uomini e donne; e ad Arad (questa volta sotto il nome Tel Kedar) è ambientato Non dire notte.
Oz era un gigante perché come pochissimi scrittori al mondo sapeva narrare le più recondite emozioni delle persone comuni, e basti pensare a Una pace perfetta, o a Lo stesso mare: un modo di indagare il mondo, proprio dei grandissimi russi, come Cechov o Gogol. Quando, una volta sentì dire che era un autore russo che scriveva in ebraico, la faccia gli si illuminò (aveva una faccia bellissima): era felice.
Nuovo antisemitismo Il “test Israele” a Parigi
I macroniani contro l’antisionismo, Corbyn ne mette in discussione il “diritto a esistere” . Giulio Meotti Il Foglio 4 Dicembre 2019

Lo scorso 16 febbraio, a margine di una manifestazione dei gilet gialli, il filosofo ebreo francese Alain Finkielkraut venne aggredito per strada: “Merda sionista” gli dissero, e lo minacciarono di morte. Pochi giorni dopo l’aggressione a Finkielkraut, Emmanuel Macron dichiarò che l’antisionismo rappresenta “una delle forme moderne dell’antisemitismo”. L’episodio ha spinto il deputato macroniano Sylvain Maillard a convincere i colleghi parlamentari a votare una proposta di risoluzione sull’antisemitismo. Il test intende affermare che “gli atti antisionisti possono talvolta nascondere realtà antisemite”.
Il deputato di Parigi propone di adottare la definizione di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per il ricordo dell’Olocausto (Ihra). Nonostante il sostegno del presidente, l’iniziativa divide la maggioranza in Assemblea. Maillard ha così riscritto la risoluzione attenuandola: l’antisionismo ora è “a volte “ e non “spesso” la maschera dell’antisemitismo. La proposta è firmata da un terzo del gruppo della République en marche, pochi considerando che il presidente del gruppo, Gilles Le Gendre, e il capo del partito, Stanislas Guerini, ne sono i firmatari. Contraria alla risoluzione la leader del Rassemblement National Marine Le Pen. “Questa definizione dovrebbe consentire di stabilire un quadro per insegnanti, magistrati e polizia”, ha detto Francis Kalifat, presidente del Consiglio delle comunità ebraiche di Francia, per il quale la negazione dell’esistenza di Israele è “uno dei fattori essenziali dell’antisemitismonel nostro paese”. I un un appello sul Monde, 127 esponenti della sinistra ebraica chiedono ai parlamentaridi non votare la risoluzione , perché inibirebbe la critica a Israele, sebbene sia stata adottata nel 2017 dal Parlamento europeo, nel 2018 dal Consiglio della Ue e sia considerata la carta fondamentale contro il nuovo antisemitismo contemporaneo.
“La risoluzione non proibisce le critiche a Israele”, dice Frédéric Potier, delegato interministeriale per la lotta al razzismo e all’antisemitismo. La discussione arriva a poche settimane dalla visita di Macron in Israele e un voto positivo da parte della Francia verrebbe accolto favorevolmente a Gerusalemme, dove il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva già assicurato al presidente francese la sua “stima” quando quest’ultimo lo aveva informato del suo desiderio che la Francia adottasse la definizione di antisemitismo.
“Possiamo criticare il confine, le colonie, ma non possiamo mettere in discussione lo stato di Israele, per noi questo è antisemita”, continua il parlamentare parigino Maillard, promotore della risoluzione. Che è proprio quello di cui, in Inghilterra, viene accusato il leader del Labour, Jeremy Corbyn.
Ieri è uscita la clip di un’intervista rilasciata da Corbyn alla tv di regime iraniano Press Tv. In un documentario che esaminava le accuse di pregiudizio della Bbc nei confronti di Israele, Corbyn, allora deputato laburista, si domandava se Israele avesse il “diritto di esistere”. “Penso che ci sia un pregiudizio nel dire che Israele è una democrazia in medio oriente, che Israele ha il diritto di esistere e che Israele ha i suoi problemi di sicurezza” ha detto Corbyn, che non a caso si era duramente opposto alla risoluzione dibattuta a Parigi.
Intanto, dall’Ihra, ci si aspetta che anche l’Italia adotti la risoluzione contro l’antisemitismo dopo che è stata già approvata da quindici paesi europei. “In data 4 ottobre 2018,la Camera dei deputati della Repubblica italiana, mediante apposite risoluzioni, ha impegnato il governo ad adottare la definizione Ihra di antisemitismo. Malgrado la convergenza di tutti i partiti su tale impegno, il governo non ha ritenuto di dargli alcun seguito”.
La volontà delle democrazie europee di combattere l’antisemitismo si misura anche dalle famose “tre D” indicate da Nathan Sharansky nel test per distinguere la critica legittima a Israele dall’attacco antisemita: la delegittimazione, ovvero negare agli ebrei il diritto all’autodeterminazione; il doppio standard, cioè applicare a Israele una morale differente rispetto ad altri paesi, e la demonizzazione, dove si fa dello stato ebraico l’oggetto di un complotto malvagio. Quante delle critiche a Israele oggi supererebbero questo test?
Il presunto “antisemitismo” di Corbyn che spaventa Gad Lerner
Rosa Gilbert Contropiano 27 novembre 2019
Sono abbastanza stupita di vedere che il panico sull’antisemitismo nel Labour Party del Regno Unito si sia diffuso anche in Italia, in un modo forse più distorto e complicato anche grazie alla narrativa parziale e anche per le discussioni nate con le vicende su Liliana Segre, Chef Rubio, Meloni, il sindaco di Predappio ecc.
Provengo da una famiglia ebrea che come tante famiglie di immigranti ha quasi perso la fede dopo la Shoah – mia nonna è stata una profuga dall’Austria e la maggior parte dei suoi familiari sono finiti nei campi di concentramento. Mio nonno è nato in Inghilterra da genitori profughi per antisemitismo dell’Europa orientale e lui ha combattuto con l’esercito britannico qui in Italia durante la guerra antifascista. Come tanti dei miei parenti sono iscritta al Labour Party e vorremmo con forza un governo Corbyn per il Regno Unito.
Ho letto l’articolo su Repubblica di Gad Lerner e anche quello sul Venerdí di Repubblica scritto dal corrispondente britannico, Antonello Guerrera, con rabbia e sgomento, dopo 4 anni ormai di attacchi contro il capo del partito più antirazzista mai visto nella mia vita.
Ricordo che il governo di Blair ha costruito prigioni per richiedenti asilo, che sono stati imprigionati a lungo fino al rimpatrio forzato o che dir si voglia a una deportazione, senza che questi abbiano commesso alcun reato (un governo di Corbyn chiuderebbe queste “prigioni”).
Ad ogni modo la parte più insidiosa dell’articolo di Lerner è quest’idea che la sinistra veda gli ebrei come un “elite” economica. Mi dispiace per lui perché questo è uno spettro assolutamente inventato – ogni volta che il Labour parla dei ricchi, dei banchieri, o del sistema “truccato” un commentatore della destra accusa il partito di antisemitismo, un accusa che è essa stessa antisemitica.
L’idea che lo slogan del Labour “per i molti, non per i pochi” possa essere interpretata contro gli ebrei (“the few”/”the Jew”) è proprio antisemitica perché è un pregiudizio.
Mio nonno é morto prima della pensione dopo una vita di lavoro in fabbrica, inalando fumi tossici. Trovo questa strumentalizzazione ripugnante. E’ vero che le dinamiche di classe sono cambiate tanto negli ultimi 40 anni, ma il discorso sugli ebrei come un elite finanziaria (già propaganda nazista) è un archetipo vecchio che esiste nella società, ma non c’entra nulla con la narrazione del partito riguardo i ricchi e i poveri.
I sondaggi dimostrano che è minore l’antisemitismo nel Labour Party rispetto agli altri. Dunque ci dobbiamo chiedere se sia utile parlare di antisemitismo come un problema del Labour/la sinistra o un problema della societá, ricordando che gli iscritti di un partito – e parlo del partito con più iscritti nell’Europa occidentale – rappresenta una parte della società.
Sarebbe più utile porsi il problema sulla società e non limitato solo ad un partito, perché dunque distrazione? E’ chiaro che sia giusto avere una disciplina forte e un’educazione politica per espellere dal partito gli antisemiti ma, senza avere una programma antirazzista da applicare ogni giorno nella societá, è evidente che il problema non è risolto.
Infatti Lerner tocca proprio questo argomento, parla dei “clandestini” per dire che i migranti di oggi sono come gli ebrei di ieri. Per esempio, qual é il partito britannico che ha fatto una campagna con una scritta su un furgone che riportava “vai a casa” nei quartieri a più alta concentrazione di migranti?
Quale partito ha deportato cittadini britannici di origini carabiche nei paesi che non conoscono (il cosidetto Windrush Scandal)?
La risposta è che sono stati i Tories, cioè il partito conservatore.
Invece, quale capo di partito é andato a incontrare i migranti a Calais, abbracciarli, e ha sempre preso parte nelle campagne in favore dei migranti e dei profughi? Solo uno, Jeremy Corbyn.
Lerner cita poi il Jewish Chronicle, un settimanale ebreo che è una delle fonti di accusa principale contro il Labour. Una volta questo giornale mi chiese di scrivere un articolo sulle vicende di mia nonna che fu costretta – per salvarsi la vita – a falsificare i suoi documenti per scappare dai nazisti ed entrare cosi nel Regno Unito. Ebbene il mio articolo verteva sui migranti fermi a Calais (2016), facendo appunto un parallelo storico con la biografia di mia nonna, cercando di far comprendere alcune similitudini in un momento storico in cui la stampa e i media della destra attaccavano continuamente queste persone accusandole di essere “clandestine”, “bugiarde” e fuori legge.
L’articolo dopo esser stato ufficialmente commissionato non vide la luce sul Jewish Chronicle probabilmente perché ho sottolineato (argomentando ampiamente) come Corbyn al tempo fosse l’unico politico che trattava e tratta i migranti come esseri umani.
Per quelli che non lo conoscono, il Jewish Chronicle si può affermare che si posiziona politicamente più che altro a destra. L’editore Stephen Pollard è un giornalista che lavorava per tabloid come il The Daily Express, simile al giornale Libero qui in Italia, forse anche peggio – spesso su questo genere di stampa vengono scritti articoli isterici proprio contro i migranti.
Per esser più chiari, nel 2006 Stephen Pollard ha scritto che esiste una battaglia per “conservare la civilizzazione occidentale” e che “la sinistra, in ogni forma riconoscibile, è il nemico”.
Quando Lerner spiega come il Jewish Chronicle interpreta – a suo modo di vedere – la posizione di Labour contro i ricchi come “antisemitismo”, avrebbe potuto citare direttamente Pollard quando ha condiviso un video di Corbyn per i 10 anni dalla crisi finanziaria, dove attaccava i banchieri che hanno contribuito alla crisi, come l’attuale ministro dell’economia Sajid Javid, ex Goldman Sachs. Invece si insinua che Corbyn, il loro nemico, si riferisca ai pochi come ad ipotetici banchieri ebrei e quindi di conseguenza accusandolo di antisemitismo.
Pollard è ben conosciuto per i suoi attacchi agli ebrei socialisti e alla sinistra in generale. Nel 2011 il Jewish Chronicle ha pubblicato un articolo su un attivista ebreo che su Twitter aveva dato consigli legali per tutelarsi ed evitare l’arresto della polizia durante manifestazioni dove potevano succedere episodi violenti.
Ebbene in questo articolo furono inclusi dettagli personali su di lui e i suoi genitori, entrambi attivisti socialisti ebrei. Dopo la pubblicazione, la famiglia ha ricevuto minacce di ogni genere dalla destra estrema, così gravi che hanno dovuto mettere in sicurezza la loro casa ed avere massima attenzione, soprattutto quando su un forum neo-nazista su web è stato fatto circolare il loro indirizzo.
Lo stesso Pollard ha rifiutato di rimuovere l’articolo, anche se questo ha messo a rischio una famiglia ebrea minacciato dai nazisti. Ed ora, candidamente, parla di Corbyn come una minaccia per gli ebrei?!
Non solo, la fonte preferita da Gad Lerner, il Jewish Chronicle, ha in precedenza attaccato la sinistra, incluso il capo del Labour prima di Corbyn, Ed Miliband, un ebreo burlato dalla stampa di destra per non essere in grado di mangiare un panino con la pancetta, e per avere un padre che era un profugo ebreo accusato di odiare la Gran Bretagna, in un articolo reazionario difeso dai giornalisti del Jewish Chronicle.
Il Jewish Chronicle e Pollard hanno attaccato Miliband per aver preso una posizione troppo radicale sul Medio Oriente cioè, criticare le azioni di Israele durante l’”Operation Protective Edge” e riconoscere lo stato di Palestina.
Più di recente, un altro giornalista del Jewish Chronicle, Lee Harpin, ha risposto al famoso poeta ebreo socialista Michael Rosen, che difende il partito e Corbyn dalle accuse come quella di essere un “cheerleader per George Soros”.
Per il Jewish Chronicle, gli ebrei socialisti sono i bersagli preferiti.
Ma veniamo ai fatti interni al partito. Probabilmente lo scandalo più grande di antisemitismo del Labour era sull’uso da parte del IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) della definizione di antisemitismo per i processi disciplinari del partito.
Il comitato nazionale del partito ha deciso di cambiare non la definizione, ma gli esempi, includendo le “illustrazioni”, in parte ci sono problemi segnalati anche da uno dei autori della definizione originale – perchè 6 su 11 di questi esempi si riferiscono ad Israele, incluso uno molto controverso che afferma che sarebbe antisemita definire Israele come “un’entità razzista”.
Uno dei rappresentanti del comitato, anche lui ebreo, ha descritto il codice istituto dal Labour come un “gold standard” – ma non sembrava essere abbastanza, ed è cominciata nell’estate del 2018 una campagna della stampa – di destra e liberale – che accusava il partito di essere antisemita per non interpretare alla lettera il codice comportamentale di IHRA.
I lettori e le lettrici più interessate possono leggere qui un articolo su questo clamore, e c’è anche un nuovo libro su questa “crisi” che spiega il ruolo della stampa sul sensazionalismo dato alla vicenda.
Anche in Italia dove il discorso sull’antisemitismo è diventato sensazionalista; ritroviamo un dipinto parziale della scena inglese e questo è pericoloso.
Pare che Lerner voglia fare un paragone fra l’antisemitismo della destra italiana, che è indifferente all’antisemitismo nella societá europea ma sostiene Israele per essere anti-islamica, e quello del Labour che lui crede sia nato da un amicizia fra il movimento operaio e il movimento palestinese, incluso quelli che “mettono in atto pratiche terroristiche”.
Paragonare l’antisemitismo della destra italiana al partito Labour è non solo completamente sbagliato, ma non spiega con i fatti come sia possibile mettere sullo stesso piano le idee della destra italiana con le politiche del Labour Party a maggior ragione quando lo stesso Corbyn è stato grande amico di un sopravvissuto all’Olocausto recentemente scomparso.
Curioso come un altro articolo, quello sul Venerdí scritto da Antonello Guerrera, corrispondente britannico della Repubblica, dipinga Corbyn come un vecchio marxista amico di terroristi islamici, attingendo direttamente – anche qui – da “fonti” false e direttamente dalla stampa tabloid, dove si raffigura Corbyn come una minaccia e al tempo stesso come un incompetente.
Guerrera scrive che il problema dell’antisemitismo nel partito Labour “non è mai stato seriamente affrontato” e questo non corrisponde alla verità. Dopo una campagna di accuse contro Corbyn da prima che fosse il capo del partito, per ogni evento pro-Palestinesi, ogni articolo che ha scritto, ogni tweet o post su social di ogni candidata del partito, il partito ha sempre preso seriamente le posizioni prese ed ha attivato un’indagine generale per verificare le accuse che erano state mosse ed eventualmente punire e censurare qualsiasi caso scoperto come antisemita.
Nel 2016 a questa indagine ha diretto un avvocato con l’aiuto di alcuni accademici, dopo alcuni commenti anti-Israele di due membri del partito in cui si affermava che i sionisti furono sostenuti da Hitler, Ken Livingstone (uno dei due) è stato sospeso ed in seguito ha rassegnato le dimissioni dal partito.
A onor del vero bisogna dire che la stampa – ostile al Labour – si dedica costantemente alla ricerca di affermazioni anche non significative mettendo in luce post su social di membri secondari del partito solo per scatenare un caso e gonfiare ad arte dei fatti che meritano certo attenzione ma vanno contestualizzati e non strumentalizzati.
Non scrivo questo per negare che c’è antisemitismo nel mio partito, perché esistono ovunque, anche sessismo, razzismo, islamofobia e omofobia. Voglio chiarire la situazione circa una campagna brutale, che strumentalizza i fatti, mettendo paura alla comunità ebraica (un giornalista della destra ha detto che Corbyn vuole riaprire Auschwitz), mentre non sono interessati a condurre una vera lotta antirazzista nella società.
E’ una delle campagne di diffamazione più intense mai viste – anche oggi 24-11-19 su un giornale domenicale l’ex capo di MI6 (uno che ha affermato falsamente che c’erano le “armi di distruzione massa” in Iraq) ha detto che Corbyn sarebbe una minaccia alla sicurezza del paese; è per questo che la campagna anti-Corbyn non finirá mai – è una minaccia agli interessi consolidati dell’imperialismo e del capitalismo britannico.
Antisemitismo, l’ambigua sinistra inglese
Tra i laburisti casi di minacce, aggressioni, accuse al leader Corbyn e anche la denuncia pubblica di 67 esponenti del partito
Paolo Mieli Corriere della Sera 2 Dicembre 2019

Impossibile valutare quanto influirà sulle imminenti elezioni inglesi l’atto terroristico compiuto da Usman Khan venerdì scorso sul London Bridge. Poco, secondo la maggior parte degli osservatori e per quel poco a vantaggio di Boris Johnson che i sondaggi danno in ogni caso come vincitore. Del resto il partito di Nigel Farage ha deciso di facilitare il partito di Johnson non presentando propri candidati nei seggi in cui i conservatori prevalsero nel giugno 2017. Ma è vero altresì che proprio nel giugno 2017 Theresa May, data per iperfavorita dalle rilevazioni demoscopiche, perse inaspettatamente tredici seggi e con essi la maggioranza assoluta nel Parlamento inglese. Un identico passo falso — quello di provocare le elezioni sicuro di vincerle — lo aveva fatto nel 1974 il conservatore Edward Heath a tutto vantaggio del laburista Harold Wilson. La Gran Bretagna ci ha abituato a questo genere di sorprese. Anche grandi. Il laburista Jeremy Corbyn si mostra perciò ottimista anche in virtù di un programma davvero ambizioso: tassazione super per le imprese — a cominciare dalle multinazionali come Amazon, Google e Facebook — e per coloro che guadagnano più di ottantamila sterline l’anno (il 5% degli inglesi); nazionalizzazione di ferrovie, acqua, energia e poste (rimborsando le società mediante titoli di Stato, come fece tra il 1946 e il 1948 Clement Attlee. E non solo.
Jeremy Corbyn prevede anche un aumento della spesa pubblica di 83 miliardi, settimana lavorativa accorciata a 32 ore, aumento del 5% dei salari, controlli odontoiatrici gratuiti una volta l’anno, abolizione delle tasse universitarie, 150 mila nuove case popolari, banda larga per tutti entro il 2030. L’insieme in una visione della politica internazionale dai forti connotati antiatlantici corroborati da una più che decisa simpatia per organizzazioni come Hamas e Hezbollah (definite «amiche») e di spiccata antipatia nei confronti «delle politiche dello Stato di Israele». A tal punto evidente che in molti, anche dall’interno del Partito laburista, hanno identificato in essa i caratteri di un’ostilità a Israele tout court, sconfinante per di più in un (magari involontario) sentimento antisemita. Ne ha parlato in un editoriale sul Times (in termini assai più decisi di quelli che ho testé usato), il rabbino capo del Regno Unito e del Commonwealth Ephraim Mirvis domandandosi e domandando ai lettori: «Che ne sarà degli ebrei e dell’ebraismo britannico se il Labour formerà il prossimo governo?». Ma ancor più clamoroso è che l’appello di Mirvis sia stato fatto proprio e rilanciato – con parole ugualmente impegnative – dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby.
Corbyn, alla guida dei laburisti inglesi dal 2015, non è nuovo a questo genere di rilievi. Non si contano, nella sua biografia, episodi che anche in Italia avrebbero sollevato (immaginiamo) commenti aspri non soltanto da parte ebraica: la partecipazione, nel 2012 a Tunisi, a una cerimonia in onore di uno dei terroristi che nel 1972 alle Olimpiadi di Monaco avevano sequestrato e ucciso atleti israeliani; l’amichevole incontro con il leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina alla vigilia di un attentato a una sinagoga di Gerusalemme in cui sarebbero rimasti uccisi quattro rabbini (uno dei quali inglese: Avraham Shmuel Goldberg); la conferenza con Khaled Meshaal, il leader di Hamas già sulla «lista nera» del Regno Unito; la protesta contro il sindaco di Londra reo di aver fatto cancellare un dipinto murale di Mear One – un nome d’arte – da lui, non a torto, ritenuto antisemita; la prefazione a sua firma alla ristampa di un libro del 1902 in cui John Atkinson Hobson sosteneva essere il capitalismo internazionale «controllato da uomini di una singola razza particolare» (analisi «corretta e lungimirante» l’ha definita Corbyn); il capo laburista ha altresì chiamato «fratello» Abdud Aziz Umar condannato a sette ergastoli per aver fatto esplodere a Gerusalemme un ristorante, provocando la morte di sette persone. E si potrebbe continuare…
Intendiamoci presi uno per uno tutti questi casi (alcuni più, alcuni meno)potrebbero trovare delle giustificazioni. Ma nel loro insieme non possono non suscitare perplessità. Del resto Corbyn non è stato certo il primo nel mondo laburista a manifestare sentimenti del genere. L’ex sindaco di Londra Ken Livingstone provocò un grande trambusto allorché sostenne l’ardita tesi secondo cui «quando Hitler vinse le elezioni, la sua politica era che gli ebrei dovessero spostarsi in Israele… Hitler era di fatto un sostenitore del sionismo prima che perdesse la testa e finisse per uccidere sei milioni di ebrei». Un candidato alle amministrative di Peterborough, Alan Bull, aveva poi più sbrigativamente sostenuto essere l’Olocausto «una bufala».
Recentemente l’atmosfera si è fatta ancora più calda. In febbraio la deputata Luciana Berger ha strappato la tessera dopo che a un congresso del Labour aveva subito minacce e aggressioni fisiche a seguito delle quali le era stata assegnata una scorta. Joshua Garfield ha lamentato di essere stato qualificato come «sporco sionista». La deputata laburista Margaret Hodge si è ribellata e ha accusato il leader del suo partito di essere un «fottuto antisemita». Dopo di lei 67 esponenti del Labour hanno acquistato una pagina sul Guardian per rilanciarne le denunce. In maggio la Commissione per l’eguaglianza e i diritti umani ha aperto un’inchiesta sul Labour Party per «aver illecitamente discriminato, importunato e perseguitato persone appartenenti alla comunità ebraica». Appresa questa notizia, il celebre autore britannico di spy story John le Carré (nome d’arte di David John Moore Cornwell) ha annunciato che non voterà più per i laburisti: una sorpresa dal momento che le Carré è un convinto anti-Brexit, anti-Trump e un protagonista del suo ultimo libro, «La spia corre sul campo», definisce Boris Johnson un «maiale ignorante». In molti si sono uniti a le Carré tra i quali un altro grande scrittore, Frederick Forsyth, nonché l’attrice Joanna Lumley. Alan Sugar, tradizionale finanziatore del partito della sinistra britannica, ha annunciato che non darà più un soldo.
In luglio un documentario della Bbc ha reso pubbliche otto testimonianze che dall’interno del Labour denunciavano in modo circostanziato alcuni casi di cui si è detto. Corbyn ha replicato sostenendo che gli episodi accertati vedevano coinvolti lo 0,06 degli iscritti, che lui stesso aveva ordinato l’inchiesta interna per esaminare trecento denunce in merito a episodi di ostilità nei confronti degli ebrei, provvedendo all’espulsione dei colpevoli (la metà degli indagati). L’indagine era stata condotta dall’avvocatessa Shami Chakrabarti secondo la quale il partito soffriva soltanto di una «occasionale atmosfera tossica». Gideon Levy un celebre giornalista della sinistra israeliana ha poi difeso su Haaretz il leader laburista. Ma Corbyn è rimasto sotto tiro.
L’Anti-Defamation League, in una rilevazione quinquennale sull’antisemitismo compiuta in diciotto Paesi, ha denunciato l’aumento vertiginoso del fenomeno in Europa orientale – con punte record in Russia, Polonia e Ucraina – e la consistente diminuzione in Italia (–11 punti) ma anche, sia pure meno vistosa, nel Regno Unito in cui hanno fin qui dominato i conservatori (–1 punto). Stupisce che la sinistra politica e culturale del nostro Paese (con alcune – purtroppo poche – lodevoli eccezioni) pur particolarmente attenta agli slittamenti antisemiti nel discorso pubblico italiano non abbia ritenuto meritevole di attenzione queste particolarità di Corbyn che hanno suscitato allarme persino nell’arcivescovo di Canterbury.

Antisemitismo, quel pregiudizio firmato Corbyn
Gad Lerner – Repubblica 20 Novembre 2019
La vicenda inglese pone una questione spinosa anche alla sinistra: è mai possibile che per sintonizzarsi con il sentimento di esclusione delle classi subalterne, sia inevitabile introiettare anche il pregiudizio antisemita e antisionista?
Mentre la destra italiana, dopo il caso Segre, rifiuta categoricamente di ammettere la presenza nelle sue file di posizioni antisemite – e a riprova esibisce il suo sostegno incondizionato al governo d’Israele, ammirato baluardo occidentale contro la “minaccia islamica” – il Regno Unito sembra vivere una situazione rovesciata: è il partito laburista di Corbyn a subire, non senza buone ragioni, l’infamante accusa di antisemitismo.
Come vedremo, l’apparenza inganna. Le argomentazioni della rinascente ostilità antiebraica mantengono significativi tratti comuni, di per sé non etichettabili come di destra o di sinistra, e proprio per questo sono ancor più insidiose. Semmai va rilevato che, a differenza della destra italiana, il Labour rifugge un atteggiamento di mero negazionismo: “Prendiamo molto seriamente le accuse di antisemitismo, siamo impegnati a sradicarlo nel partito e nella società”, ha dichiarato il portavoce di Corbyn replicando alla lettera pubblicata sul Guardian da John le Carré e altri intellettuali che definiscono il Labour invotabile alle elezioni del prossimo 12 dicembre dagli ebrei, angosciati dalla “prospettiva di un primo ministro associato con l’antisemitismo”.

Dopo l’istituzione di una Commissione d’indagine all’interno del partito, ancora di recente due candidati sono stati esclusi dalle liste laburiste. Kate Ramsden, ad esempio, che aveva dichiarato: “Israele mi ricorda il caso di quei bambini vittime di abusi che divenuti adulti si mettono a replicarli”. L’adesione alla causa nazionale palestinese e la simpatia manifestata ai movimenti arabi di matrice islamica, anche quando essi mettono in atto pratiche terroristiche, contraddistinguono effettivamente la componente della sinistra inglese a cui lo stesso Corbyn da sempre è legato. Questa è l’unica vera differenza rispetto alle posizioni della destra che, nel mentre le addita, occulta i veleni di cui è intrisa la sua propaganda. Fino a sostenere che oggi l’unico vero antisemitismo pericoloso sarebbe l’antisionismo fomentato dagli integralisti islamici che vogliono distruggere Israele e per estensione colpiscono gli ebrei anche in Europa.
Purtroppo c’è dell’altro in sottofondo, nel Regno Unito così come in Italia e negli altri Paesi del vecchio continente: la riproposizione dello stereotipo dell’ebreo come appartenente alla superclasse cosmopolita detentrice del potere finanziario che si arricchisce depredando i ceti popolari. Una favola che accompagna la storia del capitalismo e che fa presa tra gli sprovveduti, fin da quando, invano, prima August Bebel e poi Lenin definirono l’antisemitismo come “il socialismo degli imbecilli”. E che ha ripreso vigore negli ultimi decenni di retrocessione dei redditi e delle tutele del lavoro dipendente. L’Europa ha cancellato, tramite lo sterminio di milioni di persone, la presenza secolare del suo proletariato ebraico. E ora vede la residua, esigua, superstite presenza di ebrei sovrarappresentata nelle cosiddette élite, cioè nelle professioni liberali, nell’industria culturale e nella finanza.
The Jewish Chronicle, il più antico settimanale ebraico in lingua inglese, ha storpiato lo slogan laburista For the many, not for the few (Per i molti, non per i pochi) in For the many, not for the jews (per i molti, non per gli ebrei). In quella assonanza tra few e jews, cioè fra “pochi” ed “ebrei”, è racchiuso il messaggio subliminale che va per la maggiore: chi sta con il popolo, ma anche chi si professa anticapitalista, non può che vedere l’ebreo come appartenente alla classe predatrice. È un argomento che serpeggia tra una parte dei militanti del Labour, infastiditi dalle accuse di antisemitismo: “Ma cosa avete da lamentarvi, proprio voi, non siete vittime, siete ricchi”.
Tale insidiosa argomentazione dovrebbe suonare familiare a noi italiani. Anche se proviene dalla sponda opposta. Avete presente? L’usuraio Soros e i De Benedetti che finanziano e propagano il “verbo immigrazionista” al solo scopo di lucrare sul “genocidio del popolo italiano”. E poi i comunisti col Rolex che lanciano falsi allarmi sul ritorno del fascismo, accomodati nelle lussuose dimore di Capalbio dove non ospiterebbero mai i profughi di cui si riempiono la bocca. Non occorre ricordare a chi appartiene questo vocabolario.
Si badi bene. Anche il fastidio suscitato dalla nomina a senatrice a vita di Liliana Segre trae alimento dal modo in cui l’ex deportata ebrea ha scelto di interpretare la sua funzione. Invece di limitarsi a testimoniare le sofferenze patite settantacinque anni fa – per le quali a parole tutti esprimono rispetto – Liliana Segre si è permessa di trarne insegnamenti per il presente: “Anch’io sono stata clandestina, so cosa vuol dire”. “Anch’io fui respinta a una frontiera, altrimenti non sarei stata deportata con mio padre”. “Mi hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero, non certo che soccorrere dei naufraghi sia reato”. Così l’ebrea torna fastidiosa, ingombrante, faziosa. Cosa vuole ancora, col lauto stipendio che incassa a spese nostre? È desolante leggere con quale compiacimento i giornali della destra sostengono che le ingiurie minacciose contro Liliana Segre fossero solo una montatura. E che, anzi, gli “ebrei perbene” condividono la loro tesi secondo cui l’unico pericolo verrebbe dagli islamici.
La destra italiana, per quanto filoisraeliana si autoproclami, abbina gli eterni cliché sui perfidi dominatori del pianeta all’indulgenza con cui minimizza le colpe del fascismo e ne ospita i nostalgici nei suoi ranghi. Ma la vicenda inglese pone una questione spinosa anche alla sinistra: è mai possibile che per tornare a sintonizzarsi con il sentimento di esclusione e con le rivendicazioni anticapitaliste delle classi subalterne, come ha cercato di fare Corbyn, sia inevitabile introiettare anche il pregiudizio antisemita e antisionista?
Gad Lerner

ISRAELE: SCACCO AL RE
L’incriminazione di Benjamin Nethanyahu irrompe sulla scena politica israeliana già in piena paralisi istituzionale. ‘Re Bibi’ rilancia e accusa la magistratura di “golpe”. Ma nel Likud già parte la fronda. Dovrà dimettersi? Gli alleati lo molleranno? Per ora nulla è certo, se non che il voto, il terzo in un anno, appare sempre più vicino.
ISPI 22 novembre 2019
La notizia era nell’aria. Eppure l’incriminazione di Benjamin Netanyahu per frode, corruzione e annunciata dal procuratore generale Avichai Mandelblit si è abbattuta sulla scena politica israeliana con la potenza di un uragano. La reazione di Netanyahu non si è fatta attendere: in conferenza stampa , ‘King Bibi’ – così soprannominato per la sua longevità politica – ha denunciato un “colpo di stato” basato su “accuse politicamente motivate” in un “momento politico delicato per il paese”. Una scelta di parole tutt’altro che casuale: il paese si trova senza un governo e in uno stallo politico che si trascina da mesi. L’incriminazione arriva subito dopo la remissione del mandato esplorativo da parte di Benny Gantz, ma prima dello scadere dei 21 giorni per lo scioglimento della Knesset, il parlamento israeliano. Con Ganz dimissionario e Netanyahu alla sbarra, si ha la quasi certezza di dover tornare alle urne per la terza volta in un anno.

Per la prima volta dalla creazione dello Stato di Israele, i leader dei due partiti maggioritari, il Likud e la coalizione Blu e bianco, non sono stati in grado di formare un governo di coalizione. Benjamin Netanyahu, attuale primo ministro uscente e Benny Ganz, hanno rimesso uno dopo l’altro a distanza di un mese il mandato esplorativo nelle mani del presidente Reuven Rivlin, ammettendo di non aver saputo dar vita a un governo di unità nazionale. Nessuno dei due è infatti riuscito ad ottenere il sostegno di Yisrael Beitenu, partito laico e ultranazionalista guidato da Avigdor Lieberman che con i suoi 8 seggi è diventato l’ago della bilancia parlamentare. Secondo la giurisprudenza, ora i deputati della Knesset hanno tempo fino all’11 dicembre per designare un qualsiasi deputato in grado di formare il governo. Se anche in questo caso tutto finisse con un buco nell’acqua, si tornerà al voto entro 90 giorni, al più tardi nel marzo 2020.
A complicare ulteriormente la situazione, nel tardo pomeriggio del 21 novembre, il procuratore generale Avichai Mandelblit ha rinviato a giudizio Netanyahu per corruzione, frode e abuso d’ufficio. Anche questo è un caso inedito: nessun primo ministro israeliano in carica, prima d’ora, aveva mai dovuto difendersi in tribunale. Le accuse rivolte al premier uscente sono tre. Il “Caso 1000” che vede Netanyahu accusato di aver accettato champagne, sigari e altri regali da facoltosi imprenditori (Arnon Milchan e James Packer) in cambio di favori. Il “Caso 2000” relativo all’intesa con Arnon Mozes, editore del quotidiano Yediot Ahronot, per una copertura giornalistica benevola, in cambio di una riduzione delle tirature di Yisrael Hayom, un giornale rivale. E il “Caso 4000”: il più delicato, sull’operato di Netanyahu come ministro delle Telecomunicazioni, e le presunte agevolazioni a Shaul Elovitch, tycoon dei media e del colosso di Internet, Bezeq. Per ottenere coperture favorevoli da parte del sito web Walla News, di proprietà della società di Elovitch – sostiene l’accusa – Netanyahu avrebbe disposto leggi e norme a beneficio economico del magnate. Ma econdo la legge israeliana, un primo ministro è tenuto a dimettersi solo se viene condannato in via definitiva. Quindi Netanyahu potrà rimanere in carica durante tutto il procedimento legale, ricorsi inclusi.
È un’immagine quasi “trumpiana” quella che vien fuori dagli atti dell’indagine, e di un premier che manipola, corrompe e piega le persone e l’interesse nazionale, per il suo tornaconto. Inoltre reazioni dei due leader “sono così simili – osserva Ishaan Tharoor sul Washington Post – che si è tentati di supporre che Trump e Netanyahu si stiano consigliando a vicenda o stiano prendendo spunti da uno stesso spin-off de “le regole del delitto perfetto”. In teoria, la differenza tra i due paesi sta nel fatto che gli Stati Uniti sono nel pieno della campagna elettorale. Ma in Israele sono in pochi a dubitare che il conto alla rovescia per un nuovo appuntamento con le urne non sia già cominciato. E che la campagna elettorale che sta per aprirsi non sarà la più velenosa e vendicativa nella storia del paese. Al punto che nel Likud già volano gli stracci: Gideon Saar, il principale avversario di Netanyahu nel partito, ha annunciato che chiederà le primarie. Sulla sua strada, Saar troverà un primo ministro ferito ma non “abbattuto” dall’incriminazione e pronto a parare i colpi in arrivo. Tra questi, anche quelli dei partiti della destra nazionalista e religiosa che da dieci anni compongono la sua coalizione, sempre più tentati di sganciarsi da un leader alla sbarra per corruzione. Nelle ultime 48 ore è accaduto di tutto. E di tutto può ancora accadere. Di sicuro, come sottolinea oggi Haaretz, “Netanyahu non se ne andrà senza prima aver dato battaglia”.
Il commento di Ugo Tramballi, senior Advisor ISPI
“L’incriminazione di Netanyahu e la paralisi politica in Israele, sono due facce della stessa medaglia. Era l’elefante nella stanza di cui fino a ieri nessuno parlava. In questi mesi, l’incertezza sulla sorte dell’attuale primo ministro è diventata l’incertezza di tutti”. “La reazione del premier mette in crisi la democrazia Israeliana. Come il suo alleato americano Donald Trump, più che a governare il paese, il premier è impegnato a garantire la sua sopravvivenza politica”.

(FAR)WEST BANK
ISPI Daily Focus 19 Novembre 2019
Con una storica e radicale inversione di rotta, gli Stati Uniti legittimano gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Il Segretario di Stato Mike Pompeo sancisce la fine del sostegno americano alla soluzione dei due stati. Ma il “Piano del secolo” per la pace in Medio Oriente ancora non si vede…
La decisione rimette in discussione 40 anni di politica estera americana, ma Mike Pompeo l’annuncia quasi en passant. Da oggi gli Stati uniti non ritengono più illegali le colonie israeliane in Cisgiordania, ha detto il capo della diplomazia americana, aggiungendo che “non ci sarà mai una soluzione giudiziaria al conflitto” e che i dibattiti su “chi ha ragione e chi ha torto, ai sensi del diritto internazionale, non favoriranno la pace”. Apriti cielo. Considerati illegali dall’Onu, dalla Corte Internazionale di Giustizia e dalla Quarta convenzione di Ginevra, gli insediamenti sono uno dei temi più ‘caldi’ del conflitto in Medio Oriente e uno dei principali ostacoli alla pace tra Israeliani e Palestinesi. Se in Israele la svolta americana è stata elogiata come “il ristabilimento di una verità storica” e “il riconoscimento di una realtà di fatto”, la reazione palestinese è quasi di sgomento: “Inaccettabile” è il commento della presidenza palestinese, per cui “Gli Stati Uniti non hanno nessun titolo per legittimare insediamenti considerati illegali dal diritto internazionale”.
| Gli insediamenti sono comunità abitate da civili israeliani e costruite nei territori conquistati da Israele dopo la guerra del giugno 1967, detta “Guerra dei sei giorni”. Nel 1979, dopo aver firmato l’accordo di pace con l’Egitto, Israele si ritirò dalle colonie in Sinai. Nel 2005 l’allora premier israeliano Ariel Sharon ordinò di smantellare quelle presenti nella Striscia di Gaza. Oggi, negli insediamenti israeliani a Gerusalemme Est e in Cisgiordania vivono circa 600.000 persone. Sono considerati illegali da tutti i maggiori organismi internazionali e contravvengono alla Quarta Convenzione di Ginevra. Nonostante le condanne internazionali, Israele ne rivendica la legittimità, negando che sia in atto un’occupazione e definendo i territori “contesi”. I Palestinesi ne chiedono a gran voce lo smantellamento poiché, argomentano mappe alla mano, le colonie creano discontinuità territoriale rendendo impossibile la creazione di due stati, uno palestinese l’altro israeliano. La posizione degli Stati Uniti sull’argomento si era finora allineata alla comunità internazionale, nella direzione indicata nel 1978 dall’allora presidente Jimmy Carter. Nel 1981 il primo a scalfire questa visione fu Ronald Regan, dicendo di non ritenere le colonie “del tutto illegali”. Da allora, gli Usa hanno adottato un registro intermedio, definendole “illegittime” ma non “illegali” e soprattutto, opponendo il veto alle risoluzioni di condanna in sede Onu. Nel suo discorso, Pompeo va oltre: non solo definisce gli insediamenti “non in contrasto con il diritto internazionale”, ma suggerisce che la questione della legittimità debba essere affrontata dai giudici israeliani, tagliando fuori la comunità internazionale. La stessa linea usata per il riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico nel dicembre 2017. Il riconoscimento, di fatto, delle colonie israeliane, offre un assist politico a Benjamin Netanyahu. Proprio l’ex premier, lo scorso settembre in piena campagna elettorale, aveva avanzato l’ipotesi di annettere le colonie allo Stato di Israele, nel tentativo di conquistare i voti della destra nazionalista. Oggi l’annuncio giunge mentre la politica israeliana è in fermento: dallo spoglio non è emerso un vincitore netto e il primo ministro incaricato, Benny Gantz, ha le ore contate per cercare di formare un esecutivo. In caso di fallimento, si ritornerà alle urne per la terza volta in un anno. Ma la tempistica dell’ennesima apertura di Trump verso Netanyahu non si spiega solo con le turbolenze interne alla politica israeliana . Anche per il presidente americano, tra le audizioni alla Camera per l’impeachment e la vittoria dei Democratici in Louisiana, quella che si è aperta ieri è una brutta settimana. La svolta repentina sulle colonie, suggerisce Ha’aretz, strizza l’occhio alla base conservatrice dei Repubblicani e agli elettori evangelici, parte fondamentale del “sionismo cristiano”. Inoltre, nelle prossime settimane, il presidente dovrebbe presentare il suo piano di pace per il Medio Oriente, di cui l’amministrazione parla da mesi con riferimento agli investimenti economici, ma finora rinviato per ben due volte. “L’accordo del secolo” ha promesso Trump, “consentirà di superare i dibattiti sterili che finora non hanno portato la pace in Medio Oriente”. Vedremo se il riconoscimento di Gerusalemme e delle colonie sortirà risultati migliori |

| “Questo endorsement appare decisamente fuori tempo rispetto alle dinamiche della politica israeliana, oggi alle prese con un difficile stallo post-elettorale. Ma risponde invece bene alle esigenze interne all’amministrazione Usa, che deve distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalle audizioni in corso per l’Impeachment e raccogliere consensi tra l’elettorato conservatore”. “Le dichiarazioni di Pompeo chiariscono comunque quale è la scelta di campo fatta da Washington riguardo alla soluzione dei due Stati. Proseguendo su questa linea Trump demolisce ogni clima di fiducia con i Palestinesi e mette una pesante ipoteca — forse pietra tombale — sulla sua ambizione, più volte sbandierata, di risolvere la questione mediorientale”. Gianluca Pastori, docente Università Cattolica, Ispi “È preoccupante che la superpotenza che – a torto o a ragione – in passato si è sempre dichiarata paladina del diritto internazionale abbia in poco tempo preso due decisioni in aperta violazione di quest’ultimo, prima sul Golan e ora sulle colonie. Sia l’occupazione delle alture del Golan sia la colonie in Cisgiordania sono infatti in aperta e universalmente riconosciuta violazione del diritto internazionale. Inoltre, negli anni passati, gli Stati Uniti facevano molte pressioni su Israele per evitare l’espansione delle colonie. Con Trump ogni stretta sull’argomento si è interrotta”. “I dettagli del piano di pace dell’amministrazione Trump per il Medio Oriente stanno emergendo alla spicciolata, anche se rimane poco chiaro quando verrà ufficialmente presentato. Prima il riconoscimento della sovranità israeliana sulle Alture del Golan e di Gerusalemme Est. Ora quello delle colonie. E poi, le promesse di ingenti investimenti nei Territori e nei paesi della regione che ospitano più profughi come Libano, Giordania ed Egitto. La percezione è che con quest’ultimo atto Trump stia cercando di rilanciare il suo piano per il conflitto Israelo-palestinese che molti credevano ormai cestinato. Facile pensare che giochi un ruolo anche l’intenzione di usare questi atti roboanti per distrarre dalle gravi difficoltà interne dell’Amministrazione ”. Eugenio Dacrema, ricercatore Ispi Medio Oriente e Nord Africa |

“Guai a voi se mi leggete sul tablet”
Il libro dei numeri di Joshua Cohen (Codice, trad. di Claudia Durastanti, pagg. 745, euro 25)
Joshua Cohen, un giovane autore che continua e ringiovanisce la migliore tradizione della letteratura ebraico americana, sulle tracce di Saul Bellow, Bernard Malamud, Philip Roth ed i più recenti Jonathan Safran Foer e Nathan Englander.

Nato ad Atlantic City nel 1980, ha pubblicato romanzi (Book of Numbers), ma anche storie brevi (Four New Messages) e saggistica per il “New York Times”, “Harper’s Magazine”, il “London Review of Books”, “n+1” e altri. Nel 2017 è stato nominato da Granta uno dei migliori romanzieri americani. Vive a New York.
Memoir, thriller, allegoria biblica, dramma, commedia: Il libro dei numeri si candida a diventare uno dei testi sacri dei nostri tempi, un’epica dell’era della rete, uno di quei rari libri capaci di spingere un po’ più in là i confini del romanzo.
Quando Joshua Cohen, scrittore newyorchese fallito, viene contattato da Joshua Cohen, il misterioso fondatore della più importante azienda tecnologica del mondo, affinché gli faccia da ghostwriter per la sua autobiografia, non sa che l’impresa in cui sta per imbarcarsi lo renderà una pedina in un gioco molto più grande di quanto immagini.
Dagli albori di internet all’11/09, passando per la Shoah, il Vietnam e l’avvento dei social network, il racconto dei due Joshua si intreccia in un alternarsi di geniali invenzioni e cocenti sconfitte, amicizie incrollabili e amori infelici, per diventare uno specchio duplice della vita ai tempi della rivoluzione digitale. In fondo, nel mondo post-Facebook, chi non può vantare almeno un avatar, un alter ego, un altro io?
Raffaella De Santis ha intervistato a settembre per Repubblica l’autore
L’americano Joshua Cohen è l’autore più originale ospite al Festival di Mantova con il suo romanzo di 700 pagine
MANTOVA – Se ci fosse un premio del Festivaletteratura per il romanzo più folle, lo vincerebbe Il libro dei numeri di Joshua Cohen, 39 anni compiuti ieri a Mantova. Il tomo – nella versione italiana oltre 700 pagine – attacca così: “Se state leggendo questa storia su uno schermo, andate a fanculo. Parlerò solo se sfogliato come si deve”. È subito chiaro quale sia il carattere dell’autore, che abbiamo avvicinato incuriositi dal seguito che avevano avuto i suoi incontri festivalieri. Cohen, nato nel 1980 in una famiglia ebraica di Atlantic City ne ha avute per tutti, a cominciare da Bruce Springsteen. Il suo libro, definito dal New York Times l'”Ulisse dell’era digitale”, narra la storia di uno scrittore fallito assoldato come ghostwriter dal capo della più importante azienda tecnologica del mondo. La particolarità è che tutti si chiamano Joshua Cohen: l’autore, il protagonista del libro e il guru hi-tech. Un gioco di specchi per dire attraverso mille rivoli che dentro la Rete ogni identità perde i confini. Il Cohen vero paradossalmente detesta i social network, non twitta, non posta, non instagramma foto. Per scrivere ha consultato più di 180 testi sulla storia di Internet, tra cui le biografie di Bill Gates, Steve Jobs, Alan Turing. È appena stato nominato da Granta uno dei migliori romanzieri americani.
Dove ha trovato il coraggio di scrivere un libro selvaggio come questo? Dentro ci si perde, ci sono mail, pezzi di interviste, blog…
“Ho sempre fatto l’opposto di quello che fanno gli altri. Incondizionatamente anche da bambino tendevo a differenziarmi. Se tutti volevano un gioco, io ne desideravo un altro. Deve trattarsi di un’attitudine psicologica, o qualcosa del genere. C’è qualcosa in me che mi spinge in altre direzioni”.
Crede che il suo romanzo verrà letto fino alla fine?
“Non saprei, sono partito dal domandarmi quale sia oggi la nozione di storia. Chi la scrive, che cosa è diventata? Ho voluto raccontare la nostra era tecnologica, prendendo le mosse dagli anni ’60 e arrivando ai social network e alle agenzie che controllano i nostri dati. Il modo migliore per farlo era affidarsi alla forma romanzesca. In fondo la tecnologia è il nostro nuovo subconscio, permette di trasformare la realtà in fiction e la fiction in realtà”.
L’hanno paragonata a David Foster Wallace, le ha fatto piacere?
“Succede sempre. Quando non riescono a dire qualcosa di originale tirano in ballo uno scrittore morto. Ammiro Wallace, ma fare questi paralleli mi sembra assurdo, denota una certa pigrizia. E poi lui aveva un senso dell’ironia tutto suo e una schiettezza molto diversa dalla mia. Era un uomo del Midwest, un’altra cultura”.
Lei è nato ad Atlantic City, la città protagonista di una delle più belle canzoni di Bruce Springsteen.
“(Ride) Ci ho vissuto diciassette anni, ho frequentato lì scuole ebraiche, poi sono andato a New York… È una bella città, sull’Oceano Atlantico. Adoro Springsteen, potrei parlare per ore della sua musica, ma su Atlantic City si sbagliava”.
A questo punto si ferma e si mette a recitare il refrain di Atlantic City: “Everything dies baby that’s a fact… But maybe everything that dies somedays come back…”.
Che cosa c’è che non va?
“Springsteen non ha colto quel senso di grandezza che hanno gli abitanti di Atlantic City. In passato era una delle città più esclusive per le villeggiature al mare, c’erano hotel magnifici. Non era particolarmente ricca, ma era signorile. Quell’idea di decoro è rimasta nella percezione dei suoi abitanti. Springsteen canta sempre le persone comuni, lo ha fatto anche in questo caso, ma ad Atlantic City tutti si sentono speciali, sognano in grande”.
Anche lei?
“Certo, come chiunque”.
Quale era il suo sogno giovanile?
“Come ogni provinciale andare a New York”.
Come è la sua vita newyorchese?
“Piuttosto normale. Scrivo ogni giorno, cambio le lampadine che si fulminano, metto a posto i calzini, lavo i piatti. Una volta alla settimana insegno alla Columbia University”.
Nel romanzo fa dire al protagonista Joshua Cohen che ama vivere nelle grandi città e odia la campagna, il verde, gli ambientalisti. È così anche per lei?
“Ora l’ambientalismo va di moda e mi chiedo perché non me ne importi proprio niente. Ma è così, non riesco a proiettarmi oltre la mia morte, oltre la scomparsa delle persone che amo”.
Che cosa pensa di Jonathan Safran Foer ambientalista, allora?
“Un bravo ragazzo”.
Il successo del “Racconto dell’Ancella” di Margaret Atwood testimonia però di un forte interesse per questi temi.
“Ma credo che l’attrazione delle persone per la serie televisiva abbia altre ragioni. La gente torna dal lavoro esausta, si mette sul divano, accende la tv e si lascia affascinare dalla violenza, dalle scene di stupri e torture. Fa parte delle natura umana: condanniamo le cose da cui siamo segretamente attratti. Il nostro inconscio è molto strano”.
Con 700 pagine voleva scrivere il Grande Romanzo Americano?
“Mi domando quale sia la vera storia americana: il racconto della schiavitù o quello dell’accoglienza degli immigrati? Io so che l’unica ragione per cui i miei genitori riuscirono ad approdare negli Stati Uniti dalla Germania e dalla Polonia è che avevano abbastanza soldi per farlo”.
È stato difficile riuscire a pubblicare il suo primo libro “The Quorum”?
“Ricordo solo che mi pagarono 50 dollari e una birra”.
L’abisso a pochi passi
Stefano Jesurum – Setirot 7 novembre 2019

Checché ne pensi qualcuno, raramente Setirot si occupa di politica in senso stretto e/o “partitico” (sfido chi dissentisse a portare prove con testi e date). Ma dopo il fiume di parole (?) seguite alla proposta – approvata a maggioranza – di una commissione su razzismo, antisemitismo eccetera firmata da Liliana Segre non mi riesce davvero di tacere. Intanto mi domando come si sia ridotta una parte della società ebraica italiana – sempre più arduo definirci comunità dopo gli scambi sui social di questi giorni. A quale infimo livello siamo arrivati. A quanto i dettami della nostra tradizione e della nostra cultura (vissuta religiosamente, laicamente o perfino da atei poco importa) siano stati bellamente buttati a mare e sostituiti da irrazionali e sostanzialmente pagane “passioni” di incubotica paura e demonizzazione dell’Altro. A come la memoria abbia scotomizzato i fascisti che vennero ad arrestare i nostri nonni e i nostri genitori, i medesimi fascisti di cui oggi fanno l’apologia non pochi di coloro che ispirano e diffondono i vergognosi attacchi alla “senatrice ebrea”. E ancora: mi chiedo quando i nostri vertici istituzionali e morali diranno un secco, chiaro, definitivo «basta!» a chi fomenta il clima di ormai vero e proprio odio intra-ebraico. Certo, qualche voce tra i nostri Maestri si leva, ma che cosa dobbiamo ancora sopportare dopo lo sterco gettato a piene mani su Liliana e sui suoi figli? Qualcuno si rende conto che l’abisso è a pochi passi? Vogliamo veramente innalzare tra noi un muro non più scavalcabile?
A proposito, ricordo ciò che disse Pier Luigi Bersani, certamente non un pericoloso e violento sovversivo, alla trasmissione Otto e mezzo commentando le frasi mostruose, agghiaccianti gridate dagli attivisti legofascisti radunatisi per “accogliere” Carola Rackete, comandante della SeaWatch3. Affermò che era preoccupato perché il clima era tale per cui se lui fosse stato presente sarebbe “scappato il cazzotto”. Ecco, inviterei a fermarsi prima delle sberle.

La sfida dei due Benjamin
Sintesi degli interventi all’Evento del 28 ottobre 2019
Poteva sembrare strano che il confronto sulla situazione politica in Israele, che lunedì 28 ottobre si è tenuto a Milano, fosse dedicato alla memoria di Andrea, un giovane di Hashomer Hatzair scomparso troppo presto. Ci ha pensato David Sonnewald , il moderatore della serata organizzata in collaborazione con Sinistra per Israele, a spiegare il legame tra la politica e la figura di Andrea, definito dagli amici un “sionista di altri tempi” per la sua disposizione naturale verso Israele, dove si era trasferito per continuare gli studi universitari, ma anche per l’ambizione di volerlo migliorare. Fin da piccolo Andrea aveva sviluppato un’inclinazione ed una determinazione per le tematiche politiche e sociali, come bene si è capito dal tema che a soli 10 anni aveva scritto per raccontare cosa avrebbe voluto fare da grande e che è stato letto all’inizio della serata.

Nella sala piena di giovani e meno giovani (almeno 160 persone) al concetto di “sionista di altri tempi “si è poi riallacciata Silvia Brasca nel suo intervento, facendo notare come Andrea non si sarebbe riconosciuto nell’ Israele di oggi, uscito dalla seconda tornata elettorale molto lontana dal sionismo storico. Ricordando ciò che aveva scritto Zeev Jabotinsky nel 1923 nel famoso saggio sul Muro di Ferro, riguardo alla sua “cortese indifferenza verso gli arabi”, Silvia ha commentato come la questione palestinese sia scomparsa dalla agenda politica di tutti i partiti. Il sionismo sembra un sogno di altri tempi, pensando anche alla legge, votata nell’estate 2018, che definisce Israele come Nazione Ebraica, in netto contrasto con quanto sanciva la Dichiarazione d’Indipendenza del 1948.

Molto interessante la lettura fatta da Lia Quartapelle nel suo intervento sulla situazione politica israeliana, che per certi versi appare non diversa da quella italiana per la necessità di coalizioni, compromessi e per elementi di corruzione. Due gli aspetti che secondo Lia colpiscono, il primo legato alla (probabile) fine politica di Netanyahu, che era l’erede ed il miglior allievo del più malvagio degli spin doctor, quel Arthur Finkelstein che aveva fatto di un principio della politica una dote terribile delle campagne elettorali: trova il tuo nemico, è quello il cuore della tua linea politica. Lo stesso principio utilizzato tra l’altro da Orban e da Salvini.
Il secondo aspetto è, secondo Lia, a sorpresa il ruolo di Avigdor Libermann, che si è eretto a difensore di un principio liberale di laicità e pluralità per quanto riguarda i vincoli dello Shabbat, che non vanno imposti a tutti, e per quanto riguarda la leva obbligatoria per tutti, senza esclusione degli ultraortodossi. Da questa posizione di doveri e libertà per tutti emerge la preoccupazione per la divisione e la contrapposizione tra religiosi e non religiosi.
Da questi due aspetti si conferma che Israele stupisce e lascia un segno di speranza, visto che da Israele arrivano sempre tendenze che precorrono ciò che può accadere nella nostra società.

Nel definire l’ebreo di Sinistra una razza in via di estinzione Gad Lerner ha fatto notare che in Israele, la Sinistra è stata quasi cancellata. Nel 1977 c’era stato un rivolgimento epocale con il rovesciamento dell’establishment askenazita laburista per effetto del voto decisivo degli ebrei orientali che si sentivano sottoproletariato. Da allora il Likud ha quasi sempre prevalso ed ancora oggi la Sinistra si è autoesclusa dal dibattito sulla questione palestinese e sulla possibilità di una pace basata sul principio dei due Stati, temi impopolari dal punto di vista elettorale, rifugiandosi nella questione sociale. Secondo Gad Lerner, Gantz non sarà in grado di formare un governo e la situazione appare bloccata. La visione politica di Netanyahu non è stata ribaltata con il secondo voto e Gad ha ricordato che ai suoi esordi politici Netanyahu aveva scritto un libro che riecheggiava la tesi del Muro di Ferro ponendo Israele al centro di un’area geopolitica con una politica di pace e stabilità basata sulla deterrenza contrapposta ad una politica di concessioni territoriali ed accordi che, secondo lui, avrebbero incentivato i vicini a minacciare lo stato. Sottomettere con la forza è tuttora l’orizzonte politico delle principali forze politiche.
Nella mancata risoluzione del conflitto tra laici e ortodossi va vista la novità più rilevante e la resistenza laica appare come positiva salvaguardia della natura democratica dello Stato.
Un altro dato interessante second Gad Lerner è stato il ritorno al voto, con un ruolo di protagonisti, degli Arabi Israeliani con la Lista Unita guidata da un leader arabo moderato e intelligente. Divenuta la terza forza politica sarebbe pronta ad un appoggio esterno ad un governo senza Netanyahu ma chiaramente nessuno li vuole.
La strategia del futuro appare la conservazione dello status quo, con ricerca di alleanze, un tempo impensabili, con i Sunniti dell’Arabia Saudita contro gli Sciiti Iraniani, prendendo tempo, anche ritardando la formazione del governo.
Molto dettagliato sui 5 dossier d’accusa contro Netanyahu è stato l’intervento di Gabriele Eschenazi. Per la prima volta un Primo Ministro in carica è stato accusato di frode, abuso d’ufficio e corruzione. Oltre ai noti casi di regali di valore e spese pazze della sua famiglia, Gabriele ha spiegato l’ossessione del Premier verso i giornalisti ed i media in generale, con il suo continuo tentativo di condizionare in modo fazioso l’informazione, usata anche come moneta di scambio. Questo comportamento ha gettato discredito non solo sul suo destino politico ma anche sulla libertà di stampa.

In passato Israele era ricchissimo di giornali di ogni lingua, tendenza, opinione religiosa e laica. La crisi della stampa è stata acuita dal tentativo di Netanyahu di avere una stampa ed i media schierati in favore suo e della sua famiglia. Emblematico il caso del giornale gratuito Israel Hayom, di proprietà del miliardario americano Sheldon Adelson, puro esempio di propaganda politica su cui Netanyahu ha un controllo e può decidere di far pubblicare articoli contro i suoi avversari politici.
Edmondo de’Donato 8 novembre 2019

Ben Yitzhak, che resuscitò l’ebraico: “Saremo contadini come tutti gli altri”
Stefano Jesurum – Gli Stati Generali 23 Ottobre 2019

Quando Anna Linda Callow mi regalò “Poesie” di Avraham Ben Yitzhak (nato Abraham Sonne, settembre 1883, Przemyśl, Polonia – maggio 1950, Israele) sapeva bene che i versi non sono esattamente nelle mie corde. Ma da sensibile conoscitrice dell’animo umano qual è, oltre che fine ebraista e ottima traduttrice, credo sapesse di fare centro. Non tanto perché le poche liriche che ci ha lasciato il canettiano dottor Sonne de “Il gioco degli occhi” sono piccole gemme, bensì soprattutto perché questo libriccino curato da Callow medesima e Cosimo Nicolini Coen, pubblicato da Portatori d’acqua, contiene il potente saggio di Lea Goldberg “Incontro con un poeta”. Lea Goldberg, poetessa a sua volta, scrittrice, per me e non soltanto, amata intellettuale, è, per intenderci, l’autrice di queste semplici parole che a mio avviso racchiudono l’essenza più intima delle identità plurime: «Forse solo gli uccelli migratori / sospesi tra terra e cielo conoscono / il dolore per due patrie».
Impossibile fare sintesi di quanto Lea provò, sentì, capì, e racconta di quell’uomo, raro, che visse una esistenza di semina e non di mietitura. Come per altro lui stesso comunica negli ultimi versi pubblicati: «Beati coloro che seminano e non mietono / perché vagheranno più lontano. / Beati i generosi la cui splendida giovinezza / aumentò la luce dei giorni e la loro prodigalità / e si spogliarono dei propri ornamenti – sui crocevia. / Beati i fieri la cui fierezza oltrepassò i confini della loro anima / e diventò come l’umiltà del biancore / dopo il levarsi dell’arcobaleno in mezzo alle nuvole. / Beati quelli che sanno che il loro cuore griderà dal deserto / e sulle loro labbra fiorirà il silenzio. / Beati loro perché saranno raccolti nel cuore del mondo / coperti dal manto dell’oblio / e la parte loro riservata sarà il “tamid” senza parole». (Il tamid è il sacrificio quotidiano che veniva offerto nel Tempio di Gerusalemme).
Avraham Ben Yitzhak, uno di coloro che alla lingua ebraica ha letteralmente ridato la vita. Come scrivono i curatori: «L’ebraico in grado di assolvere al compito di “ascoltare le fondamenta del mondo” è una realizzazione del sionismo – una conquista politica – soltanto nella misura in cui tale ascolto non è condizionato, o non oltre una certa soglia, dai contenuti del sionismo stesso». Adesso torniamo all’Avraham di Lea, non certo ciò che si dice una personcina socievole. «Chiunque l’abbia conosciuto ne ricorda i lunghi silenzi, che a volte arrivavano all’improvviso, e a volte avevano il potere di zittire un’intera brigata di persone particolarmente esuberanti. Talvolta, se si trovava in compagnia di un individuo che non incontrava il suo favore, o se veniva espressa un’osservazione che non era di suo gusto, tutt’a un tratto sprofondava in quel silenzio duro e renitente (e come ho detto: “serrava il viso con il chiavistello”)». Poteva però essere affettuoso, umano, vicino, paziente con le persone semplici che gli erano care, in particolare con i bambini. Sì, la cifra umana del dottor Sonne è stata l’ostinato e tragico silenzio, il ripudio. Annota Goldberg che pronunciata da lui «la parola “loro” si caricava di un disprezzo profondo, sferzante. Senza fare nomi, senza rivelare a chi di fatto si riferisse, storceva un po’ la bocca, strizzava gli occhi da dietro gli occhiali e diceva: “Loro”, ovviamente questo non lo capiscono”. “Loro” era il simbolo della routine, dell’ottusità, il simbolo di quell’autocompiacimento, di quella soddisfazione spirituale e mancanza di impegno che detestava. Quel suo “loro” aveva una strana qualità: a volte avvicinava, altre allontanava. Vi erano casi in cui sentivi che ti stava parlando come a qualcuno in grado di capirlo, di seguire il suo ragionamento sino alla fine, di stare insieme a lui nel campo in cui “loro” erano estranei; e ve n’erano altri in cui finivi incluso nel “loro” e ti assaliva un senso di colpa e disperazione, mentre lui era lì, davanti a te, nella sua solitudine e inaccessibile indipendenza».
Sognatore, anche, Ben Yitzhak. Da poco arrivato in terra d’Israele, seduto con Lea si mise a chiacchierare del rapporto degli ebrei con la natura, del fatto che erano distaccati da quelle sensazioni di vicinanza alla terra provate da ogni popolo che lavori i propri campi da secoli. «Ma spero che la situazione cambi. Oggi ero nella Commissione agricola, e uscendo di lì ho visto un ragazzo e una ragazza che camminavano mano nella mano, proprio come una giovane coppia del Tirolo, o della Stiria, con gli stessi gesti, ed è stata una sorta di testimonianza di una vita ebraica differente, del fatto che saranno contadini come quelli di tutto il mondo».
Così ho finito di leggere “Poesie” e ho pensato una cosa sola, semplice: come si fa a non commuoversi e a non amare l’Avraham Ben Yitzhak di Lea Goldberg? E pensate che qui vi ho riportato un milionesimo delle emozioni provate…
Stefano Jesurum

Inventarsi il passato. La Polonia, per esempio
David Bidussa Gli Stati Generali 21 Ottobre 2019

“Allora ricostruiamo quello che sappiamo per certo”. È l’invito che Anna Bikont rivolge, nell’ultimo capitolo del suo libro, al procuratore Radosław Ignatiew, dell’Istituto della memoria nazionale, incaricato dal governo polacco, all’indomani della pubblicazione di Neighbors, di Jan T. Gross il libro che nel 2000 ha rotto il silenzio sui massacri di ebrei in Polonia nell’estate 1941, in particolare nella zona orientale del paese.
Radosław Ignatiew: “Sin dalle prime ore del mattino [il10 luglio 1941, a Jedwabne, 170 km circa a NE di Varsavia, n.d.r.] gli ebrei furono trascinati fuori dalle loro case e portati nella piazza del mercato. Fu ordinato loro di strappare le erbacce che crescevano tra le pietre del selciato. Gli abitanti di Jedwabne e dei villaggi vicini erano armati di bastoni, spranghe e altro. Un gruppo numerosi di uomini fu costretto a demolire la statua di Lenin che si trovava in una piazzetta vicino al mercato. Verso mezzogiorno fu ordinato loro diportare un pezzo del monumento demolito prima nella piazza e poi in un fienile distante alcune centinaia di metri. Lo portarono usando due pali di legno. Tra loro c’era il rabbino. Vennero uccisi e i loro corpi gettati in una fossa scavata all’interno del fienile. Sui corpi furono gettati dei pezzi della statua di Lenin. La fossa probabilmente non fu ricoperta, perché nel corso dell’esumazione sono stati trovati segni di bruciature su alcuni pezzi della statua. Un secondo gruppo di ebrei, più numeroso, fu portato via dalla piazza più tardi. Tra loro c’erano donne, bambini e anziani. Furono condotti al fienile, che era di legno con il tetto di paglia. Sull’edificio venne versata della benzina, che probabilmente proveniva sa un ex magazzino sovietico di Jedwabne”
Anna Bikont: “Questo significa che prima di morire le persone del secondo gruppo videro i corpi massacrati dei propri padri, fratelli, figli?
Radosław Ignatiew: È possibile.
Anna Bikont: “Sei stato in grado di ricostruire gli ultimi passi degli ebrei di Jedwabne? Sapevano di andare incontro alla morte?
Radosław Ignatiew: “Tra i resti sono stati trovati oggetti di uso quotidiano, come una scatola con chiodi da calzolaio, ditali da sarto, cucchiai, monete d’oro e un numero sorprendente di chiavi: di cancelli, case, lucchetti, armadi. Come se le persone avessero la speranza, illusoria, di avviarsi per una strada dalla quale un giorno sarebbero tornate indietro”. [Bikont, pp.514-515]
È solo una parte dell’intervista che chiude il lungo libro di Anna Bikont, dove tutti i tasselli che lentamente la giornalista di “Gazeta Wiborcza” (il più importante quotidiano polacco fondato nel 1989 da Adam Michnik) ha raccolto intervistando (spesso con risposte offensive, porte sbattute in faccia, rifiuti, insulti) tutte le voci ancora in vita della scena di quel 10 luglio 1941, ma anche i loro figli, i loro nipoti, il parroco del paese, Edward Orłowski, il vero organizzatore del sentimento popolare.
Alla fine, il quadro è chiaro. Ma la grande maggioranza dei polacchi di Jedwabne, a cominciare dal parroco fino al sindaco, per non dire la maggioranza dei polacchi di tutta la Polonia crede a Jedwabne gli ebrei siano stati uccisi dai tedeschi; crede che la loro morte comunque sia stata una punizione per aver collaborato con gli occupanti sovietici tra settembre 1939 e giugno 1941, e crede che quel rimestare il passato, risponda a un solo obiettivo :far pagare i polacchi per responsabilità non loro, e ricattarli per avere soldi. In breve, l’ennesimo complotto giudaico per sottomettere e schiacciare la Polonia in una condizione di servitù al fine di per impedirle di diventare “nazione libera”.
Così tra il 2001 e il 2004 (gli anni in cui Anna Bikont costruisce e raduna il materiale e da corpo a questo suo libro).
Ma così anche oggi, in questo nostro oggi, ottobre 2019.
Intorno a ciò che accade in quella parte di Polonia che a partire dal 22 giugno 1941 viene occupata dall’esercito tedesco, mentre le forze dell’Armata Rossa di ritirano confusamente e precipitosamente è abbastanza chiaro: il tipo di occupazione tra fine settembre 1939 e giugno 1941 è stata avvisata dai polacchi come invasione, come tentativo di rovesciare e cambiare radicalmente la natura della identità polacca. Per la maggior parte dei polacchi l’arrivo dell’esercito della Germania nazista non era avvisato come una minaccia dello stesso tipo. Non c’era simpatia, ma per certi aspetti i nuovi venuti erano anche percepiti come liberatori.
Dentro a questa dinamica complicata, con cui ancora molti devono fare i conti, compreso noi che da questa parte dell’Europa, guardiamo quei fatti, si collocano vari episodi di pogrom e poi di massacro nei confronti degli ebrei locali.
Per la precisione: un pogrom è essenzialmente un attacco alle case, un furto più o meno sistematico delle proprietà e raramente, o occasionalmente, l’uccisione di persone. In altre parole, il suo obiettivo principale non è uccidere (anche se non è escluso). Un massacro, invece, è un atto che ha come obiettivo la vita delle persone e si propone la loro uccisione.
Dunque, nei giorni compresi tra l’ultima settimana di giugno e le prime due settimane di luglio 1941, avvengono vari episodi di pogrom che si trasformano in massacri. L’episodio più noto di tutti (anche se, per divenire episodio noto sono stati necessari 60 anni e che Jan T.Gross, lo raccontasse) accade a Jewadbne, tra il 10 luglio 1941.
Il libro di Anna Bikont è una paziente inchiesta intorno a quei fatti, mosso dalle reazioni che in Polonia si scatena nell’estate 2000 all’uscita del libro di Gross in polacco.
Si potrebbe leggere quel libro come un documento storico collocato in un tempo preciso (e sarebbe già significativo).
Ma il fatto è, invece, che quel libro, consente di capire molti elementi del nostro oggi, 2019.
Ovvero per dirla esplicitamente: a un lettore di oggi, quel testo non appare un’inchiesta datata intorno a un episodio di storia di circa 80 anni fa, ma assomiglia di più alla traccia archeologica del nostro tempo.
In questo senso il libro di Anna Bikont va letto come un’immersione nella “la pancia” dell’opinione pubblica in Polonia. Più precisamente è contemporaneamente, l’archeologia, ma anche la genealogia e la descrizione dei sentimenti della Polonia di oggi (ottobre 2019)
La prima edizione del libro è del 2004, ma il fatto che arrivi oggi in Italia, nel 2019 (l’edizione americana è del 2015) non lo rende un libro superato.
In breve, Anna Bikont con 15 anni di anticipo, rispetto alla nostra consapevolezza, ma in tempo reale rispetto alle dinamiche che in Polonia prendevano corpo nel primo quinquennio di questo nostro secolo, descrive stati d’animo, emozioni, convinzioni, che oggi noi riconosciamo nelle forme del linguaggio sovranista, ma che hanno radici profonde, e non sono figlie della delusione delle politiche dell’Unione Europea, della crisi economica (anche se si servono di questi riferimenti nella loro propaganda quotidiana).
Quelle parole, quelle metafore, quel linguaggio, e quell’immaginario -in breve quel sentimento diffuso e quella convinzione radicata – sono figlie ed espressione di un apparato culturale, mentale, emozionale, prima ancora che ideologico, che ha una sua lunga storia nella tradizione culturale europea tra prima Età moderna e XX secolo.
Un codice che si nutre dell’antigiudaismo cattolico e dalla convinzione che la presenza ebraica in Europa sia un elemento di disturbo, comunque sia un corpo estraneo da sottomettere e rappresenti sempre la “quinta colonna” di un potere e di un nemico, il cui fine è sottomettere gli “indigeni” (la campagna contro Soros non è che l’ultima espressione di questo paradigma politico e culturale). Un nemico che ha in animo di sottomettere i buoni “venerdì” nazionali e che di solito è collocato immediatamente al di là del confine orientale.
Un nemico da cui occorre proteggersi erigendo muri e il cui fine è distruggere l’Europa cristiana.
Una convinzione fondata sul panico che vede nemici ovunque e la cui matrice originaria è una visione autoassolutoria della storia.
Anche questa una scena già vista molte volte nella storia d’Europa, non solo in Polonia.
David Bidussa

Israele: da Netanyahu a Gantz, il governo che verrà
Claudi Vercelli – Joimag 23 Ottobre 2019
La situazione politica attuale e i suoi protagonisti in un’analisi dei prossimi equilibri nazionali

La politica israeliana sembra essere diventata un tavolo da ping pong. La pallina dell’incarico di governo va da una parte all’altra ma, a rigore di metafora, è possibile che presto venga fermata dalla rete divisoria. Dopo di che, se ciò dovesse succedere, e lo si saprà nel qual caso entro quattro settimane, i giocatori saranno rimandati alle urne. Con quali potenziali risultati è prevedibile il dirlo, poiché ciò che il Paese sta vivendo è uno stallo che è assai improbabile che gli elettori possano sciogliere. Il numero magico, cabalistico è 61, la quantità di deputati della Knesseth necessari per garantirsi la maggioranza parlamentare. Minima. È la soglia della speranza e del desiderio. Ma sembra un miraggio.
Benjamin Netanyahu, premier incaricato, ha resistito fino all’ultimo, cercando in qualche modo di trovare una soluzione plausibile, soprattutto a se stesso. Ma dinanzi al rifiuto dei suoi potenziali alleati, ha dovuto gettare la spugna. Ora tocca a Binyamin Gantz, leader di Kahol Lavan. Il quale dovrebbe però riuscire nel difficilissimo equilibrismo di garantirsi maggioranze mutevoli, tra la destra di Yisrael Beiteinu e la Join List dei quattro partiti arabi. In altre parole, un esecutivo di minoranza che raccolga, di volta in volta, i voti parlamentari che gli mancano, pescando tra gli schieramenti opposti. Questa è l’ipotesi prefigurata come unica chiave alternativa al governo di unità nazionale, oggi non più tra destra e sinistra (come negli anni Ottanta, quando Likud e Labur dovevano trovare dei terreni comuni di intesa) ma tra destra e centro-destra. Poiché Netanyahu e Gantz sono posizionati su quest’asse, posto che gli equilibri politici, anche in Israele, in questi ultimi vent’anni hanno trovato il loro bilanciamento sempre di più verso questa parte dello spettro politico. Dopo di che, qualora non intervenga un fattore del tutto inedito, senza quindi varare un esecutivo, i giochi si chiuderanno.
In questi ultimi giorni, un Netanyahu sempre più affannato ha accusato i suoi interlocutori di coltivare l’intento di tradire il mandato di una consistente parte degli elettori, prefigurando scenari a suo dire molto problematici per Israele: l’ipotesi di partiti arabi nella maggioranza di governo (non però con incarichi ministeriali) è presentata come una prospettiva poco o nulla gradevole, soprattutto per l’elettorato conservatore. La risposta di Yair Lapid, numero due del partito Blu e Bianco, non si è fatta attendere, avendo rimarcato che il premier incaricato «ha fallito ancora una volta; sembra essere divenuta un’abitudine». Sarcasmi a parte, la situazione è obiettivamente delicata. Perché Israele si trova in queste condizioni? Può andare avanti ancora per molto essendo entrata, almeno da aprile (in realtà già da prima), in una lunghissima fase interlocutoria, dove la vera posta in gioco sembra lo sfibrare gli avversari piuttosto che il costituire un esecutivo?
Le risposte sulle ragioni dell’attuale situazione possono essere molteplici. Alcune sono strettamente endogene, legate a questioni interne alla società e alla politica nazionale. Altre, invece, si inquadrano in una dinamica molto più ampia, che sta interessando i paesi a sviluppo avanzato. Il fuoco del conflitto politico in Israele è l’estromissione di Netanyahu dal ruolo attivo che fino ad oggi ha mantenuto, quindi dal premierato. Si tratta di una volontà piuttosto diffusa, trasversale, in parte dichiarata apertamente (Kahol Lavan e Avigdor Lieberman), in parte coltivata silenziosamente (ad esempio dentro una parte del Likud). Il suo ruolo di decisore supremo piace sempre meno. Come anche alcuni lettori di questa testata hanno rilevato, l’assunzione delle deleghe di ben quattro dicasteri nella sua persona (e in quella di sua moglie, vera e propria ghostlady della politica israeliana) ha accentrato enormemente il processo decisionale, riducendo i margini di collegialità, e quindi di contrattazione tra le diverse componenti dell’esecutivo. Nel crescente malcontento, al limite della maretta, di queste ultime, dinanzi alle farraginosità, alle discrasie e al solipsismo di un «Re Bibi» che si vorrebbe ancora alla guida di un Paese che, a fronte dei molteplici risultati positivi in economia misura, però, una crescita molto marcata delle diseguaglianze interne e dei divari di trattamento retributivo. Un fenomeno peraltro in linea con gli indirizzi prevalenti nei paesi a sviluppo avanzato. Anche in ragione di ciò, ossia della netta impressione di non essere tutelati nei propri interessi materiali, è quindi derivato un silenzioso esodo di elettori, quanto meno la componente meno identitaria e radicalizzata, dal Likud verso il partito di Gantz. Laddove un altro punto di dissidio è la compiacenza che Netanyahu esprime sul piano politico (ma anche nelle scelte economiche che ha potuto determinare o avallare tramite il suo premierato) verso l’ultraortodossia e la destra più radicale, mettendo a rischio, secondo una parte cospicua dei suoi critici, il tradizionale ancoraggio laico del Likud. In realtà, per ciò che concerne quest’ultino fenomeno, più che una opzione ideologica – ossia uno spostamento della posizione politica del capo del governo uscente verso le fazioni più estreme – in tutta plausibilità è in atto un meccanismo di scambio, laddove Bibi ha cercato di fidelizzare il consenso parlamentare intorno alla sua persona, nel tentativo di ottenere l’immunità per i possibili processi a venire.
Una cosa è certa, ossia che la perdita della leadership gli comporterà l’esclusione dai giochi politici più importanti. Il che, sommato alla gragnuola di colpi giudiziari con l’incriminazione che si intravede all’orizzonte, costituirebbe la linea del fronte del suo tramonto, non solo sul piano istituzionale (governo) ma anche partitico. Lo sa benissimo e, in tutta probabilità, a questo punto lotterà con le unghie e con i denti per impedire a Gantz di raggiungere, al suo posto, l’accordo per un governo di unione nazionale tra Kahol Lavan e Likud, auspice Yisrael Beiteinu. Non potendo fare lui il capo dell’esecutivo, cercherà di escludere gli altri. In realtà, lo scenario a venire, a questo punto, poco dipenderà dalla sua volontà oppositiva e molto dalla capacità degli altri attori politici di trovare un nuovo terreno d’intesa. Quanto il Likud sia quindi disponibile ad abbandonare colui che dal 1996 ne determina l’indirizzo di fondo, è uno degli scogli con i quali i suoi avversari dovranno fare i conti. Si tratta di un transito non solo di leadership ma di indirizzo politico profondo, tutto da metabolizzare, a fronte della mancanza di una figura forte (ossia credibile) a destra che possa coprire il vuoto che altrimenti si apre.
Il Likud, in questi anni di “Bibimania”, ha subito al suo interno diverse secessioni, frutto sia del contrasto con un leader che non ammette repliche e neanche compartecipazioni ma solo patti di desistenza, sia della trasformazione di posizionamento di una parte della classe dirigente della destra (si veda, solo per citare i nomi più noti, i casi di Ariel Sharon e Tzipi Livni). Al di fuori d’Israele, un fattore che ha una sicura incidenza nelle dinamiche del Paese è la ricaduta di lungo periodo di quello che può essere definito come il ciclo populista (usiamo questo aggettivo in mancanza di altre espressioni più consone a definire una situazione caratterizzata dal messaggio diretto agli elettori, dalla leadership carismatica, dalla sostanziale diffidenza verso un sistema di pesi e contrappesi), il quale spezza la capacità coalittiva in sistemi elettorali proporzionalistici, qual è quello israeliano. E ad alimentare questo ciclo, facendosene alfiere (e potenziale beneficiario), è stato lo stesso Bibi, confidando sulla sua capacità di fare alleanze e sullo svuotamento della sinistra (cosa che nelle ultime elezioni si è verificato solo in parte).
Sullo sfondo si pongono gli Stati Uniti di Donald Trump, la crescente imprevedibilità di una presidenza che sta mutando le coordinate di presenza ed intervento in Medio Oriente, all’interno di una regione che sta a sua volta trasformandosi. Netanyahu si è fatto garante del rapporto diretto, se non privilegiato, con gli Stati Uniti di «The Duck». Ma nel momento in cui la chioma gialla sembra seguire più il corso dell’opportunità immediata che non quello della coerenza di lungo termine, il rischio di rimanere con il cerino in mano, bruciandosela elettoralmente, è sempre più pronunciato. Anche questo è un elemento che sta incidendo sul piano politico. La condotta della Washington presidenziale rispetto ai curdi siriani lascia a dire poco perplessi molti israeliani.
Vedremo quindi, nelle settimane a venire, cosa ne potrà derivare. Inseguendo la corsa della pallina sul tavolo del confronto tra i diversi national players. Finché l’arbitro Reuven Rivlin, il “buon padre di famiglia” che garantisce gli equilibri istituzionali, non interverrà in un senso (varo del nuovo esecutivo) o nell’altro (elezioni).
Claudio Vercelli
Torinese del 1964, è uno storico contemporaneista di relazioni internazionali, saggista e giornalista. Specializzato nello studio della Shoah e del negazionismo (suo il libro Il negazionismo. Storia di una menzogna), è esperto di storia dello stato di Israele e del conflitto arabo-israeliano.

L’ultima intervista, il nuovo libro di Eshkol Nevo
Invito alla presentazione del più recente bestseller dell’autore israeliano Eshkol Nevo. L’autore incontra i lettori lunedì 21 ottobre ore 18:30 La Feltrinelli Piazza Duomo Milano

Un tempo mi alzavo felice e oggi mi alzo triste. Così comincia questo struggente e feroce romanzo in cui uno scrittore mette a nudo il suo cuore. Sulla scia di grandi autori quali Nabokov e Roth, l’acclamato autore Eshkol Nevo nel suo nuovo romanzo L’ultima Intervista (Neri Pozza), ci mostra come la vita stessa di uno scrittore possa diventare autentica letteratura. E’ un’intima confessione e, al contempo, un romanzo sorprendente, audace e assolutamente avvincente. Interviene Malcolm Pagani.

Lo scrittore Eshkol Nevo è nato a Gerusalemme nel 1971 ed è il nipote di uno dei padri della patria di Israele, Levi Eshkol, che fu il terzo Primo Ministro del Paese dal 1963 al 1969. Eshkol è cresciuto tra Gerusalemme ed Haifa e Detroit negli Stati Uniti. Dopo aver studiato Psicologia lavora come pubblicitario ma dopo qualche anno si dedica alla scrittura e all’insegnamento. Considerato allievo di Amos Oz ha scritto libri molto intensi a partire dal primo Nostalgia del 2006 , a cui hanno fatto seguito La simmetria dei desideri (2010) , Neuland (2012), Soli e perduti (2015). Nel 2017 ha pubblicato Tre piani , romanzo in cui riemergono gli studi di psicologia di Nevo: racconta infatti le vicende degli abitanti di una palazzina di tre piani che rispecchiano in realtà la dimensioni della psiche secondo la tesi freudiana Es, Ego e Super Ego. Da questo libro Nanni Moretti sta girando un film con Margherita Buy che sarà nelle sale nel 2020.
Nel 2018 ho avuto la fortuna di partecipare ad un incontro a Milano con Eshkol Nevo presso la Fondazione del Corriere della Sera. In quella occasione è stato citato e commentato un bellissimo racconto di Nevo che era stato pubblicato sulla Lettura il 25 giugno 2017, dal titolo L’abbraccio silenzioso. Il racconto parla di uno scrittore (chiaramente di sinistra) che viene invitato a parlare in un insediamento di ebrei (non chiaramente ortodossi). Alla fine dell’incontro, a causa del blocco della strada per un allarme terroristico, è costretto a trattenersi a dormire lì a casa di Iris, la bibliotecaria. Lei è vedova con tre figli, il marito pugnalato al petto a 34 anni. Nel buio della notte notte un corpo solitario scivola accanto allo scrittore e si scioglie in una stretta di calore , ma non era il corpo di Iris , era più piccolo. Era il corpo di di suo figlio Nimrod, orfano del padre pugnalato due anni prima da quelle parti, sulle colline della Samaria.

Invito all’Evento Israele: la sfida dei due Benjamin
Confronto sulla situazione politica israeliana in memoria di Andrea Cabibbe .
Abbiamo il piacere di invitarvi al Convegno sulla situazione politica israeliana che si terrà il 28 ottobre p.v. alle ore 21 al Circolo El Salvadanee in via De Amicis 17 , Milano.
L’iniziativa è promossa da un gruppo di ragazzi cresciuti nella Hashomer Hatzair, per onorare la memoria del loro compagno Andrea Cabibbe.
Ne discuteranno i giornalisti Silvia Brasca, Gabriele Eschenazi, Gad Lerner e Lia Quartapelle , Capogruppo PD alla Commissione Esteri della Camera dei Deputati.
Si prega di confermare la partecipazione con un’email a: dibattitoisraeleperandrea@gmail.com

I GIUSTI, IL PIÙ ALTO LIVELLO DI UMANITÀ” intervista a Lizzie Doron
In occasione dell’inaugurazione il 6 Ottobre 2019 del nuovo Giardino dei Giusti dopo i lavori di riqualificazione (e le polemiche che hanno accompagnato questa riqualificazione) pubblichiamo l’intervista alla scrittrice Lizzie Doron realizzata nel 2014 da Martina Landi, Redazione Gariwo
Lizzie Doron è nata in Israele da genitori sopravvissuti
all’Olocausto, ed è cresciuta in un quartiere a sud di Tel Aviv, Bitzaron,
popolato dai reduci dei lager nazisti. Proprio questo luogo fa da sfondo ai
suoi libri, che hanno riscosso un grande successo di pubblico e di critica e
hanno vinto numerosi premi, tra cui il premio Buchman di Yad Vashem.
L’abbiamo incontrata durante la sua permanenza a Milano in occasione del
Festival della cultura ebraica Jewish and the City, per discutere di memoria e
parlare di Giusti, che lei definisce “il più alto livello di umanità”.
Lei afferma che i Giusti tra le Nazioni sono il più alto livello di umanità. Gariwo, attraverso il loro esempio, cerca di raccontare il Male parlando di storie di Bene. Secondo lei qual è il ruolo dei Giusti nell’educazione dei giovani?
Non sono molto ottimista sul fatto che
noi possiamo cambiare la tendenza del mondo: il male e l’odio sono uno dei
principali comportamenti dell’essere umano. Penso tuttavia che le storie dei
Giusti sono uno dei modi principali per fornire ai giovani un’altra prospettiva
delle opzioni dell’essere umano. Credo che raccontando le loro vicende si
riesca a mostrare che, anche nei giorni più bui della storia, è sempre
possibile fare una scelta. E questo è molto importante.
Seguendo l’esempio di Yad Vashem e del Giusti della Shoah, Gariwo ha
istituito una Giornata europea per onorare i Giusti di tutti i genocidi. Cosa
ne pensa?
Sono una grande sostenitrice dell’importanza di ricordare i Giusti, prima di tutto per un motivo che riguarda la mia esperienza personale. Pochi anni fa ho scoperto che mia madre, dopo l’Olocausto, decise di tornare in Polonia per testimoniare in favore di un ufficiale delle SS. Si recò in tribunale e chiese ai giudici di risparmiargli la vita, dal momento che l’uomo l’aveva salvata durante la guerra. Purtroppo non conosco i dettagli di questo episodio, perché mia madre non me ne ha mai parlato. Ho però ritrovato alcuni documenti relativi alla sua testimonianza grazie a un’amica. In seguito a questa vicenda alcuni sopravvissuti all’Olocausto si sono arrabbiati con mia madre, perché sostenevano che l’ufficiale avesse compiuto tante azioni negative, e che una sola cosa buona non fosse abbastanza. Mia madre tuttavia sosteneva la necessità di incoraggiare persone e comportamenti come questo, ed era davvero orgogliosa di quello che aveva fatto per salvare quell’uomo. Quando ho scoperto questa storia ho capito perché per tutta la vita lei ha insistito sull’importanza di raggiungere il più alto livello di umanità, sostenendo che la vera prova nella vita di una persona – soprattutto nei momenti più difficili – è di cercare di essere coraggiosi abbastanza per essere giusti.
Qual è il significato di “fare memoria” per lei? E quale il senso della memoria della Shoah?
La memoria di per sé è qualcosa di passivo, e può anche portarti indietro. Per me le memorie sono pietre miliari che devono servire per tornare indietro nella storia e capire cosa è successo, per poi permetterti di cercare di cambiare qualcosa, di combattere nel tempo presente e costruire un futuro diverso. Le memorie non sono solo storie, non sono solo qualcosa che deve toccare il tuo cuore, farti piangere e creare empatia, ma sono importanti strumenti per guardare avanti. Io scrivo sul passato non perché ho qualcosa di speciale da ricordare o un trauma da superare. Uso il passato per cercare di migliorare il futuro.
Oggi ci sono leggi che istituiscono Giornate della Memoria, celebrate in molti Paesi. Cosa pensa di queste ricorrenze? Possono essere uno strumento utile per i giovani, o possono portare al rischio di banalizzare la memoria?
Credo che entrambe le opzioni siano rilevanti, e dobbiamo combattere contro questa celebrazione e “banalizzazione della memoria”. Dobbiamo anche essere molto creativi: forse mettere in risalto le storie dei Giusti lasciando il male alle nostre spalle può servire a cambiare qualcosa.
Secondo lei esiste un solo modo per parlare della Shoah?
Per risponderle voglio raccontarle un episodio veramente molto interessante che mi è capitato in Italia. Era il 27 gennaio dell’anno scorso. Io ero a Forlì, per le celebrazioni della Giornata della Memoria, e ho visto tantissimi cittadini sfilare dalla casa ebraica al comune per giurare che “mai più” si dovesse verificare una cosa del genere a causa di una religione, di un gruppo etnico o di altri motivi. Ho trovato che questo fosse uno dei modi migliori per commemorare la Giornata, con una promessa per il futuro e non solo con il ricordo del passato. Credo infatti in un modo innovativo di fare memoria, che deve essere creativo e stimolante per i giovani, e avere dentro di sé il seme della speranza di poter cambiare qualcosa.
Durante la Giornata della Memoria spesso sentiamo ripetere le parole “mai più”…
Credo che queste parole siano diventate degli slogan vuoti. E se ci sono solo slogan, ci si ricorda di quanto è avvenuto solo durante le ricorrenze, e poi la memoria scompare. Non amo questo tipo di discorso perché penso agli slogan come a qualcosa che tende a coprire, che spesso può far sentire bene ma che in realtà non serve per costruire un futuro diverso.
Pensa che la memoria della Shoah possa essere utile nella prevenzione di altri genocidi?
Credo che, in generale, per essere attratti da qualcosa si ha bisogno di un lieto fine, di una bella storia, di credere o sperare di poter fare la stessa cosa. I Giusti quindi sono buoni esempi da seguire. Ritengo che rappresentino il massimo livello dell’umanità, perché insegnano l’importanza del compiere una scelta e, non limitandosi a predicare di non fare il male, mettono in evidenza valori alternativi. Possiamo quindi usare i Giusti come esempio per noi, ma anche come “strumento”. Di fronte al male, infatti, ci si sente confusi, si pensa di non poter far nulla, si vuole solo scappare, e in questo contesto i Giusti possono essere la luce che indica la via.

Nei suoi libri le donne – e in particolare sua madre – hanno un ruolo centrale. Può spiegarci il motivo?
Sicuramente questo deriva dalla mia
esperienza personale. Sono cresciuta in un quartiere di sopravvissuti alla
Shoah, e quello che mi colpiva era che tutte le donne erano più forti degli
uomini. Gli uomini andavano a lavorare, ma erano le donne ad insegnare ai
bambini i valori della vita. Mia madre poi era una persona davvero
forte, sapeva che avrei capito quello che mi insegnava e mi diceva. Non parlava
mai dell’Olocausto, e credeva davvero che i Giusti fossero uno degli esempi che
io avrei dovuto comprendere profondamente. Mi diceva che, anche se comportava
il rischio della vita, era quello il modo in cui gli esseri umani dovrebbero
comportarsi.
Un altro aspetto interessante è legato al coraggio delle donne del
quartiere dove sono cresciuta. Israele doveva combattere per la propria libertà
come nazione, e per farlo avevamo bisogno di soldati e potere. Tuttavia nel mio
quartiere nessuno dei sopravvissuti all’Olocausto, specialmente le donne,
accettava questa idea che essere forti significasse necessariamente essere il
vincitore. È molto interessante questa presa di posizione, perché era una sorta
di ribellione contro il pensiero canonico della nazione israeliana. Io stessa
ne ero sorpresa a quei tempi, ma quando sono cresciuta ho realizzato di aver
avuto leader eccezionali in quel piccolo quartiere il Tel Aviv.
Amos Oz: “Vivo spiando la gente”
Nel libro che raccoglie le sue ultime riflessioni, che qui anticipiamo, il grande scrittore scomparso racconta come le storie ascoltate per caso lo abbiano sempre ispirato: “La curiosità è la più grande virtù”
DI AMOS OZ da Repubblica 28 Settembre 2019
Nel cortile del liceo Rechavia, a Gerusalemme, c’era un albero di eucalipto su cui qualcuno aveva inciso un cuore trafitto da una freccia. Sul cuore trafitto, ai due lati della freccia, stava scritto: Gadi-Ruti. Ricordo che già a quell’epoca, avrò avuto tredici anni, pensavo: L’avrà fatto Gadi, quel cuore, non Ruti. Perché l’aveva fatto? Non lo sapeva che amava Ruti? O lei non sapeva che lui l’amava? Se ben ricordo, già a quell’epoca dicevo a me stesso: Forse qualcosa dentro di lui sa che passerà, che tutto passa, che quell’amore finirà. Così, voleva lasciare qualcosa. Voleva che di quell’amore restasse memoria anche dopo, una volta passato. Il che somiglia molto all’impulso che porta a raccontare storie, a scrivere libri: mettere qualcosa in salvo dalle grinfie del tempo e dell’oblio. Questo, e anche il desiderio di dare una seconda occasione a ciò che un’altra occasione non avrà mai più. Anche questo. Le forze che spingono questa mano a scrivere sono anche il desiderio che quel qualcosa non sparisca, che non sia come se non fosse mai stato – e non intendo solo cose successe a me. (…)
Ogni tanto mi chiedo da dove vengano le storie, e non sono poi così capace di rispondere. Vedi, per un verso lo so, sì, perché è tutta la vita che faccio la spia. L’ho scritto in Una storia di amore e di tenebra. Ascolto conversazioni altrui, osservo gli estranei, e quando mi trovo in coda dal dottore, alla stazione o all’aeroporto, non leggo mai il giornale. Preferisco ascoltare la gente che parla, rubare sprazzi di conversazioni, completarle con le parti mancanti. Oppure osservo i vestiti, lancio un’occhiata alle scarpe – le scarpe hanno sempre un mucchio di cose da raccontare. Studio la gente. Ascolto.
Il mio vicino di casa al kibbutz Hulda, Meir Sibahi, diceva: Ogni volta che passo davanti alla finestra della stanza dove Amos scrive, mi fermo un momento, tiro fuori un pettine e mi pettino, perché se mai dovessi entrare in una sua storia almeno ci entrerei pettinato. Il ragionamento non fa una piega, ma da me non funziona cosi. Prendiamo come esempio una mela. Di che cosa è fatta una mela? Acqua, terra, sole, un albero di mele e un po’ di concime. Eppure non somiglia a nessuna di queste cose. È fatta di questo, ma non somiglia a niente. E cosi è una storia, né più né meno di un impasto di incontri, esperienze, ascolti.
Il mio impulso primario è quello di provare a indovinare come mi sentirei se fossi lui, se fossi lei: che cosa penserei? Che cosa desidererei? Di che cosa mi vergognerei, se fossi lei? Che cosa, per esempio, non vorrei che nessuno al mondo sapesse di me? Come mi vestirei? Che cosa mangerei, se fossi lei? Ciò mi accompagna da sempre, da ancor prima che cominciassi a scrivere delle storie, sin da quando ero bambino. Ero figlio unico, non avevo amici. I miei genitori mi portavano al caffè di via Ben Yehudah a Gerusalemme, promettendomi il gelato se stavo buono mentre loro parlavano con gli amici. A Gerusalemme in quell’epoca il gelato era una rarità. Non perché costasse molto, ma perché le nostre madri, religiose e laiche, sefardite o ashkenazite che fossero, erano tutte senza eccezione fermamente convinte che il gelato fosse sinonimo di gola rossa, di infiammazione, di influenza, di angina, di bronchite, di polmonite, di tubercolosi. In poche parole: o gelato o bambino.
Ciononostante, loro promettevano che mi avrebbero comprato il gelato se non li avessi disturbati durante la conversazione. Con quei loro amici loro chiacchieravano a dir poco settantasette ore filate. E io, per non impazzire di solitudine, decidevo di spiare le persone sedute ai tavoli vicini. Rubavo frammenti di conversazioni, osservavo, chi invita chi? Chi paga? Cercavo di indovinare in che rapporti fossero le persone sedute al tavolo accanto, e provavo persino a immaginare da dove venissero, come fosse casa loro, studiandone l’aspetto, il linguaggio corporeo. Faccio lo stesso, ancora oggi. Non intendo dire che scatto delle fotografie, torno a casa, le sviluppo e mi ritrovo con una storia. Strada facendo si attraversa una marea di trasformazioni.
Ne La scatola nera, per esempio, c’è un ragazzo che ha la mania di grattarsi l’orecchio destro con la mano sinistra, passandosela dietro la testa. Una volta una donna mi ha chiesto: Dove l’hai presa, questa cosa? Perché anche lei conosceva un tizio che si grattava l’orecchio con la mano sinistra, passandola dietro la testa. Le ho risposto che ero quasi sicuro di averlo visto fare, una volta, e lei mi ha incalzato: Dove, dove l’hai visto? Con tutta la buona volontà, proprio non lo so. Veniva da un ricordo dimenticato, non era una cosa campata per aria, ma non ho proprio idea di dove l’avessi presa. Sai una cosa? Te la dico così: quando scrivo un articolo, di solito lo faccio perché sono arrabbiato. La spinta principale è che sono arrabbiato per qualche motivo.
Ma quando scrivo una storia, una delle cose che muovono questa mano e la curiosità. Una curiosità tale che non riesco a saziarla. Mi incuriosisce da matti mettermi nei panni degli altri. Credo che la curiosità non sia soltanto una condizione indispensabile per qualunque opera intellettuale, ma anche una virtù morale. Forse proprio la dimensione morale della letteratura. Ne discuto sempre con A.B. Yehoshua, che pone la questione morale a monte della creazione letteraria: delitto e castigo. Io credo che ci sia, sì, una questione morale, ma in altri termini: mettere te stesso per qualche ora nei panni di un’altra persona, o dentro le scarpe di qualcun altro. Il che ha un peso morale implicito, non troppo grande.
Senza esagerare. Ma credo davvero che una persona curiosa sia un partner un po’ migliore di quanto non lo sia una che non lo è, e anche un genitore un poco migliore. Non ridere di me, ma credo che una persona curiosa sia anche un automobilista un po’ migliore di chi non lo è, perché si domanda che cosa sarebbe capace di fare quello che guida sulla corsia parallela. E ho l’impressione che una persona curiosa sappia perfino amare meglio. (…)
Una volta c’era una donna a una finestra illuminata, alle quattro e mezzo del mattino, che guardava verso il buio. Mi sono fermato a guardarla io, dal buio. Non per il motivo che credi tu. Comunque non solo per quello. L’ho guardata dall’oscurità e mi sono chiesto che cosa poteva esserle successo, in quelle ore. Poi si è allontanata dalla finestra e ha spento la luce, o forse è rimasta lì a guardare verso il buio, io ho proseguito per la mia strada, ma mi sono portato via con me il primo nucleo di una storia. Che non ho ancora scritto. Forse un giorno la scriverò, forse mai.

UN UOMO SI GIUDICA DAI SUOI SOGNI. L’INSEGNAMENTO DI SHIMON PERES
Gabriele Nissim , pubblicato su Gariwo News 13 Settembre 2019
Un essere umano, ma direi anche un
Paese, si giudica anche dai suoi sogni, non solo quando gli eventi vanno in una
buona direzione, ma anche quando tutto sembra andare storto. La filosofa Agnes
Heller, che ci ha appena lasciato, scriveva che la bella persona è quella
che accetta il proprio destino, ma che ambisce per tutta la vita ad essere
buona, anche se non raggiungerà mai la meta, come essere parziale e fragile, ma
ci proverà comunque.
Etty Hillesum viveva l’inferno nel campo di concentramento, ma sognava che dopo
la fine della guerra potesse nascere un mondo senza odio e senza nemici.
Uno dei politici del nostro tempo che ha
legato il suo percorso all’idea del sogno è stato il premio Nobel per la pace
Shimon Peres.
Domenica nella sinagoga di Milano parlerò di lui, a poche ore dalle prossime
elezioni israeliane, con Nadav Tamir, il direttore del centro Peres che
è stato in tanti anni il suo più fedele collaboratore.
Mi capita così l’occasione di rivisitare una prospettiva politica ed
esistenziale che non vale solo per il passato, ma che è molto attuale nei
nostri tempi.
Mi sono riletto l’intervento che Shimon Peres fece ad Oslo il 10 dicembre del
1994 nel momento in cui sembrava che la pace definitiva nel Medio Oriente fosse
a portata di mano.
Allora il Ministro degli esteri israeliano fece anche una riflessione sulla
sua vita.
Un uomo, raccontò, non può fermare il corso dei suoi anni, ma ha sempre la
possibilità di rimanere giovane con i suoi sogni. Le leggi della biologia non
si applicano alle proprie aspirazioni, sono indice della vitalità dell’essere
umano e gli allungano la vita. La sua famiglia riuscì infatti a superare
il dramma della persecuzione e della guerra con il sogno di uno Stato ebraico.
Se lui e i suoi genitori non avessero avuto questo sogno non sarebbero forse
sopravvissuti e non sarebbero mai sbarcati nel porto di Jaffa.
Ma neanche quella terra conquistata in tante guerre poteva bastare se non si
immaginavano nuovi sogni.
Le guerre per l’indipendenza gli avevano
fatto capire due cose importanti. Si può anche vincere con le armi, ma poi non
necessariamente ottenere la pace. La guerra gli aveva fatto comprendere che per
ottenere la pace non bastano le armi più sofisticate, ma bisogna prima di tutto
creare degli uomini migliori in tutto il Medio Oriente. È questa la garanzia
che determina la vittoria.
Shimon Peres immaginava due grandi sogni, uno per l’Israele del futuro e uno
per i popoli di tutta l’area mediorientale.
Dopo la conquista territoriale non era tanto importante il numero degli
ebrei che sarebbero andati a vivere in Israele, quanto il carattere morale
dello Stato che avrebbe dovuto diventare un centro spirituale e tecnologico al
servizio del mondo intero. Il carattere particolare degli ebrei e degli
israeliani avrebbe dovuto aspirare ad avere sempre una dimensione universale.
Si era ebrei veri quando ci si sentiva cittadini del mondo. Il particolare e
l’universale dovevano essere l’anima dell’identità ebraica.
E anche il Medio Oriente doveva cambiare. Il luogo da cui erano nate le tre
religioni monoteiste doveva diventare un riferimento morale per il mondo
intero. Pungete la sua battuta: “ Qui da noi tutti si vantano di essere stati
la culla della civiltà, ma è ora che la finiamo di essere soltanto dei bambini
per tutta la vita.” Era tempo di diventare uomini maturi.
Come Etty Hillesum lanciava una grande
sfida.
Tutti i popoli del Medio Oriente dovevano sentirsi impegnati per superare nel
linguaggio politico l’idea del nemico, l’idea più obsoleta e pericolosa per
il genere umano.
Di fronte a chi divideva il mondo, gli Stati e le religioni in entità
contrapposte era tempo di dire che l’umanità intera si doveva unire contro i
veri nemici che mettono in pericolo la nostra sopravvivenza: la povertà, la
fame, la radicalizzazione religiosa, le droghe, la proliferazione nucleare, la
desertificazione, i cambiamenti climatici.
Era tempo di costruire un Medio Oriente senza guerre, senza nemici, senza
missili balistici, senza testate nucleari, senza dogane, dove tutti potessero
circolare liberamente, dove ognuno avesse la libertà di pregare liberamente e
senza censure nella propria lingua, in arabo, ebraico, latino, dove la massima
aspirazione fosse l’istruzione per tutti e la cooperazione scientifica e
tecnologica.
Oggi, 25 anni dopo, sembrano forse i sogni di un ingenuo, di fronte ad un moltiplicarsi delle guerre, dei fanatismi e dei nazionalismi in tutta l’area.
Qualcuno lo chiamerà buonista e dirà che la sua profezia ha fallito e che la forza delle armi deciderà ancora una volta il futuro.
Come però aveva capito Shimon Peres, la prospettiva della pace è l’unica speranza realista perché senza cooperazione e condivisione i popoli del Medio Oriente minacciati più degli altri dai cambiamenti climatici e dalla siccità, possono soltanto affondare.
Peres li aveva invitati a sognare per dare un senso al destino di tutti e per insegnare loro il segreto della giovinezza.
La decadenza comincia quando si smette di sognare.

Analisi di Gabriele Nissim, presidente di Gariwo

Israele, a Netanyahu l’incarico di formare il governo
di FRANCESCA CAFERRI Repubblica 25 Settembre 2019
La scelta del presidente Rivlin: nonostante sia arrivato secondo alle elezioni, il premier uscente può contare su una coalizione più ampia di quella del rivale Gantz.
GERUSALEMME – Il presidente israeliano Rueven Rivlin ha affidato l’incarico di formare il nuovo governo al premier uscente Benjamin Netanyahu. Rivlin ha deciso di incaricare Netanyahu, 69 anni, dopo colloqui con gli altri leader di partito ed una volta emersa l’impossibilità di formare un governo di unità nazionale. Il Likud di Netanyahu è risultato il secondo partito alle elezioni del 17 settembre, con 32 seggi contro i 33 del rivale Blu e Bianco. Ma ha vinto a livello di coalizione: il premier uscente conta su 55 seggi – la maggioranza è di 61 – mentre il partito dell’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz, 60 anni, ne ha ricevuti 54.
Netanyahu avrà adesso 28 giorni di tempo per formare un nuovo governo, con una possibile estensione di due settimane: se non riuscirà nel suo tentativo, il presidente potrà affidare l’incarico ad un’altra persona. “Accetto l’incarico, occorre un governo di unità nazionale e la riconciliazione che in questo momento è essenziale”, ha detto Netanyahu. Ma è difficile pensare che Gantz accetterà di sedere in un governo con il rivale, dopo aver giocato l’intera campagna elettorale sul rifiuto di condividere la responsabilità di governo con un uomo, come Netanyahu, che nel giro delle prossime due settimane potrebbe essere formalmente messo sotto accusa per corruzione.
L’altra ipotesi è una replica del governo delle destre con cui il premier ha retto il Paese negli ultimi anni: ma in questo caso sarebbero fondamentali i voti di Avigdor Lieberman, ex ministro della Difesa e degli Esteri, che ha fatto naufragare i precedenti tentativi di Netanyahu per il rifiuto di cedere alle richieste dei partiti ultra-religiosi, in particolare sull’esenzione dalla leva obbligatoria per tutti i giovani della comunità. Lieberman ha raddoppiato i suoi seggi nella Knesset (da 4 a 8) facendo campagna contro i privilegi degli ultra-religiosi: e difficilmente tornerà indietro.
Se nessuno riuscisse a formare il governo Israele tornerebbe alle urne per la terza volta in un anno.

Storia senza perdono
Di Walter Barberis

Dieci anni dopo l’uscita del libro “ Dopo l’ultimo testimone” di David Bidussa, lo storico (non ebreo) Walter Barberis torna sul tema della memoria e testimonianza della Shoah con il libro “ Storia senza perdono” presentato questa sera al Memoriale della Shoah. Proprio David Bidussa ha introdotto la presentazione mettendo in guardia da una certa tendenza di alcuni storici di diventare dei “narratori” che raccontano gli eventi senza una vera analisi che dimostri con prove documentate e che cerchi di spiegare le ragioni. La Shoah è stata raccontata quasi esclusivamente dalle vittime e dai sopravvissuti, con casi di falsi testimoni. Rare le memorie dei testimoni “dall’altra parte”, quelli che hanno partecipato e contribuito, i carnefici.
Il rischio è che la testimonianza diventi una lezione retorica, che racconta cosa è successo, che colpisce emotivamente, ma che non aiuta a capire come e perché è successo. La Storia deve essere uno strumento di civiltà per spiegare e far comprendere che nella società i fattori contaminanti sono ancora attivi.
Così viene presentato il libro nella quarta di copertina:
La Shoah, lo sterminio degli ebrei d’Europa da parte del nazismo, è una vicenda la cui efferatezza non ha precedenti. Ma per rendere conto di questa tragedia, quanto è importante il ruolo dei testimoni e quanto quello della storiografia? È il tema di questo intenso libro di Walter Barberis. Esso inizia con una frase di Primo Levi: «La memoria è uno strumento meraviglioso, ma fallace», che subito individua l’universo concettuale del libro. Di fronte alla scomparsa, giorno dopo giorno, dei testimoni oculari, di fronte al pericolo di una caduta nell’oblio, si rende necessario un nuovo vaglio delle testimonianze acquisite e dei loro limiti. Ma soprattutto, un ricorso deciso alla storia, disciplina chiave per la trasmissione del sapere e per una solida comprensione di ciò che è stato. Il testo rende conto dei diversi aspetti della ricezione della Shoah, da un iniziale disinteresse e incredulità nei confronti dei sopravvissuti, a una successiva “ipertrofia” della memoria – l’«era del testimone» – fino a non isolati e clamorosi casi di impostura.

Yehoshua: “Alle urne come in un referendum. Con o contro Netanyahu”
DI FRANCESCA CAFERRI 11 SETTEMBRE 2019 La Repubblica
Martedì il Paese torna alle urne per la seconda volta in un anno: al centro del dibattito le vicende del premier che rischia il processo per corruzione. Parla il grande scrittore
MANTOVA – Di fronte a uova strappazzate e caffè, Abraham Yehoshua riflette sul destino del suo Paese con tono amaro, nonostante le bustine di zucchero che una cameriera solerte sistema sui tavoli intorno. Tunnel, il suo ultimo romanzo, appena pubblicato in Italia da Einaudi, parla di un matrimonio consumato dal tempo e dalla malattia, ma anche del legame che nonostante tutto unisce i due sposi. Metafora perfetta dell’unione fra uno dei più grandi scrittori israeliani e il suo Paese: amatissimo, eppure fonte di perenne preoccupazione e amarezza.
Soprattutto alla vigilia di un voto, come quello per il rinnovo del Parlamento (Knesset) della prossima settimana, in cui in gioco c’è l’identità stessa dello Stato ebraico: laici contro ultraortodossi, la sinistra dei padri fondatori ridotta al lumicino da una destra sempre più aggressiva, il rifiuto della popolazione araba di prendere parte.
Se accetta di indossare i panni dello sposo, come va il matrimonio? Riconosce ancora il suo grande amore?
“Come potrei? Sono estremamente critico verso l’identità di Israele oggi. La maniera in cui ci siamo trasformati, il ruolo che la religione ha preso nella vita pubblica, i nostri politici: non mi riconosco in nessuna di queste cose”.
E allora perché non divorzia? Potrebbe andare a vivere ovunque…
“Io non potrei mai essere parte della diaspora ebraica. Sono un ebreo nato a Gerusalemme, vissuto a Gerusalemme: se Israele non ci fosse più non ci sarebbe più la mia identità. Resto e parlo, scrivo, critico”.
Martedì il Paese va al voto per la seconda volta in un anno. Ci racconta il clima che c’è?
“Al centro di queste elezioni c’è una scelta pro o contro Netanyahu: ha vinto le elezioni ad aprile ma non è riuscito a formare il governo. Tutto il voto è su di lui e sulle sue questioni giudiziarie: potrebbe finire in carcere. Lo sa e per questo si comporta come un animale ferito. In campagna elettorale non si è parlato di pace con i palestinesi, di due Stati, di come sarà Israele nel futuro. Stiamo decidendo se cacciare o no Netanyahu”.
Che cosa pensa accadrà?
“Posso solo sperare che perda”.
E che cosa si aspetta dal futuro se questo accadesse?
“Noi israeliani abbiamo già mandato in prigione primi ministri e presidenti: potrebbe accadere ancora. Ma se mi chiede cosa mi auguro, quello che vorrei è che fossimo in grado di rimediare all’errore che Mosè fece sul Monte Sinai, quello di legare religione e identità. Questo è ciò che rende gli ebrei unici ma anche il loro maggiore problema. In America, in Italia, ci sono ebrei, ma questo non impedisce loro di essere cittadini dei loro Stati. In Israele non accade: religione e appartenenza allo Stato sono la stessa cosa”.
Si riferisce alla legge approvata qualche mese fa che definisce Israele “Stato degli ebrei…”?
“La destra ha voluto questa legge per difendersi da ciò che sta accadendo: l’unica soluzione per israeliani e palestinesi è uno Stato bi-nazionale. Non due Stati uno accanto all’altro, come volevano gli accordi di Oslo. Per questo ha varato la legge”.
Lei sostiene l’idea dello Stato unico: ciò le ha provocato molte critiche…
“Ho litigato con tanti amici di sinistra. Anche con uno dei più cari fra loro, Amos Oz, fino alla fine. Lui diceva che dovrebbero esserci due Stati, uno ebraico e uno palestinese. Ma ormai è impossibile, è tempo di riconoscerlo. L’ho detto a Amos, lo ripeto oggi. Dovremmo dare ai palestinesi della Cisgiordania gli stessi diritti degli ebrei. E loro dovrebbero usarli per partecipare alla vita pubblica: andando a votare, per prima cosa. Non sarà un piano di pace grandioso, né una soluzione perfetta: ma è l’unica possibile”.
Perché?
“Anche se nascessero due Stati il confine sarebbe troppo frastagliato. Nessun governo si ritirerebbe da tutti gli insediamenti: quindi da una parte servirebbero connessioni, strade, servizi per garantire i coloni. E dall’altra, come si potrebbe governare una minoranza palestinese piena di rabbia e senza diritti all’interno di uno Stato ebraico? Per non parlare di Gerusalemme: non si può dividere la città e non ci sarebbe Stato palestinese senza Gerusalemme”.
Servirebbero tunnel, che poi è il titolo del suo libro…
“Non a caso: in Israele ci sono religiosi e non religiosi. Osservanti contro non osservanti. Ultraortodossi e arabi. Ogni gruppo costruisce un muro per difendere la sua identità: io vorrei invece che si costruissero tunnel”.
C’è un’altra protagonista nel suo libro: la malattia che affligge il protagonista, la demenza. Anche questa non è stata una scelta casuale…
“Volevo lanciare un messaggio simbolico a israeliani e palestinesi: dire che è tempo di iniziare a dimenticare, di guardare al futuro. Basta rivangare nelle ferite del passato: parlare sempre di Shoah e di Nakba. Il mondo va avanti veloce: dobbiamo adattarci e andare avanti. Invece spesso siamo così incastrati nel passato da non guardare a ciò che potremmo avere”.

Nel segno di Amos Oz
Pubblicato in Attualità il 26/05/2019
L’affetto e il legame del pubblico internazionale per Amos Oz continua ad essere forte, anche dopo la sua scomparsa. Un segno evidente di come le sue parole siano ancora vive. Lo ha ricordato negli scorsi giorni la figlia del grande scrittore israeliano, Fania Oz-Salzberger, protagonista di un partecipato incontro bolognese in occasione del Festival Mens-a, rassegna itinerante dedicata al pensiero ospitale e cosmopolitismo. “Il dolore per la morte di mio padre, nonostante il passare del tempo e tutto l’affetto che ricevo dalla gente di tutto il mondo, non si attenua, anzi si acuisce, tanto che incontrare il pubblico italiano come anche quello cinese o tedesco, che mantiene viva la memoria di mio padre, è una sorta di consolazione per la tristezza che sento”, le parole di Oz-Salzberger, intervistata sul palco da Sarah Kaminski, docente di ebraico all’Università di Torino e traduttrice. Dall’esperienza di crescere nel kibbutz fino alle opinioni politiche e le questioni sull’identità ebraica e democratica dello Stato di Israele, diversi i temi toccati nel corso della serata frutto del lavoro della psicanalista Beatrice Balsamo, ideatrice di Mens-a, in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna (nell’immagine, Fania Oz-Salzberger in visita al museo bolognese). Docente di storia delle idee all’università di Haifa, Oz-Salzeberger ha parlato dell’aspirazione di vivere in pace in Medio Oriente e del sostegno, condiviso con il padre, per l’opzione politica di due Stati per due popoli. La storica e scrittrice ha raccontato poi delle innumerevoli discussioni con il padre su ogni argomento possibile. Discussioni che hanno portato a una collaborazione molto apprezzata da pubblico critica, ovvero la scrittura a quattro mani del libro, Le parole e gli ebrei, scritto prima in inglese e poi diventato un best seller mondiale. Ad affiancare la conversazione tra l’autrice israeliana e la professoressa Kaminski, la lettura di alcuni brani di Amos Oz da parte dell’attore Alessio Vassallo.
A chiudere l’incontro, il ricordo di Fania di una breve parabola che piaceva molto al padre: “possiamo concentrare tutto l’insegnamento etico dei grandi filosofi o perfino il decalogo biblico in una sola e semplice mitzvah, ovvero, non ferire e non fare del male al nostro prossimo”.
Nel suo passaggio bolognese, Oz-Salzeberger ha inoltre ricordato un legame particolare con la città. “Ho una storia personale qui: mio suocero Maccabi Salzberger si trasferì da Gerusalemme a Bologna per studiare medicina nel 1946. Ma il suo lavoro segreto era quello di portare i sopravvissuti alla Shoah sulle navi illegali che li portavano in Terra d’Israele”.

Nuovo referendum su Netanyahu: tutti vogliono batterlo, poi lo abbracceranno
Di Gabriele Eschenazi da Gli Stati Generali 5 Settembre 2019
Da un’elezione all’altra nello spazio di pochi mesi Israele sembra non aver altro tema da trattare che Benjamin Netanyahu. Il voto finisce per diventare soprattutto un referendum nei suoi confronti. Nessuna strategia sembra quella buona per sconfiggerlo. Eppure di nemici ne ha moltissimi: a sinistra come a destra e anche al centro. La sua indiscussa capacità oratoria, un trasformismo senza scrupoli unito a una prudenza nei fatti anche se non nelle parole lo hanno reso credibile e sempre “irresponsabile” di ogni problema. Un blocco del 25% degli elettori israeliani gli dà fiducia a priori ed è pronto a votarlo elezione dopo elezione. E il 25% dei voti significa almeno 30 seggi su 120. A questi poi se ne aggiungono facilmente altri raccolti all’ultimo dal gran calderone degli indecisi.
Inutili i tentativi dell’opposizione di attribuirgli responsabilità su crisi a Gaza o in Cisgiordania, su disparità sociali sempre più ampie, sulle concessioni ai partiti religiosi. A trasformarlo in una semplice voce dei libri storia potrebbero provvedere i giudici se il consigliere legale del governo, Avishai Mandelblit, deciderà di farlo incriminare per corruzione, frode e violazione di fiducia. Ma anche in questo caso Netanyahu ha pronta la contromisura: una nuova legge sull’immunità parlamentare, che lo protegga dalle inchieste. Dovrà, però, farla approvare in fretta prima dell’incriminazione e per questo conta sui suoi futuri e possibili alleati di governo. Ma proprio da destra è uscito l’uomo, che potrebbe fargli saltare il piano, Avigdor Lieberman, un tempo direttore del suo ufficio governativo, poi fedele alleato e aspirante “erede al trono”. Lieberman è stato colui che ha impedito a maggio a Bibi di formare il suo governo spingendolo a nuove elezioni. È colui che ha trovato una nuova chiave per sconfiggere l’invincibile leader, colpirlo da destra sul tema della laicità. Proclamandosi paladino dello stato liberale in un paese dove la modernizzazione è frenata dai partiti religiosi ha fatto breccia. I sondaggi gli danno stabilmente il doppio dei seggi attuali: da cinque a dieci e forse oltre. La matematica dei sondaggi dice che senza Lieberman non si fa un governo di destra né tanto meno di centrosinistra. E lui abilmente si è posizionato al centro riprendendo un tradizionale mantra della politica israeliana: “il governo di unità nazionale”, che tanto piaceva a leader storici come Begin, Shamir e Peres, Ha proposto una coalizione laica tra i partiti Blu e Bianco)di Benny Ganz, il Likud e il suo partito Israele Casa Nostra. La soluzione di Lieberman mira a neutralizzare Netanyahu in una coalizione dove non abbia più la maggioranza e spinga il suo partito a sostituirlo.
Ma la strategia dell’alleanza non è patrimonio solo dell’ex-ministro della Difesa. Anche altri leader israeliani sembrano pensarla allo stesso modo. Lo stesso Ganz dopo aver toccato con mano in aprile l’impossibilità di sostituirsi a Netanyahu sulla poltrona di primo ministro continua a ventilare la possibilità di entrare in coalizione con chi voleva sostituire, ma non riesce a sconfiggere. E il motivo è da ricercarsi nello stesso partito e nella sua incapacità di proporsi come vera alternativa. Le critiche di Blu e Bianco al governo si concentrano sulla difesa del potere giudiziario e le istituzioni di garanzia come l’ufficio del “Controllore dello Stato” a capo del quale BIbi ha da poco messo Matanyahu Englman. Non un giudice come era tradizione bensì un amministratore vicino al partito di maggioranza e che è già al lavoro per indebolire il ruolo di garanzia del suo ufficio e sembra concordi le sue scelte di nascosto col primo ministrro. Occuparsi di questo tema non basta per definire i contenuti di una politica di opposizione come ha scritto Guy Rolnik su The Marker, quotidiano economico edito da Haaretz. Servirebbe avere una soluzione per Gaza, piani per eliminare la dipendenza della politica dai capitali dei gruppi d’interesse, per smantellare i monopoli e ridurre la crescente disuguaglianza economica, spiega Rolnik. A queste mancanze del principale partito di opposizione si aggiunge la sua indisponibilità a legittimare la “Lista Comune Araba” come possibile partner di governo. Oggi i cittadini arabi d’Israele costituiscono il 18% della popolazione (9 milioni di abitanti) e non è possibile escluderli a priori da un governo col pretesto che non accettano l’ebraicità dello stato. Ayman Odeh, a capo della Lista Comune si è dichiarato disponibile a valutare l’ingresso nel governo della sua lista, ma la sua offerta non è stata per ora raccolta. E Bibi ne ha subito approfittato per lanciare lo slogan “O Bibi, o Tibi”, riferendosi ad Ahmed Tibi, rappresentante dell’al più estrema del partito arabo unito. Rinunciare a priori ad un’alleanza con questo partito per l’opposizione significa fare a meno di 10/11 seggi e quindi diminuire, se non azzerare le possibilità di costituire un governo di alternativa.
Il sospetto di voler abbracciare Netanyahu dopo le elezioni alleggia anche sui laboristi di Amir Perez alleati di Ponte, il partito di Orli Levy Abecassis, figlia di David Levy, noto uomo politico del Likud, più volte ministro degli Esteri. Perez ha dichiarato di voler rafforzare il suo partito prendendo voti a destra e questa scelta unita a una certa ambiguità ha lasciato pensare che proprio i laboristi con 6/8 seggi potrebbero essere dopo le elezioni la stampella ideale per un nuovo governo del Likud. Non una novità per i laburisti storicamente inclini a cadere in tentazione con governi di centrodestra.
L’unico partito, a parte la lista araba, che sembra immune da ogni tentazione di governo è L’Unione Democratica di Nizan Horowitz, Stav Shafir fuoriuscita dai laboristi, Ehud Barak, l’unico che ha sconfitto Netanyahu alle elezioni nel 1999. Questa forza politica dopo una partenza carica di aspettative è accreditata dai sondaggi di 7/8 seggi. È l’unico partito che, per bocca di Ehud Barak, ha presentato delle proposte per risolvere il conflitto con i palestinesi. Il suo piano prevede un accordo di pace regionale che affronti i temi della minaccia iraniana, del terrorismo islamico radicale, di un progetto di sviluppo delle infrastrutture e della questione palestinese secondo il principio dei due stati o comunque di una forma di di separazione tra i due popoli. Il laborista Amir Perez invece si è limitato a dire che appoggerà Netanyahu dall’esterno se quest’ultimo deciderà di aderire al piano Trump, ancora mai presentato.
Tutt’altro che disponibili a restare fuori dalle stanze del potere sono i partiti religiosi, che si rivolgono a un elettorato piuttosto variegato e ricco di sfumature. Fino a pochi anni fa i cosiddetti ortodossi erano rigidi sul clericalismo, ma flessibili sul piano politico. Al contrario, invece, i nazional religiosi erano intransigenti sul concetto della “Grande Israele”, mentre erano più aperti al dialogo con i laici e soprattutto mandavano i loro giovani, maschi e femmine, ad arruolarsi. Oggi, invece, ci sono ortodossi nazionalisti, nazional religiosi semiortodossi, religiosi light, religiosi pacifisti e democratici. Con questi ultimi, però, in netta minoranza. I maggiori pericoli derivano da personaggi come Betzalel Smotric del partito A Destra, capeggiato da una donna laica, Ayelet Shaked. Smotric vorrebbe un paese, dove le uniche leggi fossero quelle bibliche, senza donne nell’esercito e con i territori occupati annessi allo stato d’Israele. Smotric, attualmente al dicastero dei Trasporti, è col suo partito contemporaneamente un alleato e una minaccia per Netanyahu, che non si fida di alleati troppo intraprendenti a destra. A voler salire sul treno del prossimo governo sono in tanti, forse troppi, almeno 100 deputati sui 120, che compongono la Knesset. E anche a voler sostituire Netanyahu sono in molti, soprattutto nel suo stesso partito, ma al momento non sembra ci sia nessuno con il suo carisma e la sua esperienza che lo possa sfidare davvero. E allora tanto vale abbracciarlo.
Gabriele Eschenazi

Israele, la politica non c’è più Così Netanyahu ha svuotato la contrapposizione destra-sinistra
di ABRAHAM B. YEHOSHUA
La Stampa 8 agosto alle ore 05:26 ·
di ABRAHAM B. YEHOSHUA
Come ho già detto nel mio ultimo articolo nel corso dei miei ottantadue anni, ho assistito a molti eventi politici, tra cui aspri scontri ideologici e manifestazioni turbolente. Molti di quegli scontri erano ovviamente tra rappresentanti della destra e della sinistra, ma anche tra gruppi laici e religiosi.
Ricordo che da ragazzo, nel 1952, l’allora leader della destra Menachem Begin (divenuto in seguito primo ministro di Israele) organizzò una violenta manifestazione a Gerusalemme contro l’accordo per le riparazioni di guerra firmato con la Germania Ovest. Begin esortò a ribellarsi all’accordo e i suoi sostenitori lanciarono pietre contro il parlamento, ubicato all’epoca nel centro di Gerusalemme.
Ricordo bene le manifestazioni di destra e di sinistra del 1974, dopo la guerra dello Yom Kippur, che pretendevano le dimissioni dell’allora primo ministro Golda Meir e del celeberrimo ministro della Difesa Moshe Dayan dopo il fallimento dell’Intelligence e la prova di debolezza data dell’esercito nei primi giorni dell’attacco egiziano e siriano. In seguito a quelle proteste i due leader rassegnarono le dimissioni nonostante il loro partito, il partito laburista, avesse vinto le elezioni poche settimane dopo la fine della guerra.
Libano, 1982
Ricordo le manifestazioni e l’enorme amarezza di molti sostenitori della pace in seguito agli insuccessi della guerra del Libano nel 1982, soprattutto dopo la strage perpetrata dai cristiani con il tacito assenso degli israeliani nei campi profughi di Sabra e Shatila. Durante una di quelle dimostrazioni l’attivista di sinistra Emil Grünzweig rimase ucciso da una granata lanciata da un militante di destra. E in effetti, in seguito a quelle contestazioni, il primo ministro Menachem Begin, divorato dai sensi di colpa, rassegnò le dimissioni e si rinchiuse in casa fino alla morte.
E come non ricordare le violente proteste e le sedizioni della destra contro il governo dopo gli accordi di Oslo firmati nel 1993 alle quali presero parte anche Ariel Sharon e Benjamin Netanyahu, entrambi divenuti in seguito primo ministro? Quelle terribili incitazioni ad opporsi agli accordi di Oslo sfociarono nell’omicidio dell’allora capo del governo Yitzhak Rabin.
Gaza, 2006
Ricordo bene anche le manifestazioni contro Ariel Sharon, primo ministro di Israele durante il ritiro e l’evacuazione dei coloni dalla Striscia di Gaza nel 2006. Contestazioni della destra nazionalista religiosa a detrimento di un primo ministro che era stato lui stesso un estremista di destra ma che, con l’evacuazione degli insediamenti, andava a colpire il Sancta Sanctorum dei conservatori.
Questi e altri eventi, per quanto dolorosi e violenti, erano il risultato di prese di posizioni ideologiche ed etiche. Gli schieramenti che si fronteggiavano si esprimevano con toni forti ma nessuno metteva in dubbio che, dietro l’estremismo, ci fosse una chiara posizione politica che voleva, in base a concezioni diverse, il bene del paese e teneva conto del suo futuro.
Nell’attuale realtà politica israeliana non c’è invece alcun dibattito politico tra opposti schieramenti. Le parole sinistra e destra rimbalzano da tutte le parti vuote di significato, utili solo come arma per infangare gli oppositori. Il termine «sinistra», in particolare, viene costantemente utilizzato dagli attivisti di destra, specialmente quelli religiosi, come condanna automatica di chi non appoggia il primo ministro. Nessuna soluzione
Il dibattito ideologico è da tempo congelato e si è dissolto. Nel nuovo partito «Blu e bianco», fondato prima delle ultime elezioni, ci sono esponenti indiscutibilmente di destra, come l’ex ministro della Difesa Moshe Ya’alon che ha servito nell’esecutivo di Netanyahu, ma niente serve a risparmiarli dell’appellativo di «sinistroidi» con il quale i sostenitori di Netanyahu li bollano con profondo biasimo e disprezzo.
Nell’Israele di oggi vi è una paralisi ideologica perché nessuno, di fatto, ha una soluzione possibile al problema principale: cercare di raggiungere un accordo con l’Autorità palestinese. Tutta l’energia politica si disperde perciò in piccole soluzioni localizzate, dirette a cambiare il comportamento di poliziotti e soldati o a fare qualche concessione ai checkpoint.
Fintanto che il dibattito pubblico si è svolto in una specie di palude ideologica e di impasse politico si riusciva ancora mantenere un minimo senso di solidarietà, malgrado il lento processo di apartheid in atto nei territori e il crescente nazionalismo dei religiosi. Ma quando sull’ordinamento istituzionale si è abbattuta la richiesta di incriminazione di Benjamin Netanyahu e il suo astuto tentativo di eludere un processo calpestandole norme dell’attuale regime legale e amministrativo, si è scoperto che dietro un leader di notevole abilità in campo estero, attento a non lanciarsi in avventure militari e politiche e che gestisce con relativo successo l’economia, c’è un uomo corrotto che un apparato legale da lui stesso nominato vorrebbe portare a giudizio. Per evitare la prospettiva di un processo Netanyahu, da leader politico, si è trasformato in quello di una setta che, mediante minacce e lusinghe, argina l’opposizione dei suoi membri mentre il sistema politico si piega davanti a lui per garantirgli un’eventuale immunità annullando elezioni appena tenute, disperdendo il parlamento e indicendo nuove consultazioni elettorali entro tre mesi.
Solidarietà addio
Nemmeno i più anziani ed esperti fra noi erano pronti a questo scenario di corruzione e di aperto attacco politico dei partiti di governo allo stato di diritto per far sì che il Primo Ministro non finisca in prigione. E tutto questo con il sostegno di una folla acclamante. Di fronte a tale realtà proviamo un senso di disgusto e di prostrazione. Non è più questione di posizioni politiche diverse e nemmeno di tendenziose panzane raccontate dal primo ministro e dai suoi assistenti che si succedono a ritmo incessante. Questa è una chiara e spudorata violazione dei valori di solidarietà che erano alla base della promessa sionista di riunire ebrei di diversa provenienza e livello in uno stato democratico.
Negli anni ’70 del secolo scorso due ministri del governo laburista furono sospettati di avere preso tangenti e ancora prima di essere processati si suicidarono per la vergogna. Il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin nel 1977 diede le dimissioni perché accusato di aver mantenuto un piccolo conto corrente all’estero, cosa allora vietata ai cittadini israeliani. Il presidente Moshe Katsav fu condannato a sette anni di carcere da un giudice distrettuale arabo per aver sessualmente molestato la sua segretaria. Il primo ministro Ehud Olmert finì in carcere per aver ricevuto finanziamenti illeciti per la sua campagna elettorale.
Fino a ieri potevamo consolarci con il fatto che nella palude politica israeliana ci fossero ancora principi di giustizia e di uguaglianza. Ma ecco che ora il primo ministro calpesta spudoratamente la legge per salvare la propria pelle e conduce il paese a una nuova, aspra e costosa campagna elettorale a poche settimane di distanza dalla precedente. C’è quindi da meravigliarsi che persone come me, indipendentemente dalla loro posizione politica, provino un senso di avvilimento e di paralisi? — Traduzione di Alessandra Shomroni ®
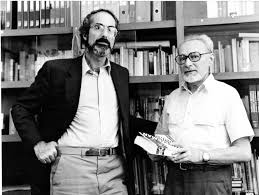
Primo Levi e Philip Roth nelle parole di Marco Belpoliti
Storia e storie di un’amicizia fondata sulla stima reciproca, in forma di intervista. Di Micol De Pas – Joimag 31 Luglio 2019
Un incontro speciale, quello tra Primo Levi e Philip Roth. Per lo scrittore americano, Levi era forse l’autore che apprezzava maggiormente, almeno tra quelli non americani. Per Levi, Roth era uno scrittore famoso dall’ineguagliabile capacità di ascoltare gli altri. Anzi, come precisa Marco Belpoliti, quella dell’ascolto era una capacità reciproca, così importante da consentire ai due protagonisti di costruire tra loro un rapporto di quasi fratellanza. Belpoliti ha curato per Einaudi anche il terzo volume delle Opere Complete dello scrittore torinese, che ha come sottotitolo Conversazioni, interviste e dichiarazioni e che contiene anche l’intervista (anzie, le interviste) che Roth fece a Levi. Ne abbiamo parlato con lui.
Come ha lavorato sul carteggio Levi/Roth e quale ruolo ha nella comprensione dell’opera di Primo Levi?
Devo dire che non ho lavorato sul carteggio tra i due scrittori, ma solo sulla intervista che Roth ha fatto a Levi. Ne esistono diverse versioni. Intanto bisogna dire che quando Roth si recò a trovare Levi nel 1986 a Torino non fece nessuna intervista. O meglio; parlarono insieme di molte cose, visitarono la fabbrica di vernici SIVA in cui aveva lavorato Levi (era in pensione da dieci anni), parlarono in casa dello scrittore torinese, andarono a cena insieme. Poi una volta tornato a Londra, come ho raccontato in un lungo articolo su doppiozero, Roth mandò a Levi delle domande in inglese, cui Levi risposte per iscritto. Da quelle domande Roth ricavò l’intervista che pubblicò sulla NYRB. Levi successivamente all’uscita di quella intervista pubblicò in due puntate su “La Stampa” la versione che aveva inviato a Roth e che differiva da quella apparsa nella rivista americana. Poi vi furono altre versioni fatte da Roth con correzione e vari cambiamenti, dal giornale a un primo volume da lui pubblicato (Chiacchiere di bottega, Einaudi, e poi successivamente). La cosa più importante per me è che Roth colse molti aspetti della personalità umana e intellettuale di Levi. Riconobbe in lui un artista.
Quali sono stati gli elementi che hanno permesso la costruzione di un rapporto speciale tra i due scrittori?
La capacità di Roth di ascoltare. Basta leggere le interviste di quel volume, le conversazioni con autori a lui decisamente simpatetici. Quasi tutti ebrei. Levi si sentì ascoltato e compreso come non gli era mai accaduto prima di allora da uno scrittore. Roth era più noto di Levi come scrittore e questo fu per Levi importante. E a Roth Levi apparve come un fratello maggiore. Una sintonia particolare da quello che traspare dal testo di Roth e dalle testimonianze di chi li vide insieme in quel fine settimana.
Quanto si sono reciprocamente influenzati (nello scrivere successivo e anche nel carteggio che si sono scambiati)?
Non credo che ci siano influenze successive. Si trattò di un riconoscersi reciproco. Levi però non ha lasciato nulla di scritto su questo, almeno di pubblicato. Forse esistono lettere che si sono scambiate. Ma di questo non sono al corrente. Bisognerebbe cercare tra le carte di Roth, se sono accessibili. Le carte di Levi non lo sono, per ora.
Levi sottolinea un parallelismo tra Svevo e Roth, in particolare nei personaggi Zeno Cosini e Zuckerman: quali sono gli elementi comuni?
Probabilmente l’aspetto caratteriale. Ma sono personaggi letterari, forse l’aspetto psicoanalitico che per Roth ha avuto un ruolo nella sua narrativa; così anche per Italo Svevo. Levi è estraneo a tutto questo, lui non aveva simpatia per la psicoanalisi. Ha detto in alcune interviste di avere letto Freud, e lo ha anche scritto. Ma non mi pare che questo possa essere un terreno comune tra i due scrittori, Levi e Roth.
Come (e perché) Levi ha definito la propria identità ebraica e il suo ruolo nell’ebraismo italiano?
Levi si è dichiarato italiano per due terzi e ebreo per un terzo, ma questa parte minore era per lui fondamentale. Ma Levi è un laico, non credente, iscritto alla comunità ebraica di Torino. Su questo aspetto del suo rapporto con il “divino” ne ho scritto di recente su Vita & Pensiero, la rivista della Cattolica.
Il suicidio di Levi è mai stato commentato da Roth pubblicamente?
Non mi risulta. Forse in qualche lettera, ma non ne ho alcuna certezza.
E quali sono state le sue reazioni davanti a questa perdita?
Di sconcerto, di dolore. Una perdita irrimediabile, perché avevamo bisogno della intelligenza e della curiosità di Primo Levi. Negli ultimi anni si era interessato ai temi ecologici, oggi di nuovo importantissimi. Ma ci ha lasciato un’opera importante e vasta su cui riflettere.
Lei, da studioso di Levi, come vorrebbe ricordarlo in questo centenario?
Come un uomo di buona memoria. Come uno scrittore. Come un uomo problematico. Come un uomo.

Caro Primo Levi c’è bisogno di te
Cent’anni fa esatti nasceva lo scrittore testimone della Shoah. Il suo sguardo sul mondo e sulla Storia è oggi più che mai necessario
DI MARCO BELPOLITI – Repubblica 31 Luglio 2019
Caro Primo Levi,
l’altra sera sono passato sotto casa sua sperando di incontrarla. Ma era tardi e probabilmente Lei era già rientrato e stava cenando. Perciò mi sono fermato sotto l’ippocastano della sua poesia, Cuore di legno, e ho provato a guardare in su, verso le finestre del suo appartamento. Era tutto spento. Avevo varie domande da porle. Non si preoccupi, non le chiederò, come l’è capitato varie volte nelle scuole dove andava a parlare della sua esperienza nel Lager, perché Lei e i suoi compagni non siete evasi dal campo di Monowitz-Auschwitz. Dopo aver letto e riletto in questi anni Se questo è un uomo mi sembra di aver capito quale sia stato lo shock che ha subìto entrando nel campo, dove non valeva la divisione tra amici e nemici che c’era fuori: lì dentro tutti nemici di tutti.
L’ha spiegato in un libro straordinario e terribile, I sommersi e i salvati, dove ha raccontato con esempi – i Sonderkommando e Chaim Rumkowski – la forza coercitiva del potere, il modo attraverso cui corrompe l’animo umano. Quello che vorrei chiederle è come ha fatto a scrivere al ritorno dalla deportazione, a ventisette anni, che il Lager non era nient’altro che “una gigantesca esperienza biologica sociale”, come ha compreso che i nazisti non volevano solo sterminare milioni di uomini, ma cambiare la definizione stessa di uomo?
Ogni volta che rileggo il suo primo libro mi colpiscono le quattro storie dei salvati che racconta: Schepschel, Alfred L., Elias e Henri. Ma come è riuscito a catturare sulla pagina il loro carattere, la loro volontà di sopravvivere a ogni costo venendo a patti con il potere dei Kapos e delle SS? L’ha forse aiutato il suo mestiere di chimico? In un suo articolo ha scritto di essere diventato chimico per via del naso, per poterlo usare. Che sia stato proprio il fiuto a farle capire gli uomini così bene e a raccontarli in modo così efficace? Vorrei chiederle anche da cosa le deriva quella capacità di spiegare le piccole cose d’uso quotidiano, e di risalire dai dettagli, dalle minuzie, alle questioni generali. Si tratta di un aspetto che scaturisce dal suo carattere? Ha a che fare con la natura schiva che i suoi amici, ad esempio Massimo Mila, le hanno attribuito?
In un suo articolo Mila ha scritto: “Cortese, affabile; ma con quel suo fisico magro, con quella barbetta scattante, con quegli occhietti vivaci, aveva qualcosa del camoscio, un animale che ispira tanta simpatia, ma che si lascia avvicinare poco”. Ci si ritrova in questa descrizione? Non so se Lei somiglia davvero a un camoscio, ma a vedere le sue foto in montagna, arrampicato sulle rocce o sui tetti dei rifugi, lei sembra davvero un abitante delle vette. Se riuscissi a bloccarla domani all’uscita dal portone, le domanderei: se il suo primo libro, il resoconto del Lager, avesse avuto successo, avrebbe fatto solo lo scrittore? O non è stato meglio guadagnarsi da vivere come chimico, nonostante la fatica che le è costata passare la sera dalla chimica alla scrittura?
In fondo da quella attività alla Siva (Società industriale vernici e affini), come dalla deportazione ad Auschwitz, Lei ha tratto l’ispirazione per scrivere. Lo so che è difficile rispondermi, ma che scrittore sarebbe stato senza l’esperienza nel campo di sterminio? Collegato a questo c’è un’altra questione su cui vorrei un suo parere: non ha forse dovuto subire per tanto tempo il ruolo di testimone, il fatto di essere il testimone per eccellenza, prima dell’antifascismo e poi dell’Olocausto, lasciando così in secondo piano la sua identità di scrittore? Questo non l’ha limitata nella sua possibilità d’esprimersi come narratore?
Una cosa che mi sorprende sempre è il modo con cui le sembrano parlarle gli animali, cui ha prestato spesso la voce, e anche le piante, le cose, gli oggetti in generale. Ho in mente un suo articolo in cui racconta i marciapiedi di Torino e le gomme da masticare spiccicate sui selciati, le loro qualità organolettiche e cinetiche. Mentre cammina per strada cosa guarda?
L’invidio sinceramente per questa sua capacità di mettere a fuoco cose che gli altri non vedono. Non è forse proprio quest’attenzione che dà forza a ciò che ha scritto sul Lager? E poi l’attenzione rivolta agli oggetti del lavoro, come la chiave a stella, o alle mani, nostro primo strumento? E ancora: come le è venuto in mente di criticare Manzoni per i gesti sbagliati che fa Renzo nei Promessi sposi? Non era Manzoni uno dei suoi maestri insieme al sommo poeta Dante?
Già che ci sono, perché è stata così importante per lei la cultura del liceo classico, non è forse lei più un tecnico che non un umanista? Lo so che ha già risposto molte volte nelle interviste, che non sono poche (ne ho contate oltre trecento, quasi tutte negli ultimi quindici anni), tuttavia Lei ha parlato di sé come un uomo diviso, tra chimica e letteratura, tra identità ebraica e italiana. Perché ha scelto proprio la figura mitologica del Centauro per raccontare la sua natura doppia? Non è il Centauro diviso piuttosto tra natura animale e natura umana?
L’animale-uomo, come lo chiama Lei, è quello che si rivela nel Lager, quando gli sperimentatori nazisti hanno voluto capire “che cosa sia essenziale e cosa acquisito nel comportamento dell’animale-uomo nella lotta per la vita”. Non siamo forse noi tutti anche degli animali, e sempre in lotta, come diceva un altro suo maestro Konrad Lorenz?
Un’ultima cosa. Ho letto la lettera che ha scritto nel novembre del 1945, appena tornato da Auschwitz, ai suoi parenti rifugiatisi in Brasile nel 1938 dopo le leggi razziali, per raccontare quanto le era accaduto. C’è una parte sull’Italia che mi ha molto colpito: “Quanto all’Italia, forse qualcosa già sapete. La parte migliore della nostra generazione (nel Nord: a Sud le cose si sono svolte diversamente) ha partecipato alla resistenza contro i tedeschi e i neofascisti, poi alla guerra partigiana e all’insurrezione dell’aprile ’45.
Com’è d’uso, i migliori sono scomparsi, e a cose finite la scena è stata invasa dall’ambizione e dalla dubbia fede. Le superstiti coscienze integre sono deluse: il fascismo ha dimostrato di avere radici profonde, cambia nome e stile e metodi ma non è morto, e soprattutto sussiste acuta la rovina materiale e morale in cui esso ha indotto il popolo. Fa freddo, c’è poco da mangiare, non si lavora; fiorisce il banditismo, e mentre si parla di democrazia sociale, crescono mostruosi nuovi capitalismi nati dal traffico nero: è l’aristocrazia più antisociale”.
Fatte le debite differenze, sembra scritta oggi. Per questo, caro Levi, credo che abbiamo ancora bisogno di Lei del suo sguardo. Proverò a passare di nuovo sotto casa sua nelle prossime settimane nella speranza di intercettarla. Uno come Lei non nasce tante volte in un secolo, e noi siamo stati fortunati ad averla e possiamo continuare a leggerla ancora. Buon centenario!
Suo Marco Belpoliti

Le Meretz, Barak et Shaffir annoncent une fusion aux prochaines élections
Par Raoul Wootliff et Times of Israel Staff 25 juillet 2019
Le président du Meretz, Nitzan Horowitz, sera à la tête de cette liste électorale de gauche, suivi de Shaffir ; Barak s’empare de la place numéro 10, à son souhait
Le parti de gauche Meretz s’associera à Ehud Barak, ancien Premier ministre, et à Stav Shaffir, qui a récemment quitté le Parti travailliste, dans une course commune pour les élections de septembre, ont annoncé les trois partenaires jeudi matin.
Nitzan Horowitz, dirigeant nouvellement élu du Meretz, figurera en tête de liste, suivi de Shaffir.
En dépit de sa place plutôt basse sur la liste, des sources du Parti démocrate israélien ont confirmé au Times of Israël que Barak aurait la garantie de pouvoir choisir le premier un poste ministériel si l’union, nommée le Camp des démocrates, entrait au gouvernement.
La plupart des dix premières places de la liste – hormis Horowitz, Shaffir et Barak – seront données à des législateurs du Meretz. Les places 7 et 9 seront réservées à des membres du Parti démocrate israélien, qui doivent encore être nommés.

Shaffir, étoile montante du Parti travailliste, a critiqué avec véhémence ces derniers jours la décision du dirigeant du parti, Amir Peretz, de former une union avec un parti plus centriste, Gesher, en excluant toute fusion avec Meretz ou Barak. Un communiqué de la liste commune avec le Meretz indique que Shaffir a été une force unificatrice majeure dans les négociations.
La création d’un « ‘Camp démocrate’ est la première étape nécessaire dans la mission visant à remettre l’Etat d’Israël sur la bonne voie », ont déclaré les trois responsables dans un communiqué.
Une course commune évitera une situation dans laquelle les électeurs de gauche auraient été contraints de choisir entre le Parti travailliste, le Meretz et Barak – l’un d’eux serait potentiellement resté sous le seuil électoral de la Knesset, gaspillant ainsi des milliers de voix. Des militants avaient exhorté les partis à unir leurs forces afin de mettre à mal le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a appelé à de nouvelles élections après avoir échoué à former une coalition en mai dernier.
L’annonce de cette union exercera probablement une certaine pression sur Peretz, qui a été pris pour cible par son camp et la gauche pour sa fusion avec la dirigeante de Gesher, Orly Levy-Abekasis.
Pendant plusieurs jours, Shaffir a critiqué Peretz pour avoir écarté une fusion avec d’autres partis, et laissé entendre qu’elle pourrait quitter le parti.
« Dans la situation actuelle, un parti ou même deux dans notre camp risquent de ne pas dépasser le seuil, a averti Shaffir. C’est tout simplement un danger pour ses précieux sièges que nous ne devons pas nous permettre de prendre. »
Mercredi, Itzik Shmuli, numéro 2 du Parti travailliste, a également critiqué Peretz pour son engagement, mais n’a pas précisé s’il quitterait ou non le parti.
Le Parti travailliste est en déclin depuis près de 20 ans. Son résultat aux dernières élections, où il a obtenu seulement six sièges, est le pire de ses 71 ans d’histoire.
Barak a été le dernier dirigeant travailliste à occuper le poste de Premier ministre, mais il s’est séparé du parti afin de rester dans une coalition avec le Likud de Netanyahu en 2011. Sa 10e place sur la liste remet à nouveau son avenir politique en question, et illustre son déclin politique depuis qu’ont été révélés ses liens avec le financier américain Jeffrey Epstein, accusés d’agressions sexuelles. Choisir lui-même la place de numéro 10 pourrait également calmer ses critiques, selon lesquelles il aurait repris la politique pour satisfaire son ego.
La population israélienne retournera aux urnes le 17 septembre, après l’échec de Netanyahu à former une coalition suite au dernier scrutin d’avril. Les partis de droite et de gauche explorent les possibilités de fusion afin de s’assurer de dépasser le seuil électoral de 3,75 %.

‘My name is Sara’, la storia di una tredicenne ebrea parla ai ragazzi di oggi
ARIANNA FINOS 23 luglio 2019
Emozionante proiezione al Giffoni Film Festival del film che racconta la storia vera di Sara Goranik, ebrea polacca che, dopo aver visto la famiglia sterminata davanti agli occhi dai nazisti, fuggì in Ucraina e venne nascosta in una fattoria
Tra i film più applauditi in questo Giffoni edizione 49 c’è My name is Sara, storia vera di Sara Goranik, ebrea polacca che a 13 anni, dopo aver visto la famiglia sterminata davanti agli occhi dai nazisti, fuggì in Ucraina dove assunse l’identità di una amica cristiana, trovando ospitalità e lavoro in una fattoria. “La reazione dei giovani giurati al film, le loro domande profonde mi hanno commosso. I giovani sono il futuro, per questo è importante per noi essere qui. Ci sono tanti magnifici film sull’Olocausto ma noi volevamo portare una storia diversa, focalizzarci su nuove sfumature, parlare dei danni collaterali, le storie di chi è fuggito, si è nascosto, si è perso fuori dai campi di concentramento, ma anche il clima di sospetto e il deterioramento dei rapporti umani, qualcosa che per molti versi ricorda il presente”, racconta il regista esordiente Steven Oritt.
“Molti ragazzi si possono immedesimare in questa storia di una giovane che lotta per sopravvivere, possiede un solo vestito e un solo paio di scarpe. Ed è un magnifico esempio di come, se sei forte, puoi sopravvivere a qualunque cosa, come è riuscita a fare Sara”. “Se fosse viva mia madre avrebbe amato il film, avrebbe pensato che la sua storia poteva aiutare gli altri”, dice il produttore Mickey Shapiro, nonché figlio della vera protagonista della storia”. Tra le difficoltà più grandi c’è stata la ricostruzione d’epoca, il film è ambientato tra Polonia e Ucraina “l’autenticità era fondamentale, fin dall’inizio abbiamo coinvolto consulenti storici in Stati Uniti, Polonia, Ucraina. E ci siamo appoggiati alla USC Shoah Foundation (creata da Steven Spielberg ai tempi di Schlinder’s list), che ci ha dato un aiuto prezioso. La prima testimonianza di Sara l’ho vista alla Foundation, ero stupefatto dai dettagli che ricordava in modo vivido, la sua struttura di racconto era già quella di un film. Poi ovviamente il nostro non è un documentario, ci siamo presi libertà narrative pur essendo sostanzialmente fedeli alla storia”.
Molto del film poggia sulla bravura della protagonista, Zuzanna Surowy: “la ricerca dell’attrice è stata imponente. Quando ci siamo incontrati chiesi a Sara ‘come fa una ragazzina di tredici anni a sopravvivere in quelle condizioni?’ Lei mi ha risposto: ‘Ascoltando senza mai parlare’. Ho capito che dovevo cercare un’attrice che potesse calarsi così tanto nel trauma da andare avanti quasi con il pilota automatico, il pensiero fisso alla sopravvivenza. Ho visto una quarantina di attrici in America, erano giuste per età ma non ero convinto. Abbiamo riempito di volantini le città polacche, sono arrivate centinaia di ragazze. Visionando i provini mi sono imbattuto in Zuzanna, ricordo esattamente quel momento perché ho capito subito che era lei”. È andato in Polonia a conoscerla, sapendo che l’esperienza del set sarebbe stata dura: “sono rimasto conquistato: è seria, determinata, disciplinata, e sostenuta da una famiglia piena di amore. Anche se non ci sono campi di concentramento nel film, ho voluto portare Zuzanna ad Auschwitz per comprendere meglio il dramma dell’Olocausto”. La vera Sara non è mai voluta tornare in quel luogo, sarebbe stato troppo doloroso per lei. Ha sofferto a lungo di stress post traumatico, è scomparsa nel 2018, il ricordo più bello lo regala il figlio maggiore: “Prima che si ammalasse di demenza facemmo una serata in onore dei sopravvissuti, vennero Spielberg e tante star di Hollywood. Il sorriso meraviglioso di mia madre, la sua gioia di quel giorno sono l’immagine di lei che mi porto dentro”.
La difesa postuma di Oriana Fallaci? Un inno al conformismo
di Stefano Jesurum 29giugno 2019
Con le idee che propugnava Oriana Fallaci (riposi in pace) si può essere molto, un po’, per niente d’accordo. Di fronte alla sua scrittura e alla sua professionalità di giornalista e scrittrice ci si deve inchinare e basta. Ma innalzare un peana del suo andare controcorrente a testa alta, del suo sfidare continuamente il conformismo, del suo essere ribelle davanti agli stereotipi correnti si può, se si vuole, anzi in questo caso si deve fare, ma rigorosamente swimming against the current.
Il nuotare controcorrente di skakesperiana memoria messo a incipit del pezzo per commemorare i novant’anni dalla nascita di Oriana dal professor Pasquale Hamel (gli Stati generali del 28/6/2019) suona però come un ossimoro, dal momento che è un monumento ai nuovi luoghi comuni del mainstream odierno.
Bene fece, ad esempio, la scrittrice a non accettare di indossare il velo per intervistare l’ayatollah Khomeini, però da qui a esaltarsi nel 2019 per la definizione di “stupido cencio del Medioevo”, bè, insomma, anche no. Ancora (sempre tenendo ben presente di quanti anni sono passati da quando Fallaci sentenziava “assoluti” che dopo nuove verità acquisite e analizzate più approfonditamente oggi sono per lo meno discutibili): la “rilassante vacuità del politically correct”, “intellettuali della sinistra radical chic che avevano”, dice Hamel, “l’arroganza di pensare che le proprie tesi non potevano essere messe in discussione”.
Non so come si ponga il professor Hamel di fronte alla deriva illiberale imboccata dal nostro paese. Certo è che l’Italia non è più quella conosciuta da Oriana Fallaci. Alla quale spero nessuno vorrà mettere in bocca neo sciocchezze tipo l’aggettivo buonista oppure imprecazioni razziste e fasciste come quelle urlate dal “popolo” di Lampedusa nei confronti della capitana Carola Rackete.

La rebetsin Perele
Di Stefano Jesurum 4 luglio 2019

Per chi come me si appassionò a Isaac B. Singer prima che vincesse il Nobel nel 1978, e sull’onda di quella passione intraprese la strada piena di meraviglie della letteratura yiddish, oggi la pubblicazione da parte di Giuntina de La moglie del rabbino di Chaim Grade è stata, giustappunto, l’ultima, ennesima meraviglia. Non soltanto perché la storia si dipana in maniera divertente e insieme profondissima tra intrighi familiari e di shtetl, intrighi che ruotano attorno a una donna di potere, la rebetsin Perele, moglie e madre perennemente delusa e incattivita, personaggio odioso e tuttavia ispiratore per taluni versi di ammirazione. Gradevolissima lettura quindi. Come dicevo, non solamente di evasione però.
Parola dopo parola, gesto dopo gesto, “sentire” dopo “sentire”, nella mirabile traduzione di Anna Linda Callow si coglie la sostanziale differenza (che Callow medesima ben ci spiega e erudisce nella postfazione) tra ultraortodossia chassidica di matrice sostanzialmente polacca (e dintorni) e haredismo (si può dire?, non so, ci provo) lituano. Più semplicemente: manca, anzi è osteggiato e criticato, l’aspetto mistico tanto presente nella più conosciuta letteratura yiddish mitteleuropea. Grade quindi grande cantore di una particolare fetta di Mondo Scomparso, la fetta cresciuta intorno a Vilna, Gerusalemme di Lituania, Yerushalaim de-Lita. Con le dovute differenze legate al passare del tempo, una atmosfera haredi lituana la si trova a B’ne Brak, grande sobborgo satellite di Tel Aviv o in precise zone di Gerusalemme, nulla a che vedere appunto con il chassidico Mea Shearim.
Dice bene Anna Linda quando sostiene che quello di Grade è un libro “che si può leggere in molti modi, non da ultimo per capire qualcosa, da un’angolazione diversa dal solito, di un settore importante e anche molto contestato dell’Israele odierna che, grazie soprattutto al suo sviluppo demografico, sta acquistando un’influenza crescente sulla società”. Il mondo dei grandi rabbini dai molti seguaci, dei giovani che studiano nelle yeshivot, delle dispute roventi su questioni politiche e/o di principio, dei religiosi sionisti e antisionisti, delle lotte per la successione alla guida delle varie comunità…

Tra gli ortodossi d’Israele che ora dettano legge. E il Mossad li vuole 007
Di Davide Lerner 21 luglio 2019
Cappotto nero, rigidi rituali, sussidi: presto saranno il 30% della popolazione. Sempre più decisivi in politica, invisi ai laici: così cambiano il volto del Paese.
BNEI BRAK (Israele). «Tel Aviv è a dieci minuti da qui
ma non ci metto piede, per carità, là le donne vanno in giro mezze nude. Chi si
espone a quel mondo lì poi torna in yeshivà e non capisce più niente degli
studi religiosi» dice Elad Kuper, ultraortodosso israeliano di 27 anni,
passeggiando nell’enclave haredi di Bnei Brak.
Kuper abita con la moglie e i suoi primi tre figli (la media per gli
ultraortodossi è di circa sette) in una stanza e mezza affittata in uno stabile
sgangherato e circondato di spazzatura, vicino alla sovraffollata arteria di
“Rabbi Akiva”. Vive del sussidio della yeshivà, la scuola religiosa, che
ammonta a 2.000 shekel al mese (490 euro), in buona parte prelevati
direttamente dalle casse dello stato. Studia di notte – «solo col buio si
raggiunge la massima concentrazione secondo l’importante rabbino Shimon Bar
Yochai» – e durante il giorno aiuta un vecchio per raggranellare qualche altro
shekel.
Ma nella comunità ultraortodossa sono piuttosto le mogli che, non “obbligate” a
studiare le scritture ininterrottamente, sono autorizzate a fare qualche
lavoro: in molte, come la ventiquattrenne Avigail, moglie di Kuper, fanno le
maestre a scuola o negli asili part-time. Agli sforzi del governo per cerare di
spingere più ultraortodossi a integrarsi nella società “mondana” si è di
recente aggiunto niente meno che il Mossad, l’agenzia di intelligence
israeliana.
«Abbiamo cominciato ad assumere personale ultraortodosso dopo lunghi percorsi
propedeutici specializzati», ha detto il direttore del Mossad Yossi Cohen
all’inizio del mese, citando una collaborazione con la Ong Pardes che si pone
l’obiettivo di conciliare la vita religiosa degli haredim con quella lavorativa,
finanche nel settore della difesa.
Kuper è un caso particolare nella comunità ultraortodossa: è un hoser
leteshuva’ (colui che ritorna alla chiamata), cioè ha vissuto da laico fino a
circa vent’anni, compreso il servizio militare, prima di scegliere il lungo
cappotto nero e il cappello a larghe tese dei religiosi.
Ma per i suoi figli la strada è segnata. Kuper scandisce: «Dai 3 ai 13 anni
talmud torah, poi yeshivà fino al matrimonio, che verrà organizzato da un
“shachdan” o agente matrimoniale e approvato dai genitori, poi continueranno a
studiare al kollel, la scuola religiosa per uomini sposati. Qui le vite sono
semplici, è tutto pre-ordinato: non bisogna mai prendere decisioni», dice.
«Ovviamente useranno cellulari kasher, che possono fare solo telefonate. E
quando a 18 anni arriverà lo “zav rishon”, la chiamata dall’esercito, ci faremo
dare un certificato d’esenzione dalla yeshivà», spiega.
Proprio sul risentimento verso i super-religiosi, visti come parassiti che
eludono il servizio militare e vivono di sussidi statali da molti israeliani,
si sono incagliati i negoziati per formare il quinto governo del primo ministro
Benjamin Netanyahu. Ed è probabile che la stessa impasse si riproponga
dopo le nuove elezioni del prossimo settembre: Avigdor Lieberman,
che ha impugnato la causa dei laici, ha già detto che non farà sconti per
andare in coalizione coi religiosi. E, secondo recenti sondaggi della
televisione israeliana, senza Lieberman Netanyahu, ancora una volta, non sarà
in grado di formare un governo.
Secondo l’Ocse, entro pochi decenni la componente haredi della società
israeliana (attualmente circa un milione) potrebbe raggiungere il 30 per cento
della popolazione, con gravi conseguenze su economia e politica del Paese. «È
fondamentale che vengano rivisti i curriculum delle scuole haredi inserendo
materie più classiche, dalla matematica alle scienze all’inglese, se si vuole
favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro», ha detto Peter Jarrett
dell’Ocse al giornale economico israeliano The Marker. «È una battaglia
contro il tempo», ha aggiunto.
C’è anche chi, come il noto scrittore israeliano Yuval Noah Harari, autore del
bestseller “Sapiens,” interpreta la questione degli ultra-ortodossi in chiave
positiva. In un mondo in cui l’automazione rendesse i mestieri dell’uomo sempre
meno utili, teorizza nel suo ultimo libro “21 lezioni per il XXI secolo”
(Bompiani editore), le persone godranno di un reddito di cittadinanza e
dovranno realizzarsi facendo a meno del lavoro. Ecco allora che gli
ultraortodossi, secondo diverse ricerche appagati da una vita fatta di soli
rituali, sarebbero un’avanguardia da imitare invece che una zavorra di cui
disfarsi, relegandola al passato remoto. Ma, per ora, la preoccupazione
principale in Israele rimane quella di come favorire una loro integrazione alla
luce del crescente peso demografico ed elettorale.
Al contrario della minoranza araba, anch’essa poco emancipata nella società
israeliana, le autorità religiose haredi mandano i propri discepoli a votare
come soldati. «Sappiamo che avere peso politico conta parecchio, anche se la
nostra società vive separata», spiega Kuper.
Per misurare il peso politico degli ultraortodossi basta prendere in mano le
prime pagine goliardicamente distopiche dei giornali “haredi” all’alba
dell’ultima consultazione elettorale: “Matrimoni civili in arrivo,” “Trasporti
pubblici di Shabbat (sabato) nella maggior parte delle città del Paese,” e
ancora “Coscrizione obbligatoria per tutti”. Nessuno di questi scenari, con 16
deputati ultra-ortodossi alla Knesset, si possono realizzare.

ISRAELE-PALESTINA: COSA RESTA DEL “PATTO DEL SECOLO” DI TRUMP?
| A cura di: Eugenio Dacrema, Associate Research Fellow, ISPI MENA Centre ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 24 giugno2019 |
Il 25 e 26 giugno si terrà a Manama, in Bahrein, una conferenza economica che vedrà la presenza di rappresentanti di numerosi stati arabi, degli Stati Uniti e di Israele. Nella mente dei suoi ideatori – in primis il genero di Donald Trump Jared Kushner e l’inviato statunitense per il Medio Oriente Jason Greenblatt – questo incontro avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per presentare gli aspetti economici del cosiddetto “Patto del Secolo” (Deal of the Century), ovvero il piano dell’amministrazione Trump per mettere fine al conflitto israelo-palestinese. Alcuni imprevisti hanno però ridimensionato le aspettative degli organizzatori, i quali nelle ultime settimane hanno cercato di riformularne il significato per evitarne il completo fallimento. Quali sono quindi i nuovi obiettivi che gli organizzatori si prefiggono? Chi vi parteciperà? E quanto verrà svelato sul “Patto del Secolo”?
La verità è che, se non fosse per la pompa magna che ne ha accompagnato l’annuncio all’inizio dell’anno, quello che ci apprestiamo a vedere in Bahrein sarebbe uno di quegli eventi che anche gli osservatori abituali della regione tendono a segnalare come una semplice nota a margine. Questo perché la Conferenza di Manama è stata progressivamente ridimensionata dai suoi stessi ideatori – tanto che la sua definizione ufficiale è stata recentemente “degradata” da “conferenza” a “workshop” – a causa di alcuni imprevisti occorsi nell’ultimo mese. Il più grave è l’annuncio di nuove elezioni in Israele il prossimo 17 settembre, dopo il fallito tentativo del Premier in carica Benjamin Netanyahu di formare una maggioranza di governo in seguito alle consultazioni dello scorso aprile. Ciò ha comportato un nuovo rinvio della presentazione ufficiale del “Patto del Secolo” – inizialmente prevista questo mese – al prossimo autunno, quando un nuovo governo israeliano si sarà sperabilmente insediato. Come spiega Giuseppe Dentice in questo commentary, la Conferenza/Workshop di Manama, che doveva enucleare gli aspetti economici dell’accordo in concomitanza con la presentazione del Patto tout court, si è trovata quindi improvvisamente “azzoppata” della sua parte “politica”. A complicare le cose sono poi intervenute le resistenze di molti paesi arabi a partecipare a un incontro internazionale in presenza di una delegazione israeliana di alto livello. Per permettere una quanto più ampia adesione di stati arabi, quindi, è stato necessario ridurre il livello della partecipazione israeliana, la quale nei piani iniziali di Washington avrebbe dovuto includere lo stesso Premier Netanyahu. La delegazione in arrivo da Tel Aviv sarà quindi composta da uomini d’affari vicini al governo ma privi di cariche pubbliche rilevanti. Tutto ciò non è comunque servito a evitare il boicottaggio della conferenza da parte dell’Autorità Palestinese che, contraria fin da subito al piano Trump, è riuscita a mostrarsi compatta e a resistere alle pressioni statunitensi. In sostanza, quindi, la Conferenza annunciata in pompa magna pochi mesi fa assomiglia oggi più a un incontro preparatorio minore, in attesa che il Patto effettivo venga annunciato in autunno.
Al fine di garantire che non si tratti di un completo flop, gli organizzatori della Conferenza dovranno trovare il modo di darle un significato di qualche rilievo, sia nel framework del piano di pace israelo-palestinese sia rispetto agli ultimi avvenimenti che hanno riguardato la regione, in particolare la recente crisi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico.
Per quanto riguarda la questione israelo-palestinese, è da aspettarsi che a Manama vengano comunque rivelati alcuni aspetti fondamentali del piano Trump, che ha nella parte economica un pilastro fondamentale. Dalle voci trapelate finora, infatti, la logica fondamentale sottesa al “Patto del Secolo” è proprio quella dello scambio tra la rinuncia ad alcune fondamentali rivendicazioni palestinesi – Gerusalemme capitale, ritiro israeliano dal Golan, diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi all’estero, formazione di uno stato indipendente in Cisgiordania e a Gaza – in cambio di ingenti investimenti e aiuti economici a favore di uno stato palestinese solo semi-indipendente e limitato ad alcuni territori della Cisgiordania (forse sotto tutela congiunta israeliana a giordana) e verso i campi profughi palestinesi all’estero, i cui abitanti dovranno essere incorporati come cittadini negli stati che li ospitano. Secondo indiscrezioni, a Manama verranno promessi non meno di 50 miliardi di dollari in investimenti e aiuti, provenienti soprattutto dagli stati arabi del Golfo. In assenza di dettagli sui contenuti effettivi del piano Trump e di qualunque legittimazione del “Patto” da parte di qualunque rappresentante palestinese queste cifre rischiano però, con alta probabilità, di rimanere semplici numeri sulla carta con ben poche conseguenze concrete. La speranza di alcuni diplomatici americani, come Dennis Ross, è quindi che la discussione si concentri meno su piani di lungo termine e più sulle esigenze immediate dei palestinesi, le cui istituzioni e condizioni di vita sono allo stremo sia in Cisgiordania sia a Gaza.
L’incontro di Manama potrebbe però essere utilizzato da alcuni dei suoi più entusiasti partecipanti – ovvero Arabia Saudita ed Emirati, le due monarchie del Golfo più vicine a Israele e all’amministrazione Trump – anche per discutere della presenza iraniana nella regione. Non è un segreto infatti che il sostegno di queste nazioni al piano Trump – e la loro disponibilità a investirvi ingenti somme – sia soprattutto dovuta all’obiettivo di ricevere in cambio un attivo supporto statunitense contro Teheran.
La Conferenza di Manama rischia quindi di essere un flop, quantomeno rispetto agli obiettivi originali per cui era stata ideata. Ma secondo voci sempre più insistenti, a rischio fallimento non vi è ormai solo il workshop economico in Bahrein, ma l’intero piano Trump, ovvero quel “Patto del Secolo” di cui si parla da oltre due anni. Dopo aver subito numerosi rinvii e impreviste resistenze anche da parte di stati arabi molto vicini a Washington, come la Giordania, il “Patto” ha ricevuto un nuovo colpo – forse questa volta mortale – dall’annuncio di nuove elezioni israeliane. Secondo l’ultima versione della scaletta di implementazione formulata dai suoi ideatori – primo fra tutti il genero del presidente americano Jared Kushner – la presentazione ufficiale del piano sarebbe dovuta arrivare questo mese, poco dopo la formazione del nuovo governo a Tel Aviv. Il fallimento di Netanyahu nella ricerca di una nuova maggioranza parlamentare ha fatto slittare l’annuncio almeno fino al prossimo autunno, periodo che però cade in concomitanza con l’inizio della campagna per le elezioni presidenziali del 2020 negli Stati Uniti. Secondo diverse voci circolanti negli ambienti diplomatici, la strategia emergente nella regione – soprattutto fra gli stati contrari come la Giordania e l’Egitto – sarebbe quella di smettere di contrastare il piano in modo diretto – dopo molti tentennamenti Giordania ed Egitto manderanno infatti una delegazione a Manama – e di aspettare che il “Patto del Secolo” muoia di “morte naturale” dopo l’estate. La stessa amministrazione americana sarebbe sempre più scettica sulle effettive possibilità di riuscita del piano e non sarebbe disposta a spenderci troppo capitale politico in piena campagna elettorale. Ad amplificare questa percezione da parte degli americani vi sarebbero anche gli atteggiamenti ambivalenti dimostrati da molti alleati arabi durante l’organizzazione della Conferenza di Manama. Mentre, infatti, durante incontri privati molti leader si sarebbero detti disposti a partecipare insieme a una delegazione israeliana di alto livello, gli stessi leader avrebbero poi rinnegato le proprie affermazioni nei loro annunci pubblici, sconvolgendo i piani americani. Ciò avrebbe dimostrato ai membri dell’amministrazione Trump l’evidente difficoltà, anche per i leader più vicini a Washington, di accettare pubblicamente un piano che azzera di fatto le principali storiche rivendicazioni del popolo palestinese. Scarso entusiasmo, inoltre, sarebbe stato dimostrato dallo stesso governo israeliano il quale, dopo aver incassato alcuni obiettivi cruciali come il riconoscimento statunitense di Gerusalemme capitale e della propria sovranità sul Golan, non sarebbe ora altrettanto entusiasta di accettare le seppur limitate concessioni previste dal “Patto del Secolo”.

Israel Is at Peace (With Itself)
The country can’t form a government, its peace process is permanently stalled—and things have never been better.
By Steven A. Cook | May 30, 2019, 5:30 PM
When Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu failed to form a government on Wednesday, you could hear a collective groan from all 8.7 million Israelis at the thought of having to endure another election campaign this fall. But the exasperation was quick to dissipate. Israelis—at least Jewish Israelis—are at peace with themselves and aware they are enjoying an unreservedly good moment. “It could be worse,” declared a former Israeli official as we sipped coffee on a spectacular May evening overlooking the Old City of Jerusalem’s Jaffa Gate.
The country is clearly on a roll. Israel ranks as the 13th-happiest country in the world, its economy is steady at 4 percent unemployment, no one is afraid to board a bus, the tourists keep coming, relations with its neighbors are mostly good and growing, and no one (outside of the government) much cares about the Boycott, Divestment, and Sanctions movement. On that May evening, one would have never known by the crowds on the beach south of Tel Aviv that Hamas and other extremist groups had recently poured rocket fire into Israel from Gaza or that the U.S. national security advisor was threatening war with Iran. The rockets had stopped, there was no war, and so things were good. They certainly “could be worse.”
Among the many benefits of personally visiting a given country is the chance to take all the chatter currently in circulation about it before separating the nonsense from the relevant parts. This is especially true in Israel’s case given the distortions and even outright lies that have become accepted facts about the country. The Israelis have a lot to answer for, including their slow-rolling, 52-year-long annexation of the West Bank; the terrible conditions they’ve allowed to fester in the Gaza Strip; and the so-called corporate Mossad that is doing everything from running hit squads for hire in Yemen to providing spyware to unsavory governments around the world. But Israelis do not harvest the organs of Palestinian prisoners, and they are not responsible for police brutality in the United States. On most of the crucial issues of the day, Israelis simply do not conform to much of the most widely prevalent reporting, analysis, and caricatures, both good and bad.
Now that the Israelis find themselves again waiting for a new government, the peace plan prepared by White House staffer Jared Kushner (if it even exists) will itself have to wait until at least September for its rollout. But the whole thing barely rates a mention among Israelis. They seem to be more interested in chatting about Israel’s domestic political dramas. Mostly they do not seem to care about foreign efforts to forge peace, because it has become an article of faith that the Palestinians cannot, will not, and do not want to negotiate in good faith. That there is “no partner” sounds like an excuse, especially because Palestinian security forces have worked hard to maintain security, but it speaks to the searing experience of the Second Intifada that ended almost 15 years ago.
The Israelis have managed to use technology, territory, power politics, and the success of Israel’s economy to minimize the pain to themselves of occupation. The one thing that the Palestinians can do that would make a difference is something they emphatically will not do: shut down the Palestinian Authority and make the Israelis pay an actual price for their occupation and annexation. Under these circumstances, the Israeli attitude seems to be, “Let Jared Kushner try to sell his plan—we have better things to do.”
If Israelis are feeling any sort of worry right now it’s over Iran—or rather, U.S. President Donald Trump’s Iran policy. Israel has always been a sort of regional Sparta—heavily militarized with steely national security focus—but it has also been more cautious than anyone gives it credit for. After years of sounding the alarms, raising red flags, and otherwise trying to get the attention of just about everyone concerning Iran—efforts that were almost always interpreted as warmongering—the Israelis are pleased that Trump understands the challenge the Iranians pose and like the squeeze Washington is putting on Tehran. That is a long way away from wanting war, however. The Israelis I met were worried about the price they and their kids would pay in the event of a conflict between the United States and Iran. No one believed National Security Advisor John Bolton’s saber-rattling was wise, and they certainly did not want it to be at their behest. Their lives were good, after all. Deterring the Iranians, like what the IDF has been doing in Syria, seems to be their preferred policy, particularly because the Iranian response has been weak.
If not for Netanyahu’s legal troubles, he likely would have won April’s election in a landslide. Netanyahu tends to frame all discussion of politics among Israelis. That makes sense given how long he has been prime minister, but it also speaks to how dominant he and the right have become. The coalition of former generals (plus one TV anchor) known as Blue and White is not an opposition in terms of its conservative approach to policy, but rather personality. Taken together, Netanyahu has already won half the battle.
Between now and September a lot of smart analysts will game out the Israeli elections and inform their readers and listeners of all the different ways in which Netanyahu is vulnerable. But upon the dissolution of the Knesset, an Israeli interlocutor—someone who dislikes the prime minister—sent me a message saying he cannot be hopeful for a different outcome. That is because Netanyahu, for all his faults both real and perceived, has kept Israel prosperous and safe. And that is what Israelis seem to care about most and why heading into a long, hot summer of crazy politics and electioneering, the prime minister continues to have the electoral edge. If Netanyahu is interested in a new campaign slogan, he’d be smart to consider: It could be worse.
Steven A. Cook is the Eni Enrico Mattei senior fellow for Middle East and Africa studies at the Council on Foreign Relations. His latest book is False Dawn: Protest, Democracy, and Violence in the New Middle East.

Israele e Gay Pride, una lunga storia
di Stefano Jesurum dal libro “Israele nonostante tutto”, Longanesi, 2004
…. Io so cosa fare adesso, me ne torno a Tel Avìv, lì ci saranno pure “quelli che fanno le feste”, ma a Gerusalemme la cupezza attanaglia, avvolge e diviene angoscia. Troppe certezze, troppe fedi e tutte assolute, troppo assoluto, troppo di tutto. Da ragazzi ci si può permettere di sentirsi profeti, si può essere convinti di avere la verità in tasca. Quanto ero orgoglioso di partecipare al picchetto d’onore che all’università Statale di Milano accoglieva il compagno Abù Qualcosa. “Sì – mi convincevo – sono un ebreo giusto”. Poi mi hanno fatto capire che ero un ebreo e basta.

1972, Monaco, Germania, i fedayn compiono un massacro. Il 5 settembre, alle quattro e dieci del mattino, un commando di otto uomini riesce a entrare negli alloggi della squadra olimpica israeliana. I terroristi di Settembre Nero uccidono subito l’allenatore di lotta libera Moshe Weinberg e il campione nazionale di sollevamento pesi Yosèf Romano. Nell’appartamento al numero 31 di Connollystrasse ci sono altre dodici persone. Tre riescono a scappare, nove vengono prese in ostaggio: i lottatori Mark Slavin e Elièzer Halfin, i pesisti Davìd Berger e Zeev Friedman, gli allenatori Kehat Shorr, Andre Spitzer e Amitzur Shapiro, i giudici Jokov Springer e Joseph Gotfreund. In cambio della loro liberazione, il governo israeliano dovrebbe scarcerare immediatamente duecentotrentaquattro prigionieri, il governo tedesco i principali esponenti della Rote Armee Fraktion. Da Tel Avìv il premier Golda Meir fa sapere che non tratta. Il risultato è un orripilante bagno di sangue: muoiono i nove ostaggi più un poliziotto e un pilota d’elicottero, dei fedayn cinque sono uccisi e tre catturati.
Le Olimpiadi non si fermano, the show must go on. Che vergogna. Corro in via Festa del Perdono, dove c’è la mia università, la mia famiglia, il mio Movimento studentesco. Con l’eloquio tipico di quegli anni dico che questo è un tragico errore, che così si infanga la giusta causa del popolo palestinese. I miei capi rispondono: “Su questi temi, voi compagni ebrei è meglio che stiate zitti”. Quella sera, a casa, piango.
Il passare degli anni peggiora le cose. Mi aspetta dell’altro. Ad esempio vedere nelle recenti manifestazioni per la pace qualche maledetto imbecille vestito da kamikaze di Hamàs. O sapere che a Parigi i compagni di mia figlia, i ragazzi dell’Hashomèr Hatzaìr, scendono in piazza a urlare insieme a tanti che la guerra in Iràq è sbagliata, che va fermata: ma dal momento che indossano la casacca azzurra del movimento sionista-socialista, che proprio in quei giorni compie novanta anni, allora li picchiano selvaggiamente. Sarà per questo che adesso io, da non osservante quale sono, il 25 aprile e il Primo maggio sfilo dietro alle rosse bandiere internazionaliste con la mia brava kippà (non ricamata) in testa?
Sono i ricordi a tenermi sveglio mentre scendo a Tel Avìv. Cerco un baretto a Nèveh Tsèdek, quartiere chic-alternativo che non ha nulla da invidiare a certe zone di Parigi o Londra o New York. Ho urgenza di aria, di persone che sappiano sorridere, godersi la vita, ho bisogno di un buon cocktail. Il cuore di Nèveh Tsèdek è via Shabàzi, con le sue erboristerie e i locali dove praticano massaggi di ogni genere purché siano orientaleggianti, le palestre per arti marziali, eleganti boutique, scuole di danza del ventre, negozi che vendono vecchi manifesti, centri yoga, bigiotteria non convenzionale, ricercatezze.
Alcuni padri rasta passeggiano con il figlioletto infilato nel marsupio appoggiato sulla pancia, giovani donne pedalano su biciclette dai portapacchi carichi di sacchetti, una vecchia coppia di raffinati omosessuali esce a mani vuote dalla libreria dove forse ha cercato un romanzo che non è più in commercio. Ci sono molti cani, grandi, piccoli, di razza, meticci. Anni fa, in Israele, ce n’erano pochissimi, di cani. Chiedevo perché e mi rispondevano: “Non abbiamo tempo, c’è altro di cui occuparsi”.
Dietro a via Shabàzi scorre un labirinto di stradine su cui si affacciano caffè con giardini da mille e una notte. Sbirciando attraverso i portoni delle case più affascinanti appaiono all’improvviso cortili fioriti. In uno, sotto a un albero, una soldatessa in divisa verde, con il mitra appoggiato sul fianco, sta baciando appassionatamente un ragazzo con la coda di cavallo bionda, e lui con una mano le accarezza il seno, con l’altra la tiene appiccicata a sé.
Desiderio, sesso, amore, tenerezza. Il contrario delle caserme, delle camerate. Ricordo ciò che mi ha bisbigliato la moglie di un amico: “Per noi donne la Tzavà è più pesante, per le cose che vedi intorno, per i turni massacranti, per la nostra stessa natura. Però se ti dai al tuo ufficiale – e ce ne sono di assai carini – diventa più facile, è ignobile e umiliante, ma più facile”.
Al cameriere che porta un martini vodka domando informazioni sull’associazione Agudà per la “protezione dei diritti individuali”. La si raggiunge in meno di un quarto d’ora. L’indirizzo che avevo appuntato sul taccuino era sbagliato, per fortuna dalle finestre della sede sventola un enorme e riconoscibilissimo drappo arcobaleno. Ad aprire è Shaul, la cui massiccia corporatura da paracadutista è in netto contrasto con l’acquosità malinconica degli occhi celesti. C’è un altro giovane uomo presente che invece è scuro, riccio e mingherlino, porta la kippà ricamata dei religiosi, e la cosa – debbo ammetterlo – mi colpisce. Mi stupisco del mio stupore, per un istante vince l’imbarazzo. Di loro non so nulla, soltanto che rappresentano l’orgoglio gay. Essere gay, da queste parti, ha un significato – se possibile – ancora più estremo che in altre regioni del mondo. Vuol dire, per esempio, che esistono più di cinquecento individui fra i venti e i trent’anni, omosessuali, bisessuali e transessuali, che si nascondono nei sobborghi di Tel Avìv, che non possono lavorare perché non hanno un permesso di soggiorno, che vivono nel terrore di essere arrestati dalla polizia e di essere rispediti a casa. Ovvero a Ramallah, Gaza, Nablus. Sono palestinesi che convivono con un compagno ebreo. Si nascondono dalle famiglie che, se li trovassero, purificherebbero col sangue il disonore di un figlio o un fratello luti, contronatura secondo il mondo musulmano, frocio, finocchio, checca.
Shaul mi dice di Loren, all’anagrafe israeliana maschio, nella quotidianità donna truccatissima dai lunghi capelli tinti di biondo. Il lui di Loren si chiama Mohàmmed, ventiduenne bisex muscoloso con occhi grigioazzurri. La loro tana è in un agglomerato di emarginazione pullulante di lavoratori stranieri, cinesi, africani, filippini, centro-americani, molti dei quali sono clandestini. Povertà e paura.
Shaul racconta anche di una tragedia. Quella di Adam, ebreo divorziato con due figli, e di Shon, più giovane, palestinese di Hevròn. Shon l’hanno beccato e la legge l’ha rimandato a casa. Di lui Adam non ha saputo mai più nulla.
Shaul parla, si infervora e suda per l’agitazione, la commozione e la rabbia. Shaul parla e il mingherlino con lo zuccotto se ne resta nell’angolo e tace, gli occhi bassi, le mascelle contratte.
Shaul porta a esempio Uzi Even, rinomato docente universitario di chimica che nel 1993 sfidò la Knesset, il Parlamento, con parole di libertà. Anni dopo, Uzi, che aveva passato la sessantina, alla Knesset ci è tornato da deputato del Mèretz, il partito della sinistra sionista progressista che sta a sinistra del Labour party. Però intanto lo hanno cacciato dall’intelligence dell’esercito, gli hanno revocato il grado di ufficiale riservista, gli hanno reso la vita impossibile all’ateneo. La guerra di Uzi alla fine lo ha premiato: in uno dei periodi in cui era Primo ministro, Yitzhàk Rabin aveva ordinato che la legge militare fosse corretta e i soldati gay non più discriminati.
L’omone dagli occhi celesti continua a parlare e il mingherlino se ne resta nell’angolo. Shaul ha l’orgoglio – gay o no poco cambia – di chi vuole sfidare, il piccoletto si aggiusta nervosamente il copricapo ricamato dei religiosi. Vorrei condividere questo momento con un caro amico ebreo italiano omosessuale, uno di quelli che faticano a vivere, che stanno male. Lui andava nei parchi in cerca di arabi, e solo di arabi. Li aveva conosciuti nei suoi anni francesi belli e forsennati, in quei sottoponti della Senna che brulicano l’intera notte di lavoratori mediorientali che vanno lì a sfogarsi negli orifizi dei parigini. Il mio amico voleva liberarsi di un padre retto e severo, giusto e castrante, buono e perfido, pio e ottuso, voleva liberarsi di se stesso. Chissà se nei luridi sobborghi di Tel Avìv l’eros proibito dalla Bibbia scorre con maggiore serenità; mi chiedo che cosa provino mentre si scopano due maschi che non possono fare a meno di guardare i propri cazzi circoncisi, segnati entrambi dal Patto con l’Onnipotente, solo che per uno il patto è stato siglato da Abramo e per l’altro è stato riconfermato da Maometto.
Diceva il buon vecchio Ben Guriòn che Israele sarebbe diventata finalmente una nazione normale qualora avesse avuto i suoi ladri e le sue puttane. Ai gay e alle lesbiche non ci pensava, non erano tempi.
Stefano Jesurum

Le parole di Primo Levi: Dio e gli ebrei
di MARCO BELPOLITI Repubblica 5 giugno 2019
Il 31 luglio di quest’anno Primo Levi avrebbe compiuto 100 anni, abbiamo pensato di raccontarvelo in 13 parole, tredici lemmi, uno per settimana, che riassumono la sua opera così importante, vasta e poliedrica. Sono voci di una piccola enciclopedia portatile per conoscere aspetti della sua opera e della sua vita, dalla presenza degli animali nei suoi libri al rapporto con la fede religiosa e l’ebraismo, dalla poesia alla chimica e alla fantascienza. Un ritratto a tutto tondo di un autore decisivo per la nostra letteratura, ma anche per la nostra coscienza civile.
Nel novembre del 1983, quattro anni prima della sua morte, un giornalista del settimanale “Gente”, Giuseppe Grieco, va trovare Levi a Torino. Sta pubblicando una serie d’interviste dedicate al rapporto con Dio. Il secondo interlocutore è proprio lo scrittore torinese, ex chimico in pensione. L’esordio è diretto: “Io credo di essere un caso estremo – dice – , nel senso che quello di Dio è un problema del quale finora non mi sono mai veramente occupato. La mia è la vita di un uomo che è vissuto, e vive, senza Dio, nell’indifferenza di Dio”.
Lo dice con molta tranquillità e tutta l’intervista è una dichiarazione di ciò che possiamo definire il suo agnosticismo. L’anno precedente Levi ha incontrato Elie Wiesel, anche lui deportato ad Auschwitz, che ha fatto dell’Olocausto il centro della sua vita – Wiesel ha anche dato legittimità a questo termine che significa “tutto bruciato”. Levi dice che Wiesel è divenuto in un certo senso un “ossesso” di Dio, mentre lui è rimasto nella sua non-fede. Com’è possibile?, gli chiede Grieco. Non ha forse invidia per chi aveva la fede nel Lager? Certo gli risponde Levi: “Io invidio i credenti. Tutti i credenti”.
L’intervista è molto chiara e racconta il rapporto di Levi, non solo con la religione, ebraismo compreso, ma anche con il tema del Male, che ossessiona i credenti: se c’è stato Auschwitz, dove era Dio? Perché l’ha permesso? Wiesel, spiega lo scrittore torinese, si è trovato a vivere brutalmente da credente il grande trauma di Auschwitz, quello del “trionfo del male”, ed è arrivato “ad accusare Dio di permetterlo, di non intervenire a fermare i carnefici”. Io, continua, “mi sono limitato a concludere: Dunque è proprio vero: Dio non c’è”.
Il suo punto di vista, spiega, è lo stesso di Giacomo Leopardi, “il poeta che accusa la natura di ingannare i suoi figli con false promesse di bene che sa di non poter mantenere”. Levi era un materialista, nel senso filosofico del termine, per via della sua formazione culturale, per l’adesione alla scienza in senso positivo, seppure non sia mai stato un Positivista in senso filosofico: conosceva bene i limiti e i rischi stessi della scienza, cosa su cui si è soffermato con vari scritti dopo l’esplosione di Chernobyl.
Allora, che ebreo è stato? Un ebreo non credente, si potrebbe rispondere. Ha spiegato che il credente nella sua famiglia, per quanto superstizioso e riluttante, era il padre, che ne seguiva i precetti anche alimentari, eppure amava molto il prosciutto. L’educazione che ha avuto è dunque quella di un ebreo. A tredici anni ha fatto il Bar Mitzvah, ovvero la cerimonia d’ingresso nella comunità ebraica, a Torino, una cerimonia che necessitava un esame di lingua ebraico e di storia e cultura ebraica.
Ma dopo qualche mese, si è ritrovato allo stesso punto: non era credente, come i suoi amici cristiani che avevano fatto la comunione e la cresima. L’ebraismo per lui è qualcosa di diverso da una religione. Dice: “è una questione di identità: una identità della quale, devo però dire anche questo, non intendo spogliarmi”. Sono frasi che ha ripetuto molte volte. Intanto s’era scoperto ebreo dopo le leggi razziali del 1938, e poi aveva conosciuto l’ebraismo ortodosso nel Lager, e anche prima, nel campo di Fossoli, come testimonia il primo capitolo di Se questo è un uomo, dove assiste alla cerimonia di addio alla vita della famiglia di ebrei italiani provenienti da Tripoli, i Gattegno, tutti falegnami.
Lì parla di se stesso e dei presenti usando il noi, noi ebrei: “Noi sostammo numerosi davanti alla loro porta, e ci discese nell’anima, nuovo per noi, il dolore antico del popolo che non ha terra, il dolore senza speranza dell’esodo ogni secolo rinnovato”. Si tratta di uno dei punti più espressivi della sua dichiarazione d’identità. Che non significa dichiarazione di fede.
Una delle cose che Levi ha più volte ripetuto è di essere italiano, per tre quarti, e per un quarto ebreo, ma che quel quarto era molto importante per lui. Sopravissuto al Lager, è tornato a Torino, dalla sua famiglia e dai suoi amici, non è migrato in Israele, come documenta il finale de La tregua. Non è stato neppure sionista, anche se da giovane qualche simpatia per i sionisti l’aveva provata, dice.
E anche nei confronti di Israele, lui da laico, socialista e antifascista militante, ha sempre mantenuto un rapporto complesso, mai di adesione completa e totale, differenziando il diritto di esistenza di quel paese dalle scelte politiche e militari dei suoi governanti. Cosa che gli ha provocato non poche polemiche e anche conflitti nel mondo ebraico. Così era Levi: un uomo particolare, molto poco conformista, anche a livello di scelte ideali e di valori. Pur essendo un illuminista, sul piano intellettuale – gli ebrei hanno partecipato alla rivoluzione illuminista – non ha mai sostenuto posizioni estreme.
Critico nei confronti dei palestinesi di Al Fatah, il suo ebraismo è stato un ebraismo politico di sinistra, se così si può dire. C’è un punto della sua prima opera, di cui parla, seppur indirettamente nell’intervista del 1983, che definisce molto bene il suo atteggiamento verso la religione in generale e l’ebraismo nello specifico. Si trova nel capitolo Ottobre 1944, dedicato alla selezione degli uomini non validi, o presunti tali, nel Lager di Monowitz, dove lavora.
Nel silenzio della baracca Primo sente il vecchio Kuhn che prega. Lo fa ad alta voce e tenendo il berretto dei deportati in testa. Dondola il busto con violenza alla maniera dei vecchi ebrei. Kuhn, un ebreo ortodosso, sta ringraziando Dio perché non è stato scelto. La reazione del giovane chimico torinese finito in Lager perché ebreo è secca: Kuhn è senza dubbio un insensato.
Nella cuccetta accanto Beppo, un greco di vent’anni, è stato invece scelto per essere inviato alle camere a gas, cosa che accadrà puntualmente l’indomani mattina. Se ne sta sdraiato e fissa la lampadina senza dire nulla e senza pensare nulla. Levi si chiede: non lo sa il salvato che la prossima volta toccherà a lui?
Non capisce Kuhn che è accaduto un abominio e “che nessuna preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell’uomo di fare, potrà rinascere mai più?”. La conclusione di Levi è dura e forte: “Se fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn”. Ecco, in questa frase si compendia l’atteggiamento del non-credente Levi nell’inferno di Auschwitz.
Molte delle dichiarazioni di Primo Levi su questo tema dell’ebraismo e non solo si trovano nel volume Opere complete III, pubblicato da Einaudi lo scorso anno. Il suo sottotitolo è: Conversazioni, interviste e dichiarazioni; sono oltre 1000 pagine raccolte.
Marco Belpoliti
Da leggere anche:
Le parole di Primo Levi. Auschwitz, diteci se questo è un uomo
Le parole di Primo Levi. I marciapiedi di Torino
Le parole di Primo Levi: gli animali
Le parole di Primo Levi. La chimica a misura d’uomo

LA PARALISI DI BIBI Israele rivota. Perchè? A chi giova? Dov’è la sinistra?
INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SULLO SCIOGLIMENTO DELLA KNESSET AD APPENA SETTE SETTIMANE DAL VOTO E SUGLI SVILUPPI DELLA POLITICA ISRAELIANA
Introducono ANNA MOMIGLIANO Giornalista e scrittrice
GABRIELE ESCHENAZI Giornalista e scrittore
Giovedì 13 giugno 2019 alle ore 21.00 Presso il
CIRCOLO
DE AMICIS
via Edmondo de Amicis 17, Milano

Israele piace a tutti ma non interessa a nessuno
Anna Momigliano 9 Aprile 2019 Rivista Studio
Nel giorno delle elezioni, com’è cambiata la percezione del Paese sul piano “estetico” e su quello “politico”.
Martedì si vota in Israele: la cattiva notizia è che Netanyahu, il primo ministro amico di Trump, Putin e Salvini che governa il Paese dal 2009, potrebbe essere rieletto e dice che annetterà la Cisgiordania. L’unico che ha qualche possibilità di sconfiggerlo, perché la speranza è l’ultima a morire, è un generale centrista a capo di un partito chiamato, non sto scherzando, “resilienza”, che si tiene sul vago su molte cose, mentre la sinistra è ridotta a un ruolo marginale.

Nella mia bolla non se ne sta parlando. Il dato interessante è che nella stessa bolla – un mondo che ruota attorno a riferimenti culturali, estetici e politici globalizzati, più o meno giovani e più o meno di sinistra – Israele è diventata una presenza fissa. Sono sempre più gli amici e i conoscenti che vanno a Tel Aviv, e a differenza di qualche anno fa non sono più soprattutto gli ebrei e/o i gay: gli arrivi turistici in Israele sono aumentati di quasi il 40 per cento tra il 2016 e il 2018, toccando un record di quattro milioni di presenze. Questo weekend a Tel Aviv c’era pure la Ferragni e il mese prossimo ci sarà l’Eurovisione: trovo bellissimo che ci manderemo un tipo di nome Mahmood. Poi c’è il cibo, che ha portato l’israelianità nelle città (e nelle timeline) globali: in principio era Yotam Ottolenghi, adesso è soprattutto Miznon, la catena di street food nobilitato che ha lanciato il cavolfiore arrostito, il piatto più instagrammato del biennio scorso.
Oggi Israele è cool, e il paradosso è questo: mai quanto oggi Israele è stata popolare in un certo mondo, quello dei liberal under-40 cittadini del mondo; eppure mai quanto oggi Israele è stata politicamente lontana dalla sensibilità anti-populista di quel mondo. Bella novità, dirà qualcuno: Israele ha sempre avuto un rapporto difficile con la sinistra, ma la cultura israeliana è sempre piaciuta, guarda un po’, a sinistra. Quello di cui stiamo parlando però è una cosa diversa, più recente. Gli scrittori e registi israeliani che andavano per la maggiore un decennio fa erano più cosa da secchioni impegnati che da connaisseur globetrotter: si leggevano i romanzi di Yehoshua e di Oz anche perché si seguiva il conflitto israelo-palestinese e dava soddisfazione sentirselo raccontare da voci critiche, mentre l’israelianità che piace oggi sembra uscita da un universo parallelo dove il conflitto israelo-palestinese neanche esiste. Israele – più che altro Tel Aviv – piace perché è modernità godereccia e internazionale, crogiolo di lingue e culture vegan-friendly, gay-friendly e Instagram-friendly (magari un po’ meno immigrant-friendly, però mica si può avere tutto): cose che rimandano a un’altra idea di sinistra, in guerra più con i sovranisti provinciali che con l’occupazione della Cisgiordania.
Quando parliamo di sinistra e Israele, dobbiamo precisare quale sinistra. Con i socialisti e socialdemocratici europei, lo Stato ebraico ha un rapporto difficile almeno dalla guerra dei Sei Giorni (era il 1967). L’Italia meriterebbe un discorso a parte, vista la tradizione filoaraba del PCI e dei suoi eredi, che si è interrotta con Renzi. Però la sinistra liberal, quella dei Democratici americani e dei blairiani, ha sempre amato Israele e soprattutto la sinistra israeliana. Quello che sta succedendo oggi, invece, è che sono proprio i cosiddetti liberal ad allontanarsi politicamente. In America, c’è un partito Democratico sempre più tiepido: un sondaggio commissionato a YouGov dall’Economist segnalava un tracollo nel sostegno a Israele tra i liberal e i millennials, un po’ perché c’è uno slittamento a sinistra dei giovani di sinistra, un po’ perché c’è uno spostamento a destra di Israele. E l’Europa? Il Labour britannico lasciamolo stare, che c’è Corbyn (questione da approfondire), ma la situazione della sinistra italiana la racconta bene Emanuele Fiano, parlamentare PD e segretario di Sinistra per Israele: «Non c’è una forte antipatia nei confronti di Israele, ma c’è nei confronti del governo Netanyahu, più che altro per questioni di posizionamento internazionale». Tradotto, Netanyahu è vicino a Putin e a Trump, va d’accordo persino con la destra polacca e con Orban (altra questione da approfondire: come fanno a piacergli quegli antisemiti?), cosa che lo mette automaticamente nel campo avversario: «Oggi la sinistra italiana è fortemente anti-Trump e anti-Putin, e questo sta producendo contrarietà», dice Fiano in una chiacchierata telefonica. Da sottolineare che questi imbarazzi non c’entrano con la questione palestinese, anche perché «sul Medio Oriente la sinistra è sempre più confusa» e visto il caos che c’è nella regione «non è così semplice capire dove deve stare».
Riassumendo: Israele, come destinazione e prodotto culturale, è sempre più parte della bolla anti-populista, eppure Israele è membro dell’internazionale populista, e il risultato è qualcosa a metà strada tra San Francisco e Visegrad. Queste elezioni potrebbero cambiare le cose, ma fino a un certo punto, perché il Paese è sempre più a destra e, se anche dovesse vincere, lo sfidante di Netanyahu, il generale Benny Gantz, non porterà rivoluzioni. Del resto, è il mondo che va a destra. È stato questo l’errore più grande della sinistra israeliana, contare su una comunità internazionale liberal che non esiste più, racconta Anshel Pfeffer, corrispondente dell’Economist ed editorialista di Haaretz: «Per trent’anni la sinistra israeliana ha detto che se non avessimo messo fine all’Occupazione la comunità internazionale avrebbe reagito, che Netanyahu ci avrebbe portato all’isolamento», dice Pfeffer al telefono. «Evidentemente, non è successo: Israele è tutto fuorché isolata, va d’accordo con l’America, con la Russia e persino con i sauditi. La verità è che è un buon momento per Israele, anche l’economia va alla grande». Basta fare un giro per Tel Aviv, dove in pochi votano Netanyahu ma non sono in tanti quelli che rimpiangono l’era precedente, per rendersi conto che le cose vanno bene. Se uno ci pensa, e non è una cosa facile da buttare giù, la coolness israeliana è perfettamente compatibile con dieci anni di governo sovranista. Forse è addirittura il prodotto di quel decennio.

Setirot – L’esempio di Irmela
Di Stefano Jesurum Pubblicato in Attualità il 30/05/2019 – 25 אייר 5779
Nella mia abissale ignoranza non sapevo dell’esistenza di Irmela Mensah Schramm. A nominarmela è stata un’amica giornalista, Barbara Notaro Dietrich, con una “battuta” intelligente: mettete fiori nei vostri cannoni?, sì, anche, ma oggi mettete poesie, versi e colori sopra le croci celtiche.
La storia è incredibile – e in un mondo come l’attuale davvero esemplare. (Mi scuso se i lettori già la conoscono; io, lo ripeto, ne ero totalmente all’oscuro). Dunque, Irmela Mensah Schramm è una vispa berlinese nata a Stoccarda nel 1945. Ex pedagoga, dedica da decenni buona parte della propria vita alla difesa dei diritti umani. In particolare, dal 1986 “fa politica” fotografando, cancellando con poesie e colori, e archiviando graffiti e scritte antisemite e razziste che incontra nei suoi giri in Germania (e non solo). Irmela occupa mediamente dalle venti alle quaranta ore alla settimana per “pulire” lo spazio pubblico e – dice lei – la vergogna che ci circonda. Non soddisfatta, lavora nelle scuole per sensibilizzare i giovani nella lotta contro l’odio. Va da sé che la sua collezione di intimidazioni e minacce di morte è ricca quasi quanto quella di “trofei” raccolti in dozzine e dozzine di scatoloni.
Al di là della mia imperdonabile ignoranza e della felicità di “scoprire” persone simili, mi chiedo se in questa nostra corsa verso il precipizio illiberale non sia il caso di dare il maggiore spazio possibile ai/alle molti/e Mensah Schramm che forse ci vivono accanto senza che noi lo si sappia.
Stefano Jesurum, giornalista
(30 maggio 2019)

In Israel’s New Election Campaign, Right Battles Right
By Isabel Kershner New York Times May 30, 2019
JERUSALEM — After the spectacular collapse of Prime Minister Benjamin Netanyahu’s attempt to build a coalition threw Israel into an unprecedented do-over election, Israeli public attention on Thursday was glued to two politicians.
One was Mr. Netanyahu, Israel’s prime minister for the last 10 years, but the other was not Benny Gantz, his main challenger in the election last month.
Instead, the first day of the new election campaign was dominated by Mr. Netanyahu and Avigdor Lieberman, the leader of a small ultranationalist party and former coalition partner who has become anathema to Mr. Netanyahu.
It was Mr. Lieberman’s refusal to compromise on a new military draft law with Mr. Netanyahu’s ultra-Orthodox coalition partners that thwarted Mr. Netanyahu’s efforts to form a new government. Mr. Netanyahu needed both Mr. Lieberman’s party and the ultra-Orthodox faction to build his right-wing majority.
That divide, between the ultrareligious right and the secular right, has for the moment eclipsed the old left-right divide in Israel. It proved to be Mr. Netanyahu’s undoing on Wednesday, his deadline to form a governing coalition, and could be critical in the next election, scheduled for Sept. 17.
Having failed to meet the deadline, Mr. Netanyahu pushed the Parliament to dissolve itself early Thursday, and a politically fatigued Israel awoke to find itself in another bitter election cycle.
Positioning himself as the champion of the secular right, Mr. Lieberman had
seized on an issue of festering resentment in Israeli society: the broad
exemptions to military service currently granted to ultra-Orthodox seminary
students. Mr. Lieberman supports a new law requiring minimal quotas for them to
serve, which Mr. Netanyahu’s ultra-Orthodox partners vehemently oppose.
Mr. Lieberman, whose party scraped through the last election with just five seats, strode into a news conference on Thursday with the air of a winner, appearing relaxed and self-confident, having dented Mr. Netanyahu’s aura of invincibility.
A blunt and inscrutable politician who was Mr. Netanyahu’s former defense minister, Mr. Lieberman railed against what he called a “campaign of discreditation” after Mr. Netanyahu branded him a “leftist.”
After calling for more a measured and professional political discourse, Mr. Lieberman then accused the prime minister’s supporters of nurturing a “personality cult” and said that some of Mr. Netanyahu’s close associates required a “reputable and experienced psychiatrist.”
Mr. Netanyahu tried to make light of his setback at a meeting in Jerusalem on Thursday with Jared Kushner and Jason D. Greenblatt, architects of the Trump administration’s Middle East peace plan.
“You know, we had a little event last night,” he said. “That’s not going to stop us. We’re going to continue working together.”
Later Thursday, in a televised address, Mr. Netanyahu sought to present himself as an indispensable world statesman, speaking of his special relations with the Trump administration and Russia, and he also attacked Mr. Lieberman, blaming him for toppling a right-wing government on “a personal whim.”
Despite the political instincts that have kept him in office for the last decade, Mr. Netanyahu appeared to have been taken by surprise, outfoxed by an old nemesis and finding himself in a changing political landscape.
The right wing has won easy majorities in the last three elections, and in most elections over the last four decades, while the Israeli left has shrunk. Labor, once the main center-left challenger to the right, won only six seats in the last election. Mr. Netanyahu’s main challenger was Mr. Gantz’s centrist Blue and White party, whose main campaign issue was that Mr. Gantz was not Mr. Netanyahu.
Blue and White, which won 35 seats in April, would otherwise have been a natural alternative for a coalition with Mr. Netanyahu’s conservative Likud. But Mr. Netanyahu is facing charges of bribery, fraud and breach of trust in three corruption cases, and Blue and White refused to join a government with a prime minister facing indictment.
That narrowed Mr. Netanyahu’s options. Still, signing up the same right-wing and ultra-Orthodox allies that made up his previous government should have been a cinch. But he got caught in a battle of wills between Mr. Lieberman and the powerful ultra-Orthodox alliance.
Analysts said Mr. Lieberman’s principled stand on the military draft law was a vehicle for his more far-reaching political ambitions.
His gambit, said Orit Galili-Zucker, a former strategic communications adviser to Mr. Netanyahu and a political branding expert, was “the first stone to fall, a crack in the wall.”
In the longer term, she said, Mr. Lieberman’s goal is “to bring an end the Netanyahu era.”
Yariv Levin, a Likud minister who led the party’s coalition negotiations, said Mr. Lieberman had made excessive demands, including for three ministerial posts and had intended to torpedo the new government from the start out of personal ambition, setting conditions that he knew the ultra-Orthodox politicians could not meet.
“It’s as if he said: ‘I’m willing to join the government. I just have one demand: that the legislators from United Torah Judaism come eat lunch with me in a nonkosher restaurant,’” Mr. Levin told Ynet, a Hebrew website.
It is unclear this early in the election cycle whether Mr. Lieberman can capitalize on his success, though he may well pick up some votes, just as it is too early to write Mr. Netanyahu out. But many Israelis questioned how Mr. Netanyahu got played by Mr. Lieberman, whom he knows well.
Shmuel Sandler, a professor in the department of political studies at Bar-Ilan University, said he thought Mr. Netanyahu’s focus on his legal woes and personal survival caused him to “neglect his instincts and knowledge” of Mr. Lieberman.
The rivalry between Mr. Netanyahu and Mr. Lieberman, who immigrated to Israel from Moldova 40 years ago and rose through the ranks of Likud before forming his own party, goes back decades. Mr. Lieberman, who began his political career as an aide to Mr. Netanyahu, has prepared for eventually competing for the post of prime minister by serving as foreign minister and defense minister. But Mr. Sandler said that he felt that Mr. Netanyahu did not respect his opinion or keep promises to him.
At the same time, Yisrael Beiteinu’s traditional base of aging Russian-speakers is dwindling as the immigrants increasingly vote like Israelis across the political spectrum. So Mr. Lieberman had to reinvent himself politically.
“There’s a strong, significant group of secular Israelis who self-identify as right wing,” said Yohanan Plesner, president of the Israel Democracy Institute, an independent research center in Jerusalem. “They want a right-wing government but not a government that succumbs and gives in and allows the ultra-Orthodox to call the shots.”
Mr. Lieberman is a hard-liner even by some right-wing standards, pushing for the death penalty for people convicted of terrorist acts and a much tougher policy toward Gaza.
With coalition talks at an impasse, Mr. Netanyahu was left with few options.
He chose to drag the country into new elections rather than allow President Reuven Rivlin, an old foe, to give another lawmaker the chance to form a government.
But the new election is also a big risk for Mr. Netanyahu, aside from the fact that he may lose. The election date of Sept. 17 brings his legal and political timetables dangerously close together.
The attorney general has set a hearing for Mr. Netanyahu in early October and by winter is expected to make a final decision on filing charges. Mr. Netanyahu had hoped to advance legislation in the current Parliament giving him immunity from prosecution while in office.
Even if Mr. Netanyahu wins and forms a new government by November, he may not have time to make the legal changes to protect himself. If he is indicted, he is likely to face strong pressure to step down even if he has just won the election.
Now little is certain.
A new election could turn out the same as the last, leading to the same stalemate, or not. Voter turnout could be affected. New faces could join the race.
But one thing Mr. Lieberman may have taught Mr. Netanyahu is that nothing is forever.

ISRAELE, LA ROTTURA DEL BLOCCO SOCIALE E LE CONSEGUENZE IN MEDIORIENTE
Di Fabio Nicolucci 31 Maggio 2019 , pubblicato su Il Mattino

Sette settimane fa, Netanyahu aveva affermato di aver vinto per la quinta volta le elezioni politiche in Israele. Ma il suo fallimento nel ricostruire la sua larga coalizione testimonia il contrario. Netanyahu il 9 aprile non aveva vinto, dato che non è riuscito a formare il governo nonostante i 30 giorni concessi dalla legge e i 14 extra concessi dal Presidente d’Israele Rivlin. Tanto che ha dovuto optare per la prima volta nella storia della democrazia israeliana sullo scioglimento di una Knesset (il parlamento israeliano, ndr.) appena eletta e su nuove elezioni il prossimo 17 settembre.
Ma se Netanyahu non è stato il vincitore, non ve ne sono altri. Del resto, ciò testimonia il suo successo nell’ottenere lo scioglimento anticipato anziché il reincarico a qualcun altro. Così oggi si è aperta la gara per il nuovo. Il casus belli è stata la richiesta dell’ ex alleato Avigdor Lieberman, capo di Israel Beitenu (“Israele, casa nostra”, partito prevalentemente di russi dell’ex Unione Sovietica), di ottenere finalmente la coscrizione obbligatoria per gli ebrei ultraortodossi, oggi esentati dalla leva obbligatoria. E per questo avversi alla legge.
Ma se pure questa vicenda sembra più vicina alla popolare commedia israeliana comica “Polishuk” (che narra le vicende fantozziane di un fantasioso politico israeliano dal nome omonimo) che non alla più drammatica serie americana “House of Cards” è più per l’apparenza che non per la sostanza.
La rottura di una maggioranza politica ventennale, quasi un blocco sociale, ha sempre ragioni e conseguenze molto più strutturali.
Per le prime, si può dire che Lieberman ha avvertito, con il suo leggendario fiuto politico tattico, l’avvicinarsi della fine dell’era Netanyahu. O meglio, della coalizione politica fondata su un arco ampio che abbracciava la sua tradizionale destra sionista fino all’estrema destra dei seguaci del rabbino razzista Kahane e ai partiti degli ebrei religiosi ultraortodossi. Di questa coalizione il capolavoro politico di Netanyahu era la saldatura tra il laicismo e l’autoritarismo putiniano degli ebrei russi venuti dall’ex Unione Sovietica, con la visione messianica e ultrareligiosa degli ebrei religiosi ortodossi e dei coloni. Per questo, la cifra politica era il mantenimento indefinito dello status quo nei rapporti israelo-palestinesi.
Il problema è che questo status quo – tenere sia tutta la Terra sia il carattere ebraico e democratico dello Stato – alla lunga è insostenibile. Irrealistico. Anzi, pericoloso per il paese, anche se vantaggioso per sé. Per questo l’ex Capo di Stato Maggiore dell’esercito Benny Gantz aveva formato contro Netanyahu il suo nuovo partito Kahol Lavan e ottenuto il 9 aprile 35 seggi, tanti quanti il Likud.. Il premier uscente aveva tentato il 9 aprile un referendum su di sé, con la trasformazione della Repubblica in una monarchia de facto, per rimettere il genio nella bottiglia. Ma il paese era già in moto.
La rottura di questo blocco sociale avrà conseguenze tutte da studiare. Sul piano interno, si nota l’inizio di un movimento centrifugo nella coalizione di destra sinora egemonica, ed un parallelo movimento invece aggregante in un campo del centrosinistra sinora balcanizzato. A destra partirà la gara alla successione del capo. Mentre a sinistra sono partiti i primi segnali di dialogo tra Gantz e le liste arabe, per esempio. Il cui stallo prima del 9 aprile aveva portato ad una disaffezione degli arabi israeliani e ad una penalizzazione nelle urne. Tutta l’opposizione – 55 seggi su 120 – si è ritrovata unita sabato scorso a Tel Aviv nella protesta “per la democrazia” e contro la legge per l’immunità a Netanyahu, a scudo delle accuse di corruzione che dovrà fronteggiare in tribunale i prossimi 2 e 3 ottobre. E si parla di una lista unitaria tra Meretz, che è a rischio soglia 4%, e i laburisti, svuotati da Gantz.
Ma è sul piano occidentale e regionale che ci saranno le conseguenze più profonde. E si innescheranno dinamiche di discontinuità più rilevanti. In occidente, di cui Israele è il centro di cultura politica, la coalizione tra suprematisti bianchi, sovranisti e neoconservatori, vedrà indebolirsi il collante razzista dell’islamofobia che finora la univa, venendo meno la sorgente della sua legittimazione. La componente razzista e suprematista diventerà molto divisiva, specie per le minoranze, come dimostra l’autorevole e netta iniziativa della comunità ebraica di Roma e della sua Presidente Ruth Dureghello dieci giorni fa contro “i suprematismi in Europa. Dalla rabbia all’odio”. Sarebbe bene che le sinistre europee se ne accorgessero, e dessero una mano, costruendo una nuova lotta all’antisemitismo non più fondata solo su una retorica antifascista bensì sulla lotta ai due terrorismi – quello jihadista e quello suprematista bianco – imperniata su un nuovo rapporto con questo nuovo Israele, incontrando Gantz e promuovendo nel nuovo Parlamento Europeo il rigetto della campagna antisraeliana e per questo controproducente anche per i palestinesi del movimento BDS per il boicottaggio.
Sul piano regionale, si vedrà il bluff pluriennale del piano di pace israelo-palestinese di Trump prossimo ad essere presentato in Bahrein. Con una sponda così debole, e con Cina e Russia e palestinesi che hanno già marcato visita, il summit è in forse. Da parte di Trump vi sarà però la tentazione di colmare questo vuoto politico con l’inasprimento delle tensioni con l’Iran. E da parte di Netanyahu con quelle con Hizballah in Libano e Siria. E i venti di guerra soffieranno molto più forti nei prossimi mesi nella regione.
Fabio Nicolucci
Setirot – Assonanze
di Stefano Jesurum, giornalista
Pubblicato in Idee il 23/05/2019 – 18 אייר 5779
Nessun paragone tra Shoah e decreti governativi emanati di recente o in (teorica, sbandierata, elettorale) via di emanazione. L’abbiamo ripetuto milioni di volte: la Shoah è un unicum nella storia. Ancora: fascismo, nazismo, non si ripetono uguali, come d’altronde nessun processo storico. Esistono tuttavia assonanze, più o meno udibili, osservabili, constatabili. Inutile elencarle. La cronaca quotidiana ce le ripropone fino alla nausea. Il dramma è che esista chi non le coglie o non ci ragiona, e sono molti, troppi. Altrettanti molti, troppi, giocano con le parole, si perdono in sofismi. Qualcuno – decerebrato o realmente neofascista e neonazista oppure ancora talmente preso dalla propria battaglia alle democrazie liberali – accusa e svillaneggia al grido di Gott mit uns (Dio con noi) chi si allarma per la disumanità e gli attacchi ai diritti e alle persone. Ci mettono in bocca parallelismi, analogie mai espressi. Quanta malafede. O forse, semplicemente, nella loro ignoranza non conoscono la parola assonanze.
Stefano Jesurum
Leggendo questo breve articolo di Stefano Jesurum ho trovato molte assonanze con il libro di Siegmund Ginzberg “Sindrome 33” di cui trovate la recensione del 2 maggio di Wlodek Goldkorn qui nel sito nella sezione News. Il libro, che vi consiglio assolutamente di leggere, narra e analizza le vicende e le ragioni che portarono Hitler al potere nel 1933 nel paese allora più democratico d’Europa. Le assonanze sono sorprendenti ed inquetanti e vale la pena citarne qualcuna oggi , giorno delle elezioni europee. Una campagna elettorale permanente, un partito che non è di destra né di sinistra ma “del popolo”, un improbabile contratto di governo, la voce grossa che mette a tacere i giornali, l’odio che penetra nel discorso pubblico, le accuse ai tecnici infidi, il debito la gestione demagogica e irresponsabile delle finanze.
Hitler nel settembre 1930 alle elezioni raccoglie poco più del 18%, i socialisti della SPD sono il primo partito con il 24,3% e i comunisti del Kpd terzi con il 13,3%. Dopo nemmeno due anni , il 31 luglio 1932, diventa il primo partito con il 37,4%. Solo pochi anni prima non raggiungeva il 2%.
Tra le ragioni di questo successo c’è una sapiente campagna mediatica di odio, di antisemitismo, di esaltazione della “Germania per i tedeschi”. In particolare l’odio verso gli ebrei coniuga perfettamente l’odio verso verso l’immigrato (in Germania erano arrivati milioni di ebrei che fuggivano profughi poveri da paesi dell’Est, dalla Russia e dalla Polonia) e verso l’elite, fatta di ebrei colti e ricchi e quindi soggetti a invidia e denigrazione. Ginzberg fa notare che anche oggi coloro che più ce l’hanno con gli immigrati, i poveracci arrivati dal Medio Oriente, dall’Afghanistan, dall’Africa o dal Sudaamerica, sono quelli che più ce l’hanno con le elite, con chi viene accusato di non comprendere, anzi di prosperare sul malessere del “popolo”, dell’uomo qualunque, dei “dimenticati”.
Assonanze inquietanti : uno dei primissimi provvedimenti del Ministro degli Interni del governo di Hitler fu il Decreto Immigrazione, che chiudeva le porte sopratutto agli ebrei, espelleva quelli privi di permesso di soggiorno, metteva fine alla naturalizzazione degli ebrei orientali. Cosa vi ricorda?
Edmondo de’Donato 26 Maggio 2019
Lo scrittore Stefano Jesurum a Bologna: «Netanyahu, il nuovo vitello d’oro dello Stato d’Israele»
Andrea Olgiati La Gazzetta di Bologna 15 Maggio 2019
Mancano poche ore alla formazione di un nuovo governo in Israele dopo le elezioni del 9 aprile scorso che hanno visto Benjamin Netanyahu e il suo partito di destra Likud ottenere 35 seggi su 120 (65 se si conta l’intera area di centro destra). Netanyahu riceverà così dal Capo dello Stato, Reuven Rivlin, l’incarico di formare un nuovo governo, di nuovo. «Israele fa parte del globo, e il vento che soffia per le destre nel mondo gonfia le vele del Paese», ha detto Francesco Lucrezi, professore di Storia dell’Oriente mediterraneo della facoltà di scienze Politiche dell’Università di Salerno, ospite ieri all’incontro “Israele oggi: orientamenti e prospettive dopo le elezioni” promosso all’associazione Sinistra per Israele nel museo ebraico di via Valdonica a Bologna.
Per risolvere il conflitto israelo-palestinese il Likud sostiene la soluzione dei due Stati a patto che il riconoscimento dello Stato della Palestina sia subordinato alla piena accettazione di Israele da parte di tutte le forze politiche palestinesi, compresi gli islamisti radicali di Hamas. Tuttavia, «nessuno crede più ai due Stati. È una chiacchiera. Il paese è spaccato tra destra e sinistra che hanno in comune la perdita di speranza in un accordo di pace. La verità è che, con gioia o rassegnazione, si sopporta lo status quo. Il dissenso è il cuore d’Israele, ma qualcosa nel Paese negli ultimi anni è cambiato radicalmente nel cuore della democrazia», ha continuato Lucrezi.
Un cambiamento che significa anche l’accentramento di poteri. «La ricchezza culturale del Paese – ha detto lo scrittore Stefano Jesurum– si è ridotta alla figura di Netanyahu, il “mago”, il “re” come lo chiamano che rischia di diventare un nuovo vitello d’oro. È intoccabile, non si può metterlo in discussione senza passare per un nemico».

Secondo il presidente della comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz, «il risultato delle elezioni è frutto di un sentimento diffuso. Israele è un Paese democratico e il voto va rispettato. Auspico che questo governo, come quello precedente, possa in qualche modo continuare un percorso che definisca la possibilità di rimettere equilibrio nei territori contesi».

Israele oggi
Orientamenti e prospettive dopo le elezioni
Martedì 14 maggio ore 17:30 Museo Ebraico di Bologna
Da Stefano Jesurum

Scruttura ed esilio
Marjorie Agosin
Domenica 12 maggio 2019 ore 15:00 Museo Ebraico di Venezia
Da Stefano Jesurum

Opinion: Israel Is Independent, but Not Free
Da Haaretz , Zvi Bar’el 9 Maggio 2019
Seventy-one years have passed since Israel declared its independence but the country has yet to fully achieve sovereignty.
Its borders were recognized by the international community, yet its people, similarly to Arab countries before the War of Independence, still refuse to accept the Partition Plan. It occupies about 5 million people in the West Bank and Gaza, and has annexed territory it doesn’t own in the Golan Heights and East Jerusalem. Its control over Gaza is absolute, hundreds of thousands of its Jewish citizens have settled in enemy territory where they’ve established a quasi-state, it draws its national identity from a violent struggle whose end doesn’t seem to be on the horizon, and its laws are based on an ideology of an insatiable hunger for territory.
Generations of pupils no longer know to sketch out a map of the country and can’t distinguish between Kiryat Arba and Kiryat Gat, or between Ofra and Gedera, or Shfaram and Nablus. Generations of students haven’t learned and won’t learn about the Palestinian struggle or the Nakba. They have been trained to identify anyone who isn’t Jewish as an enemy and in adulthood they will also point to half the Jewish population as an enemy of the nation and country. They will not know what “love of homeland” is because they have been born and bred in an unfinished skeleton of a country. They will be asked to become shahids of the religion of the territories, which has become the only permissible belief, and in its name they will kill Palestinian children, not because they threaten the country’s security but because they interfere with fulfilling a dream of divine promise.
As it begins the eighth decade of independent statehood, Israel doesn’t yet know the meaning of freedom. It is imprisoned inside a dual siege, the one imposed by the residents of Gaza and the West Bank and the one that is smashing its values from within. The presence of the Palestinians on a Jewish fantasy map requires the state to fortify and arm itself, cultivate threat, justify killing, and above all to halt any attempt to achieve a political settlement or peace. For peace is an explosive that threatens the national dream.
Peace means demarcating final borders, sufficing with some partition plan, narrowing the realm of illegal sovereignty and giving up most of the nationalist weeds that have sprouted beyond the Green Line. Peace means losing an enemy and smashing the sense of being besieged from without, which has fueled the persecuted people’s consciousness and turned it into a Spartan nation – a nation of “not again” and “only thus,” one that is “prepared for all scenarios,” one that is always ready to return its enemies “to the Stone Age.”
And yet the sense of being besieged from within is much more dangerous. It threatens like a ghost, it crawls and seeps into everything, and lacks any face or shape. It lies in schoolbooks, in racist legislation, hateful demands by rabbis, nasty political declarations, in posts by hate-filled ignoramuses. It’s a siege that disguises itself as culture, Jewish identity and national awareness. It recruits loyal volunteers and gatekeepers who locate and mark those who dare to break through. They screen the teachers’ faculty lounges and lecture halls, human rights organizations, theaters and courts to purify them and rid them of their traitors. These are the revolutionary guards in charge of the creation and cultivation of the new Israeli identity. Their mission is to ensure uniform opinion and national purity.
Don’t get the wrong idea. Israeli citizens must rejoice on Independence Day, wave flags and crowd the squares, bonk their plastic hammers and fan the blazing barbecues. That’s what people do in independent countries. They are really glad their country has passed the age of uncertainty. It has a strong army, a burgeoning economy, its citizens are better educated than the founding generation, its trains provide a fitting answer to the trains of the Holocaust and the U.S. president provides more goodies than it can digest. Israel is under siege, is guarded by thought police, yearns for fresh air but it’s an independent country. Independent, but not free.

Da Haaretz : Manifestazione congiunta israelo palestinese per il giorno del ricordo dei caduti
Pubblicato da Gabriele Eschenazi
Israeli-Palestinian Memorial Day Event Disturbed by Protesters; Ceremony Streamed in Gaza
‘I’m hoping people in Gaza will get a different idea about Israelis – and vice versa,’ Gazan organizer tells Haaretz; protesters call participants ‘Nazis’ and ‘traitors’
Hagar Shezaf
May 07, 2019 9:46 PM
A joint Israeli-Palestinian Memorial Day ceremony held on Tuesday was broadcast in the Gaza Strip for the first time ever.
Israel’s High Court overturned on Monday Prime Minister Benjamin Netanyahu’s decision to bar 181 Palestinians from entering Israel to participate in the alternative ceremony, organized by Combatants for Peace, an NGO for former Israeli soldiers and Palestinian militants and a group of bereaved Israeli and Palestinian families that work together for reconciliation.
The ceremony is organized by Combatants for Peace, an organization of former Israeli soldiers and Palestinian militants and the Parents Circle Families Forum, a group of bereaved Israeli and Palestinian families that work together for reconciliation.
Outside the ceremony, a few dozen protesters demonstrated against the event, and a few tried to burn a Palestinian flag. The police detained three of them for disturbing the peace and “throwing items at participents.” A few of them tried to cross the protective barriers, and called participants “traitors,” “kapos” and “Nazis.”
They screamed, “Terror will come for you, too, don’t be mistaken.” Another shouted, “The Arab who sits at this ceremony covets your daughter, too, sir. This is the Memorial Day for fallen IDF soldiers, not terrorists, hopefully God will take you, you leftists, dirty leftists.”
The screening of the alternative Memorial Day ceremony in Gaza is the brainchild of Rami Amman, a 37-year-old activist from Gaza. “I welcome every peace initiative coming from the Israeli side, I don’t care if it’s right or left wing,” he said. “I don’t think we – Palestinians and Israelis – should be busy blaming one another, especially after the terrible number of days we all went through – we need something else.”
Amman is the founder of a Gaza-based youth movement called Gaza Youth Committee, which is focused on developing local leadership in Gaza. He told Haaretz that the idea first came to him after Operation Cast Lead in 2009.
“I saw the meaningless deaths of normal civilians, and it made me realize I have to do something to change the reality here.” He began reaching out to Israeli activists five years later, after Operation Protective Edge in 2014, and launched the project Skype with the Enemy, in which Israelis and Palestinians could talk via video. “That helps us overcome the siege,” he said. “Both sides would sit there and apologize to one another, saying ‘it isn’t my war!’”
Tuesday night’s screening of the joint Palestinian-Israeli memorial ceremony was broadcast in his office. “I’m hoping that people in Gaza will get a different idea about Israelis – and vice versa,” he said, though he added that the event will be a very small one.
The screening, he noted, cannot take place in any public space due to security concerns following the recent flare-up. Amman said that despite his efforts, he feels that most Gazans may not be prepared to participate in such an event.
“Some of those who were killed were children, a school teacher, not militants. These killings create new enemies, people who are in pain,” he said. As a result, what was initially intended to be a large event consisted of around 10 participants who watched the ceremony simultaneously taking place in Tel Aviv.
In Tel Aviv, Israelis and the Palestinians who were lucky enough to be granted a permit also viewed a pre-recorded video address by another Gazan, Fatmeh Muhammadin from Shujaiyeh, who currently lives in the West Bank and was denied entry to participate in the ceremony.
Muhammadin is a 26-year-old activist with family members still living in Gaza. Her cousin, a member of Hamas, was killed in clashes with Israel, and the family house was struck a number of times. Muhammadin was also present when Razan Najjar, a Palestinian paramedic, was killed during a protest on the Gaza border fence. “It is still an open wound for me, even talking about it now makes me profoundly sad,” she told Haaretz.
When asked what prompted her to take part in the joint ceremony, Muhammadin answered: “An activist of Combatants for Peace in Ramallah told me about the event, it was clear to me that I want to take part.” When asked if she receive any negative reactions for her decision, she laughed. “Not at all! Everybody said wow, that’s amazing!”
She said she hopes to bring the plight of Gazans into the spotlight on Tuesday night. “I want to tell the story of Gaza. We live under siege, there is a shortage of electricity and our daily life is simply very difficult,” she said. “Some people think that Gaza is a terrorist-territory but I want the world to know that it is a very humane place, to tell about its people.”
“I was hoping I’d be there with you Israelis, and talk to you on the stage – not through a screen”, she said. Muhammadin now lives in Ramallah, after she was granted a permit from Israel to move there. “It took 5 years,” she added. “It wasn’t easy.”
Back in Gaza, Amman faced his share of criticism and negative consequences for his actions. Last November, he claims he was abducted and interrogated by Hamas. Now, he said, some accuse him of “normalization” – collaborating with Israelis. “I hear that from people,” he says. “But I stand by my ideas. I believe in the path I have chosen.”

Gaza: la situazione
Commento di Roberto Della Rocca
Nel recente passato ho ripetutamente scritto su quello che succede nella striscia di Gaza, andate a cercare i miei lunghi post nella precedente crisi .
Come i miei lettori sanno, sono una persona di sinistra che non si vergogna di essere democratico e pacifista (due stati per due popoli e’ la soluzione, l’unica).

Sulla striscia si sentono tonnellate di cazzate, disinformazione pura, degna del fu Minculpop. Tale disinformazione, magistralmente divulgata dai terroristi di Hamas e dai loro padrini (Iran specialmente) alimenta le batterie delle masse di debosciati gia’ antisemiti che cercano qualcosa per camuffarsi meglio.
La realta’ e’, in poche parole, che piu’ di due milioni di abitanti della striscia sono ostaggi di poche migliaia di terroristi che tutto gli interessa tranne il walfare degli Azati. Hamas non riconosce, de jure e de facto, il diritto all’esistenza di Israele, e il suo scopo e’ distruggere “l’entita’ sionista”.
Nonostante cio’ Israele e’ quella che passa, ogni giorno, centinaia di tonnellate di merci attraverso i valichi.
Israele e non Egitto, che ha anche lui un confine con la striscia, ma non muove un dito, El sisi odia Hamas perche’ fanno parte del fronte dei “Fratelli musulmani” acerrimi nemici .
Questo trasporto di merci si compie ogni giorno, anche mentre Israele viene bombardata, come oggi. Hamas vive del fatto che c’e’ crisi umanitaria, ci lucra sopra, rimpinguando le tasche dei suoi leader e dei suoi militanti, tassando e gestendo direttamente, senza pieta’, gli aiuti umanitari. Senza di essa verrebbe cancellato.
A Gaza non ci sono diritti umani, non c’e’ rispetto, non c’e’ niente, manifestazioni contro Hamas vengono affogate nel sangue, non esistono tribunali e le esecuzioni sommarie sono all’ordine del giorno, vuoi far sparire qualcuno? Basta dire che e’ una spia di Israele. Arrigoni docet.
Le poche migliaia che vanno da un anno a dimostrare, violentemente (ieri hanno sparato dalla folla su soldati israeliani), sul confine con Israele sono dei disperati, in minoranza dopo lavaggio del cervello, in maggioranza pagati da Hamas per protestare, soldi che servono per sopravvivere. I fomentatori, stanno dietro e si nascondono tra i civili.
I razzi, da ieri mattina piu’ di 450, che vengono mandati verso Israele, colpirebbero al 99.9% civili israeliani.
Vengono puntati apposta su citta’ come Ashkelon, Ashdod, e oggi anche la mia, Rehovot, apposta perche’, statisticamente parlando, e’ piu’ facile centrare una casa. Ho scritto colpirebbero perche per fortuna vengono intercettati dalle armi di difesa, invenzione israeliana, Iron Dome. Intercettati, ma non tutti, purtroppo, c’e’ gia un morto ad Ashkelon e svariati feriti gravi.
Chi pensa che Israele non possa risolvere questo conflitto in 10 minuti sbaglia, cosa pensate, che non sappiamo dove si nascondono i “coraggiosi” terroristi di Hamas? Guardate la foto, da dove lanciano i razzi Kassam? Da dentro le case, o le scuole,o gli ospedali, come hanno fatto sempre. Se non fosse per le perdite umane civili, Israele raderebbe al suolo in un secondo il comando generale di Hamas e della Jiad Islamica ma essendo sotto l’ospedale di Gaza City non lo fa.
E’ chiaro che bisogna arrivare ad un accordo di pace con l’autorita’ palestinese, autorita’ che non e’ responsabile di Gaza ma solo della Giudea e Samaria. Sono molto dubbioso sulle possibilita’, non con questo governo Israeliano di destra, non con un leader palestinese anziano, malato, debole e corrotto.
Con altri partner sia la’ che qua’ si potrebbe, forse, fare e dopo, solo dopo, occuparsi di Gaza, mandando via, con le buone o con le cattive, i terroristi islamici.
Il problema Gaza esiste da molti anni, Israele lo ha molto amplificato scappando senza accordo con la A.P. , sotto il governo Sharon, e regalando la striscia agli islamici, monito che la pace non si fa unilateralmente, mai.
Solo per precisare, per chi per sbaglio ancora non lo sa: Israele se ne e’ andata dalla striscia nel 2005, 14 anni fa, da tutta la striscia, fino all’ultimo centimetro quadrato, lasciando la’ infrastrutture poi distrutte, stupidamente, dalla foga islamica. Non ci sono rivendicazioni territoriali sulla striscia, punto! Hamas avrebbe potuto, con i miliardi di euro arrivati dai paesi arabi e dagli aiuti internazionali, investire in infrastrutture, avrebbe potuto creare posti di lavoro e Israele avrebbe permesso a decine di migliaia di Azati di venire a lavorare, come gia’ succedeva negli anni 70 e 80,avrebbe permesso la riapertura dell’areoporto e la costruzione di un porto commerciale. Hamas invece ha deciso di investire i soldi in armamenti, costruzione di tunnel d’attacco e per mantenere i miliziani.
Percio la soluzione per le sabbie mobili di Gaza si dovra’ trovare in un secondo tempo, insieme: Palestinesi moderati (esistono, esistono, non preoccupatevi ipersionisti di destra che fate di tutto per affossare i tentativi, andando, di fatto, a braccetto con quelli come voi dell’altra sponda) Israeliani e comunita’ internazionale.
Shabbat shalom! (Anche se shalom non c’e’ e non ci sara’ per molto tempo).
Aggiornato 5.5.19 07.50

1933, l’incendio dell’Europa; vi dice qualcosa? 02 Maggio 2019
02 Maggio 2019
Nel suo ultimo saggio, Siegmund Ginzberg racconta dodici mesi decisivi per i destini dell’Occidente: Hitler diventa cancelliere, cresce la violenza ma pochi fiutano il pericolo. Ogni riferimento all’oggi è puramente voluto
di WLODEK GOLDKORN
Nel 1933 Georges Simenon, inviato belga del settimanale francese Voilà, è in Turchia, ne trae un libro, un piccolo capolavoro, I clienti di Avrenos, in cui racconta la storia di una giovanissima ballerina ungherese che seduce gli uomini al potere a Istanbul. Ma prima ancora, a due passi dalla città sul Bosforo, metà Europa metà Asia, il reporter intervista il più celebre esule russo, nato in Ucraina e di origini ebraiche, Trotzkij. Simenon all’epoca ha trent’anni e il suo compito è raccontare il Vecchio Continente in crisi, o meglio, lo spirito di un pezzo del mondo che sembra voler rifiutare la naturale mescolanza e sovrapposizione delle appartenenze e degli idiomi a favore invece dell’ossessione identitaria, dell’odio verso chi è considerato diverso. Dove la democrazia è un fenomeno sempre più raro e precario, mentre trionfa quello che oggi chiamiamo sovranismo e populismo.
L’affascinante libro Sindrome 1933 di Siegmund Ginzberg, anche lui nato a Istanbul, in uscita con Feltrinelli, inizia proprio così, con l’inventore del personaggio del commissario Maigret in giro per l’Europa. Ora, per affrontare un tema difficile e scivoloso come le analogie tra la situazione di ottantasei anni fa e oggi in un modo avvincente per il lettore e non troppo saggistico, è molto utile narrare la storia con gli occhi di altri scrittori e autori, ed è questo il grande pregio del libro. Ginzberg mette a confronto l’immaginario degli uomini (sono quasi tutti maschi, segno dell’epoca), romanzieri, poeti, registi, giornalisti che forgiavano il racconto del mondo di allora, con la vera storia come la conosciamo oggi e con rimandi alla situazione attuale, in Italia e altrove. Allora, come oggi, sembra suggerire l’autore, nessuno, o quasi, si accorgeva di niente, la vita scorreva normale, mentre nel cuore dell’Europa c’era chi stava preparando la catastrofe. Simenon racconta di aver incontrato Hitler nell’ascensore dell’albergo Kaiserhof a Berlino, e non sappiamo se è vero. Ma era vero il suo colloquio con Trotzkij, appunto, un uomo che al netto della retorica bolscevica era capace di un acume quasi profetico, e che gli spiega quanto la prospettiva inevitabile nel Vecchio Continente sia il propagarsi delle dittature nazionaliste e di conseguenza la guerra.

Una di queste, anzi la peggiore delle tirannie della storia umana, dice Ginzberg, inizia quasi in sordina. “Il 30 gennaio 1933 era un lunedì. Freddo ma asciutto. Al mattino ancora non si sapeva come sarebbe andata a finire”, scrive. Finì con Auschwitz e Treblinka, lo sappiamo oggi, ma prima di arrivare a mettere in atto, qualche anno dopo, l’inimmaginabile, i politici si davano da fare come sempre, tra astuzie, piccoli inganni, calcoli di convenienza. Non riassumeremo la giornata del 30 gennaio qui (basta leggere le pagine del libro, scritte con piglio da romanziere e non solo da cronista), ma al mezzodì l’imbianchino austriaco diventò cancelliere della Germania. Nel suo governo i nazisti avevano pochi ministeri; il dicastero chiave, quello delle Finanze, era in mano a un tecnico che prometteva di tenere i conti in ordine: garante dell’operazione era l’ex cancelliere Franz von Papen, esponente del partito del Centro cattolico, formazione moderata, che nell’esecutivo ricopriva la carica de vice-cancelliere. Non tradì mai Hitler (anche se dissentiva di certo dai suoi metodi) e morì nel suo letto nel 1969 all’età di novant’anni.
Ginzberg spiega che non era inevitabile formare quel governo, in cui in realtà l’odio reciproco tra la vecchia destra militarista e la nuova destra nazionalsocialista era fortissimo e racconta, con punte di vero divertimento e sincero stupore, come la stragrande maggioranze degli osservatori e commentatori fosse sicura che quello di Hitler era un potere destinato a durare pochissimo tempo. Ne era convinto, tra le personalità citate dall’autore, Karl Kautsky, teorico marxista, ormai ritiratosi in Austria, che definiva i nazisti “imbecilli ignoranti”; e anche i “ragazzi di Oxford” Wystan H. Auden, Christopher Isherwood e Stephen Spender, presenti nella capitale tedesca, erano del parere che a primavera Hitler sarebbe diventato una storia del passato. In Italia, Gramsci dalla sua prigione intuisce invece come ogni potere anche estremista e radicale diventi “centrista” e per questo di lunga durata.
Una narrazione a sé è poi quella della morbosità dei racconti dei crimini a sfondo sessuale, di cui si appassionano ai tempi i tedeschi: inevitabile la citazione di Moosbrugger, il perverso assassino che colpisce l’immaginazione di Ulrich, il protagonista de L’uomo senza qualità di Musil, pubblicato in quegli anni. Fanno parte del racconto anche la retorica del ripristinare l’ordine naturale dei generi e porre fine agli eccessi di libertinismo. E la retorica razzista e contro gli immigrati.
Le analogie con oggi sono tante e Ginzberg le esplicita tutte (talvolta troppo, per fare una sola annotazione critica), pur dichiarandosi consapevole dei limiti del metodo: aiuta a capire il presente, non a prevedere il futuro. L’autore alla fine del libro dice che Cassandra non era creduta perché il potere (e il popolo) non ama le previsioni.

L’Acrobata di Laura Forti, in 100 pagine tutte le cose importanti della vita
Stefano Jesurum 9 aprile 2019
La domanda è come si possano concentrare in poco più di cento pagine l’essenza stessa del dolore e dell’amore, la violenza struggente dell’esilio, la bruciante ricchezza delle identità plurime, la rabbia sorda, la Memoria e le memorie, il lacerante senso di giustizia e il linguaggio profondo della depressione. E orgogli. E rimorsi. Tutto ciò in una narrazione che parte da due ebrei rivoluzionari nella Russia bianca zarista, passa per l’Italia dapprima accogliente e poco dopo vigliacca e fascista, zig-zaga tra Svizzera, Cile e Svezia. Per concludersi in un epistolario via e-mail tra una nonna affermata geologa e un nipote clown.
Accadimenti reali, emozioni e pensieri associati e dissociati e di nuovo associati nella mente e nel cuore di una donna. Memoria e memorie al femminile, che perforano il fondo dell’anima. «Ogni riferimento ai fatti e alle persone che li hanno compiuti è autentico; ogni parola, ogni pensiero di quelle persone è un’idea, Un’immaginazione, una speranza», scrive Laura Forti, l’autrice di “L’acrobata” (Giuntina editore). Un ricordo lontano, il cugino Pepo che dopo il golpe di Pinochet si ferma qualche giorno con la madre a casa Forti, a Firenze. 1987, fuggono, ancora una volta qualcuno della famiglia scappa. Quindi nel 2008 un viaggio a Santiago, e l’apparire di un dybbuk, di un’ossessione. Dybbuk e ossessione s’impossessano di Laura. Che ricerca, studia, chiede, vuole sapere. Vuole conoscere la storia del padre di Pepo, Jose Valenzuela Levi che 29enne – 16 giugno 1987 – fu ucciso dalla Dina, la spietata polizia cilena. Lui e alcuni compagni di lotta, i responsabili del fallito attentato al dittatore, massacrati. Una volta catturati fu strage dimostrativa, la Matanza de Corpus Christi. Vuole conoscere, Laura, e cercare di comprendere perché la sua famiglia non ne sapesse alcunché o non avesse mai voluto approfondire.
Così nasce “L’acrobata”, dapprima testo teatrale e ora libriccino prezioso. Probabilmente anche perché, o soprattutto perché, la potenza e la necessità del racconto sono inscindibili da qualunque “modo” di essere ebrei: tramandare la storia ai nipoti e al mondo aiuta a salvare se stessi, e forse il mondo. Dunque Pepo, alias Comandante Ernesto, ovvero Jose, lascia la Svezia divenuta rifugio sicuro, lascia la madre, le certezze, la comodità. In nome della giustizia. Perché? «Forse perché eravamo stati costretti a scappare, eravamo stati perseguitati come minoranza, forse perché avevamo perso tutto, come oggi succede agli immigrati?». Forse.

Forse per via che in alcune vicende umane si mescolano l’ebraismo, il bolscevismo, la Hashomer Hatzair e il suo sionismo socialista, e la Gioventù Comunista, i valori universali di giustizia, la speranza (quasi messianica) nel futuro e le molteplici sfaccettature di una medesima identità. E la paura, tanta paura. Paura trasmessa di generazione in generazione in una sorta di psicoDNA (come bene ha spiegato Anne Ancelin Schützenberger in “La sindrome degli antenati – Psicoterapia transgenerazionale e i legami nascosti nell’albero genealogico”). Paura, paure, e depressione come estrema difesa, «Se ero morta dentro, chi poteva farmi ancora del male?». E coraggio, eroismo, l’altra faccia del buco nero.
Una lettura importante. Parafrasando la nonna che scrive a totopajazo@gmail.com, grazie. Grazie Laura Forti per quelle lacrime..
Stefano Jesurum

Bugiarda: un libro per ricordarci che ogni bugia è una verità di comodo
Stefano Jesurum 26 aprile 2019
«Incredibile, quanto possiamo sapere senza sapere di sapere».
Proprio così. Che la maestria di Ayelet Gundar-Goshen, il suo segreto, stesse nello svelarci questa dirompente verità lo avevo intuito leggendo il potente romanzo “Svegliare i leoni”. Lo trovai avvincente e di una lucidità psicologica assoluta. Ora però penso che la giovane autrice israeliana abbia superato se stessa con “La bugiarda” (Giuntina, traduzione di Raffaella Scardi) – detto per inciso, Ayelet Gundar-Goshen sarà al Teatro Parenti lunedì 13 maggio alle ore 20.

“Bugiarda”, ovvero la sua trama non può essere raccontata per due semplicissimi motivi: si rovinerebbe il gusto di una lettura costellata di suspance né noir né thriller; bisognerebbe, anche solo a riassumere, essere “bravi” come l’autrice… missione impossibile. Per chi ha amato “Svegliare i leoni” segnalo che ancora una volta Ayelet analizza la dimensione psicologica del protagonista fino all’indicibile, gioca e ragiona con la menzogna fino alla sua stessa essenza, vive e fa vivere “ai margini” chiunque compaia. Ed ecco cadere – meglio scivolare – i molti comprimari nella bugia.
Che poi, spesso, la bugia altro non è che una verità di comodo. Infatti c’è comunque una seconda opportunità, nel senso che si paga sempre per ogni cattiva azione compiuta, si espia la colpa e in fondo i personaggi divengono tutti positivi. E chi meglio della psicologa clinica Gunder-Goshen potrebbe condurci nei fantasmagorici meandri dell’inganno?
Chi non ha mai addestrato i propri sensi di colpa fino a trasformarli in un cane addomesticato? Gli «dai da mangiare, lo porti a spasso e in cambio dimentichi che una volta era un lupo».
Stefano Jesurum

Piero Cividalli, ultimo eroe della brigata ebraica: “La nostra è stata una lotta per la libertà”
16 Aprile 2019 di ZITA DAZZI
Ebreo italiano sfollato a Haifa dopo le leggi razziali, ha 93 anni: il suo discorso in consiglio comunale a Milano
“Sono
preoccupato per la dimenticanza del passato e di quel che ha portato il
fascismo. Gli italiani non conoscono abbastanza la storia. Io ho visto l’Italia
distrutta e ho capito i motivi della rovina. La gente non sapeva dove portavano
certe idee. Mussolini all’inizio ha gettato la polvere negli occhi a tutti.
Andrebbe insegnato di più nelle scuole a che cosa ha causato quell’ideologia.
Ho paura perché molti non lo sanno”. Parla seduto su una panchina in
piazza San Fedele, Piero Cividalli, classe 1926, ebreo italiano sfollato ad Haifa
dopo le leggi razziali, ultimo combattente della Brigata ebraica, costituita il
20 settembre 1944, dopo una lunga trattativa fra le autorità ebraiche in
Palestina ed il governo britannico, mandata in Italia nel ’45 a combattere i
nazisti in fuga, al fianco degli alleati e dei partigiani.
L’hanno
invitato a parlare in Consiglio comunale, alla vigilia dell’anniversario della
Liberazione. E lui, con tutta la fatica dei suoi fieri 93 anni, arriva da Tel
Aviv accompagnato dal suo assistente, Stefano Scaletta e da Davide Romano,
della Comunità ebraica. Quando entra, l’aula intera scatta in piedi. Il sindaco
Giuseppe Sala lo abbraccia commosso. E coglie l’occasione per attaccare i
gruppi filopalestinesi che ogni anno, durante il corteo del 25 Aprile fischiano
lo spezzone degli ebrei che sfilano con i fazzoletti della Brigata e con le
bandiere israeliane: “Penso che quei 4 gatti, che hanno l’abitudine di
fischiare lo fanno senza conoscere a fondo questa profonda pagina di libertà.
L’azione
della Brigata Ebraica fu pienamente parte della Resistenza italiana, con i suoi
5 mila soldati ed ha inciso sulla lotta al fascismo e nella storia della nostra
città”. L’anziano Cividalli, nato da famiglia benestante fiorentina,
legatissima ai fratelli Rosselli, dopo il loro assassinio, a 13 anni dovette
scappare in Palestina. “Ma di fronte ai racconti degli orrori che
avvenivano in Europa e nell’ansia per quel che accadeva ai nostri cari, non
potevo restare indifferente. Quindi a 18 anni decisi di arruolarmi per liberare
l’Italia dal giogo nazisfascista”, ha raccontato lui in aula. “Per
farlo ho dovuto giurare fedeltà al re di Inghilterra, cosa che personalmente
non era una mia necessità. Ma la spinta a combattere tutti quegli orrori mi ha
fatto sorgere un desiderio non di vendetta, ma di giustizia”.
L’anziano
combattente – che nella sua vita ha partecipato a tre guerre – oggi si dice
“pessimista, preoccupato per il presente, per il risorgere del
nazionalismo: il mondo purtroppo non è molto cambiato, anche se ai miei tempi
c’è stata una vittoria sulle forze del male, che si erano intromesse negli
animi di tante persone, oggi ci so o brutti segnali. Siamo tutti cittadini del
mondo dovremmo darci la mano gli uni con gli altri, invece di fare la guerra.
Ma oggi ci siamo persi. Anche la gioventù di oggi non la capisco. Tutti con
occhi bassi sul cellulare, invece che avere speranza di cambiare il mondo. Ai
miei tempi c’era più musica nell’anima degli uomini”. Mentre parla col
cuore in mano, l’aula di Palazzo Marino si ferma. “Sbarcato a Taranto, ho
visto con i mie occhi come il fascismo aveva ridotto il Paese nella miseria più
totale, non solo materialmente ma anche moralmente. C’era povertà, alla
miseria, una rovina totale”, racconta per concludere con un appello agli
“italiani perché conoscano la loro storia e sappiano dove li ha portati il
fascismo”. Il sindaco gli stringe le mani: “Le vicende storiche si
possono subire oppure si possono vivere da protagonisti. Lei ha scelto la
seconda strada, in ogni momento della sua vita. Ed è in questo profondamente
milanese”. Applaudono tutti e il presidente del Consiglio comunale,
Lamberto Bertolè sottolinea quello che insegnano le parole Cividallii: “La
Resistenza è stata un’esperienza collettiva straordinaria, ma nasceva anche da
scelte coraggiose e di responsabilità di singole persone”.
LA VITTORIA DI NETANYAHU, ISRAELE E L’OCCIDENTE
Fabio Nicolucci (articolo pubblicato su Il Mattino di giovedì 11 aprile 2019 )
Dopo la notte elettorale in Israele, solo una persona si è svegliata ieri mattina più felice di Benjamin Netanyahu. Ed è Donald Trump. La vittoria di Netanyahu conferma infatti l’attuale direzione della politica occidentale, che marcia a passo spedito verso la rimozione della complessità dei fenomeni, la conseguente abdicazione alla loro soluzione sistemica e la scelta di capri espiatori illusori ma sempre diversi da sé.
Se Netanyahu è l’ideologo di questa larga coalizione di destra basata sull’irrazionalismo e sul moralismo anti-realpolitik, Trump ne è l’azionista di maggioranza. E dunque da ieri il Presidente Usa può più serenamente guardare al traguardo della rielezione nel 2020. Ha fatto di tutto per dargli una mano, spostando dapprima in modo unilaterale l’ambasciata Usa a Gerusalemme, poi proclamando il riconoscimento della sovranità israeliana sul Golan strappato in guerra alla Siria nel 1967, e quindi piegandosi allo schieramento anti-Iran voluto da Netanyahu. Malgrado esso significhi fare perno sull’Arabia Saudita del principe Mohammed Bin Salman, coprendone tutti i comportamenti, dall’assassinio di Khasoggi a soprattutto la disumana guerra in Yemen.. Su cui il Congresso Usa ancora non si è rassegnato a chiudere gli occhi.
Se dunque i vincitori della cruciale tornata elettorale del 9 aprile sono chiari, il primo perdente è la sinistra. Quella che di fronte alla crisi dell’Occidente propone una grammatica di scientismo e razionalità che la coalizione di destra vincente ed egemonica è riuscita ad etichettare come “casta”, “intelligenza con il nemico”, “debolezza”, e in definitiva tradimento. Una forse vetusta, certo non nuova, proposta di rispondere a complessità con complessità, che in questi tempi di fugacità e percezioni immediate, immersi nel turbine di una globalizzazione che porta con sé anche disuguaglianze e terrorismo, è parsa incerta ed elitaria.
A studiare i dati di ieri del laboratorio politico israeliano, che la sinistra non capisce più da tempo e che invece è strategico e per ragioni storiche costituisce “l’occidente dell’Occidente”, si vede come a far vincere a Netanyahu il suo quinto mandato è stata soprattutto la sua capacità coalizionale. Dando rappresentanza e quindi identità a tutte le pieghe della destra. Perfino a quelle razziste e violente dei seguaci del rabbino Kahane, rientrati nella Knesset dopo esserne stati cacciati da Shamir – un’altra destra, un altro Israele, un altro sionismo – nel 1988. Il risultato dello sfidante Benny Gantz, pluridecorato generale ex Capo di Stato Maggiore del glorioso esercito israeliano, è infatti numericamente strepitoso. Dal nulla ha conquistato 35 seggi su 120, esattamente come il premier uscente. Il problema è che la sua proposta di sicurezza per Israele basata su una piattaforma democratica e non tribale, di riconoscimento del nemico e non della sua rimozione – i palestinesi – o della sua fuorviante demonizzazione moralistica – l’Iran – ha convinto a sinistra ma non a destra.
Dopo la sbornia elettorale, però, i problemi di Israele rimangono sul tappeto.. Anzi sotto. In primis quello della scelta tra tutta la Terra biblica oppure il Popolo. Perché se si sceglie la Terra, come vogliono la destra e soprattutto i partiti religiosi ortodossi che la sostengono, ad un certo punto la superiore crescita demografica dei palestinesi imporrà di scegliere tra un Israele ebraico ma non democratico oppure un Israele democratico ma non più ebraico. Per evitare questa scelta, che snaturerebbe il sionismo, i professionisti della sicurezza hanno fondato il partito di Benny Gantz. Perché per loro la scelta è il Popolo, la cui difesa è suprema. Ed è possibile solo con uno Stato palestinese, malgrado tutto e con tutte le possibili cautele. Legata a questa questione principe e dirimente, da cui discendono le altre e la cui rimozione dalla scena politica prima israeliana e poi internazionale è proprio per questo indicativa, vi è poi quella del tipo di sistema politico. La rielezione per la quinta volta di Netanyahu, con il suo fardello di conflitti di interesse sotto inchiesta della magistratura, rischia di spezzare il sin qui funzionale equilibrio dei poteri. E, di conseguenza, dipendendo dalla volontà dei partiti religiosi di fare una leggina ad hoc che gli conceda l’immunità, anche di sbilanciare i rapporti tra religiosi e laici a favore dei primi..
Così, mentre le ricadute internazionali della vittoria di Netanyahu sono per lo più positive per la destra occidentale, che festeggia – insieme a Putin – e affila le armi contro europeisti e multilateralisti “lenti” e “razionalisti”, esse rischiano di essere drammatiche per la sicurezza di Israele sul lungo periodo. Un giornale israeliano ha definito Netanyahu “un genio politico che sta guidando Israele verso l’abisso”. Una contestuale grande notizia di scienza, la fotografia per la prima volta di un buco nero, rischia di indicare quale possa essere la destinazione di un Israele incapace di raddrizzare la rotta.

Israele, Grossman: “Ormai Bibi è nella testa del Paese. La democrazia è sparita”
10 Aprile 2019
dalla nostra inviata FRANCESCA CAFERRI REPUBBLICA
TEL AVIV.
All’indomani del voto con cui Benjamin Netanyahu si è imposto ancora una volta al
centro della scena politica, David Grossman è affranto. Come la parte del Paese
a cui, da anni, insieme a un’intera generazione di intellettuali il grande
scrittore israeliano dà voce. «Ci serve solo qualcuno con un po’ di coraggio,
che dica alla gente che la pace si può fare ancora: ci giochiamo davvero
tanto», ci aveva detto poche ore prima del voto. A urne chiuse la
consapevolezza amara è quella di aver perso la sfida: e in maniera brutale.
Signor Grossman, con la vittoria in
queste elezioni Netanyahu si appresta a diventare il primo ministro più longevo
della storia di Israele. Dopo tanti anni, ha capito qual è il segreto del suo
successo?
«Bibi ha un potere sulla
gente che è molto difficile spiegare in modo razionale. È un ottimo politico,
ma il segreto non è quello: ha trovato il modo di rispondere alle paure più
irrazionali e profonde dei sionisti. L’intensità della manipolazione che ha
messo in atto sulla società israeliana negli ultimi anni è difficilmente
spiegabile per chi non ha assistito al suo sviluppo: è entrato nella testa del
Paese e tutta la vita del Paese oggi si svolge nella sua testa. E’ come se
l’intero Israele fosse soggetto alle sue priorità, alle sue ansie, alla sua
visione del mondo: e nessuna altra visione trova spazio nel dibattito. Abbiamo
accettato che facesse lui le regole del gioco, senza troppa opposizione: ed
ecco il risultato».
Non sembra sorpreso…
«Non sono sorpreso
infatti. Si sa che in Israele il blocco delle destre è più forte, anche solo
dal punto di vista demografico. Ma Gantz è un uomo di centro-destra, nonostante
abbiano tentato di etichettarlo come un estremista di sinistra: speravo che
riuscisse ad attirare più voti da destra. Invece ha solo cancellato la
sinistra, inglobando i suoi elettori».
Che cosa si aspetta ora?
«Nulla di buono. Alle
urne ha vinto l’idea che Israele è uno Stato solo per gli ebrei, ci saranno
altre leggi che seguiranno quella sullo Stato-nazione approvata nei mesi scorsi
e il Paese si adeguerà. La parola democrazia perderà di senso, per un motivo
molto semplice. Non puoi definirti democratico e occupare le terre di un altro
popolo per 52 anni consecutivi. L’Israele di Netanyahu lo fa, e non avrà problemi
a continuare a farlo nel futuro».
Da dove può ripartire il Partito
laburista e con lui la sinistra israeliana?
«Una delle poche cose
buone di queste elezioni è che è chiaro che deve esserci un partito unito per
arabi e israeliani, in cui le parti siano pienamente uguali e che parli per
entrambe. Martedì gli arabi hanno fatto un errore a non votare, perché hanno
reso a Netanyahu la vita più facile. L’unica speranza che la sinistra ha di
ripartire è non abbandonare il 20% della popolazione del Paese che ha voglia di
essere perfettamente integrata nella società: i cittadini arabi israeliani
appunto. Invece sia il Labour che Meretz, come del resto Ganz, li hanno
totalmente ignorati, come se non ci fossero, li hanno umiliati per anni: un
errore costato carissimo a cui hanno tentato di rimediare solo nelle ultime
ore, quando hanno capito cosa stava succedendo. Troppo tardi».
Crede che i palestinesi sarebbero
d’accordo con la prospettiva di un partito unico?
«Ci sono migliaia di
persone che sono pronte a lavorare insieme. Ripartiamo da loro. Se fossi un
palestinese oggi mi sentirei umiliato e spaventato».
Da qualcosa in particolare?
«Da tutto. Netanyahu ha
incoraggiato gli estremisti, li ha infiammati. E il Labour è stato a guardare.
Quelli di destra oggi non dicono che Israele ha perso la sua anima, come io
penso, ma che invece l’ha ritrovata. Perché può contare sull’appoggio
internazionale per riprendersi quelli che considera territori storici:
Gerusalemme, il Golan, domani la Cisgiordania. I piani del governo che verrà su
questi temi saranno i più estremi a cui abbiamo assistito. E non solo su
questo».
Su cos’altro ancora?
«Sull’istruzione ad
esempio. Si dice che il nuovo ministro potrebbe essere Bezalel Smotrich di
Otzma Yediuth, un partito xenofobo e razzista che per anni è stato escluso
dalla vita democratica e che ora ci entra grazie a un accordo voluto da
Netanyahu. Per contrastare tutto questo dovremmo creare un sistema di scuole
umanistico, alternativo: come le scuole religiose fondate in passato dallo Shas
e che negli anni hanno prodotto una classe di persone che incarna l’ideologia
di quel partito e lo vota alle urne. Facciamolo anche noi ma con un sistema
scolastico umanistico, aperto, democratico».
Speranze per il futuro?
«Una sola. I documenti
che hanno portato alla messa in stato di accusa del primo ministro per
corruzione saranno resi pubblici a breve. Spero che nella squadra di Netanyahu
e anche nel suo partito, il Likud, ci siano persone oneste che si rifiuteranno
di avere a che fare con una persona che è a giudizio perché accusata di essere
corrotta e criminale. A quel punto il Likud, che non ama Netanyahu in modo
unanime, potrebbe essere costretto a cambiare leader».
Benny Morris: «In Israele la sinistra è scomparsa perché Rabin e Barak si fidarono di Arafat»
Lo storico su Netanyahu: «Si dimetterà per scandali e processi»

GERUSALEMME — Benny Morris ha l’età di Israele. Nato nel 1948
nel kibbutz di Ein HaHoresh, con il suo libro Righteous Victims —
pubblicato in Italia da Rizzoli con il titolo Vittime: 941 pagine
di sofferenza ma anche di piacere intellettuale — ha cambiato il nostro modo di
pensare la storia del Medio Oriente.
Professor Morris, perché ha vinto Netanyahu?
«A causa
della demografia: ortodossi e sefarditi fanno più figli, e quasi tutti votano a
destra. E per responsabilità degli arabi israeliani: molti odiano Israele e non
votano, favorendo lo statu quo».
A Gerusalemme non cambierà nulla, quindi?
«Al contrario. Cambierà tutto».
Perché?
«La vittoria di Netanyahu è una vittoria di Pirro. Entro un anno gli scandali e
i processi lo costringeranno a dimettersi».
Chi gli succederà?
«Un altro uomo del Likud. Non so chi».
Come passerà alla storia Netanyahu?
«Be’, la
maggioranza degli storici sono di sinistra, quindi ne scriveranno male…».
Lei viene da sinistra ma ne è stato molto criticato, quindi il suo
giudizio è obiettivo.
«Lo considero un cattivo leader e un uomo corrotto. Anche se gli vanno
riconosciuti alcuni meriti. È stato cauto: non ha fatto guerre inutili; e non
ha corso rischi bombardando l’Iran».
Cosa accadrà dopo di lui?
«Può accadere di tutto. Le cose possono migliorare ma pure peggiorare. Di
sicuro, l’idea che il Medio Oriente sia immobile è un abbaglio clamoroso. Tenga
conto che siamo alla vigilia di un cambiamento anche nel campo avverso».
Abu Mazen è finito?
«Sì. Sarà presto sostituito. Non so dirle se il suo erede sarà più moderato o
più radicale».
Israele non è mai stato così sicuro? O l’Iran può minacciarlo?
«Israele è sempre in bilico. Sono certo che l’Iran stia proseguendo il suo
programma nucleare. Va fermato».
Come?
«Ci sono soltanto due strade. Sanzioni severe che ne blocchino l’export e
mettano in ginocchio l’economia. O le bombe. Poi c’è l’altra grande minaccia».
Quale?
«I palestinesi. Non hanno mai rinunciato a distruggere Israele. La pace è
impossibile, perché per fare la pace ci vuole un partner. E come fai con uno
che vorrebbe sgozzarti?».
Abraham Yehoshua pensa a uno Stato in cui ebrei e
arabi possano convivere.
«È un’utopia. Ci sono luoghi come Hebron in cui ebrei e arabi si ammazzano tra
loro da centinaia di anni. Come possono stare insieme? Il Muro, la separazione
sono una dolorosa necessità».
Ben Gurion disse nel 1938: «Noi stiamo difendendo le nostre vite.
Ma sul piano politico, siamo noi che attacchiamo, e loro che si difendono».
«Ben Gurion aveva ragione. Ma ora quel ragionamento non vale più. Israele ha
creduto davvero alla pace. I palestinesi no».
Per questo la sinistra israeliana non esiste più?
«Sì. Rabin e Barak si fidarono di Arafat. La disillusione è stata terribile».
Rabin assassinato. Sharon che cade in coma dopo il ritiro da Gaza.
Sembra che il diavolo in questa terra meravigliosa e tragica ogni tanto infili
la coda.
«Non serve il diavolo, fanno già tutto gli uomini. Anche se la malattia di
Sharon è stata davvero una disgrazia, anche politica. Credo che, dopo Gaza, si
sarebbe ritirato anche da parte della Cisgiordania».
Con Sharon in «Vittime» lei non è tenero.
«Ma lo considero uno dei più grandi comandanti militari che Israele abbia mai
avuto. Passare il Canale di Suez sulle zattere, sotto il fuoco dell’artiglieria
egiziana, la pioggia di missili sovietici e i Mig 21 che mitragliano a bassa
quota, richiede una certa personalità».
E Dayan?
«Quando i siriani sembravano vicini a sfondare sul Golan, e già vedevano il
Lago di Tiberiade e la Valle del Giordano, Golda Meir perse la testa. È
possibile che abbia ordinato di armare missili a lunga gittata con testate
nucleari. A quel punto l’Urss avrebbe reagito e chissà come sarebbe finita.
Dayan allora rivolse un messaggio ai carristi: “Voglio che teniate duro fino
all’ultima cartuccia. Vi state battendo come i Maccabei. Se non vi farete
piegare, rimarremo padroni del Golan”».
Era il 9 ottobre 1973. Non si fecero piegare.
«Contrattaccarono e giunsero a trenta chilometri da Damasco, fermati dal corpo
di spedizione iracheno. Metà dei nostri 2.300 caduti nella guerra del Kippur
erano carristi».
Lei scrive che il 4 ottobre un agente segreto al Cairo aveva
avvertito Israele che la guerra sarebbe cominciata «dopodomani alle 18».
«Invece
gli egiziani attaccarono alle 14, l’aviazione non si mosse — e lì Dayan sbagliò
—, fummo colti di sorpresa. La notizia era giusta. L’ora era sbagliata».
Il Mossad si convinse che l’errore fosse deliberato, e l’agente
facesse il doppio gioco.
«Io invece credo che fosse leale. Infatti i capi dell’intelligence furono
rimossi. E alla fine saltarono pure Dayan e Golda Meir».
Ancora una cosa. Trump può dare una mano, o combinerà solo guai?
«Trump è del tutto imprevedibile. Questa è la sua forza, e la nostra condanna.
Prepariamoci a ogni eventualità».

Yehoshua: «Bibi, genio manipolatore non è Trump, è Berlusconi»
IL grande scrittore: alla pace non credo più, la morte è un dono di Aldo Cazzullo, inviato a Tel Aviv 10 Aprile 2019
Abraham Yehoshua, 82 anni, coscienza critica di Israele, scrittore amato in tutto il mondo, vive al ventunesimo piano di una torre che domina Tel Aviv. «Così posso tenere sott’occhio tutti i miei sette nipoti. La più grande, Tamar, è già nell’esercito. Sono fiero di lei».
Yehoshua, lei è considerato un pacifista.
«Io sono un ex parà. Ho fatto la guerra del Sinai nel 1956. Comandava Moshe
Dayan».
L’ha conosciuto?
«Diventammo
amici. Era lui il vero premier, Golda Meir lo subiva. Impose la pace con
l’Egitto. Era un uomo con una formidabile carica erotica. Animato dalla libido.
Grande guerriero, con un lato romantico: cultore della letteratura,
dell’archeologia. Le donne lo adoravano. La benda nera sull’occhio poi le
faceva impazzire. Mai visto un amatore così».
Anche lei è considerato un
fascinoso.
«All’università
di Gerusalemme incontrai la mia Rivka e dopo sei mesi la sposai. Lei aveva 19
anni, io 23. Siamo stati insieme per 56 anni, fino alla sua morte. La amo
ancora, tantissimo».
Perché ha vinto di nuovo
Netanyahu?
«A
me non piace. Però non posso negare che abbia grandi qualità».
Ad esempio?
«È
intelligentissimo. Un genio della comunicazione. E purtroppo anche uno straordinario
manipolatore. Ha un figlio di 26 anni che passa le giornate sui social a
seminare zizzania».
E poi?
«È
un leader internazionale. Noi siamo un piccolo Paese da otto milioni di
abitanti, e Netanyahu è sempre in tv a conversare in russo con Putin, abbracciare
Trump, stringere la mano a Modi, ridere con Xi-Jinping. Sono cose che fanno un
certo effetto. E poi l’economia va bene».
Perché allora Netanyahu non le
piace?
«Non
gli perdonerò mai quello che ha fatto agli arabi israeliani. Ha trasmesso
l’idea che solo un ebreo può essere un vero israeliano; cosa che ai religiosi
piace moltissimo. L’ha detto pure in questa campagna elettorale: “La sinistra
tresca con gli arabi…”. Vagli a rispondere che “la sinistra” oggi in Israele è
un partito guidato da tre ex capi dell’esercito».
Lei crede ancora nella pace?
«No. Credo nella partnership: vivere insieme, sotto lo stesso tetto, sotto un unico cielo. Per decenni mi sono battuto, accanto al mio fraterno amico Amos Oz, per un’idea affascinante: due popoli, due Stati. Ora non ci credo più. Penso che saremo uno Stato solo, ma non uno Stato ebraico: aperto ai palestinesi, compresi quelli della Cisgiordania. Ho litigato con Amos per questo».
Vi vedevate spesso?
«Ogni settimana a cena. Lui mi rimproverava: con la tua idea finiremo per avere un premier arabo!».
Pare la trama di
«Sottomissione» di Houellebecq: i musulmani al potere.
«Un giudice non ebreo ha condannato un ex capo di Stato a sette anni di
carcere. Abbiamo generali drusi. Ci sono ospedali diretti da arabi. E
l’ospedale è la chiave dell’integrazione».
Perché?
«Perché in ospedale siamo nudi. È il luogo della sofferenza e dell’intimità.
Già oggi medici arabi curano malati ebrei, e medici ebrei curano malati arabi».
Sì, ma in concreto Netanyahu
cosa dovrebbe fare? Negoziare?
«Negoziare non serve a niente. Dovrebbe concedere in modo unilaterale prima la
residenza, poi la cittadinanza israeliana ai palestinesi dei Territori. Non ci
sarà mai una pace con trattati, firme, bandiere. Ci può essere convivenza.
Basta con l’apartheid. Dobbiamo mescolarci».
L’obiettivo appare
lontanissimo. Perché?
«Perché Israele ha il problema opposto al resto del mondo: un eccesso di
memoria. Altrove ne avete poca. Noi ne abbiamo troppa. I palestinesi passano la
vita a recriminare sulla Nakba, la catastrofe, la cacciata dalla loro terra.
Sognano la Eawda,
il ritorno. Custodiscono le chiavi della casa del bisnonno. Chiavi che non
aprono più nessuna porta. Al posto della casa del bisnonno c’è un grattacielo o
un negozio della Apple. Basta!».
E gli ebrei?
«È tutto un amarcord. Le guerre. I kibbutz. Le baracche in cui furono stipati i
coloni. E poi, ovviamente, la Shoah».
Nel suo ultimo romanzo, «Il
tunnel», pubblicato in Italia da Einaudi, il protagonista perde la memoria e si
tatua sul braccio i numeri dell’antifurto della macchina. Non è una
dissacrazione?
«Certo che lo è. Dobbiamo diminuire l’intensità della memoria. Che non
significa dimenticare; significa guardare le cose che abbiamo intorno. Uscire
dalla trappola dell’identità».
L’identità ebraica è molto
forte.
«Non esiste un’identità ebraica. Ne esistono molte. Gli askenaziti e i
sefarditi, i religiosi e i laici, gli ortodossi e gli ultraortodossi…».
Lei è sefardita?
«La famiglia di mia madre viene dal Marocco: Mogador, sulla costa. Quella di
mio padre da Salonicco. Ma anche l’identità sefardita è frammentata in dodici
tribù…».
Perché la sinistra, che governò
Israele per i primi trent’anni della sua storia, non esiste più?
«La sinistra è in crisi dappertutto, perché ha perso il popolo. È percepita
come un’élite globale di artisti, scrittori, professori che si conoscono tra
loro, si fidanzano, si invitano l’un l’altro a convegni dove esprimono giudizi
sprezzanti sul resto dell’umanità».
È una percezione o una verità?
«Un po’ è vero. In Israele la situazione è aggravata dal fatto che la sinistra
non è riuscita a fare la pace. Anche a causa del suicidio dei palestinesi».
Suicidio?
«Quando nel 1977 Sadat a sorpresa venne a Gerusalemme, chiese ad Arafat di
accompagnarlo. Arafat rifiutò, e da allora ha perso tutte le occasioni. Ora i
palestinesi sono drammaticamente isolati. Potevano far fiorire Gaza; ne hanno
fatto un base di attacchi terroristici. Il mondo arabo non è mai stato così
debole. Guerre civili. Dittature. Povertà. E gli arabi israeliani non votano.
Avrebbero potuto sconfiggere Netanyahu. Sono il 24% della popolazione, ed
eleggono il 4% dei parlamentari».
Netanyahu appare imbattibile. A
chi assomiglia?
«Non a Trump. Considero Trump un incidente della storia. Figlio
dell’impazzimento di una notte. Netanyahu mi ricorda semmai Berlusconi».
Berlusconi aveva le tv.
«Più ancora: Berlusconi, con i suoi limiti, sentiva il suo Paese. Adesso vi va
peggio, con Salvini e i 5 Stelle».
Anche lei ha troppa
memoria? Ricorda la fondazione di Israele?
«Avevo undici anni e mezzo. Rimanemmo chiusi in casa per due mesi.
Assediati. Gli inglesi combattevano accanto agli arabi, una loro bomba centrò
la nostra casa, mio padre rimase ferito. Atrocità da entrambe le parti. Se ci
avessero presi, nel migliore dei casi ci avrebbero tagliato la gola».
Come vinceste?
«Eravamo meglio organizzati. E avevamo più fiducia in noi stessi. Ma ora basta
con il passato».
Parliamo del futuro.
«Quale futuro? Ho perso mia moglie, ho perso Amos. Non mi resta
che morire anch’io».
Cosa c’è dopo?
«Nulla. Per fortuna. La morte è molto importante. Un dono che
facciamo ai nostri nipoti: lasciare loro spazio».

Israel Is on the Brink of Disaster. Trump Just Made Things Worse.
Israel’s right-wing leaders are reading signals from Washington as a green light.
By Michael J. Koplow 25/03/2019
Dr. Koplow is an advocate for a viable two-state solution to the Israeli-Palestinian dispute.
On April 9, Israelis will go to the polls to choose their next government. The campaign has largely been a referendum on whether Prime Minister Benjamin Netanyahu should remain Israel’s leader in light of his expected indictment in three corruption cases for bribery and breach of trust. With those scandals front and center, policy disagreements have largely been ignored, leaving Israeli voters at risk of unwittingly bringing an avoidable disaster on themselves by annexing territory in the West Bank.
President Trump just raised that risk.
How so? On Twitter on Thursday, he wrote that “it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!” It is the latest, and most important, signal from Washington that Mr. Trump is ready to acknowledge Israeli control of the Golan Heights.
But those signals are also being read by the Israeli right wing as an encouragement to pursue annexation of territory in the West Bank — a far more dangerous step that would present Israel with an unparalleled existential threat to its Jewish and democratic character.
To be sure, there is a big difference between the two territories, both of which came under Israeli control in the 1967 war. The sparsely populated Golan Heights, seized from Syria and annexed by Israel in 1981 in defiance of international criticism, were being used by Syria to bombard Israel’s Galilee region below.The West Bank, on the other hand, is densely populated and its future has been the most intractable issue of the Israeli-Palestinian conflict since 1967. Annexing it would foreclose independence for a Palestinian nation, and risk inflaming the entire Middle East.
That threat is not beyond the horizon any more. The young, charismatic New Right party leaders Naftali Bennett and Ayelet Shaked, both ministers in Mr. Netanyahu’s coalition government, lead the annexation movement, and their zeal has seeped into Mr. Netanyahu’s Likud Party as well. Of the 29 Likud legislators running for re-election, 28 are on record as supporting annexation of at least a part of the West Bank, as is the Likud Central Committee.
Most significantly, the speaker of the Knesset, Yuli Edelstein, who is No. 2 on Likud’s electoral slate behind Mr. Netanyahu, said on Sunday that a description of the Golan Heights as “Israeli-controlled” in the recent annual report of the United States State Department — a shift from previous reports that called it “Israeli-occupied” — represented an important first step toward recognition of Israeli sovereignty in the West Bank.
Reaching that goal, however, would create challenges as harrowing as any Israel has faced since its war of independence. As cataloged by the Israeli group Commanders for Israel’s Security, annexation would cost billions of dollars annually, would create virtually indefensible borders because of the spider web of Israeli-governed territory within the larger West Bank that most supporters of this plan want to annex, provide ammunition to the anti-Israeli Boycott, Divestment and Sanctions movement, and destroy Israel’s foreign relations with a host of countries.
It would also ensure that the partisan split emerging in the United States over Israel’s policies toward the Palestinians becomes a chasm. It might even open a rift between Mr. Netanyahu and his stalwart ally President Trump, who thinks himself able to devise an ultimate deal between Israelis and Palestinians, by making any such deal impossible.
Most important, annexing the West Bank — whether just the 60 percent of it that Israel controls now, or its entirety — would bring the collapse of security coordination between Israel and the Palestinian Authority and likely cause the demise of the authority, forcing Israel to take over all of the West Bank, like it or not. Israel would then have to grant citizenship to the 2.5 million Palestinians living there, giving itself the choice of no longer functioning as a Jewish state, or destroy its democracy by denying the Palestinians political equality. If anything can truly threaten Israel, the region’s pre-eminent military and economic powerhouse, it is that.
While Mr. Netanyahu himself has been the sole Likud leader not explicitly supporting annexation in the West Bank, his political predicament might well pull him into the annexationist camp. His legal problems create a strong incentive to form a government that will pass a law barring the indictment of a sitting prime minister.
Voter surveys suggest the election next month will result in an almost even split between the Netanyahu-led bloc of Likud and its allied parties, and an opposition bloc led by Benny Gantz. That means Mr. Netanyahu will remain in power at the whim of his preferred right-wing coalition partners, whose leverage over a prime minister seeking to stay out of jail will be enormous. And the item at the top of their wish list is extending Israeli sovereignty to the West Bank.
Most worrisome, Israelis have been barely paying attention. As the Israeli journalist Aluf Benn points out, this is a campaign that won’t turn on any issues but on Mr. Netanyahu himself. And to the extent that Israelis are paying attention to policy, they are concerned about terrorism and the cost of living, with only 9 percent listing the Israeli-Palestinian conflict as their top concern and just 2 percent listing the future of the West Bank. Even though only 15 percent of Jewish Israelis support annexing the West Bank, a core of right-wing activists are poised to overrun the preferences of a much larger but less ideologically dedicated majority.
Should Mr. Netanyahu emerge victorious once again, the prospects of Israel taking this path are alarmingly high. The pro-annexationists have never put forth a detailed proposal of what annexation will entail.
Israeli voters may be about to rush headlong into quicksand that they don’t even realize exists.
Michael J. Koplow is the policy director of the Israel Policy Forum in Washington.

Trump Has Liberated Israel
By Shmuel Rosner 22/03/2019
President’s announcement on the Golan Heights will finally free us from the “land for peace” formula that none of us believe in anyway.
TEL AVIV — On Thursday evening here in Israel, after President Trump announced that “it is time for the United States to fully recognize Israel’s sovereignty over the Golan Heights” and our prime minister, Benjamin Netanyahu, thanked the president for his “historic” decision, I wanted to talk to someone I trusted on the issue, someone with perspective. So I contacted Zvi Hauser.
Mr. Hauser was a cabinet secretary under Mr. Netanyahu and is running for the Knesset on behalf of the Kahol Lavan Party, which wants to unseat the prime minister in the April 9 general election. He is also a longtime proponent of America’s recognition of Israel’s sovereignty over the Golan Heights.
With less than three weeks until Election Day, Mr. Hauser keeps his priorities straight. He knows that Mr. Netanyahu will get credit from the public for the United States’ recognition of Israel’s control of the Golan — something many Israelis have wanted for a long time. He understands that the president intervened to boost Mr. Netanyahu’s chances in a tight race. Still, Mr. Hauser was happy. He called the move “a turning point in the annals of the Middle East” and said he wanted to “thank President Trump and Prime Minister Netanyahu.”
Mr. Hauser was not alone among Mr. Netanyahu’s rivals in praising Mr. Trump’s decision. Across the Israeli political spectrum (with some obvious exceptions), politicians are supportive of America recognizing Israel’s control of the Golan Heights.
Indeed, Mr. Trump’s statement on Thursday was a major development. It is the final nail in the coffin of the 1967 line — the armistice line that separated Israel from its neighbors before the Six Days War. More than 50 years since this line was crossed by the Israeli military, we can finally kiss it goodbye.
The part of the Golan Heights controlled by Israel is a 500-square-mile territory wedged between northeast Israel and southwest Syria. Syria ruled this area until 1967. Then Israel occupied it. Since then, there have been about 50 years of negotiations, with Syria demanding the territory back and Israel demanding a peace agreement.
Many Israelis, though, knew that it never should — or would — be returned to Syria. The area was too important strategically and historically. In 1981, the Knesset passed a law essentially annexing the territory. And yet, negotiations continued, with successive prime ministers making overtures to the Syrians, until the Syrian civil war — and the takeover of much of Syria by Iran and its proxies — put an end to the charade.
Israel had no choice but to give up on the idea of withdrawing from the Golan Heights. But this reality involves a complete overhaul of the way the international community thinks not just about the Golan Heights but also about all the lands Israel occupied in 1967. The “land for peace” formulation for the past five decades has been a basis of all peace processes between Israel and Egypt, Syria and the Palestinians. Mr. Trump seems to have accepted the position of Israel’s government and given up on the idea that Israel has to withdraw to a decades-old line to get peace.
Withdrawal worked for Israel once, in 1979, when it signed a peace agreement with Egypt and left the Sinai Peninsula, which was also occupied in 1967. But that set a problematic precedent. President Anwar Sadat of Egypt insisted that Israel hand back the entire peninsula to the last inch. Israel decided that the reward was worth the price, as a major Arab country agreed to break with other Arab states and accept Israel’s legitimacy. But there was a hidden, unanticipated cost: Israel’s adversaries, in future negotiations, would demand the same kind of compensation. The 1967 line — what Israel controlled before the war — became the starting point for all Arab countries, including Syria. It became a sacred formula, worshiped by the international community.
What Mr. Trump is doing extends far beyond the ability of Israel to control the Golan Heights, to settle it and invest in it. The American president is setting the clock back to before the peace deal with Egypt, to a time when Israel could argue that the reward for peace is peace — not land.
Syria, of course, is unlikely to accept this. At least not in the short term. But maybe someday, a Syrian leader will come along who doesn’t entertain the thought that Israel might agree to return to the pre-1967 line and who will accept a different formula for achieving peace.
In the meantime, the Golan Heights news is another clarifying moment in Israel’s election. Yes, there is a fierce fight between Mr. Netanyahu and his opponents. Yes, the stakes seem at times high. But Israelis agree on much more than many outside observers imagine. And one of the things they largely agree on is that the 1967 line is no longer relevant.
Mr. Hauser started fighting for recognition of Israel’s sovereignty in the territory when he was an ally of Mr. Netanyahu. Now he is fighting for the same thing as the prime minister’s opponent. There is nothing unnatural or strange about this. On days like these, he told me, “politics is dwarfed amid the call of history.”

Israel’s Election Shows How Dead the Two-State Solution Really Is
Even the center-left candidate isn’t talking about a viable Palestinian state.
Contributing Opinion Writer
- Feb. 27, 2019
TEL AVIV — His slogan contends that “there is no more left or right.” The list of candidates he’s running with includes a hawkish former Likud defense minister and a hawkish former Likud government secretary. In his first speech as a candidate, he vowed to keep the Jordan Valley “our eastern security border” and to “maintain security in the entire land of Israel,” by which he means the West Bank. A campaign video credits him with sending parts of Gaza “back to the Stone Age.”
Despite all this, Gen. Benny Gantz, a former Israeli Army chief of staff and a newly minted politician, is the candidate of Israel’s left of center for the April 9 general election. He is the candidate of what used to be called the “peace camp.”
And it turns out that his party has a good chance of winning. Last week, Mr. Gantz and Yair Lapid, who for the last seven years led the Yesh Atid party, announced that they are joining forces in a new party of parties they call Kahol Lavan, or Blue and White, the colors of Israel’s flag. Mr. Gantz and Mr. Lapid will, if they win, take turns serving as prime minister, beginning with two and a half years of Mr. Gantz. Polls predict a close race, with Kahol Lavan surging in recent days.
But the real lesson here isn’t just that tactical alliances are the best way to defeat Prime Minister Benjamin Netanyahu after 10 consecutive years in office. What this election is showing is that no party with even half a chance of winning power in Israel still supports the commonly understood version of a two-state solution. Paying lip service and using the term “two-state solution”? Maybe. But supporting two states — in the full meaning of the term state? Not so much.That’s not to say no one still believes in a fully independent Palestinian state. Dovish members of the shrinking Labor Party and the left-wing Meretz Party still believe in the evacuation of Israeli settlements in the West Bank and seem to be in favor of a Palestinian state with more control of its own borders. The Arab parties, too, want a fully independent Palestine. But Labor and Meretz are unlikely to win more than a few seats in the Knesset, and no Israeli party with the realistic ambition to be the ruling party is likely to cooperate with the Arab parties.
Kahol Lavan has not yet announced a platform, but here is what we can guess about its positions: It will demand that Jerusalem stay united under Israel’s jurisdiction; it would keep the main settlement blocs in place; it will oppose a unilateral evacuation of settlements; it will want Israel’s eastern border, in the Jordan Valley, to remain under Israel’s control. And most important, it will likely demand that the Israeli Army has the right to operate in all of the territory between the Mediterranean and the Jordan When the Palestinians envision their future, they envision a real state. When Israel’s center-left envisions the future, it envisions an entity in which the Palestinians have autonomy and one in which they can exercise their national self-determination, with the following caveat: Israel retains the right to operate militarily in this area and Israel controls all of its borders.
In fact, what Mr. Gantz and the center-left now offer the Palestinians is very similar to what they might get from Mr. Netanyahu who once called it a “state minus.” Even Naftali Bennett, the leader of the even more right-wing party, New Right once agreed to “autonomy plus,” a formulation that is different more in tone than in substance.
Of course, there still might be a real difference between the center-left and the right. Maybe Mr. Gantz seriously means what he says, while Mr. Netanyahu is just playing for time. Or maybe Mr. Gantz will change his tune once he is elected and decide to withdraw unilaterally from the West Bank, or accept a different deal from the one he is now supporting, as has happened with previous prime ministers.
Either way, though, the party’s stated positions tell us plenty about Israel’s state of mind.
Israel’s trust-the-Palestinians camp lost the argument after the 2000 Camp David summit failed and was followed by a bloody Palestinian uprising, the second Intifada. Israel’s unilateral-withdrawal camp lost the argument following the 2005 “disengagement” from the Gaza Strip, which resulted in nearly constant conflict on the Israel-Gaza border. Even many Israelis who believe that the Palestinians deserve a state find it difficult to believe that Palestinian leaders and institutions can be trusted with one.
Israel’s current election cycle is quite revealing in this sense. The main parties, Likud and Kahol Lavan, both speak about security much more than about peace. Both are attacked from the right because of the likelihood that they will accept the “deal of the century” — President Trump’s peace plan, which is slated to be revealed immediately after the election. Both are attacked from the left for offering essentially the same platform — Mr. Netanyahu’s — when it comes to peace with the Palestinians.
So, this is it. The two-state solution is acceptable to most Israelis, including center-right, center and center-left Israeli voters, only if the Palestinians do not really get what they consider a state. This probably means, that it cannot be a solution. Not for a very long time.
Shmuel Rosner is the political editor at The Jewish Journal, a senior fellow at the Jewish People Policy Institute and a contributing opinion writer. @rosnersdomain
I TERRORISTI CHE NESSUNO VUOLE VEDERE
Fabio Nicolucci
Le dimensioni del massacro in due moschee in Nuova Zelanda sono tali da porre in modo ultimativo una semplice domanda: “chi è il nemico”? Sinora si è data una risposta confusa. Perché in occidente non vi è accordo e unità sull’analisi del fenomeno. Di conseguenza, non vi è unità d’azione.
Non vi è unitarietà di analisi perché nel nostro spazio pubblico si confrontano due letture assai diverse del fenomeno “Terrorismo”. Che discendono da due oramai opposte “Weltanschauung” – visione del mondo, ndr. – su come leggere la crisi dell’occidente nella quale siamo immersi. Più che destra e sinistra, infatti, nella cultura politica occidentale si scontrano due modi di guardare la realtà.
Il primo è intriso di ideologia, dove il “dover essere” è fumoso ma proietta sullo schermo le proprie paure e frustrazioni, e trova nell’Altro la cifra del problema. Qui la realtà è lineare, spesso monodimensionale, incontrovertibile fino all’antiscientismo e poi all’irrazionalismo, prodotto da uno scioglimento della dimensione storica in quella ideologica.
In questa modalità, fatta propria dal razzismo e dal suprematismo bianco e da tutti coloro che vedono le civiltà come monoliti monodimensionali, dopo il Comunismo ora il nemico è l’Islam. In quanto tale. Essa cresce nel brodo di coltura dell’islamofobia – un razzismo declinato in salsa religiosa e non etnica – fino a far scrivere in un comunicato ufficiale al senatore australiano del Queensland Fraser Anning ieri “la vera causa del massacro nelle strade della Nuova Zelanda oggi è il programma di immigrazione che ha permesso a mussulmani fanatici in primo luogo di emigrare in Nuova Zelanda. Siamo chiari, anche se mussulmani possono essere state oggi le vittime, di solito essi sono i perpetratori. L’intera religione dell’Islam è semplicemente la violenta ideologia di un despota del sesto secolo mascherato da leader […] e la verità è che l’Islam non è come le altre fedi.”
Il secondo modo segue invece il realismo. Lo studio di quella “realtà effettuale” che Machiavelli indicava come vero obiettivo dell’analisi per non finire ad acchiappare nuvole. Qui la realtà è complessa, spesso intricata, sicuramente non lineare e certo non meccanicistica. Ed è un fenomeno dove conta molto la dimensione della Storia, e quindi le fake news non hanno legittimità perché la contraddicono.
Se si guarda dunque con realismo politico la realtà del terrorismo, si capisce che il fenomeno non è uno e indistinto, bensì vi sono due terrorismi distinti. Il primo è un progetto politico globale del jihadismo – entro il cui universo di senso possiamo anche inscrivere i fenomeni di radicalizzazione in occidente – che opera per acquisire meriti contro “il nemico lontano” per vincere la battaglia per il potere all’interno della propria civiltà islamica. La lotta colpisce anche noi, ma l’obiettivo primo è sconfiggere i riformisti all’interno dell’Islam.
Il secondo è un terrorismo di estrema destra, razzista e suprematista. Che gli islamofobi non vedono, e che l’ascesa e la centralità dei jihadisti ha fatto sottovalutare anche agli apparati di intelligence. Che dimostra la falsità dell’assunto “non tutti i mussulmani sono terroristi, ma tutti i terroristi sono mussulmani”. Non era infatti mussulmano bensì ebreo quel Baruch Goldstein che esattamente 25 anni fa all’alba del 25 febbraio 1994 trucidò 39 fedeli in preghiera nella moschea dei patriarchi di Hebron per far deragliare il neonato processo di pace con i palestinesi di Oslo. Non era mussulmano bensì suprematista bianco e islamofobo quel Anders Beivik che il 22 luglio del 2011 uccise 77 persone a Oslo e nell’isolotto norvegese di Utoya. Non è mussulmano Luca Traini, il cui nome sporca il nostro orgoglio nazionale – e la nostra coscienza – fino ad essere citato come esempio dal terrorista che ieri ha ucciso 49 persone. Non era mussulmano bensì suprematista bianco quel Robert Bowers che il 27 ottobre scorso ha massacrato 11 fedeli ebrei in una sinagoga di Pittsburgh, negli Usa (v.foto).
I due terrorismi sono diversi, perché quello jihadista si avvale anche di una struttura organizzata mentre quello di estrema destra non ha strutture formali. Ma ambedue si nutrono di universi di senso che li sostengono, diversi ma ben precisi. Con ideologi, pubblicazioni, e una convergenza nell’uso dei social media e della propaganda, che i neonazisti sempre più mutuano da quella del jihadismo. Fino alla tattica di “alzare il volume” con dirette in streaming.
Mentre dunque il jihadismo rimane la nostra preoccupazione principale, la sottovalutazione prodotta dall’analisi di chi vede solo questa – più che reale – minaccia produce una sottovalutazione della seconda. Ed è bizzarro, anche perché mentre l’estrema destra è seconda al jihadismo per quantità di massacri collettivi, è assolutamente prima e di successo negli assassini politici, come insegna quello di Ytzhak Rabin. Eppure il Global Terrorism Index segnala una sua forte crescita, visto che siamo passati dai 20 attacchi nei 13 anni tra il 2001 e il 2014, ai 61 dei tre anni seguenti. Con l’uccisione di una deputata inglese, Jo Cox, e per esempio la diffusione di una rete internazionale di militanti che dal gruppo neonazista e antimussulmano inglese National Action si estende a Germania, Scandinavia, paesi anglosassoni – tra cui Australia e Nuova Zelanda – e paesi baltici. Almeno per il momento.
Perché se non risolveremo la nostra interna dissonanza cognitiva – che è poi un dissenso e disaccordo interno su “chi è il nemico” – , il massacro di ieri può aprire una terribile e nuova convulsione nelle nostre società e nei rapporti con l’Altro, a cominciare dal nostro Islam in occidente. Proprio come 25 anni fa il massacro di Baruch Goldstein terremotò e iniziò a far fallire il processo di pace tra israeliani e palestinesi.
Fabio Nicolucci
(articolo pubblicato su Il
Mattino di sabato 16 marzo 2019)

Setirot – Cose da prof
Stefano Jesurum Pubblicato in Idee il 14/02/2019 – 9 אדר א’ 5779
Enrico Galiano è un professore di quelli che, malgrado la considerazione sempre più bassa e gli stipendi vergognosi con cui questo paese ricambia le fatiche e l’impegno di chi forma il nostro futuro, crede nel proprio lavoro (in una scuola alla periferia di Pordenone). E s’inventa un po’ di tutto: dai libri pubblicati con Garzanti alla webserie Cose da prof che supera i dieci milioni di visualizzazioni Facebook. Se lo cito qui è perché mi ha colpito molto una sua frase pronunciata in occasione dell’ultima Giornata della Memoria. Semplice, chiara, vera: “Per pensare che il passato si stia ripetendo identico bisogna essere un po’ miopi. Ma per non vedere pezzi di quel passato nel nostro presente, bisogna essere proprio ciechi”.
Tanto per mettere un punto al dilagare di inutili, dannose, capziose, “ideologiche” polemiche su a-storici parallelismi tout court tra “ieri” e “oggi”, parallelismi pronunciati, spessissimo attribuiti in malafede a persone integerrime, magari sopravvissute al Lager. Aria fritta foriera di nuovo odio.
Stefano Jesurum, giornalista

L’innominabile Finkielkraut, aggredito perché ebreo, diventa “un signore anziano”
Stefano Jesurum 27 febbraio 2019
Tutto inizia il 15 maggio 2018 su Rai3, una puntata di “Quante storie”, il bel programma di Corrado Augias che attraverso i libri parla di attualità, politica e cultura. Il cuore della trasmissione è “Autobiografia del Novecento. Storia di una donna che ha attraversato la Storia” (il Saggiatore). L’autrice è Vera Pegna. Per me che sono ignorante una sconosciuta. Effettivamente una lacuna poiché Pegna ha alle spalle un’esistenza abbastanza speciale. Nata ad Alessandria d’Egitto in una famiglia – ci tiene spesso a specificarlo lei stessa – “di origine ebraica” (mai capito che cosa questa definizione, per altro usatissima, significhi), si laurea a Ginevra, milita nel Pci, consigliere comunale a Caccamo, successivamente Comitato Vietnam a Milano. Apprezzata interprete, gira per conferenze in mezzo mondo, Europa, Asia e Africa. Incontra il buddismo, poi il lungo viaggio verso Palermo per conoscere Danilo Dolci, il Gandhi siciliano. E il Pci, appunto, la lotta contro la mafia, l’approdo a Milano, l’impegno contro la guerra in Vietnam, la difesa della causa palestinese sotto il vessillo del laicismo. Quindi Roma, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Karol Wojtyla, moltissimi i personaggi di spicco che incontra. E racconta. Da laica (dice lei).
Già da Augias però il suo “laicismo”, alle mie orecchie, suona qualche nota stonata, tipo l’ossessione che sovente si riscontra in quel campo radicale “difensore” della causa palestinese attraverso la criminalizzazione tout court di Israele – del suo popolo, della sua democrazia, della sua storia, della sua stessa esistenza. Insomma, per intenderci, ciò che ormai viene ufficialmente chiamato con il nome che merita: una forma di antisemitismo secondo la definizione coniata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra) e adottata all’unanimità, tra gli altri, dai 28 paesi dell’Unione Europea. Fin qui – come dire? – niente di nuovo sotto il sole per chi, orgogliosamente ebreo e orgogliosamente di sinistra (chi scrive e molti altri), milita da decenni nel campo della pace, per intenderci alla Amos Oz.
Ma è il 18 febbraio di quest’anno che Vera Pegna, a mio avviso, fa un passo in più verso l’obnubilamento (cit. dizionari Corriere.it: Temporaneo ottundimento delle facoltà sensoriali o intellettive). In collegamento con la giornalista Sara Menafra che quel giorno conduce “Prima Pagina” di Rai Radio3 e si occupa dell’aggressione subita 24 ore prima a Parigi da Alain Finkielkraut per mano di un gruppo di Gilet gialli che lo assalgono al grido di «sporco ebreo, sporco sionista, viva la Palestina», Pegna non chiama mai il noto filosofo per nome – cosa che non farà per l’intero collegamento. «Quelle frasi rivolte a un signore anziano… è una cosa che non va bene comunque». E Finkielkraut, va rimarcato, rimane per i quasi sei minuti di sproloquio «un anziano signore». Tutto ciò non è antisemitismo. «Perché oggi il sionismo non è una cosa bella, è una cosa brutta, e si può dire sporco sionista». Ma il secondo passaggio “logico” – aberrante – è che «poiché Israele si vuole Stato ebraico, lo Stato di tutti gli ebrei del mondo, sporco sionismo si può dire, sarebbe come dire sporco Israele». Affermazione, per la signora Pegna, più che legittima evidentemente.
Vabbè, dai!, su Israele se ne sentono tante, sai che novità. Onestamente una “novità” Vera Pegna ce la regala. Quando dice, o meglio chiede, qualcosa che definire vergognoso è poco. «Ciò che vorremmo noi europei è che vorremmo sentire chi si considera ebreo, sempre legittimamente, protestare, condannare Israele per le sue atrocità. Vorremmo sentire gli ebrei fuori da Israele dire “Israele è Israele, è il paese dei suoi cittadini, ma non è il nostro paese”, invece questo purtroppo non viene detto». Una versione 2019 dell’eterno “Davide discolpati!”. Chiedo scusa se sarò lungo: una esegesi di quell’intervento può spiegare ben più di mille saggi su pregiudizio, razzismo, antisemitismo diffusi. E con i tempi che corrono sono profondissimamente convinto che l’ammonimento contenuto nel bellissimo “Il bambino nella neve” di Wlodek Goldkorn (Feltrinelli) sia vitale, dirimente, imprescindibile: un tempo si portavano nelle miniere i canarini, sensibili ai gas avvertivano quando la catastrofe era imminente; memoria significa essere un canarino in miniera, dare l’allarme quando si sente l’acre odore del razzismo. Perché le parole di Vera Pegna interrogano chi si impegna affinché quell’acre odore di razzismo non infesti definitivamente la nostra quotidianità gialloverde.
Per spiegarmi senza troppi giri di parole, io, per esempio, non mi considero ebreo, io sono ebreo. E così tutti gli ebrei al mondo sono ebrei, non si considerano tali: religiosi e atei, osservanti e laici, di destra e di sinistra, plaudenti o combattenti il governo Netanyahu. Pegna dice «noi europei vorremmo che…». Già, evidentemente il francese Finkielkraut non è europeo, così come non lo è l’italiano Stefano Jesurum. Il pensiero va così ai Treves e ai Sereni, ai fratelli Rosselli e a Primo Levi, a Bassani, ai moltissimi che hanno fatto la nostra cultura, la nostra società, il Risorgimento e la Guerra di Liberazione – da ebrei e da italiani. E non posso non (quasi) commuovermi andando con la memoria al 1988 o giù di lì quando per “l’Europeo” intervistai l’allora ministro degli Esteri del Pci, Giorgio Napolitano, che per la prima volta sentenziò «sionismo non è una parolaccia e sionista non è un insulto». Oggi invece Pegna ci chiede non tanto e non solamente una condanna di Israele in toto (non del governo, bensì dello Stato in sé) quanto una sorta di dissociazione identitaria. Chissà se la signora ricorda l’accusa di dual loyalty, doppia fedeltà cioè infedeltà appioppata agli ebrei durante il fascismo e/o negli anni più cupi dell’URSS – con le ben note conseguenze, lager e gulag. Insiste: «La parola antisemitismo, una parola terribile se legata al passato con tutti quei morti, oggi si è evoluta perché gli ebrei fuori da Israele non condannano Israele». Se la logica ha un senso dunque, se critichi la politica di Gerusalemme non puoi che essere antisionista e quindi non puoi che essere, “giustamente”, antisemita.
Post scriptum. Nell’intero collegamento la conduttrice Sara Menafra (“Messaggero”, “Manifesto”, “Secolo XIX”, “Sole 24 Ore”, attualmente coordinatrice della redazione romana di “Open”), pure lei, non ha mai nominato Alain Finkielkraut. Praticamente non ha aperto bocca, complimenti.
Stefano Jesurum

Setirot – Speranza
Stefano Jesurum Pubblicato in Idee il 07/03/2019 – 30 אדר
Sicurezza vuol dire
periferie dove un ragazzo di 19 anni non abbia paura di essere colpito da un
proiettile di pistola che gli segna la vita. Sicurezza significa dare il
diritto a due ragazzi che si vogliono baciare perché si vogliono bene di non
avere paura che qualcuno li insulti sull’autobus. Sicurezza vuol dire
permettere a un ragazzo che vuole pregare Allah di poterlo fare senza sentirsi
deriso. Sicurezza vuol dire per tanti ragazzi prendere l’autobus e andare a
scuola con la kippà in testa e sentirsi felici e non vittime di insulti o di
paure.
È uno dei passaggi che più mi sono piaciuti del discorso pronunciato da Nicola
Zingaretti la sera in cui le primarie lo hanno eletto nuovo segretario del
Partito democratico. Parole che – si sia piddini come me o no – dovrebbero
essere condivise e auspicate da ogni cittadino in buona fede, se non razzista e
fascista. Purtroppo temo che ci sarà chi inizierà – o forse lo ha già fatto –
con i distinguo capziosi, con le lagne vittimistiche, con una sorta di sorda
volontà di non cogliere mai il positivo bensì di incistarsi perennemente sul
negativo. Debbo essere più chiaro? Prendiamo a esempio la grande manifestazione
antirazzista di Milano. È stata semplicemente splendida, ha ridato speranza a
un popolo che rischiava di rinchiudersi nella propria frustrante malinconia. Ha
suonato la tromba del nuovo impegno per un futuro migliore del cupo e
incattivito presente. Certo, in mezzo a 200mila donne e uomini, bambini,
famiglie, anziani, ha sventolato qualche bandiera palestinese che non c’entrava
veramente alcunché. Le ho viste solamente in fotografia, però giurerei che a
portarle siano state quelle poche decine di persone che da anni hanno fatto dei
diritti palestinesi la maschera del loro antisemitismo.
E allora dai! andiamo avanti. A forza di guardare il dito finiremo sennò col
perderci lo spettacolo della luna. Noi che della speranza abbiamo fatto nei
secoli la nostra forza – oltre che l’inno di Israele.
Stefano Jesurum, giornalista

Setirot – Limiti
Stefano Jesurum Pubblicato in Idee il 14/03/2019 – 7 אדר ב’ 5779
Ma che cosa ci sta succedendo? C’è un limite? E qual è? Dove si fermerà l’asticella del consentito? In Eretz sono in piena campagna elettorale, ok, ok. I toni ovviamente si alzano, ok. Adesso però il Presidente Reuven Rivlin afferma che si rifiuta «di credere ci siano partiti politici che hanno abdicato al carattere di Israele come Stato ebraico e democratico, democratico ed ebraico»; ribadisce che «Israele riconosce la totale uguaglianza di diritti per tutti i suoi cittadini». Perché lo fa? Perché all’Università ebraica di Gerusalemme rilancia il monito che lo ha sempre contraddistinto, ovvero «non ci sono, e non ci saranno mai, cittadini di prima classe, come non ci sono elettori di seconda classe. Siamo tutti uguali nella cabina elettorale, ebrei e arabi, cittadini dello Stato di Israele»? La risposta non è un segreto. Si riferisce all’ultima sparata del premier Benjamin Netanyahu rivolta a chi la pensa diversamente da lui e dalla sua coalizione di estrema destra. Ha detto Bibi: «Vorrei chiarire un punto che, a quanto pare, non è chiaro a persone leggermente confuse. Israele è uno Stato ebraico e democratico. Questo significa che si tratta dello Stato nazionale del solo popolo ebraico. Naturalmente rispetta i diritti individuali di tutti i cittadini – ebrei e non ebrei. Ma è lo Stato nazionale, non di tutti i suoi cittadini, ma solo del popolo ebraico». Alla faccia della Dichiarazione d’Indipendenza. Sì, lo so, la nuova, contestatissima, legge. Però c’è un limite. Anche perché aggiungi e aggiungi nefandezze e aberrazioni e prima o poi si scoppia. Un esempio? Le nuove prove sul fatto che la Rabbanut israeliana chiede il test del DNA agli ebrei “sospetti” (perché provenienti dall’ex URSS – come se invece in millenni di storia non ci siano state, certamente e ovunque, “contaminazioni”). Siamo alla limpieza de sangre. Dove è il limite?
Stefano Jesurum, giornalista

Lo storico e il giornalista, la battaglia per l’anima di Israele
20 Febbraio 2019
Benny Morris e Gideon Levy hanno idee opposte su palestinesi, pace e sicurezza: sono lo specchio perfetto del Paese spaccato che si prepara a votare il 9 aprile
di BERNARDO VALLI
GERUSALEMME
– Molte famiglie, in Israele, hanno alle spalle un romanzo. Una vita avventurosa.
Spesso tragica. Risali un paio di generazioni, o anche meno, nell’esistenza di
amici o conoscenti e li scopri fratelli, figli, nipoti di vittime dello
sterminio. Sono ormai rari gli scampati dai campi della morte. Ci sono anziani
sradicati dai Paesi d’origine e giovani che non conoscono le terre da cui sono
arrivati genitori o nonni. I temperamenti sono passionali. L’ansia
dell’insicurezza è l’inconscia origine di posizioni difensive, ma anche di
reazioni offensive.
Ed ecco il sabra, l’israeliano nato in Israele,
soldato sicuro di sé, al quale Natalia Ginzburg preferiva il curvo abitante del
ghetto, scandalizzando i suoi lettori di Tel Aviv. La letteratura e la
storiografia israeliane percorrono questi sentimenti in opere tra le più
avvincenti del nostro tempo, scritte in ebraico, una lingua antica rinnovata.
Convinzioni, altrettanto antiche, animano una società tra le più
tecnologicamente avanzate. Le contraddizioni non mancano: una democrazia
dinamica, spigliata, la sola della regione, occupa militarmente terre in cui
gli abitanti non hanno i diritti dei cittadini di Israele.
Questo è un filtro
attraverso il quale seguire questo Paese unico al mondo, sicuro di sé, ma
sensibile per le tante cicatrici. Una società che sa guardarsi senza infingimenti,
con un dibattito politico animato, a volte spregiudicato, verbalmente violento,
come sembra esigere lo stato di emergenza, psicologico, ma anche reale, in cui
vive. A neppure due mesi da un’elezione (9 aprile) in larga parte dominata
dall’inamovibile problema della sicurezza, uno storico, Benny Morris, e un
editorialista del quotidiano Haaretz, Gideon Levy, animano una polemica su un problema
essenziale: arabi e israeliani possono convivere e per quanto tempo Israele
potrà esistere? E’ un interrogativo che può sollecitare il dubbio tra non pochi
elettori.
Benny Morris
è uno dei “nuovi storici” che non si sono rassegnati alla interpretazione
ufficiale del passato, e l’hanno scavato in piena libertà, non risparmiandosi
reciproche critiche. Lui, Morris, è stato uno dei bersagli preferiti dai
colleghi. Ha avuto atteggiamenti giudicati progressisti quando ha rifiutato di
fare il servizio militare nei Territori occupati per motivi morali e per questo
è finito in prigione. Ma ha anche preso posizioni opposte quando ha sostenuto
che lo Stato di Israele, appena creato, avrebbe dovuto favorire, sollecitare
l’esodo totale dei palestinesi. I suoi scritti restano comunque indispensabili
per ricostruire quel periodo. Oggi, a settant’anni, professore universitario, Benny
Morris pensa (e dice) che col tempo una maggioranza araba sommergerà Israele.
Prevede ripetute esplosioni di violenza, tra le popolazioni di diversa origine,
grazie alle quali gli arabi saranno nelle condizioni di chiedere il ritorno dei
profughi. Così gli ebrei saranno ridotti a una minoranza, come erano quando
vivevano nei Paesi musulmani. Chi ne avrà i mezzi raggiungerà l’America o
qualche Paese occidentale. Per Benny Morris i palestinesi vedono tutto in una
prospettiva di lungo termine. Al momento osservano “cinque-sei-sette milioni di
ebrei”, circondati da centinaia di milioni di arabi. “…che tra trenta o
cinquant’anni ci sommergeranno”, conclude lo storico.
Gideon Levy, 65 anni, è
una delle più efficaci voci critiche israeliane. E’ uno dei protagonisti della
permanente polemica politica che rende vitale la democrazia. E’ vero, dice, che
fin dall’inizio i palestinesi si sono opposti al sionismo, considerandolo un
potere coloniale che ha invaso e occupato il loro Paese. Nella loro prospettiva
è la verità. La loro verità. A loro non interessa il diritto alla terra della
Bibbia, né la promessa divina, né l’Olocausto. Questo riguarda il passato, dice
sempre Gideon Levy; in quanto al presente, Morris trascura il regime militare
nei Territori occupati, uno dei più severi e umilianti. Da più di cinquant’anni
le ispezioni notturne gettano fuori dai loro letti anche i bambini. In quale
altro Paese democratico ci sono milioni di persone senza cittadinanza? Morris
prevede negli anni il prevalere della maggioranza musulmana ed è convinto che
quel che è già accaduto nel passato altrove si verificherà in Israele nel
futuro.
Sbaglia. Come storico,
gli ricorda Levy, dovrebbe sapere che, più che ripetersi, la storia può essere,
al massimo, simile. E’ vero che la democrazia ha scarse speranze di realizzarsi
nei Paesi arabi, ma i palestinesi hanno dimostrato di sapersi comportare
diversamente. Eleggono il loro Consiglio legislativo, e i palestinesi che sono
cittadini israeliani eleggono i loro deputati alla Knesset. Morris è convinto
che gli arabi non perdoneranno mai Israele. Levy ribatte che gli ebrei hanno
perdonato la Germania per crimini più orribili; i neri negli Stati Uniti e
nell’Africa del Sud hanno perdonato i bianchi; Francia e Germania sono
diventati alleati dopo la Seconda guerra mondiale. Soltanto i palestinesi non
dovrebbero perdonare?
Uno storico come Morris
dovrebbe sapere che tutto può svolgersi in maniera diversa se Israele assume le
sue responsabilità morali e concrete. Esistono già città arabo-israeliane come
Haifa e Jaffa. Ed esistono tanti modi per tentare una convivenza. Ma quando si
è ultranazionalisti non si trova nulla da discutere con quelli considerati
inferiori. E allora si è portati a credere all’apocalisse, conclude Gideon
Levy.
Quelle di Morris e di
Levy sono posizioni opposte ed estreme. Il panorama politico mediorientale è
cambiato. Israele non è più isolato. Con i Paesi sunniti, dall’Arabia Saudita
all’Egitto, ha un comune nemico: l’Iran sciita degli ayatollah. Benjamin
Netanyahu partecipa a riunioni con dirigenti arabi che un tempo chiedevano la
fine di Israele.
Ma i rapporti al
vertice, tra governi, non corrispondono ai sentimenti prevalenti nelle
popolazioni. Non contribuiscono alla convivenza né il muro eretto tra Israele e
i Territori occupati; né la legge sullo stato-nazione ebraica, approvata in
luglio dalla Knesset, che di fatto fa degli arabo-israeliani cittadini di una
classe inferiore, nonostante la dichiarazione di indipendenza parli di
uguaglianza per tutti i cittadini, senza distinzione etnica o religiosa; né la
riduzione della lingua araba, un tempo ufficialmente la seconda, a lingua a
status speciale. Né del resto gli incontri tra dirigenti arabi e israeliani,
per concertare azioni contro il comune nemico iraniano, hanno cambiato gli
umori ostili delle popolazioni arabe.
Benny Gantz,
l’avversario di Benjamin Netanyahu alle elezioni di primavera, pur auspicando
un dialogo con gli arabi, parla di un’ostilità destinata a durare a lungo.
Netanyahu non la pensa diversamente. E agisce di conseguenza.

Enzo Sereni
Enzo Sereni (Roma, 17 aprile1905 – Campo di concentramento di Dachau, 18 novembre1944) è stato un attivista, partigiano, scrittore, sionista italiano, cofondatore del kibbutzGivat Brenner, letterato, sostenitore della coesistenza tra ebrei e arabi. Combattente della Resistenza, fu paracadutato nell’Italia occupata dai Nazisti durante la seconda guerra mondiale; catturato dai tedeschi, fu successivamente ucciso nel campo di concentramento di Dachau.
Biografia : Nato a Roma, i genitori Samuele Sereni e Alfonsa Pontecorvo erano esponenti dell’alta borghesia ebraica romana. Suo padre era il medico del Re d’Italia, suo zio Angelo presidente della comunità ebraica romana. Enzo era il secondo di tre fratelli: il primo, Enrico, uno scienziato legato ai movimenti antifascisti di “Giustizia e Libertà” e morto suicida in giovane età, il terzo Emilio, senatore della Repubblica italiana, partigiano e militante comunista. Le vicende della famiglia Sereni sono rievocate nel romanzo Il gioco dei regni di Clara Sereni (Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 1993), terzogenita di Emilio.
Sereni era diventato sionista da ragazzo, e fu uno dei primi sionisti italiani.[1] Sereni sposò Ada Ascarelli, anch’essa di famiglia ebraica benestante, a Roma, dove nacque la primogenita Hana. Dopo avere conseguito la laurea all’Università di Roma, fece aliyah verso il Mandato britannico della Palestina nel 1927. Lavorò nell’aranceto a Rehovot e prestò aiuto a costruire il kibbutz di Givat Brenner dove nacquero la secondogenita Hagar e il terzo figlio Daniel. Già un entusiasta socialista, Sereni fu anche attivo nel sindacato dell’Histadrut. Era un pacifista che sostenne la co-esistenza con gli arabi e l’integrazione delle società ebraiche e arabe.
Sereni fu mandato in Europa negli anni dal 1931 al 1934 per aiutare a portare la gente in Palestina attraverso la aliyah e fu arrestato per breve tempo dalla Gestapo. Aiutò a organizzare il movimento Hechalutz nella Germania nazista ed anche a contrabbandare persone e denaro fuori dalla Germania. Si recò anche negli Stati Uniti d’America per aiutare ad organizzare il locale movimento sionista. Durante la seconda guerra mondiale, fece parte delle British Army e avviò propaganda anti-fascista in Egitto. Fu quindi incaricato dagli inglesi in Iraq, ove passò parte del suo tempo ad organizzare aliyah clandestine. Ebbe problemi con i superiori della British Army per i suoi piani sionistici e fu imprigionato per poco tempo per la contraffazione di passaporti.
Successivamente aiutò ad organizzare le unità paracadutistiche della britannica Special Operations Executive (SOE), che inviava agenti nell’Europa occupata. In particolare, Sereni ispirò – a Bari, dal gennaio 1944 – la creazione di un’unità dell’Agenzia ebraica che aveva lo scopo di aiutare ed eventualmente salvare gli ebrei che si trovavano nei territori occupati dai nazisti. Di circa 250 reclute volontarie circa 110 furono selezionate per addestrarsi e 33 furono paracadutate in Europa, compreso Sereni, malgrado la sua età relativamente avanzata. Il 15 maggio del 1944 fu paracadutato nell’Italia settentrionale sotto il falso nome di Samuel Barda ma fu catturato immediatamente a Maggiano di Lucca. Condotto a Verona, fu torturato e rinchiuso nelle celle ricavate nei sotterranei del palazzo dell’INA, diventato sede del SD (il servizio segreto delle SS). Fu trasferito al campo di transito di Bolzano il 25 agosto 1944 e detenuto nel blocco E, recintato col filo spinato perché riservato ai prigionieri politici considerati più pericolosi, come riportato da Vittore Bocchetta in 1940-1945 Quinquennio Infame, Verona, Edizioni Gielle, 1991. Fu quindi deportato al Dachau il 5 ottobre 1944 dove fu sottoposto a uno speciale regime di rigore. Un sopravvissuto facente parte dello stesso trasporto, Raffaele Capuozzo, in una testimonianza filmata rilasciata all’archivio storico della città di Bolzano, ha raccontato la tempra di Sereni a Dachau: “Il capo-lager venne con un elenco e chiamò fuori Samuel Barda, capitano paracadutista inglese. Parlò in tedesco, non so cosa disse. Cominciò a sferrargli pugni sulla faccia e questo capitano, che sarà stato alto un metro e 55, non si mosse, rimase sull’attenti imperterrito come se gli facessero delle carezze”. Immatricolato a Dachau con il nome Shmuel Barda e con il numero 113160, Sereni fu condotto il 17 novembre 1944 in una cella speciale di punizione per essere interrogato e, secondo la documentazione, fucilato il 18 novembre 1944.
Altri martiri famosi che furono paracadutati in Europa con l’unità dell’Agenzia ebraica furono Hannah Szenes e Haviva Reik. Il kibbutz Netzer Sereni porta il suo nome.
Un capitolo del saggio sulla storia dei sionisti italiani Una terra per rinascere. Gli ebrei italiani e l’emigrazione in Palestina prima della Guerra (1920-1940), di Arturo Marzano, Milano, Marietti, 2003, è dedicato a Sereni.

Dedicati a Yitzhak Rabin i giardini di piazzale Tripoli a Milano
Il comune di Milano, accogliendo la richiesta che era stata presentata alcuni mesi fa da Sinistra per Israele in occasione del ventennale dell’assassinio del Primo Ministro e Premio Nobel per la pace Yitzhak Rabin, ha annunciato che:
martedì 3 maggio 2016 alle ore 14,30,
i giardini di piazzale Tripoli verranno intitolati allo statista israeliano

Il lascito di Rabin, vent’anni dopo
Di Gabriele Eschenazi
.jpg)
Yitzhak Rabin
Sono trascorsi vent’anni dall’omicidio di Yitzhak Rabin per mano di Yigal Amir, estremista ebreo religioso, e ancora in Israele si avverte la necessità di interrogarsi sul significato e le conseguenze di quell’evento traumatico. Ci fu un’eredità politica da gestire, un sistema democratico da difendere, un apparato di sicurezza da mettere sotto esame.
“Abbiamo deciso di dare un’opportunità alla pace. Una pace che risolverà gran parte dei problemi dello stato d’Israele”, disse Rabin quella sera a Tel Aviv. Questo messaggio politico fondamentale è stato raccolto solo parzialmente dai leader, che si sono succeduti dopo di lui.
Il primo fu l’inossidabile Shimon Peres, anche lui, premio nobel a Oslo, ma perdente di natura tanto da non essere mai capace di vincere le elezioni a capo del partito laburista. Lo seguirono Ehud Barak ed Ehud Olmert, gli unici che dopo Rabin cercarono di riprendere il percorso degli accordi di Oslo verso lo stato palestinese. Non ci riuscirono, anche per responsabilità della controparte, e non dimostrarono una vera capacità di leadership. Barak chiuse ad ogni prospettiva di accordo dichiarando che ”non c’era un partner”; Olmert, dopo aver offerto ad Abu Mazen (che rifiutò) il 97% dei territori occupati, restò implicato in imbarazzanti episodi di corruzione e finì così senza gloria la sua carriera politica.
Un caso a parte è quello di Arik Sharon, che se da una parte ebbe il coraggio di lasciare Gaza, dall’altra evitò come la peste ogni accordo con i palestinesi isolando prima Arafat e ignorando dopo Abu Mazen. Bibi Netanyahu, che in questi vent’anni è riuscito a condizionare la politica israeliana sia dall’opposizione che dal governo, era il grande avversario di Rabin e ha usato gli accordi di Oslo non per raggiungere la pace bensì per suggellare all’infinito una situazione di occupazione e conflitto permanente.
L’esistenza di un’Autorità Palestinese è diventata col tempo un comodo alibi per continuare la colonizzazione della Cisgiordania, mantenerne il controllo militare e rendere Israele libero dalla gestione amministrativa. Non è un caso che Abu Mazen abbia più volte minacciato di sciogliere l’Autorità Palestinese. Dunque gli accordi di Oslo sono sopravvissuti a Rabin, ma non hanno dato spazio alla prospettiva di “Due popoli, due stati”, un concetto formalmente adottato anche da Bibi Netanyahu.
Il sistema democratico israeliano ha reagito alla morte di Rabin in questi anni così come in questi giorni. Con un film coraggioso presentato alla Mostra del Cinema di Venezia Amos Ghitai ha ripercorso con meticolosità i giorni prima e dopo l’assassinio di Rabin. Ogni canale israeliano ha proposto un suo documentario sul tema. Giornali e siti hanno ospitato analisi e testimonianze. Tra tutte spicca quella del fratello dell’assassino, Hagai Amir, che ha raccontato come suo fratello nel 1995 era pronto a morire da “shahid” pur di uccidere Rabin. Hagai aiutò il fratello nella sua impresa anche procurandogli le pallottole, ed è stato da poco incriminato per aver minacciato di morte su Facebook l’attuale capo dello stato Rubi Rivlin (membro dello stesso partito di Netanyahu, il Likud).
Yigal Amir è sempre in galera e il presidente Rivlin ha dichiarato che mai lo grazierà, gli estremisti di destra sono rimasti fuori dall’ultima Knesset, però la furia omicida dei fanatici della destra israeliana non si è fermata. Ancora oggi non sono stati arrestati gli assassini della famiglia di Duma, cellule terroristiche ebraiche operano nell’ombra e allo scoperto nei social network. Episodi di violenza ebraica si susseguono ad altri di parte palestinese in una spirale senza fine, che semina diffidenza, paura e progetti di nuovi muri.
Sabato 31 ottobre il presidente Rivlin e Bill Clinton hanno arringato la folla in piazza Rabin protetti da un muro di vetro antiproiettile. Il timore del ripetersi di un caso Rabin esiste ed è palpabile. La politica di Netanyahu fomenta e cavalca la paura, allontana la speranza, parla della gestione di un conflitto, che non vedrà soluzione per generazioni. In questo modo non rende un buon servizio al suo paese.
La specificità di Israele come paese democratico, tecnologicamente avanzato, aperto al mondo si corrode all’interno di un Medio Oriente dove a guerre sanguinarie tra fondamentalisti si associa la sopravvivenza di regimi politici di stampo medievale. Eppure è proprio questa specificità di Israele che Rabin voleva preservare presentandosi come leader di pace, affidabile, serio, coerente e duro nel difendere la sicurezza dei propri cittadini. Ne abbiamo ancora nostalgia e questo non è un buon segno.
Articoli recenti
 Dal 7 ottobre alla pace Manifesto promosso da Sinistra per Israele
6 Marzo 2024 | 3
Dal 7 ottobre alla pace Manifesto promosso da Sinistra per Israele
6 Marzo 2024 | 3
Il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre scorso e le drammatiche conseguenze dell’operazione milit...
 Setirot – Speranza
19 Marzo 2019
Setirot – Speranza
19 Marzo 2019
Stefano Jesurum Pubblicato in Idee il 07/03/2019 – 30 אדר Sicurezza vuol dire periferie dove...
iscriviti alla newsletter
Errore: Modulo di contatto non trovato.









